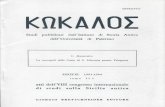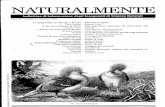Su delle rimanenze statuarie d’età romana. Ritrovate nell’agro settentrionale siracusano ...
Transcript of Su delle rimanenze statuarie d’età romana. Ritrovate nell’agro settentrionale siracusano ...
Sebastiano Lanteri
Su delle rimanenze statuarie d’età romana
Ritrovate nell’agro settentrionale siracusano
presso Fondo Fico a (Priolo Gargallo)
Melilli (SR) - © 2013
1
Sulle rimanenze statuarie d’età romana ritrovate nell’agro settentrionale siracusa-no presso Fondo Fico (Priolo Gargallo).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Il contesto topografico - archeologico.
Il manufatto lapideo rappresentato in foto
[Fig. 1], ritrovato nei dintorni del Fondo Fico
nel 1923, è oggi rimanenza archeologica di
una statua panneggiata1, priva di tutta la parte
superiore compresa la testa, presumibilmente
di marmo pentelico2, come riportato
dall’Orsi,3 alta m. 1,70, che poggia su
1 Il panneggio è il modo di disporre le masse e le
pieghe delle vesti nelle opere d'arte figurativa e
specialmente nella scultura, ha avuto sempre una
notevole importanza nella produzione artistica, e
soprattutto in quella classica. 2 Marmo a grana fina, leggermente opaco, estratto sul
monte Pentelico in Grecia, celebre nell’antichità per le
cave di marmo bianco, usato in Grecia per la statuaria e
per l’architettura e anche largamente esportato; esposto
agli agenti atmosferici, assume col tempo una patina
calda e dorata che rende particolarmente suggestive le
opere architettoniche con esso eseguite (come, per es.,
il Partenone e i Propilei di Atene). 3 P. ORSI, Romanità e avanzi romani in Sicilia. Priolo.,
estratto dalla Rivista Roma – 1934 – XII - n. 6, Rocca
S. Casciano, 1934, p. 253.
piedistallo di forma parallelepipida di circa
20-30 cm di spessore.
Il reperto costituito da due pezzi
separati, è datato tra il I - II sec. d.C., periodo
rientrante nella dominazione romana in
Sicilia.
Riportato alla luce per caso, durante i
lavori di messa in cultura di un grande
vigneto,4 nel terreno di proprietà del nobile
Filippo Francesco Gargallo di Castel
Lentini, VIII° barone del feudo Priolo, V°
Marchese di Castel Lentini.5
I resti del colossale monumento
marmoreo dovevano provenire da una
v i l l a r u s t ĭ c a ,6 ubicata nelle vicinanze,
trasportati nel luogo del ritrovamento per
motivi a noi del tutto ignoti.
Risultanze archeologiche, relative a
fabbricati rurali, furono individuate nei
primi anni del ‘900 nel territorio circostante.
A Torre Girotta durante saggi di scavo
effettuati nel 1892, «… esistevano fino a
pochi lustri addietro ruderi di una suntuosa
villa romana, tale a giudicarla dai molti
avanzi marmorei che ha dato; ma
saccheggiata da Vandali e Saraceni, dopo
che già era stata modificata in tempi
bizantini, negli ultimi tempi i villani per
spetrare il suolo ne trassero molti blocchi e
pezzi marmorei, onde è che oggi il punto dei
4 Ivi, p. 253.
5 G. MIGNOSA, Priolo Gargallo da borgo feudale a
centro industriale, Siracusa, 1960, p. 35. 6 Residenza di campagna con funzioni di fattoria
occupata in modo stabile da servi o schiavi che ci
lavoravano per i padroni. Il loro lavoro era organizzato
con disciplina militare e sorvegliato da un v i l l i c u s
vicario del padrone.
Fig. 2 – Tipica villa rustica romana.
Fig. 1 – La statua poco dopo il ritrovamento.
2
ruderi è appena segnato da una gibbosità del
suolo, cosparsa di rottami di ogni
maniera.»7 I resti di un altro fabbricato si
intravedevano a 500 m. verso nord,
costituiti da «… vaste e complicate
installazioni idrauliche,»8 vicino la foce del
torrentello Ricuccio, nella località
denominata Bagnoli. Toponimo che ci
ricorda un luogo ove vi erano la presenza di
bagni o di vasche, avanzi ancora visibili nei
periodi di esplorazione archeologiche del
sito.9 La sua origine etimologica proviene
dal pl. lat. b a l n ĕ ŏ l u m , ‘piccoli bagni’;10
sic. vagnoli ‘bagni’.11
Queste strutture di
raccoglimento idrico forse facevano
riferimento a una v i l l a e m a r i t i m a e con
funzioni di t h y n n ō r u m r e t i u m12
‘tonnara’ o di c ē t ā r ĭ a e13
‘vivaio, vasche
per macerare’ utili a lavorazioni e
commercio ittico. Altri resti di abitazioni di
età romana imperiale furono segnalati di
fronte l’odierna stazione ferroviaria di
Melilli – Priolo.14
Ancora più a sud in
località Petraro - Specchi, sorgeva un’altra
villa nei pressi del monumento funerario
denominato la Guglia di Marcello.15
I resti statuari dovevano rappresentare
l’effigie di un d o m i n u s r u r i s locale, ed è
verosimile che, per essere esposta ai
viaggiatori percorrenti, fu posta lungo i
margini della strada consolare Pompea; asse
viario paralitoraneo ionico che sfruttava il
vecchio tracciato d’epoca greca e che serviva a
7 P. ORSI, Priolo. Catacombe di Riuzzo, in NdSA anno
CCCI – s. V, Vol. I, Roma 1904, p. 369; P. ORSI,
Priolo. Le catacombe di Riuzzo, in NdSA anno CCCIII
– s. V, Vol. III, Roma, 1906, p. 218. 8 Ibidem, p. 218.
9 Ibidem, p. 218.
10 L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, Vocabolario della
lingua latina, ed. Loescher, Torino, 1980, p. 136. 11
G. TROPEA, Vocabolario Siciliano, Catania-
Palermo, 2002, Vol. V, p. 972. 12
L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, Op. Cit., p. 2432. 13
Ibidem, p. 187. Le cetariae romane erano stabilimenti
per la lavorazione e conservazione del pesce. Il pescato
veniva lavorato veniva sottoposta a salagione per la
conservazione o per l’ottenimento del g a r u m , una
salsa molto diffusa nelle mense romane. 14
G. VALLET – G. VOZA, Dal neolitico all’era
industriale nel territorio da Augusta a Siracusa,
Siracusa, 1984, p. 42. 15
Ivi, p. 42. Ma anche P. ORSI, Op. Cit., p. 218.
collegare le colonie costiere della Sicilia
orientale.16
Necessita considerare che, il ritrovamento
del gigantesco manufatto è giustificato dalla
presenza all’interno del comprensorio Priolese,
oltre che dalle strutture abitative ad impiego
agreste e ittico, anche da un contesto
antropizzato più ampio, complesso e alquanto
dinamico; persistente durante tutta la
dominazione greco-romana, bizantina, fino a
quella normanna. Ulteriore testimonianza ne
sono le molteplici scoperte archeologiche e la
susseguente documentazione che ne deriva.
Infatti, a ovest di Bagnoli sempre sulla
sponda destra dell’alto corso del Ricuccio, che
prende il nome di Vallone della Neve, fu
segnalato in località fondo Bondifè un
insediamento romano con relativa necropoli.17
Ancora più a monte, questa volta sul lato
sinistro del vallone, persistono i resti di: una
necropoli castellucciana, un abitato tardo
romano, probabilmente un v i c u s , palmenti a
cielo aperto, latomie e tratti di carreggiata
incassata in roccia.18
Altro agglomerato urbano
con relative catacombe precostantiniane e
16
G. UGGERI, La viabilità della Sicilia in età romana,
ed. Congedo, Galatina (LE), 2004, pp.199-200. 17
P. ORSI, Modica. Costruzioni megalitiche di età
storica sull'altipiano, in NSc, Roma, 1897, p. 252. 18
Escursione effettuata assieme all’archeologo Dott. P.
Piazza in data 26.11.2011. Per la necropoli risalente al
bronzo, Vd. P. ORSI, Melilli. Sepolcri siculi del primo
periodo, in NSa, Roma, 1899, p. 69.
Fig. 3 – Tav. atlante di S. von Schmettau particolare del
tratto di litorale ove venne ritrovata la statua.
3
necropoli sub divo, individuabili in località
Manomozza o cugno Grande, a sud
dell’odierno comune di Priolo G.,19
nelle
vicinanze si può ancora ammirare la chiesa
paleocristiana di S. Focà.20
In contrada
Castellaccio si identificano i resti di un
acquedotto, un piccolo abitato e necropoli di
età tardo romana.21
A sud-ovest dello stesso
abitato, presso il torrente Monachella si
segnalano una necropoli sub divo e catacomba
di età imperiale romana.22
Seguono gli ipogei
di età tardoromana di contrada cava della
Porcheria;23
toponimo, quest’ultimo, che
nomina un tratto del torrente Priolo.24
In con-
trada Spatinelli resti di insediamento di età
tardo – romana.25
Ancora più a meridione,
nel Cozzo della Apara, nell’ex feudo
Biggemi si ravvisano i segni di un
insediamento di probabile età romana.26
Ai
19
P. ORSI, Op. Cit., p. 252; P. ORSI, Priolo. La catacomba
di Manomozza, in NdSA, Roma, 1906, p. 187. 20
P. ORSI, Nuove chiese bizantine nel territorio di
Siracusa, in Byzantinische Zeitschrift VIII ,pp. 636 - 642. 21
G. VALLET – G. VOZA, Op. Cit., p. 42. 22
Ivi, p. 42. 23
Ivi, p. 42. 24
Cfr. S. LANTERI, Il toponimo Porcheria segnala due
ipogei cristiani del IV – VI sec. d.C., Melilli, 2015, p. 1. 25
G. VALLET – G. VOZA, Op. Cit., p. 42. 26
Ivi, p. 42.
piedi delle balze rocciose di Monti Climiti,
presso Masseria Scrivilleri sono ingrottate
due ipogei paleocristiani.27
Oltre, a tutto ciò,
sono da ravvisare, anche se di età diversa,
nell’odierna Isola Magnisi, gli importanti
insediamenti preistorici (cultura di Thapsos)
e protostorici (greco arcaico) contenenti:
necropoli con tombe a grotticella e a
enchytrismòs con relativi abitati e strutture
difensive.28
Inoltre, nei pressi, se non nel luogo stesso,
dell’odierna Torre del Fico o Torre della
Fontana della Fico, doveva esistere
antecedentemente una presumibile, quanto mai
opportuna, s t a t i o n e s agraria o mansiones
- tabernae romana, connessa a un grande
lat i fundium, la fundorum massa
chiamata Pyramitanae (a. 489)29
. Tale tappa era
di una certa rilevanza strategica sotto l’aspetto
economico - geografico, in quanto intermedia
tra l’urbe Syracusae e quella di Megara del
cursus publicus. Lo stesso sito fu riutilizzato e
trasformato successivamente nel periodo arabo-
normanno a uso di funduq ‘alloggio per
viandanti, osteria, albergo, magazzino’30
, sic.
fùnnucu, chiamato fino al 1719-21 fondaco de
la Fico.31
«Turris in sinu Megarico, Augustae
hodie, ad littoris custodiam. Ibi fons ejusdem
nominis, Collegi Syracusani, cujus est
amplissimus ager, aedes sburbanae, &
hospitatoria taberna.»32
. Un torrione di forma
parallelepipeda a base quadrata terminante con
un cordolo merlato si erigeva tra i fabbricati
rurali e una chiesetta, a difesa del sito. La sua
costruzione è antecedente al 1688, data
documentata da un medaglione in pietra che si
trovava sull’architrave del cancello d’ingresso
27
Ivi, p. 42. 28
Cfr.: P. ORSI, Thapsos (penisola di Magnisi presso
Siracusa) - Esplorazioni della grande necropoli sicula,
in NdSA, Roma, 1894; P. ORSI, Thapsos, in MA – v.
VI, Milano, 1895; L. BERNABÒ BREA, La Sicilia prima
dei greci, ed. Il Saggiatore, Milano, 1982; S. TUSA, La
Sicilia nella preistoria, ed. Sellerio, Palermo, 1983. 29
G. MARINI, I papiri diplomatici, Roma, 1805, p. 128. 30
G. B. PELLEGRINI, Contributo allo studio dell’elemento
arabo nei dialetti siciliani, Trieste, 1962, pp. 19-20. 31
Toponimo presente nella cartografia degli inizi del
XVIII sec. Cfr. Fig. 3, che riproduce parte di una
Tavola dell’atlante di S. Von Schmettau, relativa al
litorale di Melilli. 32
V. M. AMICO, Lexicon topographicum Siculum - Neti
Vallis, Ed. Villenam, Panormi, 1759, p. 248.
Fig. 4 – Torre del Fico o Torre della Fontana della Fico.
4
al cortile della cappella della Madonna del Fico
che oltre all’anno recava i simboli della
“Compagnia di Gesù”.33
«… qui surgeva una valida, ed antichissima
Torre, ma fu abbattuta dal Terremoto nel
gennaio del 1693, ed a piè di essa la celebre
Fontana della Fico, così nominata, perché
dove sgorga, fuvi un tempo un Albero di
Fico.» 34
Quindi, edificata prima del grande
terremoto, utilizzata per la difesa del litorale
e come punto di avvistamento, con locanda
e fondaco e con alcune ville di nobili
siracusani annessi durante il periodo
medievale.35
Il marchese Gargallo lo stesso anno del
reperimento della statua la fece posizionare
sopra un alto pilastro a ridosso della strada
ferrata, così da renderla visibile ai
passeggeri, e una lapide recitava:
«Questo segno di Roma – che quasi saluto
augurale dell’Alma Urbe – fu qui rinvenuto
nel marzo MCMXXIII - redimendosi
l’Agro Priolese - Filippo Francesco
Gargallo - marchese di Castel Lentini,
barone di Priolo - fece innalzare.»36
2. Tentativo di un’analisi critica artistica.
In merito a una analisi sulle
caratteristiche artistiche del manufatto, pochi
sono i dati ricavabili dalle brevi e uniche
informazioni prodotte a suo tempo dall’Orsi
33
G. MIGNOSA, Priolo Gargallo da borgo feudale a
centro industriale, ed.Marchese, Siracusa, 1960, p. 20. 34
G. A. MASSA, Sicilia in prospettiva, la topografia
littorale di Melilli, Vol. II°, Palermo, 1709, p. 392. 35
S. MAZZARELLA – R. ZANCA, Il libro delle torri,
Palermo, 1985, p. 283. 36
P. ORSI, Romanità e avanzi romani di Sicilia, in
Rivista Roma, 1934, XII, Num. 6, p. 253
oltre quelli che si possono dedurre osservando
le foto che lo ritraggono.
Lo stesso studioso annota sommariamente che
la statua è costituita da due pezzi, di tipo
drappeggiata, alta complessivamente m. 1,70
senza plinto, con uno spessore che variava fra
i 0,80 e 0,90 cm, «… priva di tutta la metà
superiore, e quindi anche della testa.»,
scolpita «a quanto pare» in marmo
pentelico.37
Il monumento, considerate le su citate
misure, doveva assurgere a un’altezza di oltre
i 3 m. escludendo l’eventuale piedistallo e
plinto. Tali dimensioni imponenti ci fanno
presupporre alla funzione di
m o n u m e n t u m h o n ŏ r i s o f u n ĕ b r i s
del togato gigante di marmo, finalità
documentata anche a Siracusa con un’opera in
marmor proconnesium38
proveniente dal
Ginnasio Romano. Procediamo ora in questa
disamina sulla questione della quantità dei
pezzi scoperti e quanto rimane oggi di tali
reperti. Tra le brevi annotazioni dell’insigne
archeologo, divulgate undici anni dopo il
ritrovamento, assieme alla foto che ritrae la
scultura, pubblicata contestualmente come
immagine a corredo nel breve saggio, e le
altre diverse disponibili; sembra chiaramente
37
Ivi, p. 253. 38
Il marmo proconnesio è una varietà di marmo bianco
con sfumature cerulee e venature grigio-bluastre, tra le
più utilizzate nell’impero romano. Le cave si trovavano
nell’isola del Proconneso, gr. Prokonnesos, nel mar di
Marmara. Questo marmo è ampiamente attestato nella
produzione statuaria siciliana nel periodo romano.
Fig. 5 – Ingresso cappella della Fico con medaglione in
marmo con il volto della Madonna.
Fig. 6 – Cerimonia per la collocazione della statua sul pilone.
Alla base di esso si nota l’altro pezzo della statua.
5
che la parte posata sul pilastro è rimasta tale
da allora. Arriva a superare di poco la metà
femorale, circa m 1,00. L’altro pezzo appare
appoggiato ai piedi del pilone, considerando
l’altezza complessiva fornitaci (m.1,70),
deduciamo che poteva misurare non più di cm
0,70. Non ci è dovuto sapere quale sia stato il
motivo o la scelta di lasciare separati i due
frammenti, possiamo pensare a difficoltà
tecniche di assemblaggio o a altre valutazioni
di merito della sovrintendenza del tempo.
Sulla tipologia del marmo utilizzato
dallo sconosciuto scultore, viene presa in
considerazione la roccia metamorfica
chiamata pentelico, ma quel “a quanto
pare”39
enuncia un’espressione che fa
pensare all’incertezza della scelta o quanto
meno alla mancanza di verificabilità da
parte dell’archeologo. Infatti, proseguendo
nella sua nota, scrive che «La statua merita
uno studio più diffuso, da farsi in altra
sede».40
Fatto non avvenuto, infatti di essa
39
Ivi, p. 253. 40
Ivi, p. 253.
non risultano ad oggi saggi, approfon-
dimenti, schizzi o quant’altro.
«Il marmo pentelico detto cipolla, o
cipollino statuario bianco che tende un poco
al giallognolo, con poco discernibili vene
verdastre derivanti dal talco, e di grana
simile al lumense»;41
è ampiamente attestato
nella produzione architettonica e statuaria in
età romana. Nella capitale venne utilizzato
per l’edificazione di imponenti strutture
come: il tempio di Giove Ottimo Massimo
sul Campidoglio; il fornice in opera
quadrata dell’arco di Tito. Riguardo le
opere scultoree ricordiamo la Igea esposta
nei musei Capitolini; il Sofocle del
Laterano, una statua togata, probabile
membro della famiglia imperiale, ritrovata
nel 2014 al parco rudiae a Lecce.
L’osservazione, per quello che ci è
consentito, pur non de visu, della
disposizione delle masse e delle pieghe
delle vesti, sulla porzione rimanente
dell’opera, fa pensare che il soggetto sia un
personaggio maschile da ascrivere a quelli
di alto rango poiché indossa la t ŏ g a42
e il
41
F. BELLI, Catalogo della collezione di pietre usate
dagli antichi per costruire e adornare le loro
fabbriche, ed. Mugnoz, Roma, 1842, pp. 15-16. 42
Il termine tŏga, ‘coperta’ in senso generico ‘veste’,
proviene dal verbo latino tĕgo, is, teϰi, tectum, tegĕre,
‘coprire, ricoprire, riparare, proteggere’. L. CASTIGLIONI –
S. MARIOTTI, Op. Cit.. Era il principale vestimento esterno
dei romani, costituito da lana bianca, formava l’abito
nazionale ed era distintivo di questo popolo. Esso
consisteva in un pezzo di panno semirotondo, ampio e
ondeggiante, si indossava in modo che il braccio sinistro
vi si riposava come su una fascia.
Fig. 7 – Statua togata proveniente dal Ginnasio Romano di
Siracusa.
Fig. 8 – Il Sofocle. Fig. 9 – Il Sacerdote.
6
p a l l ĭ u m ,43
che lo avvolgono. Presumiamo,
per quanto sopra esposto, che tale risultanza
scultorea sia un lavoro affidato a qualche
bottega italica, richiamante una iconografia e
stile della società romana più antica che
utilizza la posizione statica e frontale del
togato della tradizione scultorea onoraria e
funeraria.
L’Opera, in quanto tale, doveva soddisfare
per maggiore efficacia comunicativa un
pubblico meno colto, lontano dai contesti
urbani. Una mostranza figurativa che richiama
un genere conosciuto del fine Repubblica, inizio
Impero; e ne possiamo congetturare le movenze
scultoree paragonandoli ad altre. A parte il
Sofocle del Laterano, un raffronto può essere
fatto con il sacerdote di Serapide ritenuto fino a
qualche anno fa la raffigurazione di Giuliano
l’apostata (a. 120-130 d.C.) e localmente con
una statua del ginnasio romano di Siracusa. Le
prime due statue hanno in comune, con il
manufatto in questione, anche la tipologia del
marmo, insieme alle altre condividono la
postura somigliante dei personaggi, per la
plasticità degli atteggiamenti e delle posizioni.
In esse gli arti superiori sinistri sono avvolti dal
pallio, poggiano sul petto con la mano che
porge la piegatura,[Fig. 8-9] quelli destri invece
sono liberi ma sempre coperti dal panneggio,
sono: ora rivolta indietro nascosta; [Fig. 8] ora
distesa con l’avambraccio in avanti tenendo tra
le dita un volūmĕn ‘rotolo’ di papiro o di
pergamena. [Fig. 9]
Riguardo le gambe appaiono: quella di
sinistra, in posizione avanzata e portante, si
appoggia ad un puntello laterale a forma di
tronco d’albero o di colonna; quella di destra
è ripiegata leggermente all’indietro in
posizione di scarico.
Mancando un indagine accurata di
laboratorio non è possibile stabilire se vi sono
ad esempio tracce di pigmentazione presenti
soprattutto nei canali delle pieghe del
panneggio o in altre zone della scultura.
43
Il p a l l ĭ u m ‘pallio, mantello’ Ivi, p. 1026; era
un’altra parte di vestiario sempre ad uso romano,
consisteva in un ampio lenzuolo o coperta di lana a
forma quadrata, fissata intorno al colloo sulle spalle
con una fibbia. Tale sopravveste fu usata soprattutto
dagli oratori e da filosofi.
3. Note conclusive.
Fino alla fine degli anni ’50 della statua
non si hanno notizie. Negli anni ’60 la
ritroviamo collocata, privata del pezzo non in
opera, che non si sa che fine abbia fatto, su un
ripiano piramidale piastrellato con basole
cementizie per adornare il piazzale d’ingresso
dello Stabilimento Montecatini ‘La Torre’,
costruito nelle contrade di: Fondo Fico,
Pezzagrande, Petraro; aree adiacenti alla
contrada San Francesco dove persiste la
portineria Sud della zona industriale.
Nei giorni festivi, la piazzetta diventava
un luogo di ritrovo e di passeggio di intere
famiglie.
Il piazzale in cui era stata collocata la
statua, venne in seguito smantellato per
impiantare l’attuale area di stoccaggio
nominata SG14.
Durante la successiva fase di costruzione
dello stabilimento Sincat o Montedison e
chiusura di quello Montecatini della Torre, la
Fig. 11 – Il piazzale luogo di ritrovo e di visita della statua.
Fig. 10 – La statua collocata nel piazzale dello stabilimento
‘La Torre’.
7
stessa statua venne ancora una volta spostata e
risistemata all’interno dell’area industriale nel
piazzale d’ingresso della nuova Direzione
Montedipe presso la portineria centrale.
Fino a un lustro fa personalmente ricordo che
stava posizionata ancora sul posto succitato.
Da recentissimi comunicazioni verbali sembra
che sia ancora allocata sempre allo stesso
posto.
Sarebbe auspicabile ed opportuno
individuare la rimanenze dell’opera e pensare
ad un suo eventuale restauro conservativo,
così da poter riconsiderare ad una sua
ricollocazione in sede più confacente, in
modo di dare la possibilità agli esperti di
studiarla e contestualmente farla ammirare da
tutti coloro che amano l’arte e la storia delle
nostre origini.
Melilli, 14 aprile 2015
© Sebastiano Lanteri
Fig. 12 – La statua posizionata all’interno dell’attuale area
industriale.