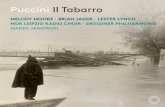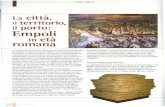Antonio Scarpa y su obra Saggio di osservazioni e d'esperienze sulle principali malattie degli occhi
«Purgar con gli occhi il fallo della lingua». Eloquenza visuale delle Lacrime di san Pietro, in...
Transcript of «Purgar con gli occhi il fallo della lingua». Eloquenza visuale delle Lacrime di san Pietro, in...
andrEa torrE
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA». eloQuenzA vISuAle delle LAGRIME DI SAn PIETRo
Attraverso le mie lacrime, io racconto una storia, do vita a un mito del dolore e da quel momento mi uniformo ad esso; posso vivere con il dolore perché, piangendo, mi do un interlocutore empatico che riceve il messaggio ‘più vero’: quello del mio corpo e non già quello della mia lingua.
r. Barthes
Il carattere intrinsecamente dialettico del nesso parola/immagine – l’opporsi dei suoi componenti e nel contempo il loro incorporarsi – è il presupposto da cui William J. T. mitchell muove per avventurarsi in quel territorio dell’ine-narrabile e dell’inimmaginabile rappresentato dalle testimonianze visive delle torture di Abu Ghraib. l’analisi di mitchell si sofferma principalmente sulla famosa figura conosciuta come hooded man: un uomo incappucciato, costretto in precario equilibrio su una scatola di razioni militari, con fili elettrici collegati a mani e genitali. A colpire lo studioso statunitense è l’affinità di questa dram-matica iconografia con un «intero repertorio di immagini cristiane dell’Inqui-sizione e (…) di immagini votive della Passione di cristo»:
Più precisamente, l’immagine evoca e fonde tre distinti momenti dell’immaginario della Passione: 1. la derisione di cristo, che spesso appare bendato perché l’identità dei suoi torturatori gli rimanga nascosta; 2. l’Ecce Homo, in cui il cristo torturato è esposto in pubblico con una finta corona, qualche volta su un piedistallo; 3. l’uomo di dolori, in cui il corpo apparentemente semi-cosciente del cristo morto è ritratto quasi nella stessa posizione, braccia aperte a ore quattro e ore otto1.
1 W. J. T. mitchell, L’inenarrabile e l’inimmaginabile. Parola e immagine ai tempi del terrore [2005], trad. it. di A. l. carbone e F. mazzara, in Id., Pictorial turn. Saggi di cultura visuale, a cura di m. cometa, Palermo, duepunti edizioni, 2008, pp. 163-185: 181. commentando le osservazioni di mitchell, michele cometa ha aggiunto «un ulteriore riferimento visivo che concorre ad ispessi-re la semantica dell’hooded man. (…) un altro exemplum doloris che ha determinato l’immaginario
AndreA Torre324
Secondo mitchell, la subliminale evocazione (lui parla di ‘clonazione’) della più importante icona votiva della cristianità assolve la funzione di tradurre scenari indicibili in una forma eloquente e immediata, e contribuisce a spiegare la vasta comprensione empatica che ha fatto di quest’immagine il controverso, apocalittico simbolo della guerra americana al terrore:
È la magia della tradizionale immagine religiosa dell’iconografia cristiana, che inco-raggia la contemplazione prolungata di un’immagine, e non semplicemente la ‘lettura’ rapida che attribuisce alla figura un nome proprio e la colloca all’interno di un tessuto narrativo. l’immagine votiva richiede atti d’immaginazione simpatetica che incorag-giano l’identificazione con la figura rappresentata2.
Il tempo lungo di lettura richiesto dalle immagini sacre dipende dalla densa e stratificata memoria visiva, testuale e liturgica che esse veicolano per rappre-sentazione diretta o in forma simbolica. Il medesimo tempo lungo è richiesto anche dalle numerose e diversificate esperienze cinque-secentesche di letteratura religiosa che vivono – più o meno esplicitamente, più o meno contiguamente, più o meno materialmente – sul fertile dialogo tra codice testuale e codice iconico. la poesia sacra, le prediche pubbliche e le private meditazioni mirano spesso a tradursi in una immagine mentale, così come possono talvolta riflettersi in una illustrazione reale (incisa, dipinta, disegnata, scolpita); ed entrambe, queste forme di rappresentazione, a loro volta possono divenire veicolo di preghiera meditativa e fonte per nuovi saggi di arte, oratoria e poesia sacra. nell’affrontare queste opere devozionali – spesso connotate dalla serialità di una letteratura di consumo – il fulcro dell’analisi potrebbe dunque collocarsi in quel territorio di confine che si fonda da una parte sul tessuto non-verbale che attraversa il testo (l’immagine che esso lascia trasparire) e dall’altra sull’inestricabile rete di parole che avvolge e condiziona l’immagine (il testo che essa suggerisce allo sguardo dello spettatore/lettore)3. In questo studio non mi soffermerò propriamente su un libro sacro illu-
occidentale, il Laocoonte…». m. cometa, Iconocrash. Sul disastro delle immagini, in Cultura visuale. Paradigmi a confronto, a cura di r. coglitore, Palermo, duepunti edizioni, 2008, pp. 43-62: 56.
2 mitchell, L’inenarrabile e l’inimmaginabile, p. 182.3 cfr. F. cousinié, Poétique de l’image de dévotion. Image et méditations dans les traités illustrés
d’oraison du XVIIe siècle français, in Emblematica sacra. Rhétorique et herméneutique du discours sacré dans la littérature en images, éd. par r. dekoninck e A. Guiderdoni-Bruslé, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 83-108, in part. p. 85: «lors de la méditation, réglée par des procédures bien déterminées, les indications iconiques élémentaires de l’image gravée (une ‘image-schème’), sont intégrées dans une construction complexe où sont développés des éléments d’ordre référentiel et narratif, sémantique, expressif (affectif) et en dernier lieu pragmatique, c’est-à-dire producteurs d’effets, de relations, de transformations. cette construction iconique, verbale et signifiante réalise une nouvelle ‘image’ qui n’est pas seulement, me semble-t-il, mentale, ‘intérieure’, ou ‘spirituelle’ au sens où elle serait indé-pendante de l’image initiale. Au contraire, cette construction procède directement de l’image gravée
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 325
strato, quanto piuttosto su un poema devozionale privo di immagini: le Lagrime di san Pietro di luigi Tansillo (1510-1568). rimosso come diretto oggetto di stu-dio, il codice visivo sarà comunque presente come costante punto di vista critico sul testo, reagente attraverso cui far emergere le strategie e le finalità discorsive proprie sia del travagliato esperimento tansilliano di poesia sacra, sia della più ampia costellazione di scritture lacrimali su quello esemplate. Anzi, proprio dal più riuscito fra i testi di letteratura devozionale tardocinquecentesca che subiro-no l’influsso del poema tansilliano – le Lagrime della Beata Vergine di Torquato Tasso – prenderò l’abbrivio per l’analisi delle Lagrime di san Pietro.
Per la sua rivisitazione controriformistica del modulo medievale del Planctus Mariae, Tasso sceglie la formula narrativa dell’ecfrasi; e, come ci avverte la nota Ai lettori della princeps del 1593, decide di illustrare il cordoglio estremo di maria di fronte alla Passione del figlio attraverso la descrizione di
un’imagine di nostra donna in pittura, che dall’illustrissimo e reverendissimo signor cinzio Aldobrandini (…) viene con molta riverenza tenuta nella sua propria camera; la quale (…) mostra avere quei suoi santi occhi sì vivamente pregni di pianto, e tiene quelle guance sue benedette rigate di tanto vere lagrime, che, l’altrui vista ingannando, invita a rasciugargliene ogni pia mano4.
Per quanto sintetica e tutta costruita intorno al topico encomio del «dotto ed esperto artefice», questa avvertenza editoriale presenta numerosi elementi d’interesse che ne giustificano il ruolo di soglia strategica del poemetto tassiano. la protagonista unica del racconto poetico che si andrà dipanando viene infatti presentata come un’immagine artefatta, che appartiene ai domìni dell’interiori-tà, e che per la sua perfezione appare così viva e sincera da suscitare una reazione di compassione in chi la mira. I lettori delle Lagrime sono dunque avvisati. Il testo tassiano, che a breve si dispiegherà davanti agli occhi, consentirà loro di dar forma nella mente a una riproduzione che di quell’icona conserva tutto il valore e rivela tutte le funzionalità. così puntualmente accade. dopo che nelle
(l’image-schème) et reste en relation étroite avec elle. elle en est une sorte d’amplification, au sens rhétorique du terme, elle constitue un ‘tiers terme’, une forme de ‘méta-image’, entre l’image-schème et le texte du traité, résultant de leur interaction et de leur prise en charge par l’esprit du fidèle».
4 T. Tasso, Le lagrime della Beata Vergine, in Id., opere, a cura di B. maier, milano, rizzoli, 1964, vol. Iv, pp. 411-418: 411 (corsivi miei). Su quest’opera tassiana si vedano: G. Santarelli, Studi sulle Rime sacre del Tasso, Bergamo, centro Tassiano, 1974, pp. 226-235; G. Getto, Malinconia di Torquato Tasso, napoli, liguori, 1979, pp. 310-312; S. ussia, Fra le ultime fatiche del Tasso: le lagrime della vergine e le lagrime di christo, in Torquato Tasso. Cultura e poesia. Atti del conve-gno (Torino-Vercelli 11-13 marzo 1996), a cura di m. masoero, Torino, Paravia Scriptorium, 1997, pp. 121-131. una lettura attenta alla dimensione visuale del testo ci è offerta da m. Treherne, Pictorial Space and Sacred Time: Tasso’s lagrime della Beata vergine and the Experience of Religious Art in the Counter-Reformation, «Italian studies», lII (2007), 1, pp. 5-25.
AndreA Torre326
stanze iniziali assistiamo al riverberarsi del pianto della vergine in quello di tutti gli elementi della natura, all’ottava 5 lo sguardo del poeta si focalizza su maria. Il suo lagrimoso canto diviene un’invocazione affinché la vergine doni le proprie lagrime agli occhi degli uomini, e lo faccia attraverso un atto di svuotamento e trasfusione, ossia stabilendo un canale lacrimale di comunicazione che consenta ai riceventi (l’«alma devota») di innalzarsi «agli stellanti chiostri»:
Tu, regina del ciel, ch’ a noi ti mostri umida i lumi e l’una e l’altra gota, fa di lagrime dono a gli occhi nostri, ed ambe l’urne in lor trasfondi e vota, perché, piangendo, a gli stellanti chiostriteco inalzi il pensier l’alma devota; parte del Tebro in su la verde riva il tuo santo dolor formi e descriva5.
la concezione del pianto come ‘dono’ – dono di dio all’uomo e, al contem-po, tributo dell’uomo a dio – ha la sua origine nella cultura monastica e gode di una duratura fortuna, testimoniataci anche dalla più puntuale trattazione teologica del topos lacrimale nell’età della tarda controriforma, il De gemitu columbae, sive De bono lacrimarum del gesuita roberto Bellarmino6. ma cos’è che viene donato? Qual è il contenuto delle lacrime sacre di maria? Tasso lo rivela tra le ottave 5 e 15 attraverso l’impiego quasi esclusivo di predicati appartenenti allo stesso campo semantico. Si tratta dei ricordi; dei ricordi di una madre che ripercorre per istantanee la vita del proprio figlio, e si sofferma in meditazione sui momenti esiziali di questa vita. le gioie e i travagli della natività, dunque: «e prima le sovvien ch’il nobil pondo | senza fatiche espose e senza duolo» (9, 1-2); «Rimembra l’umil cuna e i rozzi panni | (…) | e ’l sospetto d’erode e i primi affanni» (10, 1 e 5). A seguire, il dolore estremo della Passione (11, 1-2: «Poscia il perduto suo figliuol le riede | a mente, e quel dolor ch’alora aprilla», con l’enjambement che letteralmente apre il ricordo doloroso). Questo
5 Tasso, Le lagrime della Beata Vergine, ott. v, pp. 412-413 (corsivi miei).6 r. Bellarmino, De gemitu columbae, sive De bono lacrimarum [1617], a cura di G. Galeota
S.J., Brescia, morcelliana, 1997, praef., pp. 32-34: «Sunt autem duo genera piarum lacrimarum: aliae enim sunt signa odii, aliae dilectionis, aliae doloris, aliae gaudii. lacrimae contritionis sunt signa odii erga peccatum, lacrimae desiderii videndi deum sunt signa amoris: et priores sunt signa doloris, posteriores signa dilectionis. (…) Siquidem lacrimae significantes odium et dolorem a fontibus abyssi scaturiunt, lacrimae amoris et laetitiae de caelo descendunt: omnes a deo manant. Quamvis autem lacrimae istae dona sint dei, non ideo tamen exspectare debemus, ut nobis dormientibus et nihil agentibus dentur. (…) Itaque petendum est donum lacrimarum magna cum fiducia et cum minore desiderio (…)».
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 327
dolore viene prima rivissuto nel tempo lungo della sua ritualità, di una ritualità liturgica che quasi riproduce interiorizzato il percorso della via crucis (ott. 12):
A la colonna il pensa, e stille a prova ella versa di pianto, egli di sangue; e imaginando il suo martir rinova martir de l’alma che s’afflige e langue. Pensa poi come in croce estinto ei giova, anzi vita ne dà: mirabil angue, ch’unge del nostro error l’antica piaga; così pensando, in lagrimar s’appaga7.
ed è poi condensato in un’immagine di sintesi, esaustiva, conclusiva nella sua drammatica eloquenza: «Sembra poi ch’il pensiero al dì rivolga | che l’ebbe essangue, anzi sanguigno in seno | con mille piaghe; e ’n ricordar si dolga» (15, 1-3). la scioccante imago agens del compianto occupa peraltro la mente della vergine già all’ottava 7 e attiva in lei la medesima risposta emotiva e intellettua-le, giocata interamente sull’asse percezione-memoria:
ella medesma, che ’l crudele assaltodar vide al dolce Figlio e ’n mente il serba,e vide tinta di sanguigno smaltola lancia onde sentì la doglia acerba,lucido il mirò poi levarsi in alto (…)8.
com’è proprio della comunicazione artistica cristiana, in specie durante la controriforma, tale memorabile imago pietatis intende suscitare un’analoga reazione in tutti i fedeli che la riproducono e contemplano interiormente. ciò è conclamato nella produzione figurativa, ma anche i testi devozionali mira-no a coinvolgere pienamente i loro lettori nella situazione rappresentata, così da intensificare in essi l’adesione al messaggio morale e dottrinario veicolato. Sintomatica in tal senso risulta la strategia gesuitica di compositio loci. come è noto, essa prescrive di accompagnare la meditazione degli insegnamenti cristiani
7 Tasso, Le lagrime della Beata Vergine, ott. XII, p. 415 (corsivi miei).8 Ibidem, ott. vII, vv. 1-5, p. 413 (corsivi miei). cfr. a proposito e. Ardissino, «L’aspra
tragedia». Poesia e sacro in Torquato Tasso, Firenze, leo S. olschki, 1996, p. 164: «nonostante la generosità del suo dono, ora è lasciata, come ogni essere umano, alla sua miseria terrena, al doloroso esilio. l’eclisse del Figlio, che d’altra parte ha sofferto, come “servo”, la sua parte di dolore, rende la vergine una creatura fra le creature, sorella al nostro dolore. come la madonna dipinta dal caravaggio sul letto di morte è soprattutto un tragico corpo che mostra i segni della sofferenza, anche qui maria è ritratta nella solitudine del suo dolore, indebolita dal pianto, “la vista ch’amaro duolo imbruna”. le lagrime non sono catarsi ma consunzione e immagine della umanizzazione della vergine».
AndreA Torre328
con una ricreazione memoriale, attraverso i sensi, degli episodi sacri; o meglio, con l’applicazione dei sensi esterni alle realtà spirituali sopra cui è stata condot-ta la meditazione; e tutto ciò al fine di trasferire l’unità e il dialogo tra sensi e intelletto dal piano comune della realtà fenomenica – potenzialmente sempre traviante – a quello intimo dell’interiorità spirituale, attraverso un profondo movimento psicofisico di trasposizione (traduzione e dislocazione) dell’oggetti-vità nella soggettività. In questa dimensione i sensi non necessitano infatti di un elemento esterno per funzionare ma si rapportano esclusivamente alla materia memoriale meditata, e solo in relazione ad essa trovano una ragion d’essere9. In una siffatta pratica di costruzione dell’interiorità le lacrime costituiscono un segno visibile della sincerità e dell’efficacia della meditazione:
2o preambolo. Il secondo consiste nel chiedere a dio nostro Signore ciò che voglio e desidero. b. la richiesta deve essere conforme alla materia che si sta trattando; e cioè se la contemplazione è sulla risurrezione, sarà chiedere gioia con cristo gioioso, se è sulla passione, sarà chiedere dolore, lacrime e sofferenza con cristo sofferente10.
la strategica ambiguità che articola la sintassi dell’ott. 8 conferma, e quasi dichiara, un analogo intento comunicativo:
or tutta in sé raccolta, al fin rimembra quanti per lui sofferse aspri martiri dal dì ch’ egli vestì l’umane membra, e quante sparse lagrime e sospiri, e ’n questo suo pensiero altrui rassembra freddo smalto ch’umor distilli e spiri: ben mostra a noi quel che contempli e pensi chi la dipinse e colorilla a’ sensi11.
oltre alla sede rimica, il predicato «rimembra» potrebbe infatti, senza grandi forzature logiche, condividere col verbo «rassembra» anche la forma
9 cfr. G. laynez, Trattato sulle imagini sacre [metà XvI sec.], roma, Archivum romanum Societatis Iesu, ms. opp. nn. 209, f. 354r: «È licito, come di sopra è mostrato, in presenza della imagine et guardando verso quella, ricordarsi della cosa rappresentata et conoscerla et imitarla. Sarà dunque licito in presenza di quella et verso quella adorarla perché non c’è ragione alcuna per la quale la presenza della imagine abbia a impedire più l’adoratione che la ricordatione o imitatio-ne, essendo l’imitare e l’adorare frutti della ricordatione». Sullo statuto e le funzioni dell’imma-gine presso i Gesuiti si vedano: l. Salviucci Insolera, L’uso di immagini come strumento didattico-catechistico nella Compagnia di Gesù, in I Gesuiti e la Ratio Studiorum, a cura di m. Hinz – r. righi – d. zardin, roma, Bulzoni, 2004, pp. 191-210; r. dekoninck, Ad imaginem: statuts, fonctions et usages de l’image dans la littérature spirituelle jésuite du XVIIe siècle, Genève, droz, 2005.
10 I. di loyola, Esercizi spirituali [1548], 48b, a cura di P. Schiavone, milano, San Paolo, 1988, p. 74.
11 Tasso, Le lagrime della Beata Vergine, ott. vIII, p. 413 (corsivi miei).
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 329
intransitiva e il nesso col termine «altrui». ossia, l’immagine di maria delineata da Tasso non solo potrebbe sembrare, a chiunque la guardi, simile a una statua viva ma, proprio in ragione di tale vivida e condivisibile sofferenza, potrebbe suscitare in chiunque la contempli il ricordo esemplare di tutti i martiri cristia-ni. Allo stesso modo, i vv. 7-8 («ben mostra a noi che contempli e pensi | chi la dipinse e colorilla a’ sensi») si prestano a due differenti parafrasi, e sovrappon-gono due messaggi fra loro complementari:
1. ‘chi la dipinse con sì potente naturalismo e vividezza è riuscito a rivelarci ciò che la vergine stava contemplando e meditando’;
2. ‘[il dipinto appena descritto] ci rivela perfettamente ciò che stava contemplan-do e meditando colui che dipinse così realisticamente la vergine’.
così come la prima ambiguità sintattica getta luce sullo spettatore-lettore (l’indeterminato «altrui») in quanto destinatario ideale dell’opera d’arte (figura-tiva o letteraria che sia); allo stesso modo, la seconda ambiguità sintattica pone sulla ribalta del testo l’autore dell’opera d’arte (figurativa o letteraria che sia), il mirabile artefice post-tridentino che attraverso l’immagine della vergine ha dato corpo ai propri pensieri e sentimenti. Se poi saltiamo all’ott. 18, vediamo però che questo mirabile artefice può configurarsi anche come un «interno pit-tor» che dipinge «nel cor, che di suo spirto è vivo tempio»12. ossia, il mirabile artefice può essere l’immaginazione di chiunque osservi dipinti sacri o legga testi devozionali, di chiunque ne sappia visualizzare i contenuti nell’interiorità («nella sua propria camera») in modo tale da avvertirne sensibilmente la forza, comprenderne con prontezza il senso, e conservarne per sempre attivo il ricordo. le dinamiche psico-fisiologiche di tale esperienza retorica – che dall’Ars poetica di orazio al finale di Blade Runner costituisce anch’essa un fortunato topos espressivo – sono ora state illustrate dagli studi di neurologia dell’emozione, con-dotti da Antonio damasio ad esempio, studi che insistono sul fatto che i ricordi vengono marcati emotivamente, e in ragione di ciò riescono sempre a innescare le stesse reazioni fisiologiche scatenate dagli eventi originari; sicché ogni volta che piangiamo per un episodio del passato, ciò avviene perché il ricordo di tale episodio è marcato dalle lacrime, e piangendo lo marchiamo nuovamente13. le
12 Ibidem, ott. XvIII, pp. 416-417.13 cfr. A. damasio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano [1996], trad. it.
di F. macaluso, milano, Adelphi, 1995. da questo punto di vista risulta importante anche il dia-logo tra sapere umanistico e sapere scientifico, concretizzatosi in quegli studi sulla visione, sulla percezione e sull’empatia, che hanno saputo fondere le metodologie offerte dalla storia dell’arte con i risultati delle recenti scoperte neuroscientifiche (si veda, ad esempio, d. Freedberg – v. Gallese, Empathy, Motion, Emotion in Aesthetic Experience, «Trends in cognitive Sciences», XI
AndreA Torre330
Lagrime della Beata Vergine paiono dunque mostrarci non solo la situazione topi-ca di un personaggio-chiave del vangelo còlto nell’istante del pianto, alla luce di un progetto emulativo che rende il lettore partecipe del suo dolore. esse ci illustrano anche la procedura che dovrebbe regolare la fruizione di questo testo verbale di devozione, così come quella dei suoi analoghi iconici. come ha infatti mostrato John Shearman nelle sue indagini sulla necessaria (per la compiutezza e il funzionamento dell’opera d’arte) relazione di transitività che si instaura fra lo spazio dipinto e quello reale (più specificamente, quello liminale al quadro),
la posizione dello spettatore si immagina ridefinita, psicologicamente e nello spazio, dal suo volontario coinvolgimento nell’opera d’arte. la presenza attiva dello spettatore è un predicato dell’atteggiamento di tutte le figure, di quelle dei santi in modo più accentuato, di quella del Bambin Gesù in modo più diretto. Il dipinto non dà senso se lo spettatore o la spettatrice non vengono compresi nel suo funzionamento. dove lo spazio reale incon-tra quello del quadro, non c’è né una barriera visiva né una barriera psicologica14.
laddove l’assenza di tali barriere è addirittura sostanziale, come nel caso di un’immagine mentale evocata da un testo devozionale, la composizione verbale di immagini contemplerà naturalmente il coinvolgimento del lettore (devoto) nel funzionamento retorico del testo, nonché la piena consapevolezza (e l’inten-zione strategica) dell’autore nell’attivare tale coinvolgimento. A maggior ragione dunque, di fronte a questa tipologia di immagini verbali, dovremmo chiederci «che cosa si suppone stia avendo luogo, in termini realistici, narrativi, funzio-nali o comportamentali»15.
mi sono soffermato su questi aspetti del poemetto tassiano, perché a mio avviso essi costituiscono un ulteriore livello di intertestualità con le Lagrime di san Pietro16. un’intertestualità che, negli snodi fondamentali della narrazione, si fonda sul comune ricorso al codice visivo. un’intertestualità che in Tasso sembra quasi divenire esegesi, illustrazione operativa del funzionamento e delle funzionalità di un testo, come quello di Tansillo, che ha rilanciato le ‘lacrime’ come genere poetico autonomo nel quadro della letteratura di devozione17. È
[2007], 5 pp. 197-203). Sullo statuto pragmatico e performativo delle immagini, sulla loro capacità di provocare emozioni, si ricorra ovviamente a d. Freedberg, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico [1989], trad. it. di G. Perini, Torino, einaudi, 1993.
14 J. Shearman, Arte e spettatore nel Rinascimento italiano. «only connect…» [1992], trad. it. di B. Agosti, milano, Jaca Book, 1995, p. 59.
15 J. Shearman, Arte e spettatore nel Rinascimento italiano, p. 21. 16 oltre a quelli rinvenuti da m. T. Imbriani, Intertestualità tra le «Lagrime» di Luigi Tansillo
e di Torquato Tasso, «critica letteraria», 110 (2001), pp. 15-32.17 cfr. A. A. Piatti, «E l’uom pietà da Dio, piangendo, impari». Lacrime e pianto nelle rime sacre
dell’età del Tasso, in Rime sacre tra Cinquecento e Seicento, a cura di m. l. doglio e c. delcorno,
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 331
un dato di fatto che nelle Lagrime tansilliane il soggetto principale della nar-razione non viene presentato come un prodotto artistico (differentemente da quanto dichiarato sulla soglia del testo tassiano). ma è altrettanto vero che – nel poemetto del 1560 così come nei poemi dell’85 e del 1606 –18 l’esiguità rare-fatta degli accadimenti (quasi tutti gli eventi sono narrati indirettamente, come ricordi, visioni o profezie) e l’indeterminatezza con cui viene descritto l’agire dell’apostolo penitente dispiegano davanti ai nostri occhi una scena della nar-razione non molto differente da quella rinvenibile nella tradizione iconografica relativa al pianto di Pietro. Tradizione che, da Guercino a reni, da Albani a ribera, insiste su un ritratto ‘in notturno’ dell’apostolo che in lacrime «con le palme e co’l ciglio in atto di devota contemplazione» – per dirla alla Tasso – medita sul proprio vissuto. Sarà questo dunque il nucleo visuale intorno a cui, e a partire dal quale, il lettore/osservatore potrà ricostruire la storia esemplare di Pietro. Sarà questa l’imago agens in cui ogni penitente potrà rispecchiarsi, e con cui potrà attivare un canale di comunicazione lacrimale. Il senso della vista e il campo semantico-metaforico degli occhi sono infatti il contesto di riferimento per le relazioni percettive e comunicative che strutturano la vicenda, nonché per lo sviluppo dei suoi principali snodi narrativi. la mia analisi delle Lagrime si concentrerà pertanto su alcuni motivi che segnalano l’incidenza del codice visivo nella costruzione del discorso tansilliano, e insisterà sulla funzionalità performativa di questi ‘pianti d’inchiostro’, di queste «calligrafie dell’emozio-ne», secondo la suggestiva definizione con cui Jean-loup charvet – nel suo studio sulle lacrime cinque-secentesche in letteratura, pittura e musica – ci ricorda che le lacrime non si rappresentano, bensì si versano:
Si ha l’impressione che la lacrima non cesserà mai di scorrere perché non ha né origine, né fine. l’artista inventa un tipo di rappresentazione in cui la forma si umilia dinanzi alla
Bologna, il mulino, 2007, pp. 53-106, in part. p. 61: «nel poema del Tansillo (…) il rilancio di que-sto genere coincide con il suo perfezionamento formale, grazie all’acquisizione di una compiuta autonomia narrativa e tematica. Il pianto, assimilato a strumento di redenzione, è sì espressione di tormento e lacerazione, ma diviene innanzitutto indizio visibile di uno stato di turbamento inte-riore». Per un dettagliato repertorio del ‘genere delle lacrime’ si ricorra ad A. Quondam, Saggio di bibliografia della poesia religiosa (1471-1600), in Id., Paradigmi e tradizioni, roma, Bulzoni, 2005, pp. 213-282. Per una più generale storia culturale delle lacrime si vedano invece: A. vincente-Buffault, Histoire des larmes: XVIIIe-XIXe, Paris, Payot, 2001; e T. lutz, Storia delle lacrime. Aspetti naturali e culturali del pianto [1999], trad. it. a cura di G. Pannofino, milano, Feltrinelli, 2002.
18 Sulla complessa tradizione testuale del poema di Tansillo (tra esemplare manoscritto ed edizioni a stampa) si veda T. r. Toscano, note sulla composizione e la pubblicazione de «Le lagrime di San Pietro» di Luigi Tansillo (con inediti), in Rinascimento meridionale e altri studi in onore di Mario Santoro, a cura di m. c. cafisse – F. d’episcopo – v. dolla – T. Fiorino – l. miele, napoli, Società editrice napoletana, 1987, pp. 437-461.
AndreA Torre332
potenza del significato. non si rappresentano le lacrime, si versano; la loro forma fluida non resiste alla potenza debordante del loro senso, si deforma, scorre, si distende e si rompe. Forma e senso si alimentano reciprocamente fino a esaurirsi. Fino a separarsi l’un l’altro per rappresentare l’irrapresentabile, per dire ciò che non ha più forma per eccesso di senso19.
ma veniamo a Tansillo. l’improvvisa presa di coscienza dell’errore, ad esem-pio, coincide per l’apostolo Pietro col momento in cui egli incrocia lo sguardo silenzioso ma eloquente di cristo; e l’evento che ha consentito tale sconvolgente rivelazione è descritto da Tansillo mediante i moduli lirici dello specchio e della fenomenologia erotica, quali figuranti letterariamente marcati della dinamica di azione-reazione che presiede a questa esperienza di comunicazione non verbale:
ma gli archi, che nel petto gli avventarole saete più acute, e più mortaliFur gli occhi del Signor, quando il miraro;Gli occhi fur gli archi, e i guardi fur gli strali;che del cor non contenti, sen’ passaroFin dentro a l’alma, e vi fèr piaghe tali,che bisognò, mentre che visse poi,ungerle col licor de gli occhi suoi20.
Attraverso gli occhi/archi e gli sguardi/strali cristo trasferisce la propria umanità sofferente («vi fèr piaghe tali») nell’anima del peccatore-Pietro; il quale, immedesimandosi pienamente con l’‘uomo di dolori’, comincia la sua conversione nella figura esemplare del penitente-Pietro. l’eco di questa dina-mica comunicativa riverbera peraltro dal testo tansilliano alle Lacrime di Maria Maddalena di erasmo da valvasone (1586), dove la metamorfosi della donna dissoluta in persona redenta e compiutamente inserita nel progetto divino di salvezza viene anche qui innescata dall’improvviso incontro con lo sguardo faretrato di cristo (ott. 16, 5-7 e poi 18, 6-8), nonché esplicitamente declinata nel registro amoroso attraverso la citazione del motivo ovidiano e petrarchesco della trasformazione dell’amante nell’amato (ott. 39, 1-4; vd. Tavola 1)21:
19 J.-l. charvet, L’eloquenza delle lacrime [2000], trad. it. di A. carenzi, milano, edizioni medusa, 2001, p. 56; poco prima charvet aveva osservato: «l’era dell’eloquenza fu anche quella delle lacrime. Il barocco fece delle lacrime la sua retorica divina, l’eloquenza discreta della sua anima, il tenero linguaggio del suo cuore. (…) Splendide metamorfosi in cui si rinnova il fuoco mobile delle nostre passioni, le lacrime offrono all’uomo barocco un mezzo per esprimersi all’esterno del corpo attraver-so il corpo stesso, per trovare il suo termine di paragone al di fuori di esso» (cit. a pp. 25 e 35).
20 Le lagrime di S. Piero del reverendissimo Cardinal de’ Pucci, ott. 2, venezia, rampazetto, 1560, s.i.p. (corsivi miei).
21 e. da valvasone, Le lagrime di santa Maria Maddalena, in l. Tansillo, Le lagrime di S. Pietro. Con le Lagrime della Maddalena del signor Erasmo da Valvasone, di nuovo ristampate,
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 333
16, 5
-7
(…)
ma
non
sì to
sto
ha p
oi la
vis
ta in
tens
an
el g
ran
fulg
or d
i que
l div
ino
volto
che
tutt
a si
tra
smut
a (…
)
18, 6
-8
(…)
e si
sen
tio
Pass
ar p
er m
ezo
il pa
lpita
nte
seno
A fe
rir
l’alm
a il
subi
to b
alen
o.
39, 1
-4
chi
può
mai
dir
ch’
un d
esio
so a
man
te,
che
’l pe
nsie
r tu
tto
ne l’
amat
o in
tend
a,n
on c
angi
il p
rim
o su
o ve
ro s
embi
ante
,e
d’a
ltru
i for
ma
e qu
alit
à no
n pr
enda
ed. 1
560
ed. 1
585
ed. 1
606
5 Gio
vane
don
na il
suo
bel
vol
to in
spe
cchi
on
on v
ide
mai
di l
ucid
o cr
ista
lloC
ome
in q
uel p
unto
il m
iser
abil
vecc
hio
ne
gli o
cchi
del
Sig
nor
vide
il s
uo fa
llo:
né
tant
e co
se u
dir
cupi
do o
recc
hio
Pot
ria
se s
tess
e be
n se
nza
inte
rval
loIn
tent
o a
l’altr
ui d
ir c
ento
ann
i e c
ento
,Q
uant
e ei
n’u
dio
col g
uard
o in
que
l mom
ento
.
6 cos
ì tal
’hor
(ben
ché
prof
ane
cose
Sien
o a
le s
acre
d’a
ggua
glia
rse
inde
gne)
Scop
rir
mir
ando
altr
ui le
vog
lie a
scos
eSu
ole
amat
or, s
enza
ch’
a di
r le
veg
ne.
Chi
dun
que
espe
rto
sia
ne l
’ing
egno
seSc
hole
d’A
mor
, a c
hi n
o’l p
rova
, ins
egne
Com
e se
nza
apri
r bo
cca,
o s
criv
er n
ote,
Con
gli
occh
i anc
hora
fave
llar
si p
uote
.
I, 4
2M
ai v
olto
non
si v
ide
in a
lcun
spe
cchi
o,c
he s
ia d
i chi
aro,
e lu
cido
cri
stal
lo,
com
e in
que
l pun
to il
mis
erab
il ve
cchi
on
e gl
i occ
hi d
el S
igno
r vi
de il
suo
fallo
.n
é ta
nte
cose
udi
r cu
pido
ore
cchi
oP
otri
a gi
amm
ai, s
e be
n se
nza
inte
rval
loSi
ste
sse
all’a
ltrui
dir
mill
’ann
i att
ento
,Q
uant
’ei n
’udì
col
gua
rdo
in q
uel m
omen
to.
I, 5
5G
iovi
ne d
onna
il s
uo b
el v
olto
in s
pecc
hio
non
vid
e m
ai d
i luc
ido
cris
tallo
,c
ome
in q
uel p
unto
il m
iser
abil
vecc
hio
ne
gli o
cchi
del
Sig
nor
vide
il s
uo fa
llo.
né
tant
e co
se u
dir
cupi
do o
recc
hio
Pot
ria
giam
mai
, se
ben
senz
a in
terv
allo
Si s
tess
e al
l’altr
ui d
ir m
ill’a
nni i
nten
to,
Qua
nt’e
i n’u
dì c
ol g
uard
o in
que
l mom
ento
.
I, 5
6c
ome
talo
r (b
ench
é pr
ofan
e co
seSi
eno
alle
sac
re d
’agg
uagl
iars
i ind
egne
)Sc
opri
r m
iran
do a
ltrui
le v
oglie
asc
ose
Suol
e am
ator
, sen
za c
’a d
ir le
veg
ne.
chi
adu
nque
esp
erto
sia
nel
l’ing
egno
seSc
uole
d’A
mor
, a c
hi n
o’l p
rova
, ins
egne
com
e se
nz’a
prir
boc
ca, o
scr
iver
not
e,c
on g
li oc
chi a
ncor
a fa
vella
r si
puo
te.
Tavo
la 1
Tavo
la 2
AndreA Torre334
In Tansillo il sottotesto lirico profano traluce più vividamente dall’imma-gine dello specchiamento, che nel nuovo contesto sacro – come ci ricorda Beatrice rima – non risponde più «al principio fisico della dissociazione di un’immagine nello specchio vero e proprio, bensì a quello logico e associativo tendente all’identificazione e all’unione di due identità distinte, l’una rivestita di un ruolo specchiante e l’altra che vi si riflette, riconosce e identifica»22 (vd. Tavola 2).
nel nostro caso la potenza dello strumento è assoluta («non vide mai … | come in quel punto…»), e l’esito dello specchiamento è rivelatore («ne gli occhi del Signor vide il suo fallo»). ma soprattutto, l’atto di visione in quello speculum vitae che è l’imago Christi (figurativa o letteraria che sia) sembra quasi declinarsi come un’esperienza sinestesica di conoscenza che, tanto nelle moda-lità quanto nei risultati, supera ogni logica dei sensi e si disinteressa dell’auto-rità discorsiva della lingua: «né tante cose udir cupido orecchio | Potria… | Quant’ei n’udì col guardo in quel momento». l’importanza di questo passaggio testuale è confermata anche dall’attenzione che ricevette lungo l’articolata ela-borazione redazionale del poema. Alle due estremità del percorso (il poemetto in 42 ottave uscito nel 1560 a nome del cardinal Pucci, e il poema sacro in 15 canti pubblicato nel 1606 per le cure di Tommaso costo) lo specchiamento di Pietro è assimilato, nella sua assoluta incomparabilità però, a quello di una «Giovane donna», con strategica riconversione delle istanze narcisistiche attra-verso la sostituzione dello specchio esteriore (simbolo di vanitas) con lo spec-chio interiore della coscienza (simbolo di penitenza). Peraltro, all’ottava dello specchio ne segue una che, seppur con le dovute cautele («benché profane cose | Sieno alle sacre d’agguagliarsi indegne»), testimonia la riformulazione sacra in atto dell’intero apparato figurale profano, nonché la trasposizione nel nuovo contesto di strategie di reticenza allusiva ed eloquenza visuale proprie del siste-ma comunicativo del primo: «chi dunque esperto sia nell’ingegnose | Scuole d’Amor, a chi no ’l prova, insegne | come senz’aprir bocca, o scriver note, | con gli occhi ancora favellar si puote». entrambi i luoghi sono ovviamente oggetto di revisione nel poema in 13 pianti curato da Giovan Battista Attendolo nel
venezia, vincenti, 1589, p. 170r (corsivi miei). Sul motivo letterario e figurativo della maddalena si vedano: La Maddalena tra sacro e profano, a cura di m. mosco, milano, mondadori, 1986; S. ussia, Il sacro Parnaso. Il Lauro e la Croce, catanzaro, Pullano, 1993, pp. 107-140.
22 B. rima, Lo specchio e il suo enigma. Vita di un tema intorno a Tasso e Marino, Padova, Antenore, 1991, p. 76. Sullo specchio, il suo simbolismo e la sua funzione di dispositivo visuale, si vedano anche: J. Baltrusaitis, Lo specchio. Rivelazioni, inganni e science-fiction [1978], trad. it. di c. Pizzorusso, milano, Adelphi, 2007; v. I. Stoichita, L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea [1993], trad. it. di B. Sforza, milano, il Saggiatore, 2004.
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 335
158523. l’equivoca similitudine della «Giovane donna» è sostituita da una for-mula impersonale che nella negazione di ogni comparazione esalta l’assolutezza del contatto visivo tra Pietro e cristo («mai volto non si vide in alcun spec-chio»). la successiva ottava, di sapore metaletterario, viene invece eliminata, proprio perché nel nuovo poema della controriforma è indegno anche solo ipotizzare di ‘agguagliare’ le «profane cose (…) alle sacre». Quest’ultimo inter-vento è peraltro rinvenibile anche in un documento precedente, che andrebbe inserito nella travagliata vita delle Lagrime. Si tratta delle Rime spirituali nelle quali si contengono le pietose Lagrime che fece san Pietro dopo l’aver negato il suo Signore, poste in luce nel 1577 da cristoforo Scanello (il «cieco da Forlì»), poeta-cantastorie fra i più attivi in quell’esperienza di poesia devozionale che, soprattutto attraverso il medium della stampa popolare, la controriforma pro-muoverà strategicamente, per arginare la diffusione delle istanze eterodosse e per rinsaldare il consenso delle classi subalterne24. Tranne che per l’omissione dell’ottava, il testo che Scanello fa proprio ripropone con minime varianti (ma uniformemente distribuite) quello dell’edizione rampazetto 1560, ivi compresa la similitudine della «Giovane donna».
23 Le lagrime di san Pietro del signor Luigi Tansillo da nola. Mandate in luce da Giovan Battista Attendolo da Capua, vico equense, cacchi e cappello, 1585. cfr. Toscano, note sulla composizione e la pubblicazione de «Le lagrime di San Pietro», pp. 442-443: «merita qualche con-siderazione il fatto che l’edizione del 1585 rappresenta il primo risultato tangibile, perseguito collettivamente dalle istituzioni religiose e civili di nola, di una strategia mirante a riutilizzare in chiave edificante l’intera produzione poetica di luigi Tansillo a “servigio e gloria di dio; utile delle anime di coloro che la leggeranno; et honore di nola”. (…) alla revisione ecclesiastica fu sottoposto [da Giovan Battista Attendolo] il poema già scorciato in tredici pianti e privo di buona parte delle “presso a quattrocento bellissime stanze” che saranno ripristinate nell’edi-zione veneziana del Barezzi [quella del 1606 curata da Tommaso Costo sulla scorta dell’odierno manoscritto XIII.C.84 della Biblioteca nazionale di napoli]».
24 Rime spirituali nelle quali si contengono le pietose Lagrime che fece san Pietro dopo l’aver negato il suo Signore. Con dui Sonetti, uno dell’Incarnatione, e l’altro della Passione di Christo. nuovamente poste in luce, per Christoforo Cieco da Forlì, Fermo, Astolfo de’ Grandi, 1577. la conclusiva formula editoriale («nuovamente poste…») sembra consapevolmente giocare sull’am-biguità del statuto di Scannello (autore? curatore?) rispetto all’opera. È comunque questa una modalità caratteristica della produzione editoriale di letteratura popolare a stampo devozionale fiorente nel periodo, sulla quale si vedano: A. cioni, La bibliografia della poesia popolare dei secoli XIII e XVI, vol I: La poesia religiosa, Firenze, Sansoni, 1963; l. Baldacchini, Bibliografia delle stampe popolari religiose del XVI-XVII secolo. Biblioteche Vaticana, Alessandrina, Estense, Firenze, leo S. olschki, 1980; A. Jacobsen Schutte, Printed Italian Vernacular Religious Books 1465-1550: a Finding List, Genève, droz, 1983; S. ussia, Le Muse sacre. Poesia religiosa dei secoli XVI e XVII, Borgomanero, Fondazione Achille marazza, 1999. Su cristoforo Scannello abbia-mo invece solo il datato studio (corredato da una ricca antologia di testi) di A. Pasini, Vita e scritti di Cristoforo Scanello detto “Il cieco da Forlì”, Forlì, Pietro valbonesi, 1937.
AndreA Torre336
Intorno al motivo dello specchio si costruisce anche una famosa canzone tansilliana, «Amor, ch’alberghi e vivi nel mio petto». Qui lo specchiamento si realizza con la poesia, che neoplatonicamente riflette e manifesta la bellezza nascosta nell’anima del poeta: «sian queste rime specchi | de l’alma; onde s’av-vien ch’altri l’intenda, | il bel, che dentro asconde, fuor risplenda» (vv. 11-13)25. Questo indizio può forse suggerirci un’ulteriore funzione riconoscibile al topos dello specchiamento nella generale economia comunicativa delle Lagrime: la funzione, già incontrata in Tasso, che presiede a un’identificazione tra la figura autoriale e quella del suo eroe penitente, nonché all’estensibilità di tale identi-ficazione ad ogni sguardo esterno al testo ma ad esso rivolto, cioè ad ogni let-tore. ossia, questo indizio insieme ad altri – rinvenibili sempre nel corpus lirico tansilliano e in particolare nella sezione delle rime religiose – sembra rinviare a una sovrapponibilità tra la voce narrante e la figura penitenziale del prota-gonista. A mio avviso però, le implicazioni di tale sovrapposizione non sono d’ordine biografico ma rispondono a una spendibilità pragmatico-performativa, sintetizzandosi in un verso chiastico come quello che suggella l’ottava incipita-ria della sola edizione costo («Piango le colpe mie col pianto altrui») non tanto le aspirazioni individuali di chi vuol riabilitare un passato di scritture licen-ziose, quanto piuttosto l’adesione – vedremo quanto mai problematica – a un più generale e collettivo progetto culturale di ridefinizione psichico-identitaria della vita attraverso la commozione degli affetti. un progetto perseguito in tutti quei teatri delle passioni edificati dal cristianesimo a beneficio del disciplina-mento spirituale del religioso e come ausilio all’indottrinamento dei fedeli:
le lagrime, i sospiri e le querele,che da gli occhi e dal petto uscìr di Piero,dappoi che al suo Signor poco fedeleS’avvide essersi mostro, e troppo fiero,Io narro, acciò che’l mio fallir crudelePiù sovente mi rieda nel pensiero;e rimembrando quel ch’io sempre fui,Piango le colpe mie col pianto altrui26.
25 l. Tansillo, Il canzoniere edito e inedito, secondo una copia dell’autografo ed altri manoscrit-ti e stampe. Con introduzione e note di Erasmo Pèrcopo, a cura di T. r. Toscano, napoli, liguori, 1996, vol. I (Poesie amorose, pastorali e pescatorie, personali, famigliari e religiose), p. 68.
26 Le lagrime di San Pietro del sig. Luigi Tansillo, cavate dal suo proprio originale. Poema Sacro, et Heroico, in cui si narrano i Lamenti, i Dolori, et le Astinenze di Pietro, il quale ci è figura di un vero, e divoto Penitente. Con gli Argomenti, et Allegorie della Signora Lucretia Marinella, et con un Discorso nel fine del sig. Tommaso Costo, canto I, ottava 1, venezia, Barezzi, 1606, p. 3 (corsivi miei).
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 337
ed. 1
560
ed. 1
585
ed. 1
606
33, 5
-8(…
)M
a vi
sto
de’ s
uoi p
iè s
tam
pato
il s
uolo
,Tr
oppo
inte
nso
dolo
r l’a
lma
gli p
rem
e;H
or le
voc
i, ho
r le
lagr
ime
radd
oppi
a,e
d’ir
a qu
asi,
e di
cor
dogl
io s
copp
ia
34 com
e gl
i fos
ser
tron
che
ambe
le p
iant
e,l
asci
ando
si c
ader
col
vol
to in
giu
so,
A b
agna
r co
min
ciò
quel
l’orm
e sa
nte
le
quai
ben
con
osce
a gi
à pe
r lu
ngo
uso:
Ben
ché
senz
a us
o fr
a ta
nte
orm
e e
tant
e,c
he ’l
cal
cato
terr
en a
vean
con
fuso
L’or
me
scer
ner
pote
a de
l suo
Sig
nore
,C
he p
utia
n l’a
ltre
, e q
uelle
ave
ano
odor
e.
36, 1
orm
e od
orat
e, e
da
quel
pie
de im
pres
se
II, 3
, 5-8
(…)
ma
vist
o de
’ suo
i piè
sta
mpa
to il
suo
lo,
Trop
po g
rave
dol
or l’
alm
a li
prem
e;H
or le
voc
i, ho
r le
lagr
ime
rado
ppia
,e
d’ir
a qu
asi,
e di
cor
dogl
io s
copp
ia.
II, 5
, 1o
rme
felic
i, e
da q
uel p
iè s
tam
pate
III,
7, 5
-8(…
)m
a vi
sto
da’ s
uoi p
iè s
tam
pato
il s
uolo
,Tr
oppo
gra
ve d
olor
l’al
ma
li pr
eme;
or
le v
oci,
or le
lagr
ime
radd
oppi
a,e
d’ir
a qu
asi,
e di
cor
dogl
io s
copp
ia.
III,
8c
ome
gli f
osse
r tr
onch
e am
be le
pia
nte,
las
cian
dosi
cad
er c
ol v
olto
in g
iuso
,A
bac
iar
com
inci
ò qu
ell’o
rme
sant
el
e qu
ai b
en c
onos
ceva
per
lung
o us
oB
ench
é se
nz’u
so, f
ra ta
nte
orm
e, e
tant
e,c
he ’l
cal
cato
terr
en a
vea
conf
uso,
Al fi
ero
assa
lto d
ella
turb
a re
a,Q
uelle
del
buo
n G
esù
scer
ner
pote
a.
III,
9c
hé, q
ual s
agac
e ca
n, s
ente
all’
odor
ed
ove
nem
ica
fera
il te
rren
pre
sse,
e s
e di
vis
ta p
erde
il s
uo S
igno
re,
Trov
alo
all’o
rme
dal s
uo p
iede
impr
esse
,c
osì p
area
che
’l sa
nto
Pes
cato
re,
Subi
to s
ull’a
rena
con
osce
sse
del
l’altr
ui p
iant
e, e
del
suo
Cri
sto
l’orm
aA
l lez
zo e
d al
l’odo
r, no
n ch
e a
la fo
rma.
III,
11,
1o
rme
felic
i e d
a qu
el p
iè s
tam
pate
Tavo
la 3
AndreA Torre338
Sintomatica, e non solo da questo punto di vista, è anche un’altra immagi-ne, condivisa nella ricorrenza e nella funzionalità sia dalle Lagrime sia dalle poesie spirituali. Si tratta delle impronte di cristo rinvenute da Pietro nell’orto del Getsemani. vera e propria immagine dialettica – di cui ora Georges didi-Huberman ha ricostruito la vita delle forme –, l’impronta, e nella fattispecie l’impronta cristica, visualizza la paradossale coincidenza fra l’idea di appropria-zione (il contatto con il substrato, in cui l’impronta si forma) e l’idea di perdita (la lontananza dal substrato, in cui l’impronta resta presente)27. visualizza dunque la paradossale relazione dell’uomo col divino, nonché l’intrinseca paradossalità del mistero dell’Incarnazione. Tale immagine costituisce inoltre un’efficace rappresentazione del desiderio (del desiderio di vedere, in primis; vd. Tavola 3).
Tracce memoriali di un recente passato di colpe, l’«orme sante» insorgono a segnare in profondità il presente stato emotivo di Pietro («ma visto de’ suoi piè stampato il suolo, | Troppo intenso dolor l’alma gli preme», con riverbero nell’interiorità del violento contatto esteriore). esse gli si offrono come tangi-bili, pressanti moniti a organizzare il suo immediato futuro come un itinera-rium in veritatem liturgicamente ritmato da ricordi, visioni e profezie; come una mappa dei luoghi sacri della Passione che è al contempo una cartografia dell’anima dell’apostolo assediata dai rimorsi. Il vagare notturno di Pietro lon-tano dalla città, su cui si fondano le strutture narrative delle due versioni estese delle Lagrime, muove a tutti gli effetti da questa immagine iniziale, fondativa. Anche nel presente caso la storia redazionale del testo ci riserva alcune varianti non banali. Innanzitutto, l’ott. 34 del poemetto ritorna solo nell’ed. costo 1606 (III, 8), e con alcune modifiche. Se nel testo del 1560 il crollo morale e fisico del penitente («come li fosser tronche ambe le piante | lasciandosi cader col volto in giuso») è segnato da un pianto (da un «bagnar» che di fatto prolunga la verticalità discendente del movimento di caduta, e stabilisce un contatto tra gli occhi dell’apostolo e la reliquia del suo desiderio), l’ottava del poema presenta invece la variante «baciar». Anche in questo atto simbolico – nella deferenza dell’organo della fonazione verso un oggetto visuale – credo si possa scorgere la volontà di «purgar con gli occhi il fallo della lingua»28. Il pianto e il bacio si
27 G. didi-Huberman, La somiglianza per contatto. Archeologia, anacronismo e modernità dell’impronta [2008], trad. it. di c. Tartarini, Torino, Bollati Boringhieri, 2009.
28 cfr. G.P. maragoni, La devozione e la letteratura. Sulla poesia sacra di Luigi Tansillo, roma, uniTor, 1991, p. 19: «Quando in III, 16 San Pietro rimedia alla colpa della propria bocca, traditrice del cristo, obbligandola a piegarsi sulle orme di lui, non tanto occorrerà rammentare che il bacio dell’immagine e della reliquia – al pari della genuflessione o del segno di croce o dell’uso della catena pettorale consacrata – è pratica squisitamente cattolica (…), quanto
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 339
presentano invece congiunti in un altro poemetto devozionale che affronta il topos lacrimale; è il Pianto di san Pietro del cremonese Giovanni maria Paroli (1584), che all’ottava 31 così recita:
Piange sopra quell’orme altiere e belle cui impresse del mio christo il piede Santo, Il piè che dolce incarco è l’auree stelle,vestito d’aureo incorruttibil manto.Bascia, e rimira intento, e queste, e quelle, e quelle, e queste intento onge col pianto.«deh», dice, «gli occhi, o sempiterno nume,Fammi stillar sopra quest’orme in fiume»29.
l’accezione delle lacrime quale unguente curativo delle ferite cristiche sug-gerisce peraltro un’interferenza tra le figure di Pietro e maria maddalena. Tale motivo si può rinvenire, oltre che nelle Lacrime tassiane (cfr. supra ott. 12, 7), anche nel sonetto 130 di Tansillo: «gradisci il pianto, ond’oggi io lavo ed ungo | tuoi santi piedi…». nelle rime spirituali di Tansillo l’impronta cristica costitui-sce per il soggetto lirico un’occasione di contrizione (s. 128, 9-10: «So’ indegno, Signor mio, ch’il tuo pied’entre | sotto il mio tetto…») e un irraggiungibile termine di comparazione (s. 130, 9-10: «Sin qui non trovo, ch’orma de le mie | stampi la strada tua…»). di fronte all’unicità di questo segno metonimico, al contempo vicino e lontano, rappresentato ma non riproducibile, risulta allora possibile solo la riattualizzazione liturgica del messaggio che veicola (s. 137, 11-12: «Se (…) | non posso ir dietro agli alti tuoi vestigi, | berrò ne la fontana del tuo sangue»)30.
ma torniamo alle Lagrime. una più consistente elaborazione marca il distico finale dell’ott. 34 della stampa 1560, e ci consegna nuovamente una determinazione sinestesica, un’integrazione sensoriale alla percezione visiva: «l’orme scerner potea del suo Signore, | ché putian l’altre, e quelle avean odore». cassato nell’ed. Attendolo 1585, il particolare olfattivo è ripreso nel testo del 1606 e diluito nello spazio di un’intera ottava (III, 9). Tale dettaglio, forse di debole impatto estetico, va però anch’esso còlto nella sua funzionalità simbolica, e interpretato alla luce del valore balsamico attribuito dalle Scritture
piuttosto dovremo nell’invenzione stessa ammettere la coscienza – precisamente teoretica – che ad uno speech act in cui il parlare sia stato in effetti un agire peccaminoso deve rispondere un’emenda nella quale l’organo della fonazione, ridotto a labbra osculanti, sia riparatoriamente defraudato della sua superiore capacità semica».
29 G.m. Paroli, Pianto di Santo Pietro, ott. 31, cremona, draconi, 1584, s.i.p. (corsivi miei).30 Tansillo, Il canzoniere edito e inedito, rispettivamente pp. 301, 299, 307.
AndreA Torre340
agli umori corporei di cristo31. la stessa immagine del sangue di cristo risulta infatti strettamente connessa con quella delle lacrime, tanto nella tradizione cristiana quanto nei testi di Tansillo. Il termine ebraico per ‘lacrima’ (dimah) è infatti il composto dei concetti di ‘sangue’ e ‘occhio’, sicché potremmo tradurlo come ‘il sangue dell’occhio’32. e il pianto di cristo nell’orto risulta esemplare proprio da questo punto di vista, perché – come ricorda Bellarmino – non si espresse attraverso le lacrime ma attraverso «il sudore di sangue così copiosa-mente effuso»33. oltre che svilupparlo ripetutamente nel poema attraverso il parallelo metaforico occhio-ferita, Tansillo riprende il nesso nel sonetto 139, 5-8: «Se render l’alma mia, qual’era innante | non pon l’acque ch’ognor da gli occhi io scioglio, | rèndala il sangue (or ch’io mi pento e doglio) | il qual versò da le tue piaghe sante»34. Pur non comparabile alle effusioni corporee di cristo, il pianto è comunque inteso qui come atto di purificazione, rinnovato battesimo dell’anima.
In un gruppo contiguo di sonetti (127-130), e proprio ad esaltazione dei benefici catartici del pianto, Tansillo insiste sulla caratterizzazione dell’inte-riorità umana come luogo impuro, macchiato da quei «terrestri limi» (129, 3)
31 G. Pozzi, Sull’orlo del visibile parlare, milano, Adelphi, 1993, p. 404: «Il sangue, oggetto, come le piaghe, d’un culto anteriore alla cardiolatria e autonomo ancora dopo a lungo, viene associato al cuore di cristo da quando le devozioni ai vari organi del corpo del redentore si compongono in una. Allora si ricondussero al solo cuore quelle metafore che fin lì avevano rappresentato il grondare del sangue dall’intiero suo corpo: fontana, torchio, pioggia, rugiada, mosto. due ordini di relazioni metaforiche possono nascere dall’unità di senso “sangue” se confrontata con quella “cuore”: il liquido che sgorga, il liquido che vi si raccoglie (…). la prima suggerisce l’idea della sorgente, fontana, canale, cui è associata l’azione del bere da parte del cristiano (ma circoscritta piuttosto al fianco che non estesa all’organo stesso). la seconda, l’idea del pelago, cui è associata l’azione del lavacro e del nuoto». Per un’analisi del motivo, nella prospettiva dell’antropologia culturale, si vedano: P. camporesi, La carne impassibile. Salvezza e salute fra Medioevo e Controriforma, milano, Garzanti, 1994; e m. niola, Il corpo mirabile. Miracolo, sangue, estasi nella napoli barocca, roma, meltemi, 1997.
32 A. de Souzenelle, Il simbolismo del corpo umano [1997], trad. it. di P. longo – Y. mollard, Bergamo, Servitium, 2007, p. 343.
33 Bellarmino, De gemitu columbae, l. I, p. 108: «Tertio flevit dominus in horto, cum Patri supplicaret, ut, si fieri posset, transiret ab eo calix passionis. Quamvis enim evangelistae non meminerint lacrimarum, tamen sudor sanguineus tam copiose effusus satis demonstrat neque lacrimas defuisse». Anche su questo dettaglio pseudofisiologico della Passione (attraverso cui l’exemplum mirabile viene inscritto nel regime del naturale) deve fondarsi la pratica meditativa di compunctio cordis da parte del fedele: «necesse igitur est, si quis velit thesaurum amoris dei in agro passionis dominicae reperire, ut attentissima consideratione quasi praesentem dominum cernat. nunc in horto agonizantem et luctantem cum tristitia et maerore, et non lacrimas solum, sed etiam sudorem sanguineum toto corpore fundentem…» (ibidem, l. II, p. 182).
34 Tansillo, Il canzoniere edito e inedito, p. 309.
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 341
che lo rendono simile a una «fangosa ed erma | stanza» (128, 1-2), a una palude tra le cui «spine e’l fango | (…) | m’affondo e pungo» (129, 5-6)35. Il concetto figurato dall’immagine del fango è ovviamente il peccato originale, quel «fango antico, ond’usciam sozzi noi», secondo la definizione offertane nelle Lagrime dell’edizione costo 1606:
e perché l’ampia macchia che si sparsedal primo padre su i nipoti tutti,non tinga il sen beato, ov’uom formarsedovea quel dio, c’ha il mondo e l’uom produtti,e ’l sangue, e ’l latte, onde dovea cibarseQuel puro Sol, non si denigri, e bruttiDal fango antico ond’usciam sozzi noi,Anz’il dì la guardò con gli occhi suoi36.
Quell’«ampia macchia» è però anche metonimia del «vil corpo umano …, | opra di terra che’l piè sozzo preme». non abbiamo più dunque a che fare con orme sante. resta il semplice substrato, in cui l’impronta è principalmente traccia di un’assenza. ripetizione dell’errore adamitico, il vile diniego di Pietro ha dunque precipitato nuovamente «nel fango orrido e nigro» l’effige di dio, quell’«immagine bellissima» di sé che dio ha riprodotto nell’uomo durante la creazione. da un breve ma denso passaggio di ottave (presente nella sola ed. costo 1606: vI, 54-56) emerge infatti in tutta la sua drammaticità l’immagine di Pietro che, con «gli occhi unqua non lassi | di pianger», contempla il «ter-ren fangoso», e comprende tutto il nucleo paradossale del proprio errore: «Per amar troppo questo ignobil fango, | d’amor dunque e di fè scemo rimango?»37 (vd. Tavola 4).
mi sembra questa la più efficace rappresentazione testuale di quell’imago agens cui alludevo all’inizio dell’analisi delle Lagrime. essa esibisce le stesse dinamiche scopiche attive in altre esperienze del genere, con l’atto di visione marcato dal pianto che stabilisce un contatto emotivo tra soggetto e oggetto dello sguardo, e induce a verificare nella memoria i termini di un possibile rispecchiamento tra di essi. differentemente da quanto accade per la vergine tassiana, la maddalena di valvasone o anche il Pietro tansilliano che si specchia in cristo o medita sulle sue impronte – l’incontro visivo messo qui in scena non è però più quello dell’uomo con il cristo della Passione, bensì quello
35 Tansillo, Il canzoniere edito e inedito, pp. 299-300.36 Le lagrime di San Pietro del sig. Luigi Tansillo, cavate dal suo proprio originale, vIII, 90,
p. 83 (corsivi miei).37 Ibidem, vI, 54-56, p. 57 (corsivi miei).
AndreA Torre342
vI,
54
Perc
hé d
el m
io S
igno
r po
rto
in m
e st
esso
L’im
mag
ine
belli
ssim
a sc
olpi
ta,
non
fatt
a d’
arte
altr
ui, m
a di
man
d’e
sso,
la
qual
con
l’al
ma
ande
rà s
empr
e un
ita,
Tant
o pi
ù du
nqu’
è gr
ave
ora
il m
io e
cces
so,
E p
iù la
col
pa m
ia q
uas’
infin
ita:
Che
cad
endo
nel
fang
o or
rido
, e n
igro
,D
i Dio
l’e
ffig
ie in
me
guas
to e
den
igro
.
vI,
55
e c
iò d
icen
do, g
li oc
chi u
nqua
non
lass
iD
i pia
nger
chi
na in
terr
a; n
é sì
tost
oG
li al
za s
u, m
a lu
ng’o
ra g
li ti
en b
assi
;E
sul
terr
en fa
ngos
o il
guar
do p
osto
,C
h’eg
li ha
din
anzi
, con
tem
plan
do s
tass
i,D
i qua
nto
vil m
ater
ia è
l’u
om c
ompo
sto,
Acc
iò in
pen
sar
ch’e
gli h
a di
dio
l’im
mag
o,n
o’l f
acci
a ir
tro
ppo
di s
é lie
to e
pag
o.
vI,
56
dun
que
ho, d
icea
, spr
egia
to il
re
cel
este
più
noto
a m
e, c
h’a
tutt
o ’l
mon
do in
siem
e,Pe
rché
que
sto
vil c
orpo
viv
o re
ste,
opr
a di
terr
a, c
he ’l
piè
soz
zo p
rem
e?Pe
r fa
r si
cura
la c
aduc
a ve
ste
l’an
ima
eter
na a
lto f
lage
llo te
me:
Per
amar
tro
ppo
ques
to ig
nobi
l fan
go,
D’a
mor
dun
que,
e d
i fè
scem
o ri
man
go?
ed. 1
560
ed. 1
585
ed. 1
606
7, 1
-3o
gni o
cchi
o de
l Sig
nor
lingu
a ve
loce
Par
ea c
he fu
sse,
et o
gni o
cchi
o de
’ suo
io
recc
hia
inte
nta
ad a
scol
tar
sua
voce
.(…
)
8, 6
-8(…
)Tu
mi n
egas
ti, e
t hor
con
gli
altr
i rei
Ti s
tai a
pas
cer
del m
io d
anno
gli
occh
i,Pe
rché
la p
arte
del
pia
cer
ti to
cchi
.
I, 4
3, 1
-3o
gn’o
cchi
o de
l Sig
nor,
lingu
a ve
loce
Par
ea c
he fo
sse,
ed
ogn’
occh
io d
e’ s
uoi
ore
cchi
a in
tent
a ad
asc
olta
r su
a vo
ce:
(…)
I, 4
4, 6
-8(…
)Tu
mi n
egas
ti, e
d ho
r co
n gl
i altr
i rei
Par
che
ti p
asch
i del
mio
dan
no g
li oc
chi,
E c
he la
par
te d
el p
iace
r ti
tocc
hi.
I, 5
7, 1
-3o
gn’o
cchi
o de
l Sig
nor
lingu
a ve
loce
Par
ea c
he fo
sse,
et o
gn’o
cchi
o de
’ suo
io
recc
hia
inte
nta
ad a
scol
tar
sua
voce
:(…
)
I, 5
8, 6
-8(…
)Tu
mi n
egas
ti, e
t hor
con
gli
altr
i rei
Ti s
tai a
pas
cer
del m
io d
anno
gli
occh
i,P
erch
é la
par
te d
el p
iace
r ti
tocc
hi.
Tavo
la 4
Tavo
la 5
«PurGAr con GlI occHI Il FAllo dellA lInGuA» 343
dell’uomo con se stesso. nel meccanismo retorico che presiede alle funzionalità meditazionale e catechistica del testo devozionale, quest’immagine ribadisce fortemente la sovrapponibilità degli sguardi (e delle voci) del protagonista narratore, dell’autore e di ogni possibile lettore, ma soprattutto rende condivisa fra essi l’istanza autoriflessiva che veicola. All’icona della divinità sofferente si affianca dunque quella dell’umanità dolente, e la giustapposizione può esser letta dal fedele sia in senso derivativo (Pietro, come cristo, medita fra le lacri-me), sia in senso contrastivo (Pietro, differentemente da cristo, compiange la propria umanità). Questo secondo aspetto è inoltre intensificato dall’essere oggetto dello sguardo di Pietro proprio l’orma, ossia una metonimia visiva di sé in quanto essere umano, unicamente umano. rappresentato come specula-re o mise en abîme, l’atto stesso di visione è dunque l’oggetto principale della narrazione, l’elemento descrittivo che ne determina il senso. Se invece leggiamo la giustapposizione in senso derivativo, non possiamo non notare che – nel contesto ideologico e comunicativo in cui si colloca – tale dettaglio può anche configurarsi come l’esibita presa di coscienza di una sostituzione della per-fetta immagine celeste di dio con una sua fragile riproduzione terrena; come un icastico memento contro la deriva dell’icona a idolo, contro la distorsione, finalizzata al piacere, di un meccanismo di visione deputato al pentimento e alla conversione. «Ti stai a pascer del mio danno gli occhi, | Perché la parte del piacer ti tocchi», è infatti la circostanziata accusa che Tansillo, all’inizio del poema, fa rivolgere da cristo all’apostolo Pietro che ha appena assistito allo spettacolo della cattura. la medesima accusa è ovviamente rivolta, per esten-sione, anche a tutti coloro che tra breve assisteranno compiaciuti allo spettacolo della Passione (vd. Tavola 5).
Il pianto controriformista sembra dunque venir chiamato, sulla scorta del caso esemplare di Pietro, non solo a «purgare il fallo della lingua», ma anche a purificare l’atto mentale e l’esperienza culturale della visione, riorientandola verso una corretta fruizione e riproduzione del suo unico e proprio oggetto, il corpo martoriato di cristo. con le Lagrime della Vergine Tasso dimostrerà di aver assimilato appieno tale correzione procedurale; e col Capitolo del Crocefisso Angelo Grillo ne dichiarerà tutto il valore programmatico: «Fate ch’ovunque io miro, io mi vi finga, | Piaghe amorose, e nei visivi oggetti | veggia il mio christo, e ’n croce ognun me ’l pinga»38.
38 A. Grillo, Capitolo del Crocefisso, vv. 136-138, in Tansillo, Le lagrime di S. Pietro. Con le Lagrime della Maddalena del signor Erasmo da Valvasone, p. 193v. Sulla produzione poetica sacra di Angelo Grillo si vedano: o. Besomi, Ricerche intorno alla «Lira» di G.B. Marino, Padova, Antenore, 1969, pp. 154-185; G. raboni, Il madrigalista genovese Livio Celiano e il benedettino Angelo Grillo. In margine a una recente monografia, «Studi secenteschi», XXXII (1991), pp.
AndreA Torre344
la tormentata storia editoriale delle Lagrime e la loro problematica utilizza-bilità nel quadro delle istanze religiose e politiche della controriforma poggia-no probabilmente sulla fragilità ideologica dell’eroe ritratto39. ma tale fragilità ideologica potrebbe anche essere la condizione che ne determina lo strategico appeal emulativo. non la divinità di cristo umanizzata nel martirio e nella sof-ferenza (Tasso); né l’umanità della vergine che lega anche biologicamente cielo e terra (Tasso, Basile, campeggi); e neppure l’umanità prima peccatrice poi penitente della maddalena (valvasone, camilli)40; ma proprio l’umanità troppo umana di chi aveva tutte le carte in regola per far bene41, e nonostante ciò ha tradito il suo compito, può costituire un exemplum di grande impatto politico oltre che d’indubbia valenza individuale. còlta sotto questo punto di vista, l’eco dell’accusa di cristo, risuonante nel fermo-immagine di Pietro che contempla nel fango tutta la propria precaria umanità, potrebbe costituire uno speech act in grado di indurre il fedele a meditare sulla propria natura e sulla propria esistenza; un oggetto di contemplazione religiosa che – andando oltre uno sguardo sterile e morbosamente perso, ora come allora, davanti al quotidiano dolore degli altri – può sovvenire nella «ricerca di ciò che in queste immagini si esprime al di là della loro leggibilità»42.
137-188; m. Föcking, «Rime sacre» und die Genese des barocken Stils. untersuchungen zur Stilgeschichte geistlicher Lyrik in Italien 1536-1614, Stuttgart, Steiner, 1994; F. Ferretti, Gli esordi dello «stil pietoso» di Angelo Grillo, in Rime sacre tra Cinquecento e Seicento, pp. 107-140.
39 cfr. Toscano, note sulla composizione e la pubblicazione de «Le lagrime di San Pietro», p. 440: «Tagli e aggiustamenti si renderanno necessari per ottenere l’imprimatur delle autorità ecclesiastiche, non entusiaste evidentemente di fronte a un’opera che, alla fine, enfatizzava la debolezza umana dell’Apostolo eletto da cristo depositario di quel primato, assunto da roma come cardine della strategia di riconquista, messa a punto dal concilio di Trento».
40 cfr., a proposito, Bellarmino, De gemitu columbae, l. I, p. 112: «heac enim, cum primum resipiscere coepit, christi pedes lacrimis paenitentiae lavit et capillis suis tersit; idque in publico convivio, et multis praesentibus: quam enim non puduerat publice peccare, eandem pudere non debuit publice paenitere» (corsivi miei).
41 Bellarmino, De gemitu columbae, l. I, p. 112: «Sequitur s. Petrus, qui in passione domini peccavit peccatum grande, non tamen ex malitia, ut Judas proditor, sed partim ex nimia fragili-tate, partim ex nimia confidentia virium suarum» (corsivi miei).
42 mitchell, L’inenarrabile e l’inimmaginabile, p. 182.