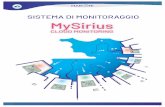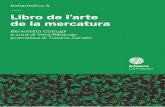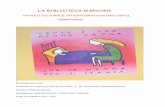Piazza Marconi: un libro aperto. La storia, l'arte, il futuro
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Piazza Marconi: un libro aperto. La storia, l'arte, il futuro
Testi: Paul BlockleyElena BaigueraNicoletta CecchiniMarta FantoniMarcella NicodemoLynn Passi PitcherLucia PeregoGiordana RidolfiMarina VolontéFoto:Paul BlockleyThomas PepeArchivio di Stato di CremonaFondo Fazioli - Comune di CremonaCoordinamento Editoriale: Nicoletta FilibertiMarcella NicodemoProgetto grafico e impaginazione: Studio Pi-TreStampa: ??Si ringraziano: Alberto BacchettaDaniela Benedetti Chiara BianchiSilvestro BiniIvan BonardiCristina BoschettiCristina CattaneoCristina De MasiSilvia Di MartinoElena MarianiSara MasseroliFabrizio SlavazziSi ringrazia inoltre tutta l’équipe di scavo
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa ina qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettroni-co, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprie-tari dei diritti e dell’editore.
Printed in ItalyFinito di stampare nel mese di gennaio 2008
In copertina: Statuetta di Artemide cacciatrice, da prototipo ellenistico.Prima metà del I sec. d.C.
la storia, l’arte, il futuro
Piazza Marconi:un libro aPerto
a cura di Lynn Passi Pitcher e Marina Volonté
5
Questa agile pubblicazione ha il pre-
gio di tracciare in modo chiaro la storia
dello scavo di piazza Marconi dal 1983
ai nostri giorni. E’ un piccolo ma piace-
vole libro che si legge tutto d’un fiato e
che mi auguro costituisca l’abbozzo di
un’opera di più ampio respiro dedicata
alle importanti scoperte che il principa-
le scavo archeologico realizzato nella
nostra città ha sino ad ora riservato.
Leggendo i vari capitoli del libro traspa-
re l’entusiasmo che questa impresa, sot-
to l’aspetto storico ed artistico, ha susci-
tato negli archeologi, da anni impegnati
a scandagliare in ogni anfratto il terreno
sottostante una delle principali piazze
cittadine. Come potrebbe essere diver-
samente vista la mole di reperti trovati
che gettano una luce nuova sulla storia
antica di Cremona, al punto da fornire
spunti inediti e molto interessanti per
ricerche e nuovi studi che aiuteranno a
conoscere meglio il nostro passato?
Certo, lo scavo di piazza Marconi, come
si legge nell’incipit del libro, è una pa-
gina travagliata della storia cremonese
contemporanea. Ma i problemi, che
indubbiamente vi sono stati in questi
anni, non hanno inficiato un’opera rile-
vante per la nostra città che si troverà
ad avere quanto prima un ampio e co-
modo parcheggio interrato che libererà
il centro storico da un numero conside-
revole di auto, una piazza riqualificata,
interamente pedonalizzata e fruibile
come spazio di incontro e di aggrega-
zione, nonché una serie di reperti che
andranno ad arricchire il nostro patri-
monio archeologico e che costituiranno
oggetto di studio e dunque elemento
catalizzatore per molti studiosi.
Mi rendo conto che, guardando il gran-
de “vuoto” ed i cumuli di terra che carat-
terizzano ora lo scenario di piazza Mar-
coni, è difficile immaginare come potrà
trasformarsi entro un anno o poco più.
Questa sensazione può rimandare allo
sgomento dei cremonesi suscitato ne-
gli anni Trenta del secolo scorso dalle
demolizioni che portarono alla realizza-
zione dell’attuale piazza Marconi e alla
costruzione di Palazzo dell’Arte.
Ma se allora prevaleva la volontà di
distruggere quanto era considerato
inadeguato all’ideale di città che era
propria dell’epoca fascista, oggi siamo
invece di fronte ad un intervento di ri-
qualificazione di uno spazio che, dalla
sua creazione avvenuta in modo deci-
samente brutale, non ha mai avuto una
connotazione precisa, ma è sempre sta-
to un luogo anonimo, dove non si coglie
nemmeno la monumentalità e la bellez-
za di Palazzo dell’Arte, ridotto - anche a
causa degli usi impropri dell’edificio e
della piazza sulla quale si affaccia - ad
un elemento di sfondo.
La nostra città ha un luogo centrale ben
riconoscibile, che si definisce in rappor-
to a due piazze, le antiche platea magna
e platea parva (oggi piazza del Comune
e piazza Stradivari) ed ha come riferi-
mento visivo, da un lato la Cattedrale,
dall’altro il Palazzo Comunale. Nella se-
conda metà dell’Ottocento, nell’ambito
della metamorfosi urbanistica che con-
nota Cremona, prevale l’impostazione
della “città giardino”, che privilegia le
aree verdi, i grandi parchi di gusto ro-
mantico e gli edifici dallo stile eclettico.
Nasce così, sull’area dove sorgeva la se-
conda, per estensione, chiesa della città,
San Domenico, con convento annesso,
piazza Roma, connotata da un’ampia
area verde dedicata allo svago. Nasce
così la terza grande piazza del centro
storico.
Tra la fine degli anni Venti e negli anni
Trenta del Novecento, sotto il forte con-
dizionamento dell’ideologia mussoli-
niana, anche Cremona viene investita
da trasformazioni in campo urbanisti-
co che sconvolgono, è il caso di dirlo,
l’aspetto di alcune zone centrali. Tra
queste vi è anche l’attuale piazza Mar-
coni, piazza che nasce da un’azione
6
demolitoria massiccia, che spazza via
un intero quartiere. Forse è anche per
questa sua origine così artificiosa e non
spontanea che piazza Marconi è stata
sempre vissuta come “non piazza” dai
cremonesi, identificata solo come un
grande spiazzo senza anima.
Lo spazio pubblico della città, dove
l’uomo è tenuto ad apparire, fruisce, per
sua stessa natura, di una duplice defini-
zione. L’una lo differenzia rispetto alla
casa, luogo del riposo e del sonno, ma
spazio chiuso, privato, difeso e da difen-
dere; l’altra rispetto allo spazio aperto
della campagna, ma luogo del lavoro
e della natura. Esso si impone come lo
spazio dell’azione senza lavoro: luogo
del rituale e della festa, del gesto e dello
spettacolo, dei piaceri e dei giochi.
Ogni città desume il proprio significato
e la propria realtà da un sistema di pun-
ti di riferimento. Quale ne sia la pianta,
geometrica o spontanea, la città è orga-
nizzata per gli scambi tra gli uomini: e
per gli scambi, ancor più che di beni, di
segni e di simboli. È raro che l’importan-
te sia la strada, luogo di transito stretto
e ingombro che le case cercano sempre
di annettersi come se fosse un cortile. Il
vero centro della vita sociale è situato
altrove, nella piazza, dove sfocia tutta la
circolazione confusa e caotica delle vie.
Sempre più difesa, finché sussiste una
vita collettiva, dagli sconfinamenti dei
privati, la piazza è il luogo pubblico per
eccellenza, una costante dell’urbani-
stica mediterranea, a partire dall’agorà
greca e dal forum romano. All’origine
semplice luogo di riunione, la piazza si
circonda ben presto di portici e arcate,
ripari contro il sole e contro la pioggia.
Ora accoglie solo eccezionalmente il
mercato, mentre riunisce intorno a sé i
principali monumenti religiosi e civili,
cui serve al tempo stesso da anticame-
ra e da proscenio. E’ l’espressione del
successo materiale e politico della città.
Quando quest’ultima si ingrandisce, si
suddivide e si specializza.
Al disotto della piazza principale si de-
linea tutta una complessa gerarchia,
che riproduce quella della vita sociale:
una piazza per ogni quartiere, per ogni
comunità etnica o religiosa; una piazza
anche per ogni funzione, dal mercato al
culto, all’assemblea; una piazza dalle di-
mensioni di una strada - un corso - lungo
la quale si allineano le case dei ricchi e le
botteghe di lusso e dove sfilano proces-
sioni e cortei; a ogni piazza, infine, la sua
coloritura, aristocratica o popolare.
Sino ad ora tutto questo è mancato a
piazza Marconi. Le cause, come ho sopra
accennato, stanno forse nella sua origi-
ne, frutto di un vulnus inferto ad una
zona che era di grande fascino, come
dimostrano le fotografie dell’epoca; o
forse stanno nel suo essere un progetto
incompiuto. Di sicuro vi è che è giunto
ora il momento di dare un’anima a que-
sto grande spazio perché possa essere
vissuto ed amato. E’ questo una forma
anche di rispetto, di riscatto per quelle
vestigia che lo scavo archeologico ha ri-
portato alla luce e che hanno dimostra-
to quanto fosse elegante e curata in età
antica questa parte della città.
Gian Carlo Corada
Sindaco di Cremona
Piazza Marconi: un libro aPerto
7
Lo svolgimento di uno scavo archeolo-
gico così ampio all’interno del centro
storico di una delle nostre città non è
mai un evento usuale. Per decenni, dal-
la nascita dell’archeologia come scienza
in Italia i grandi interventi urbanistici
hanno di fatto ignorato la problematica
archeologica, con la parziale eccezione
degli ultimi decenni dell’Ottocento. In
quel periodo grazie ad alcune figure di
grande prestigio cui è legata la storia
dell’archeologia moderna, da Giacomo
Boni ad Antonio Zannoni, espressioni
della migliore cultura positivista, in al-
cune città si è sperimentata la difficile
convivenza tra lavori pubblici e tutela
del patrimonio archeologico. Il preva-
lere all’inizio del secolo scorso di una
visione neoidealistica che identificava
l’archeologia con la storia dell’arte an-
tica ha purtroppo provocato la perdita
inesorabile di gran parte dei depositi
archeologici delle nostre città storiche,
salvando pochi reperti considerati “ec-
cezionali” e “di particolare interesse” e
perdendo ogni legame con i contesti
di scavo. Tale vero e proprio degrado
dell’idea stessa dell’archeologia in Italia
ha raggiunto, con rare eccezioni, il livel-
lo più basso durante il ventennio fasci-
sta e nei decenni della ricostruzione.
È solo con la fine degli anni Settanta
che, superando la visione della l. 1089
del 1939, che concepiva l’archeologia
solo come attività di ricerca “di beni
e cose notevoli”, è iniziata la prassi, ad
opera delle Soprintendenze Archeolo-
giche, di interventi di scavo sistematici
in occasione di grandi lavori pubblici e
privati. Tale prassi ha trovato una prima
sistemazione legislativa solo con la leg-
ge sull’Archeologia Preventiva del 2005,
poi recepita nell’ultimo testo sui lavori
pubblici del 2006.
In questa situazione si inquadra anche lo
scavo di piazza Marconi a Cremona, che,
al di là di polemiche spesso inutili, ma
inevitabili in un quadro culturale in cui
l’archeologia urbana e quella professio-
nale hanno solo pochi decenni di vita,
ha dato risultati sul piano storico asso-
lutamente apprezzabili, confrontabili
con quelli di altri centri urbani dell’Ita-
lia settentrionale di origine romana o
addirittura preromana, come l’insubre
Mediolanum, l’etrusca Felsina e la veneta
Patavium, per non citare che tra illustri
esempi di città romane che erano state
anche capoluoghi di popolazioni di po-
polazioni assai antiche.
A Cremona è stato indagato, grazie
allo scavo per i parcheggi, attraverso
un’opera di archeologia dapprima pre-
ventiva, poi esecutiva, un settore della
città antica dalla sua fondazione, e cioè
dalla colonia romana di età repubblica-
na, fedelissima all’Urbe anche durante
momenti assai difficili, come l’invasione
di Annibale, alla ricca città della prima
età imperiale saccheggiata nel 69 d.C.
dalle truppe di Vespasiano, alla ripresa
tardo-antica. Né sono stati trascurati
gli strati medioevali e tardo-medioevali
con le abitazioni più modeste e le se-
polture cristiane, le chiese e i conventi.
La sorpresa più rilevante è certamente
il rinvenimento della ricca domus della
prima età imperiale, certo appartenuta,
a giudicare dalle imponenti strutture ar-
chitettoniche e dalla ricchezza degli ar-
redi, ad una facoltosa famiglia di rango
senatorio.
E tuttavia va in questa sede ribadito
che, al di là dell’eccezionalità dei singoli
rinvenimenti, quello che conta davvero
per noi archeologi è il recupero del con-
testo di scavo, mediante un’opera atten-
ta e minuziosa di squadre di archeologi
specializzati, sola metodologia con cui
i reperti possono parlare e raccontarci
brani fondamentali e insostituibili del
nostro passato. Resta solo da aggiunge-
re che gli scavi archeologici sono inutili
senza una successiva opera di restauro,
studio, conservazione e adeguata va-
lorizzazione dei ritrovamenti. A questi
compiti assai gravosi ma ricchi di sod-
disfazioni saranno presto chiamati gli
studiosi, guidati da Lynn Pitcher, cui mi
lega comunanza di studi non così lonta-
na, e l’intera comunità cremonese.
Luigi MalnatiSoprintendente per i Beni Archeologici
ad interim della Lombardia
8
Scavo 1983Lo scavo di piazza Marconi (tav. I) è una pagina travagliata della storia cre-monese moderna, ma i risultati sono di una importanza tale da giustificare tutti i problemi che ha creato e le po-lemiche che si sono susseguite negli anni. La massa dei dati e dei reperti recuperati (se ne contano più di un milione) ci sta permettendo di rico-struire una parte considerevole della storia antica di Cremona, e anche di aprire capitoli nuovi per l’archeologia dell’Italia settentrionale.Con lungimiranza, già nel 1983 l’Am-ministrazione Zaffanella aveva com-preso la necessità di affrontare il pro-blema del traffico e dei parcheggi, e chiese alla Soprintendenza Archeolo-gica di eseguire, a spese del Comune,
Storia Dello ScaVo
un’indagine per valutare la possibilità di realizzare nell’area della piazza un parcheggio sotterraneo. Per motivi di opportunità - si ricorda che all’epoca del primo scavo la piazza era occupa-ta dalla stazione delle corriere - si era deciso di investigare solo una picco-la porzione della zona, circa 290 mq nell’angolo sud-est del piazzale (fig. 1). Già in questo primo intervento ci si era resi conto dell’importanza dei resti celati nel sottosuolo. Con il sen-no di poi, l’area indagata era davvero troppo limitata, ma bisognava conte-nere il budget, e non ci si aspettava di trovare un deposito archeologico così imponente; per la prima volta si era appurato che lo strato romano, specie nella parte sud della città, è molto profondo (iniziando da m -5 dal piano stradale, cioè 38.30 slm).
L’inaspettata profondità dei resti creò grandi problemi, dalla movimentazio-ne di quantità non indifferenti di ter-ra, alla protezione del cantiere (l’area di scavo archeologico doveva conti-nuare a restringersi per permettere la messa in sicurezza delle sezioni); e infine, il livello di falda era più alto di quello odierno. In poche parole si era dovuto necessariamente fermarsi a m -6,30 sotto il piano stradale, cioè 37.00 slm. Nonostante tutte queste difficoltà, era apparso subito eviden-te che ci si trovava di fronte a ritrova-menti di estrema importanza e, come amano dire gli archeologi, pluristra-tificati. Il termine significa, in pratica, che si hanno testimonianze continue dall’inizio della frequentazione del sito fino ai giorni nostri. Brevemente, per il periodo romano si era potuto in-
dividuare una parte di un grande edi-ficio, che all’epoca, per le dimensioni imponenti e per la vicinanza al Po, era stato interpretato come un fabbrica-to annonario o comunque legato ad attività di magazzinaggio o scambio. Tale ipotesi è stata poi confutata alla luce degli scavi in corso nella piazza dal 2005. Sono stati documentati oriz-zonti cronologici legati sia alla famosa devastazione del 69 d.C. che a labili tracce di edifici posteriori. Per l’alto medioevo, si sono potute recuperare evidenze significative circa la forma-zione degli strati del cosiddetto “dark earth” cioè depositi creati sia dalla pre-senza di cumuli di rifiuti urbani che da
Dedico questo lavoro ai miei tre figli che hanno vissuto in diretta lo scavo di piazza Marconi per tutta la loro vita, e a Yerwant Arslan che mi as-siste sempre nella fase delicata della rielabora-zione dei testi.Tav. I
Piazza Marconi: un libro aPerto
9
orti. Questo tipo di sedimentazione si trova quasi sempre alle periferie dei grandi centri durante l’alto medioevo. Il periodo medievale è rappresentato da piccoli lacerti di una residenza pri-vata, non definibile nella sua interezza per l’esiguità dello scavo; si è potuta documentare anche una divisione tra proprietà. Il convento di Sant’Angelo, che fu utilizzato fino al 1936, quan-do, tolto il vincolo architettonico, fu demolito, è stato documentato per lo più in fondazione e con le cantine,
Fig. 1
Fig. 2
che spesso si appoggiavano su par-ti di edifici più antichi non definibili. Molto interessante il rinvenimento di una ghiacciaia, poi riempita da mol-tissimi frammenti di stoviglie collegati al convento. I risultati hanno portato la Soprintendenza Archeologica ad imporre un vincolo diretto (art. 1 e 4 legge 1.6 .1939 n. 1084 , con declara-toria dell’8.1.1985, prot. 130) che pre-cludeva qualsiasi lavoro di scavo nel sottosuolo della piazza.L’Amministrazione Comunale aveva voluto informare la cittadinanza sui ri-sultati di questi scavi, con una mostra finanziata dal Comune, inaugurata nell’autunno del 1984 a Santa Maria della Pietà, e corredata da un Catalo-go a cura della Soprintendenza, dal ti-tolo “Lo scavo di Piazza Marconi - Una mostra didattica”.
carotaggi 1990 Preoccupata del continuo aumento del traffico automobilistico nel centro cittadino, l’Amministrazione Zaffanel-la ha voluto verificare, con una serie di carotaggi diagnostici, le caratte-ristiche del sottosuolo nella zona di piazza Marconi, per comprendere ad ampio raggio il deposito archeologi-co e la sua profondità. Evidentemen-te i risultati dei 6 carotaggi (eseguiti dalla Ditta Prospezioni di Gianfranco Valle) data l’ampia area e i pochi saggi eseguiti e scelti in modo casuale, po-tevano dare soltanto interpretazioni parziali. Comunque hanno indicato nei depositi pendenze notevoli, a de-clivio da ovest a est (lo sterile variava da m -1,80 fino a m -8,80); alla luce di questi ritrovamenti, ancora una volta il progetto per il parcheggio fu accan-tonato.
Scavi ecarotaggi 2002L’Amministrazione Bodini, consapevo-le dell’importanza di un parcheggio per permettere la creazione di un’iso-la pedonale in tutto il Centro Storico,
chiese nuovamente alla Soprinten-denza ai Beni Archeologici di eseguire due saggi, a spese del Comune, per definire una volta per tutte i depositi archeologici nel sottosuolo della piaz-za. Furono eseguiti nell’angolo nord-ovest della piazza, una zona dove i ca-rotaggi avevano indicato un deposito archeologico minimo. Nel saggio I (fig. 2) fu individuata una serie di solchi e piccole attività artigianali con fusione di metalli, e si ritrovarono almeno cin-que vani di una grande dimora della seconda metà del I sec. a.C. distrutta nel 69 d.C. La residenza, ricostruita nella seconda metà del I sec. d.C., ave-va una stanza centrale con tappeto musivo, affacciata su una via basolata che correva nord/sud. Tracce di una zona all’aperto, con un pozzo che ta-glia il mosaico, indicano la presenza di un edificio di età tardo antica. Sui resti romani si era poi insediato un cimitero collegato alla chiesa di San Giorgio, che inizia nel VII-VIII secolo e continua fino alla soppressione Napo-leonica. Il saggio II (fig. 3) ha permes-so di individuare una grande vasca a metà del lato sud della piazza, inizial-mente identificata come cisterna, e in seguito definita una vasca scenografi-ca da giardino della casa augustea. In questo ultimo manufatto e nel pozzo sono state trovate ingenti quantità di lacerti di intonaco dipinto. Il tardo antico vede invece la presenza di un edificio absidato, probabilmente ter-me private legate alla grande domus. Poi, la costruzione di cantine collegate al convento di Sant’Angelo aveva di-strutto tutti i livelli altomedioevali e medioevali.Una serie di 15 carotaggi allineati, ese-guiti nella parte centrale della piazza dalla Ditta Lavori Archeologici, ha confermato l’orografia antica già ipo-tizzata durante gli scavi dal 1983 in avanti.Seguì un periodo abbastanza lungo di consultazioni, in alcuni momenti con toni piuttosto accesi, con proposte e controproposte, finché il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Di-Fig. 3
10
rezione regionale del Ministero non diedero l’assenso alla continuazione degli scavi ed un’approvazione preli-minare del progetto, con riserva di va-rianti in corso d’opera nel caso che i ri-trovamenti archeologici le rendessero necessarie. Il punto fermo fu che tutta l’area interessata al parcheggio dove-va essere scavata preventivamente e sistematicamente, con scavo strati-grafico. I resti più consistenti (l’edificio ritrovato nel 1983, parte della domus con il mosaico e la vasca) e qualsiasi altro manufatto ritrovato di partico-lare importanza archeologica, saran-no musealizzati, visibili all’interno del parcheggio con allestimenti ad hoc.
Scavo 2005-2007 La scavo archeologico (figg. 4, 5, 6, 7 e 8) riprese nel maggio del 2005 all’ini-zio dell’Amministrazione Corada. Il leitmotiv delle operazioni di scavo è
stato quello di una collaborazione che potesse velocizzare i tempi di cantiere, nei limiti del rigore scientifico indi-spensabile per uno scavo urbano siste-matico. Fu deciso di iniziare le indagini archeologiche prima della costruzio-ne delle paratie, per non affrontare un rischio archeologico eccessivo, né creare difficoltà alla sicurezza del can-tiere; poi l’andamento dei lavori arche-ologici ha subito ripetute sospensioni, per la presenza di macchinari pesanti
Tav. II
in un cantiere rischioso, che non per-metteva il proseguimento ininterrotto delle indagini. Attualmente, terminate le paratie, gli scavi procedono a ritmo serrato, e nel giro di pochi mesi una delle più importanti ricerche archeo-logiche dell’Italia Settentrionale sarà completata. Nel Catalogo sono illu-strati in modo molto abbreviato gli ec-cezionali risultati di questo scavo. Tutte le documentazioni: descrittiva, fotografica e di rilievo, sono state ese-guite in tempo reale, e informatizzate in un programma appositamente rea-lizzato. Durante le esplorazioni sono stati eseguiti l’inventariazione e lo studio di tutti i reperti rinvenuti, dal più antico al più recente, utilizzando supporti informatici che con apposi-ta password sono disponibili per gli studiosi che fanno parte dell’équipe, nel sito Cremona Archeologica Amoe-nissimis aedificiis. I risultati scientifici saranno presentati in una pubblica-zione prevista per il 2011. In una par-te che non richiede password il sito è consultabile anche dal pubblico, con un’introduzione sulla storia della città in età romana e sullo stato degli scavi, ed una bibliografia specifica aggiorna-ta. Le fonti antiche sono disponibili nei testi originali con le relative traduzio-ni. La sezione news darà notizia di tutti gli eventi archeologici, quali scavi in corso, mostre, conferenze, convegni e nuove pubblicazioni.
L.P.P.
Fig. 4
Piazza Marconi: un libro aPerto
11
introduzioneallo ScavoLo scavo archeologico è come un li-bro, sfogliandolo si recupera la nostra storia, anche se, si sa, con distruzio-ne di parte delle evidenze; proprio per questo la documentazione deve essere più minuziosa possibile, e la quantità dei dati da recuperare non è mai troppa. Alla fine delle ricerche, le dimensioni totali dell’area indagata saranno di mq 4100, con una profon-dità che va da m 1,70 sul lato ovest a ben 8 sul lato est. Fino alla fine di maggio 2007 erano stati rinvenuti più di un milione di reperti. Per comodità nell’illustrare lo scavo, sono state de-finite sei fasi storiche (tav. II): pre-au-gustea (dalla seconda metà del II sec. a.C. alla seconda metà del I sec. a.C.); augustea e prima età imperiale (dalla seconda metà del I sec. a.C. al 69 d.C.); tardo antica (dal IV sec. d.C. al V sec. d.C.); alto medievale-medievale (dal VI al XIV sec.); tardo medievale-post medievale (XV - XVIII sec.); moderna (XIX - XX sec.).
P.B. L.P.P.
Fig. 6 Fig. 7
Fig. 5
Fig. 8
13
La ricchezza dei materiali pertinenti alla prima fase insediativa testimonia la vivacità produttiva e commerciale della colonia di Cremona già nel II e nel I secolo a.C.La fiorente attività artigianale locale appare evi-dente nelle produzioni della grande bottega di lavorazione delle ossa, attestate sia nelle diverse fasi di lavorazione sia nei prodotti finiti (fig. 12), che comprendono una gamma svariata di og-getti, tra cui un insolito pendente fallico (fig. 13). I ritrovamenti mettono inoltre in evidenza la complessità della rete commerciale, favorita dal-la posizione strategica della città al centro della Pianura Padana e dalla vicinanza con l’importan-te via fluviale del Po. Infatti numerosi esemplari di importazione sono presenti tra le stoviglie impiegate sulla tavola, accanto a forme più comuni e di produzione lo-cale: tra i più interessanti vi è il piccolo cratere a vernice nera esposto (fig. 14). Di probabile im-portazione sono anche i due bicchieri in cerami-ca a pareti sottili di tipo Marabini I-III (fig. 15).
I destinatari di queste merci appartengono all’élite cittadina, che risiedeva in lussuose abi-tazioni, abbellite secondo la moda proveniente dall’Italia centrale: fanno parte della decorazio-ne della domus presente nell’area il frammento di antefissa a testa di satiro (fig. 16), e stucchi e intonaci dipinti di I stile pompeiano (fig. 17), una corrente stilistica nata in ambito greco-ellenisti-co e diffusasi in Italia a partire dal II secolo a.C., che riproduce le ricche decorazioni marmoree degli edifici pubblici.Modelli provenienti dalle aree orientali del Medi-terraneo si ritrovano anche sul vasellame, come ad esempio le coppe decorate a matrice deno-minate “italo-megaresi” (fig. 18) e le lucerne “elle-nistiche a matrice” (fig. 19), prodotte in Italia ma ispirate a tipologie ellenistiche.
N.C. G.R.
la storia, l’arte, il futuroi rePerti Della faSe PreauGuStea
14
fig. 12- Scarti e frammenti di osso che illustrano le varie fasi della lavorazione per la fabbricazione di uno stilo, di cui sono esposti anche alcuni esemplari finiti. Si tratta di oggetti utilizzati per la scrittura su tavolette di cera; alcuni presentano testa appiattita per la cancella-zione degli errori.
fig. 13- Pendente fallico in osso lavorato; la raffigurazione aveva per i Romani sia valore propiziatorio per la fertilità, sia apotropaico: in-fatti possedeva la capacità di attirare su di sé l’attenzione degli occhi malevoli, dai quali si pensava partisse il fascinum, vale a dire il ma-locchio. I sec. a.C.
fig. 14- Piccolo cratere a vernice nera, che riprende la forma di vasi più grandi impiegati sulla tavola per mescolare l’acqua al vino durante il banchetto; l’esemplare trova confronti con recipienti di qualità supe-riore, prodotti in area nord-etrusca. II sec. a.C.
fig. 15- Bicchieri tipo Marabini I-III in ceramica a pareti sottili; ap-partengono ad una tipologia di bicchieri molto diffusa in età tardo-repubblicana, spesso decorata da festoni di punti realizzati alla bar-bottina, vale a dire con colature di argilla. L’annerimento della parte superiore è dovuto a un difetto di cottura. Fine II-I sec. a.C.
fig. 16- Parte di testa di satiro, raffigurante la fronte corrugata, incor-niciata dalla capigliatura a riccioli trattenuta dal cercine; questi per-sonaggi, caratterizzati da ispida barba e naso camuso, rappresentano la personificazione della natura selvaggia e sono collegati al mondo dionisiaco. Il pezzo cremonese è parte di un elemento decorativo del tetto (antefissa). II-I sec. a.C.
fig. 17- Frammenti di intonaco decorati da cubi sovrapposti con facce a differenti colori per accrescere l’effetto prospettico, motivo geo-metrico che rientra nel repertorio figurativo del I stile pompeiano.
Queste pitture sono pertinenti ad un ambiente di pregio, forse un atrio. II sec. a.C.
fig. 18- Coppa italo-megarese decorata da un fregio di bucrani, are e clipei e da un calice di foglie di acanto. Questa tipologia nasce ad Atene nella seconda metà del III secolo a.C., e successivamente viene imitata in Italia. Usata per bere durante il banchetto, poteva sostituire il vasellame metallico a cui si ispirava. II- inizi I sec. a.C.
fig. 19- Parte superiore di lucerna realizzata a matrice secondo un modello di ispirazione ellenistica; utilizzata come strumento da il-luminazione, veniva riempita di olio o sego e accesa mediante uno stoppino posto nel becco. I sec. a.C.
fig. 20- Piattello, con orlo a tesa modanata, bassa vasca e alto piede in ceramica a vernice nera, utilizzata sulla mensa, produzione locale. II-I sec. a.C.
Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14
Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17
Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20
15
Le prime fasi di vita testimoniate dallo scavo (tav. III) sono riferibili a tre tipi di evidenza diversa: solchi con alcuni buchi di palo posti in modo casuale (fig. 9); edifici in legno, un edificio in laterizi. I solchi fanno verosimilmente parte di un sistema di lottizzazione di terreni, mentre ci sono le tracce di al-meno tre edifici in legno, di cui uno, quello nella parte mediana dello sca-vo, particolarmente ben conservato, anche in alzato, perché si trovava in uno strato umido tipo torbiera (fig. 10). Le aree più basse e più umide era-no state bonificate con opere di dre-naggio, con anfore (fig. 11). L’edificio, costituito da paratie di pali in quercus sez. robur (farnia, rovere o rovella) ave-va un pavimento in assi di legno e un tetto con ogni probabilità di Arundo donax oppure Phragmites communis (canna palustre oppure paglia e terra). Il ritrovamento di un grosso deposito di ossa di animali, per lo più bovini, in varie fasi di lavorazione, indica la presenza di una bottega artigianale per la fabbricazione di stili, spilloni,
la faSe PreauGuSteacardini ed elementi decorativi da mo-bilio. Una vasca in legno doveva forse servire per una delle fasi di lavorazio-ne. Altre tracce di fabbricati in legno sono talmente frammentarie da non permettere una ricostruzione della planimetria, ma una serie di piccole fornaci con una considerevole quan-tità di scorie metalliche denota altre piccole attività produttive. A est ver-so il cardo si affacciava una raffinata domus, di cui rimane soltanto un pic-colo lacerto di muro in laterizi; verosi-milmente faceva parte della casa una serie di intonaci dipinti e stucchi del I stile pompeiano.
P.B. L.P.P.
Tav. III
17
la storia, l’arte, il futuro
I materiali di questa fase, recuperati negli stra-
ti di crollo delle stanze e nei vari riempimenti o
livellamenti dell’area, sono un’altra testimonian-
za evidente dell’alto tenore di vita degli abitanti
della casa.
Tra gli arredi, spicca per pregio e raffinatezza
un trapezoforo (sostegno per tavolo), in marmo
“giallo antico” proveniente dalle cave della Nu-
midia (fig. 28). Interessantissimi sono poi i fram-
menti di un grande vassoio realizzato con un
altro tipo di marmo pregiato, il porfido (fig. 29),
che potrebbe addirittura aver fatto parte delle
suppellettili di una residenza imperiale, prima di
giungere nelle mani del dominus cremonese.
Anche tra gli oggetti d’uso quotidiano, in parti-
colare il vasellame da tavola in vetro, ceramica
e metallo, sono numerosi gli oggetti importati
da centri manifatturieri prestigiosi (fig. 30), che
si affiancano alle migliori produzioni locali. Tra
queste ultime, non possono essere dimenticati
i noti bicchieri con pareti sottili e decorazione a
rilievo (i cosiddetti “bicchieri tipo Aco”, dal nome
del principale artigiano che li produsse) (fig. 31),
in parte sicuramente usciti dall’officina di Norba-
nus, che forse si trovava proprio a Cremona.
M.V.
i rePerti Della faSe auGuStea
5
18
Fig. 23- Frammento di intonaco parietale dipinto con figura femmini-le di profilo con girali tra le mani su fondo “rosso pompeiano”. Il moti-vo doveva collocarsi entro un riquadro nella parte altadella parete.
Fig. 24- Frammento del rivestimento in tessere e conchiglie del nin-feo (fontana) monumentale che ornava il giardino della domus.
Fig. 25- Testa di Afrodite tipo Capitolino, da originale rappresentante la dea nuda in atteggiamento pudico. Nonostante la superficie sia in parte consunta dall’azione del fuoco, si riconosce l’altissima qualità della scultura.
Fig. 26- Piccolo frammento di oscillum di forma circolare, con corni-ce piatta a leggero rilievo. Marmo bianco. Su un lato si conserva la porzione superiore di una figura di erote alato, rivolto verso destra,
dalle forme morbide e pingui, tipicamente infantili. Il lato opposto reca invece scarsi resti di rilievo, di difficile lettura (vi si può forse rico-noscere un getto d’acqua fuoriuscente da un vaso, tenuto inclinato da un personaggio quasi completamente perduto).
Fig. 27- Frammento di pavimento a mosaico di tessere minute raf-figurante uccelli e piante palustri. Potrebbe trattarsi di un riquadro o di una fascia, posta all’interno di un mosaico a motivo geometrico bianco e nero.
Fig. 28- Trapezoforo (sostegno per tavolo) in marmo numidico (“gial-lo antico”) decorato a rilevo con elementi vegetali e figure di volatili. Il pezzo, che doveva essere completato da elementi funzionali in me-tallo, mostra la particolare accuratezza degli arredi della domus.
Fig. 29- Vassoio in porfido. A causa della durezza del materiale, che ne rendeva estremamente complessa la lavorazione, questi rari oggetti sono da considerarsi di notevole valore economico, oltreché estetico.
Fig. 30- Rhyton (corno per libagioni) a forma di testa d’antilope in ceramica invetriata. Il tipo è poco diffuso, se si esclude l’eccezionale ritrovamento di dodici esemplari nel deposito del Montirone presso Abano Terme, sicuramente legato anche nell’antichità all’ambito termale.
Fig. 31- Frammento di bicchiere “tipo Aco”. Si tratta di bicchieri pro-dotti entro matrice, con decorazione a rilievo, recanti frequentemente la firma dell’artigiano che li produsse. Il nome convenzionale deriva dal più noto di questi fabbricanti; il pezzo fotografato può essere at-tribuito a Diophanes, uno dei suoi lavoranti.
Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25
Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28
Fig. 29 Fig. 30 Fig. 31
19
Poco dopo la metà del I sec. a.C. l’area delimitata da strade pubbliche fu rial-zata con grandi riporti di terra, e boni-ficata nei punti umidi con vespai costi-tuiti da anfore riutilizzate. In seguito fu costruita una lussuosa residenza (fig. 21) di almeno 4100 mq, verosimil-mente divisa in quattro parti, con aree all’aperto, giardini oppure cortili (tav. IV). Il primo nucleo costruttivo doveva essere di dimensioni leggermente mi-nori, seguito a pochi anni di distanza da opere di ampliamento. I due corpi lungo il lato ovest si svilupparono in-torno a due giardini, dei quali quello verso nord era abbellito da un ninfeo in blu egizio con motivi vari e conchi-glie (fig. 24), mentre a metà della zona a verde si trovava una vasca monu-mentale. Questi luoghi di riposo e di divertimento erano decorati con sta-tue, erme, vasche in pietra, portalam-pade, tavoli e pietre invetriate (figg. 25 e 26). Una parte delle stanze di rap-presentanza, decorate con affreschi all’ultima moda, si affacciava sul giar-
la faSe auGuSteadino. I pavimenti del piano superiore erano a mosaico (figg. 22 e 27), alcuni con motivi decorativi di tipo vegetale o acquatico. Il lato est, forse una zona adibita più a servizi e a botteghe, si svi-luppava intorno a due cortili con va-sche e pozzi. Le zone aperte più nobili erano abbellite da colonne in cotto in-tonacate e ornate da capitelli in pietra di Vicenza. Gli arredi e le suppellettili erano di grande pregio, anche se per la maggior parte gli oggetti di lusso sono persi, poiché andati a far parte del bottino delle truppe vespasianee che misero a ferro e fuoco la città per quattro giorni.
P.B. L.P.P.
Tav. IV
20
La posizione debole di Nerone all’inizio del 68
d.C. aprì la porta ad una serie di lotte intestine,
che portarono a quello che dai posteri venne
chiamato l’anno dei quattro imperatori (il 69
d.C.). Galba, sostenuto in Iberia da Marco Salvio
Otone Governatore della Lusitania, si ribellò
apertamente a Nerone, e fu riconosciuto
Augusto dal Senato; Nerone nel giugno del 68
d.C. si suicidò. Nei primi giorni di gennaio del
69 d.C., durante il tradizionale giuramento, le
truppe di stanza sul limes renano si rifiutarono
di giurare fedeltà all’Imperatore Galba,
preferendo la promessa al Senato e al Popolo
romano, e subito acclamarono Imperatore Aulo
Vitellio. Il 15 gennaio Otone, con l’appoggio
dei Pretoriani, assassinò Galba nel foro, e si
fece proclamare Imperatore dal Senato. La
grave situazione politica non trovò alcuna
soluzione diplomatica, e si passò alle armi.
Contemporaneamente gli eserciti delle zone
orientali dell’impero candidavano Vespasiano.
La pianura padana divenne teatro delle guerre
civili tra Vitellio e Otone. Le ragioni di tali scelte
furono prettamente strategiche; ambedue gli
schieramenti volevano a tutti i costi bloccare
l’avanzata dell’avversario verso Roma. La prima
battaglia, nelle vicinanza di Bedriacum (l’attuale
Calvatone) fu vinta da Vitellio; all’annuncio
della sconfitta Otone, che si trovava nella sua
roccaforte a Brixellum (l’attuale Brescello) si
suicidò. La situazione politica era molto fluida.
Verso la fine della primavera Vitellio entrò a
Roma e fu acclamato Imperatore dal Senato: ma
la sua posizione politica era piuttosto debole:
non aveva il sostegno forte dei centri di potere
tradizionali, e gli mancava il consenso di tutte le
truppe, tant’è che ai primi di luglio Vespasiano
la traGica DiStruzione Del 69 D.c.
Fig. 33Fig. 32
Piazza Marconi: un libro aPerto
21
fu proclamato Augusto da alcune legioni
dell’Egitto e delle province orientali, e dalle
legioni di stanza lungo il limes danubiano. In
autunno la situazione si aggravò; nella Cisalpina
si stavano raccogliendo ancora gli schieramenti
vitelliani e quelli vespasianei. Il 24 ottobre del
69 d.C. l’esercito di Vespasiano si mosse dal
quartier generale a Bedriacum. La città era in
fermento e in grande attività, perché era in
corso la grande fiera autunnale, con gente che
arrivava da tutto il mondo romano. I vitelliani,
accampati subito fuori quella che oggi è Porta
Venezia, furono sconfitti clamorosamente e
si arresero, abbandonando la città al proprio
tragico destino. Tacito ci racconta che la città
fu messa a ferro e fuoco per quattro giorni da
40.000 soldati assetati di vendetta e bramosi di
bottino. L’evidenza archeologica ci conferma
senza ombra di dubbio le parole dello storico:
in diversi scavi sono stati trovati strati di grandi
incendi cronologicamente compatibili con
la distruzione del 69 d.C.: in via Magenta, via
Palestro, via Milazzo, via Cadolini, nella cripta di
Sant’Omobono e, in modo impressionante, in
Piazza Marconi.
Fig. 34
Fig. 32- Elementi di ninfeo, bruciati dall’incendio.
Fig. 33- Nella sezione una stanza distrutta e crollata dal primo piano.
Fig. 34- Parte della domus augustea bruciata e crollata.
Fig. 35- Frammenti di coppa costolata in vetro, fusi dall’in-cendio.
Fig. 36- Applique in bronzo di sileno pertinente all’ansa di una brocca, combusta dall’incendio.
Fig. 36Fig. 35
Fig. 37
22
la storia, l’arte, il futuroLa residenza del IV-V sec. d.C. (tav. V),
che ricalca in parte la planimetria del-
la domus augustea, fu ampiamente
spogliata e distrutta dalle cantine de-
gli edifici posteriori; rimangono labili
tracce di fondazioni e un piccolo lacer-
to della parte inferiore del sistema di
riscaldamento ad ipocausto (fig. 38).
Non sono stati ritrovati né pavimenti
né apparati decorativi a muro. Verso
sud un fabbricato trovato soltanto in
negativo presenta una serie di absidi
di varie misure e curvature (fig. 37); la
mancanza di resti e di una gerarchia
interna degli spazi porta a non defi-
nirlo come impianto termale, mentre
etÀ tarDo antica
Fig. 38 Tav. V
Piazza Marconi: un libro aPerto
23
potrebbe verosimilmente essere iden-tificato come un quartiere di rappre-sentanza della domus: l’uso di absidi è elemento architettonico diffuso in questo periodo. Due aree cortilizie sono state identificate nel saggio ad ovest e nella parte mediana verso est. Sul lato nord-est dello scavo sono sta-te rinvenute tracce di un edificio in le-gno, con lacerti di un pavimento in ter-ra battuta; sul retro, verso sud, passava un piccola canaletta di scolo.
P.B. L.P.P.
Anche i materiali sono, per questa fase, quantitativamente inferiori rispetto alle epoche precedenti.Sembra di poter cogliere le tracce, pur nei limiti imposti dall’incompletezza della do-cumentazione, di un tenore di vita meno “sfolgorante” e più sobrio.Da una parte troviamo oggetti fortemente legati ad esigenze di utilità pratica, come i recipienti in ceramica invetriata (fig. 39), frutto di commerci a medio raggio, che vanno a completare il “corredo da cucina” (fig. 40) composto da pentole e tegami in ceramica grezza; dall’altra, non mancano suppellettili di buona qualità, provenien-ti ora dal Nordafrica, area che proprio in questa fase conosce un grande sviluppo economico. Di produzione africana sono infatti il vasellame da tavola e le lucerne, che venivano trasportate via mare come “merce di accompagnamento” di prodotti alimentari (cereali, olio, vino).Il pettine in osso (fig. 41), infine, ci fa senti-re vicini i gesti quotidiani dei nostri concit-tadini di quindici secoli fa.
M.V.
i rePerti Della faSe tarDo antica
Frammenti di mortai in ceramica invetriata. In epoca tardoimperiale sono molto frequenti questi recipienti, caratterizzati da una vetrina interna di colore verdastro o bruno, che, si suppone, erano legati a particolari usi nell’ambito della preparazione dei cibi.
Ciotola in ceramica depurata. Il vaso, fornito di due anse (manici), è di grandi dimensioni ed è stato rinvenuto all’interno del riempimento di un pozzo.
Pettine in osso con presa di forma triangolare. Il motivo decorativo “a occhio di dado” era ottenuto mediante uno strumento con punta a due o tre denti, che ruotando incideva l’osso.
Fig. 39 Fig. 40 Fig. 41
24
la storia, l’arte, il futuroLe testimonianze di questa fase (tav. VI) sono particolarmente scarse, per-ché distrutte dagli edifici conventuali posteriori. L’unica struttura rimasta è la chiesa di S. Giorgio, che dalla tito-latura potrebbe essere di fondazione alto-medievale. La zona circostante fu adibita già dai primi momenti ad area cimiteriale, continuando fino alla soppressione della parrocchia. La stra-grande maggioranza delle settantacin-que sepolture ad inumazione (Tav. VI)ha andamento E/O, con il capo rivolto verso est ed il corpo in posizione su-pina. La struttura tombale è di forma antropoide, con fondo terragno, rara-
mente con nicchia proteggi testa; le
coperture dovevano essere verosimil-
mente alla cappuccina (fig. 43), anche
se per la maggior parte furono aspor-
tate dalle tombe posteriori. In alcune
delle sepolture più antiche il fondo era
costituito dal pavimento mosaicato
della domus di età imperiale (fig. 42). Ci
sono soltanto dieci casi di inumazioni
multiple, mentre i corredi tombali, in
genere poco usati in questo momen-
to, sono presenti con quattro monete,
tutte di età romana, un pendaglio a te-
sta maschile ed uno spillo in bronzo.
P.B. L.P.P.
etÀ altoMeDieVale-MeDieValeFig. 42
Fig. 43
Piazza Marconi: un libro aPerto
Fig. 42- Fondo di una tomba ad inumazione costituito da un mosaico romano.
Fig. 43- Tomba alla cappuccina.
Tav. VI
25
etÀ altoMeDieVale-MeDieVale
L’estrema esiguità dei materiali di cor-redo dell’area cimiteriale che caratte-rizza questa fase ed il perdurare di cer-te tipologie sepolcrali, complicano di molto la definizione cronologica delle sepolture di S.Giorgio, che possono es-sere datate quasi esclusivamente sulla base di rapporti stratigrafici evidenti (figg. 44 e 45). La mancanza di oggetti di corredo da-tanti può essere facilmente spiegata con i mutamenti nelle credenze impo-ste dalla cristianizzazione e con l’usanza non più di seppellire gli oggetti cari al defunto, ma di tramandarli, valutando-li quindi come bene economico e non come materiali carichi di significato. Curiosa è la presenza, all’interno della tomba 19, di un piccolo ciondolo in bronzo a forma di testa umana stilizzata (fig. 46), caratterizzato da un buffo naso e da una bocca distorta in una smorfia rivolta verso destra, al quale potrebbe essere stato attribuito un valore apo-tropaico. Sempre in bronzo sono un piccolo orecchino di forma circolare ed un gruppo di monete romane, mentre una fusaiola cilindrica in pietra ollare (fig. 47), doveva, con ogni probabilità, appartenere ad un individuo di sesso femminile.
Fig. 44
i rePerti Della faSealtoMeDieVale-MeDieVale
Pendaglio in bronzo a forma di testa umana stilizzata [Tomba 19].Fig. 46
Fig. 47
Se i materiali del corredo ci fornisco-no poche informazioni, molto di più si evince dall’analisi antropologica e patologica degli scheletri. Le indagini demografiche hanno rivelato una so-stanziale corrispondenza nella distri-buzione dei due sessi, con un’età me-dia che si aggirava attorno ai 20 anni, e un’elevata presenza di bambini. Tra le patologie maggiormente diffuse si riconoscono malattie dentarie, perio-stiti (infiammazioni) degli arti inferiori, artriti reumatoidi dovute a carenze ali-mentari e a stress fisici riconducibili a patologie professionali.
E.B.
Fig. 45
Fusaiola a disco in pietra ollare con foro passante centrale circolare. Le fusaiole sono frequentissime nelle tombe femminili e documentano l’attività di filatura e tessitura delle donne dell’epoca [Tomba 101].
27
la storia, l’arte, il futuro
Fig. 51
Il vasellame rinvenuto nel corso degli scavi offre
un’ampia carrellata sulla varietà di produzioni
ceramiche che si sono alternate sulle mense lai-
che e religiose di questa zona della città, dagli
esemplari in graffita arcaica padana del XIV-XV
secolo (figg. 52 e 53) fino quasi ai giorni nostri.
Al monastero francescano sono riconducibili
il bel piatto con trigramma bernardiniano (fig.
54), e le stoviglie della Confraternita delle Stim-
mate, declinate nelle varie tipologie ceramiche
(fig. 55). Il frammento con filatrice (fig. 56) ci ri-
manda alla lavorazione dei tessuti, a lungo una
delle principali attività cittadine; già all’epoca
del Campi, appena fuori delle mura del con-
vento, era la contrada “Belfuso”, il cui nome so-
pravvive nell’attuale toponomastica. Ancora ad
ambiente laico sono verosimilmente riferibili i
due manufatti in maiolica, entrambi importati:
il coperchio in ceramica “latesina” ed il raffinato
piattello in smalto berrettino (fig. 57).
All’ultima fase di vita del complesso, infine, ap-
partengono gli esemplari in terraglia bianca (fig.
58) usati nella casa di ritiro per fanciulle, oggetti
seriali di produzione industriale.
L.P.
i rePerti Della faSe PoSt MeDieVale
Fig. 48- Chiostro del Convento di Sant’Angelo, 1936 ca.
Fig. 49- Pozzo in corso di scavo.
Fig. 50- Ghiacciaia in corso di scavo.
Fig. 51- Particolare della pianta di Cremona disegnata da Antonio Campi nel 1583 e incisa su rame da David de Laude.
28
fig. 52- Boccale con essere fantastico entro medaglione circondato da embricatura a squame. Graffita arcaica padana. Seconda metà XIV secolo.
fig. 53- Piatto con leone marciano. Graffita arcaica padana. L’esem-plare è riferibile al breve periodo della dominazione veneta della città (1499 - 1509). Fine XV - inizi XVI secolo.
fig. 54- Piatto con sigla IHS, sormontata da croce e circondata da raggi fiammanti che simboleggiano gli Apostoli. Graffita policroma a punta e a stecca. Seconda metà XVI secolo. Il simbolo, costituito dalle prime lettere del nome greco di Gesù, ebbe grande diffusione ad opera di san Bernardino da Siena, che lo esponeva durante le sue omelie. Alla presenza di san Bernardino a Cremona è legata l’edifi-cazione del primo convento di S. Angelo nel 1438.
fig. 55- Stoviglie con lo stemma della Confraternita delle Stimmate (1602 - 1775). La Confraternita divulgava la devozione a san Fran-cesco, assisteva poveri e infermi, provvedeva alla dote delle ragazze povere ed alla sepoltura dei confratelli defunti.
fig. 56- Piatto con filatrice. Graffita ramina e ferraccia. Prima metà XVII secolo. Già dal XVI secolo la prosperità di Cremona si basava sul-la lavorazione dei tessuti in fustagno, lana e successivamente seta.
fig. 57- A sinistra piattello in maiolica berrettina di produzione li-gure. XVII secolo. A destra coperchio in maiolica “latesina”. Fine XVII - prima metà XVIII secolo.
fig. 58- A sinistra piatto in terraglia bianca con marchio di fabbrica S.C.RICHARD. 1873-1896. A destra ciotola in terraglia bianca con marchio di fabbrica VILLEROY & BOCH, Mettlach, Germania, XX sec.
Fig. 52 Fig. 53 Fig. 54
Fig. 55 Fig. 56 Fig. 57
Fig. 58
29
A partire dall’età medievale (tav. VII), l’urbanistica dell’area gravitante in-torno alle odierne piazze Marconi e Sant’ Angelo appare caratterizzata da un’alta concentrazione di edifici reli-giosi: S. Giorgio, SS. Cosma e Damia-no, S. Vitale e Geroldo (fig. 51). Solo quest’ultima chiesa, seppure scon-sacrata, è sopravvissuta fino ai nostri giorni. Molto lunga e complessa è in-vece la storia della chiesa e convento titolato ai SS. Cosma e Damiano, i cui documenti più antichi risalgono alla fine del XII - inizi del XIII secolo. Nel 1534 il complesso, già da tempo ab-bandonato dai Benedettini, è ceduto ai frati Francescani che nel 1522, nel corso degli eventi bellici della guerra tra Spagnoli e Francesi, avevano visto distrutta la loro Casa. Anche la nuova sede viene titolata a S. Angelo, come il precedente complesso, che era sta-to eretto a seguito delle infervorate prediche di san Bernardino fuori della cinta muraria, in borgo Ognissanti. A seguito della soppressione napoleo-nica dei beni ecclesiastici del 1810, il convento viene trasformato in casa di ritiro per fanciulle, diretta dalle Suore di Carità. Tutto viene raso al suolo tra 1925 e 1936, e la successiva costru-zione del Palazzo dell’Arte ha definiti-vamente sigillato ogni testimonianza
la faSe PoSt-MeDieValesulla chiesa, circa metà del convento e quasi tutto il chiostro del pluriseco-lare complesso monastico di S.Angelo (fig. 48 e tav. VII).Le campagne di scavo condotte in piazza Marconi hanno interessato l’area che si articolava a nord del chio-stro: sono emersi cantine e ambienti di servizio ascrivibili alla fase della riedificazione francescana del com-plesso (figg. 49 e 50) , che purtroppo hanno obliterato le fasi più antiche del convento benedettino, ed è stato messo in luce parte dello stratificato quartiere che, dal medioevo in poi, si era sviluppato lungo l’antico vicolo Basolaro.
L.P.
Tav. VII
30
Tra il XIX e il XX secolo Cremona vive
una notevole metamorfosi di tipo
urbanistico, contemporaneamente
prodotto e concausa delle evoluzioni
sociali che in questo periodo si susse-
guono su scala nazionale.
L’impostazione ormai ottocentesca
della ‘città giardino’, che privilegia le
aree verdi, i grandi parchi di gusto ro-
mantico e gli edifici dal design ecletti-
co (visione portata avanti dalle prece-
denti amministrazioni), cede il passo al
nuovo corso. Il sopraggiungere della
prima guerra mondiale porta alla de-
finitiva stasi delle opere di edilizia av-
viate nel XIX secolo, lasciando spazio,
nel primo dopoguerra, ad un sentito
desiderio di rinascita, ben espresso
dalle nuove scelte in campo politico e
architettonico.
Gli anni a cavallo tra le due guerre, con
l’avvento del Fascismo, si caratterizza-
no per il particolare desiderio di cam-
biamento, tradotto fisicamente nella etÀ MoDernaFig. 59
Piazza Marconi: un libro aPerto
31
la storia, l’arte, il futuro
Fig. 60
propensione a creare spazi aperti, a
dominare la natura, a demolire l’an-
tiquato e ricostruire secondo canoni
moderni, in altre parole ogni sforzo è
concentrato verso il rinnovo dell’ur-
banistica cittadina (fig. 59). La figura
dell’architetto diviene quindi centra-
le a partire dalla prima metà del ‘900,
poiché egli, assieme all’urbanista, si
fa interprete delle nuove esigenze di
rappresentatività del Regime.
Sul piano nazionale il momento di
svolta politica ricorre nel 1922, quan-
do i massimi rappresentanti del Parti-
to Nazional Fascista di Benito Musso-
lini salgono al governo di molte città
italiane, raccogliendo l’eredità delle
precedenti amministrazioni. Nei piani
del Partito appare da subito prioritario
l’interesse verso l’istituzione di varie
forme di associazionismo, in partico-
lare rivolte ad implementare l’aggre-
gazione e la condivisione ideologica.
La nascita di associazioni dedite all’or-
ganizzazione di attività per il tempo
libero si presenta dunque quale uno
degli aspetti centrali della “liturgia
popolare” (si pensi, ad esempio, alla
nascita dell’Organizzazione naziona-
le del dopolavoro). Queste organiz-
zazioni gestiscono l’intrattenimento
popolare sulla base delle direttive
del Partito e riservano un’attenzione
particolare al campo dell’arte, ritenu-
to uno degli strumenti principe della
propaganda. Attraverso l’esercizio di
alcune pratiche artistiche dilettantisti-
che, la partecipazione ad avvenimenti
quali ad esempio i concorsi di pittura,
gli spettacoli teatrali o l’ascoltazione
della musica tradizionale italiana, si
cerca di convogliare l’opinione di mas-
sa verso la condivisione del pensiero
fascista, sfruttando il legame tra il po-
polo e le sue tradizioni.
In tale contesto ha inizio l’attività am-
ministrativa di Roberto Farinacci, gio-
vane attivista politico. Dal ‘14, anno
in cui sodalizza con Benito Mussolini,
egli prende le distanze dall’ambiente
socialista riformista raccogliendo nu-
merosi consensi tra gli agrari borghe-
si. L’undici aprile del 1919 fonda il Fa-
scio di combattimento a Cremona e,
32
etÀ MoDernalasciato il posto di ferroviere, si dedi-ca alla creazione di altri trentacinque Fasci nella provincia; in questi anni hanno inizio i soprusi e le violenze squadriste che, a Cremona, culmina-no con l’invasione dell’Aula del Con-siglio Comunale il 15 maggio del ’22, precedendo di un giorno la marcia su Roma. Il 22 luglio dello stesso anno il Ministro Facta, sollecitato dai fasci, di-mette il Sindaco socialista di Cremona Tarquinio Bozzoli e la sua giunta, col tacito assenso della cittadinanza. Il 27 ottobre 1922 la dittatura ha ufficial-mente inizio.Nel corso di questi anni il programma amministrativo sul piano nazionale dà ampio respiro all’innovazione urbani-stica (entro ben definiti parametri), e più propriamente alle nuove architet-ture di concezione razionalista, cioè caratterizzate dall’assenza di ogni de-corazione superflua e dall’uso di ma-teriali di produzione nazionale quali pietra, vetro e mattoni, ricorrendo sempre più all’uso della demolizione per creare ampi spazi edificabili, per allargare le vie principali, per creare piazze e portici, a discapito delle ar-chitetture preesistenti (fig. 61).Farinacci non incontra particolari ostacoli nella realizzazione dei pro-getti architettonici programmati, strutture che parlano della grandezza fascista, eccezion fatta per la creazio-ne del mercato coperto, progettato nella zona di piazza S. Angelo ma reso infattibile per l’impossibilità di demo-lire interamente l’omonimo convento (la distruzione viene avviata nel ’25 e
conclusa solo nel ‘36). L’impedimento
è legato alla presenza degli sfollati,
vittime della rivoluzione urbanistica
qui stipate per la penuria di alloggi
popolari. Quest’opera non verrà dun-
que realizzata ma il convento sarà in
ogni caso abbattuto, suscitando l’indi-
gnazione generale della cittadinanza.
Anni dopo, sulle sue vestigia, sorgerà
il Palazzo dell’Arte, ultima realizzazio-
ne commissionata da Farinacci per ce-
lebrare il concorso d’arte “Premio Cre-
mona”, ma che verrà portata a termine
solo nei decenni successivi.A coronamento della lunga serie di realizzazioni, la nascita del Palazzo dell’Arte di Cremona costituisce per Farinacci il trionfo dell’architettura di regime, e di quella politica dell’arte celebrata da lui, come in tutt’Italia, quale alta espressione dell’ideologia di partito ed indispensabile strumen-to di comunicazione.
M.F.
Fig. 61
Piazza Marconi: un libro aPerto
33
il Palazzo dell’arte di cremonaIl Palazzo dell’Arte (fig. 63) viene com-
missionato da Roberto Farinacci e rea-
lizzato per mezzo dell’Ente autonomo
Manifestazioni Artistiche (EaMAC).
Questo edificio nasce ad opera dell’ar-
chitetto napoletano Carlo Cocchia
(1903-1989), per celebrare un concor-
so artistico conosciuto come “Premio
Cremona” (1938-1941). Egli elabora
due progetti: il primo (1941) in linea
con il razionalismo ‘purista’ di quegli
anni contraddistinto da un design
essenziale e privo di ogni decorazione
(fig. 62), il secondo (1942) e definitivo,
caratterizzato da una maggiore ar-monia tra le parti, un ampio piazzale antistante (fig. 64) e un certo gusto ‘mediterraneo’(colonne di richiamo neoclassico e scelta del mattone qua-le materiale della tradizione dalla no-tevole resa plastica).Tra alterne vicende il Palazzo viene co-struito dopo la demolizione, avvenu-ta a partire dal 1925, dell’ormai svin-colato convento di Sant’Angelo (fig. 60). Nonostante il mancato consenso della commissione comunale, solo la
Fig. 62
Fig. 63
guerra e l’autarchia fermano i lavori (8 settembre 1943), portati poi a termine nei decenni successivi.L’edificio ha vissuto così molteplici im-pieghi: scuola di liuteria, sala da ballo, museo naturalistico, stazione delle corriere, sede radioamatori, istituto di arredamento, e molti altri, ma non è stato mai utilizzato per celebrare il “Premio Cremona”.
M.F.
Fig. 64
34
Piazza Marconi: un libro aPerto
il futuro aSSetto Della Piazza
La piazza nel tempo ha sempre rap-
presentato il “luogo dello stare”, de-
dicato all’incontro, alle relazioni, agli
scambi commerciali, allo svolgimen-
to di funzioni, riti e cerimonie: ha
pertanto sempre ricoperto il ruolo
di spazio per la collettività. Con l’uti-
lizzo diffuso dell’auto, la piazza, in
generale, ha perso la sua funzione di
polo aggregativo, divenendo sempre
più un “luogo dell’attraversamento”,
capace di convogliare e racchiudere
i bisogni ed i ritmi dinamici di fruizio-
ne veloce, tipici dei mezzi a motore.
Anche piazza Marconi, negli ultimi
decenni, pur cercando di afferma-
re la propria espressione di spazio
pubblico, è stata sopraffatta dalle
esigenze funzionali di parcheggio a
Fig. 67Fig. 66
Fig. 65
35
il futuro aSSetto Della PiazzaIl testo riprende e sintetizza il progetto presentato da Saba Italia e lo studio di fattibilità di C.S.T. di Milano
raso, configurandosi come un conte-
sto oggettivamente anonimo e privo
d’identità.
Il progetto per la rifunzionalizzazione
della piazza, presentato da Saba Italia
(figg. 65, 68-72) e lo studio di fattibilità
di C.S.T. di Milano (figg. 66-67, 73-75),
hanno pertanto dovuto tener conto
di varie necessità, legate al recupero
di un importante spazio urbano per
usi molteplici, dal mercato alla sosta
(di automobili, ma anche delle perso-
ne), alle manifestazioni pubbliche.
Tutto ciò dovendo sottostare, paral-
lelamente, ad una serie di vincoli, co-
stituiti dai resti archeologici e dall’ar-
chitettura del Palazzo dell’Arte.
Le linee guida di riferimento si posso-
no enunciare come segue: recupero
e riorganizzazione dello spazio urba-
no della piazza, oggi utilizzata come
parcheggio a raso e parzialmente im-
pedita alle funzioni della vita cittadi-
na; esigenza di rapportare il disegno
della piazza al Palazzo dell’Arte, in
vista anche di un suo recupero archi-
tettonico e funzionale; mantenimen-
to e valorizzazione delle testimo-
nianze archeologiche, nel contempo
accogliendo e mettendo in risalto le
stratificazioni storiche; ricerca di una
nuova monumentalità.
Fig. 68
36
In sintesi, quindi, secondo le linee progettuali essenziali che qui si trat-teggiano nelle linee essenziali, Piazza Marconi dovrà essere “recuperata” al traffico di superficie, ma, in quanto spazio pubblico, dovrà anche per-mettere la sosta pedonale e proporsi come luogo collettivo significativo per la vita cittadina, tanto più se si pensa alla sua capacità di caratteriz-zarsi come punto di convergenza e baricentro del territorio urbano, gra-zie alla posizione a ridosso del centro
cittadino.
La necessità di disporre di spazi non solo per le necessarie funzioni di ge-stione del parcheggio interrato (figg. 76-78) ha suggerito ai progettisti so-luzioni differenti.Nel progetto di Saba Italia, l’asset-to della piazza viene disegnato in rapporto al Palazzo dell’Arte, con la realizzazione di una fontana monu-mentale e di una struttura coperta trasparente e leggera che la conclu-dono concettualmente. In questo elemento vengono collocati due vo-lumi chiusi per le strutture di servizio
al parcheggio e al mercato.
Fig. xx
Fig. 71 Fig. 72
Fig. 69
Piazza Marconi: un libro aPerto
Fig. 70
37
Fig. 73
Fig. 72
Lo studio di fattibilità progettuale,
partendo dalla considerazione che,
seguendo il percorso pedonale da
piazza del Comune a piazza Marco-
ni, attraverso piazza Stradivari e via
Monteverdi, si coglie immediata-
mente la veduta del Palazzo dell’Arte,
ha disegnato l’asse planimetrico del-
la piazza lungo una direttrice diago-
nale, che volutamente elude le linee
ortogonali dei palazzi circostanti.
La spianata di piazza, dell’ampiezza
di 80x80 metri, si riduce grazie alla
realizzazione di pareti vetrate, che
insinuano nuove linee prospettiche a
favore di un equilibrio più consono fra
il costruito e il vuoto.
Il progetto propone due fronti vetrati
di circa 30 metri per 9 di altezza, uno
costruito sulla diagonale che taglia
la piazza ed uno perpendicolare a
Palazzo dell’Arte, parallelo a Via Bella
Chioppella.
Le cinque colonne in vetro che si pre-
vede di porre adiacenti alla facciata
ne accentuano il valore figurativo;
inoltre, la colonna assume il signifi-
cato di denominatore comune fra le
esperienze architettoniche succedu-
tesi nel sito, dalla domus romana alla
chiesa medievale sino allo stesso Pa-
lazzo dell’Arte.
il futuro aSSetto Della Piazza
38
Gli spazi tecnici emergenti sulla piaz-za, essenziali per la gestione del par-cheggio sottostante (cassa, uffici di gestione, cabina trasformazione AEM e locali tecnici), saranno volumi se-condari alla facciata vetrata, poiché collocati sul retro e compresi entro telai in acciaio necessari per il soste-gno delle facciate a vetro. Il parcheggio interrato, progettato da Saba Italia in parte a due, in parte a quattro piani, potrà accogliere 480 auto; 60 posti saranno inoltre dispo-nibili nelle aree laterali della superfi-cie della piazza.I resti archeologici mantenuti in situ dopo le operazioni di scavo -il mosaico posto lungo il lato nord-ovest, presso
Fig. 75
Fig. 74
Piazza Marconi: un libro aPerto
39
il quale sarà mantenuta una sezione esemplificativa della stratigrafia del sito, la vasca pavimentata da piccoli laterizi rettangolari, elemento deco-rativo del cortile della domus, il muro portato alla luce dallo scavo del 1983- saranno opportunamente valorizza-ti: per ciascuno di essi sarà realizzato infatti un idoneo sistema di protezio-ne e ostensione, agevolandone il più possibile la fruizione.In particolare, per quanto riguarda la zona della vasca, si è scelto di mante-nere a rotazione i posti auto del primo piano interrato, collocando ai piani inferiori quelli in subconcessione, in modo da rendere effettivamente frui-bile il reperto al maggior numero pos-sibile di persone.
il futuro aSSetto Della Piazza
Fig. 77
Fig. 76
Fig. 78