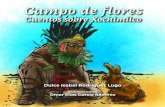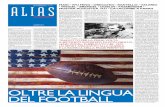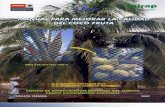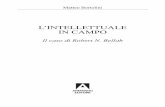Per non lasciare nulla inconscio dell'Inconscio di Alessandra Campo
Transcript of Per non lasciare nulla inconscio dell'Inconscio di Alessandra Campo
Per non lasciare nulla inconscio dell’Inconscio
Relazione incontro 8 marzo di Alessandra Campo
1) LA METAPSICOLOGIA
Con la metapsicologia, Freud indica la dimensione teorica dellapsicanalisi, la sua sistemazione formale, che intende fornire unmodello concettuale delle dinamiche psichiche, collocandosi aldi là dell'esperienza empirica. In Psicopatologia della vita quotidiana,Freud sostiene che la psicoanalisi potrebbe sostituire lametafisica, spiegando ciò che vi è di soprannaturale nel mondocome proiezioni verso l'esterno di moti psichici irrisolti. Puravvertendo il pericolo di una eccessiva teorizzazione, capiscela necessità di fissare il sapere raggiunto in un corpus, che negarantisca la conservazione, in cui però manca una compiuta edefinita sistemazione teorica. Obiettivo della teoria freudianaè infatti quello di ipotizzare un modello dell'apparato psichiconel quale potessero collocarsi le azioni e i pensieri, i bisognie i desideri, il piacere e il dolore, la memoria.
Def. di APPARATO PSICHICO (psychischer Apparat):
“La nostra ipotesi di un apparato psichico spazialmente esteso, composto da piùparti rispondenti a un fine, sviluppatosi dalle esigenze della vita, un apparatoil quale, solo in certi punti e a certe condizioni dà origine al fenomeno della
coscienza, tale ipotesi ci ha messo nelle condizioni di poter edificare lapsicologia su un fondamento analogo a quello di qualsiasi altra scienza della
natura”
(Compendio, 1938).
Il concetto di “apparato psichico”risente dell’influenza dellapsicologia fisicalista della seconda metà dell’ottocento, e inparticolare della psicofisica di Fechner, da cui Freud trasse lebasi teoriche che gli consentirono di concepire l’energia psichicao libido in senso quantitativo e visualizzabile da 3 punti divista: dinamico, economico e topico.
Il punto di vista DINAMICO :
I fenomeni psichici sono concepiti come il risultato di conflittidi forze motivazionali antagoniste o dell'intervento sinergico diforze concorrenti nella medesima direzione: in queste dinamiche, perlo più dialettiche, si articola infatti l’energia psichica. Ilcarattere dinamico spiega fenomeni come quello della resistenza,delle formazioni di compromesso, dell’esistenza di derivati delrimosso, della conversione, ovvero, in generale, fa luce suirapporti psico-fisici per cui lo psichico si converte nel somaticoe viceversa senza alterare le equivalenze dinamico-energetiche (equesto sia che l’energia si manifesti con il corpo sia che siesprima con la mente).
Dal punto di vista dinamico quindi, il modello di funzionamentopsichico è costruito riconducendo tutti i processi a un gioco diforze che si promuovono e inibiscono a vicenda, sotto il dominiodi tre polarità: mondo interno e mondo esterno (reale), piacere edispiacere (economica), attivo e passivo (biologica).
Il punto di vista ECONOMICO :
È il punto di vista che “si sforza di seguire le vicessitudini delle quantità dieccitamento e di pervenire a una loro stima, almeno relativa”
(S. Freud, Metapsicologia, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 85).
L'aspetto economico si riferisce al concetto di energia psichica (energiapulsionale). Secondo Freud, l'energia psichica deriva sostanzialmentedalle pulsioni istintuali, ed esistono soprattutto due distribuzioni dienergia, corrispondenti ai processi primari (tipici dell'inconscio primae dell’Es poi, regolati dal principio del piacere) e ai processisecondari (tipici dell'Io-coscienza, regolato dal principio dellarealtà). I primi rappresentano la tendenza dell'appagamento immediato,che se non realizzato può essere sostituito con l'immagine allucinatoriadell'oggetto di desiderio. I secondi consentono invece di posporre a unimmediato appagamento una soddisfazione più protratta, ma più certa.
Def. LIBIDO:
Termine latino che significa “desiderio” e che Freud impiega perdesignare l’energia corrispondente all’aspetto psichico dellapulsione sessuale; essa è l’espressione dinamica nella vitapsichica della pulsione sessuale.
È l’energia che funge da sostrato delle trasformazioni dellapulsione sessuale riguardo all’oggetto (spostamento degliinvestimenti), alla meta (per es. sublimazione) e alla fontedell’eccitazione sessuale (diversità delle zone erogene).
Def. INVESTIMENTO (Besetzung) o CARICA PSICHICA:
Termine impiegato per designare l’adesione di una quantità di energia psichica (Libido) a un oggetto, a una rappresentazione o auna parte del corpo. Questo concetto ha come sfondo teorico laneurologia di fine ‘800 che parla di spostamenti di eccitabilitànel sistema nervoso.
Def. PULSIONE (Trieb):
In psicologia sperimentale il termine si riferisce alla componentepsicologica di quello stato fisiologico chiamato “bisogno”.
In ambito psicoanalitico la pulsione ci appare come concetto limitetra lo psichico e il somatico, come il rappresentante psichico degli stimoliche traggono origine dall'interno del corpo. Esso è distintodall’istinto (Instinkt) -comportamento animale fissatodall’ereditarietà, caratteristico della specie, preformato nel suosvolgimento e adattato all’oggetto-, in quanto è un costituentepsichico che produce uno stato di eccitazione che spingel’organismo all’attività, anch’essa geneticamente determinata, masuscettibile di variazione entro i confini dell’individualità, edallo stimolo (Reiz), rispetto al quale la pulsione si differenziaper il fatto di trarre origine da fonti interne all’organismo e diagire in modo costante, ragioni per cui l’individuo non puòsottrarvisi con la fuga.
Dalla fonte alla meta la pulsione diviene psichicamente attiva:“noi ce la rappresentiamo come un certo ammontare di energia chepreme verso una determinata direzione. Da questo premere le derivail nome di “pulsione”” (Introduzione alla psicoanalisi, 1932 p. 205).
Fondamentali nell'aspetto economico della metapsicologia sono iprincipi di costanza e di nirvana. Secondo il primo, vi è unatendenza da parte dell'apparato psichico a mantenere costante illivello energetico, livello che secondo il principio di nirvana
tende a essere ridotto il più possibile. Pertanto, da questo puntodi vista, l’apparato ha la funzione di mantenere al livello piùbasso possibile l’energia che circola in esso. Questo lavoro sitraduce nei processi di scarica, spostamento e in tutte quelleoperazioni di investimento e disinvestimento in cui si esprime ladinamica psichica.
Conseguentemente rientrano nella concezione economica le nozionidi catarsi, abreazione e rimozione e, in generale, tutte ledinamiche delle pulsioni per quanto riguarda la fontedell’eccitazione, la meta a cui tendono e l’oggetto che di voltain volta investono.
Da questo punto di vista riveste importanza la distinzione traenergia libera del sistema Inc, legata del Prec e mobile disuperinvestimento per C. Secondo questa distinzione, mutuata dallateoria fisica di H.L.F von Helmholtz, libera è quell’energiainconscia che tende alla scarica nel modo più rapido e direttopossibile e legata quella in cui il movimento verso la scarica èritardato, deviato o controllato. Si noti come questa sia unadistinzione che vale sia a livello biologico-neuronale chepsichico-rappresentativo.
Riassumendo quindi, il modello economico parte dal presupposto chele rappresentazioni psichiche delle pulsioni abbiano uninvestimento energetico, che l'apparato psichico tende a mantenereil più basso possibile. L'affetto può essere unito o meno ad unadeterminata rappresentazione. Nell'inconscio una carica energeticapassa da una rappresentazione all'altra, lungo catene associative(energia libera), mentre, nella coscienza, ogni carica tende arimanere legata alla rappresentazione conveniente (energialegata). Lo slittamento dell'affetto non è casuale, ma risponde aduna logica, la stessa che si coglie nella sintassi del sogno.Nell'inconscio, il movimento delle cariche affettive da unarappresentazione all'altra, è retto dal principio di piacere;infatti, le cariche affettive tendono ad investire prevalentementele tracce di memoria di precoci soddisfazioni. La libido,sottratta agli oggetti sessuali, viene temporaneamente riversata
sulla propria immagine narcisistica e, solo successivamente, cosìneutralizzata, riproiettata sugli oggetti sostitutivi.
Il punto di vista TOPICO :
E’ il punto di vista che prevede che l’apparato psichico sicomponga di un insieme di sottoinsiemi con funzioni e caratteridiversi, disposti secondo un ordine che permetta di raffigurarliin modo spaziale come luoghi psichici. Anche qui Freud è debitoredelle teorie anatomo-fisiologiche delle localizzazioni cerebralie, in particolare, della teoria di T. Meynert che postulava lacoscienza come fenomeno di superficie della corteccia cerebrale egli istinti come espressione epifenomenica delle strutture sub-corticali. Tuttavia, in questa localizzazione, Freud ha sempreevitato la ricerca di un substrato anatomico, limitandosipiuttosto alla definizione di un modello psicologico. L'aspettotopico ha subito successivi rimaneggiamenti nella teoriafreudiana. Nella prima topica, costruita a partire dal processo dirimozione da cui prenderebbe consistenza l’inconscio, l'apparatopsichico è diviso secondo i livelli di coscienza in inconscio,preconscio e conscio e ciascun sistema ha la sua funzione, il suotipo di processo, la sua energia di investimento e i suoicontenuti rappresentativi. Nella seconda, il primo modello venivaampliato con l'introduzione delle istanze psichiche (Es, Io eSuper-Io).
2) LA QUESTIONE DEGLI AFFETTI: LE OCCORRENZE UTILI DI UN TERMINE ALL’OCCORRENZA PIù CHE UTILE
Def. Affekt (lett. “stato di eccitazione”):
Con il termine Affekt Freud riprende la tradizione della psicologiatedesca per indicare un qualsiasi stato affettivo, penoso ogradevole, vago o qualificato, sotto forma di scarica pulsionale.Affekt è cioè il termine che indica l’espressione qualitativa dellaquantità di energia pulsionale. Nel “normale” sviluppo affettivo ègeneralmente legato a una rappresentazione.
Quando l’abreazione non ha luogo (no reviviscenza-deflussoaffetto), tre sono i possibili destini dell’affetto: conversione,
spostamento e trasformazione. Questi tre destini sottointendonoun’autonomia dell’affetto dalle sue manifestazioni per spiegare laquale Freud ricorre alla distinzione tra Affekt e Affektbetrag, il primoessendo la traduzione soggettiva (qualitativa) della quantità dienergia pulsionale, il secondo coincidendo al contrario con ladimensione quantitativa-oggettiva della stessa.
L’ammontare affettivo corrisponde, in effetti,
“alla pulsione nella misura in cui quest’ultima si è staccata dallarappresentazione e trova un modo di esprimersi proporzionato al suo valorequantitativo in processi che vengono avvertiti sensitivamente come affetti”
(S. Freud, Metapsicologia, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 60-61)
La questione degli affetti inconsci è sviluppata nel terzocapitolo del saggio del 1915 sull’inconscio, capitolo che si aprecon l’affermazione che meglio di tutte chiarisce la naturaambivalente della pulsione, il suo carattere di ponte tra il somae la psiche:
“La contrapposizione tra conscio e inconscio non può applicarsi alla pulsione,la quale non può mai diventare oggetto della coscienza: solo l’idea (Vorstellung)
che la rappresenta lo può. Ma anche nell’inconscio la pulsione non può cheessere rappresentata da un’idea (Vorstellung)1. Se la pulsione non fosse ancorata auna rappresentazione o non si manifestasse sottoforma di uno stato affettivo,
non potremmo sapere nulla di essa”
(Würde der Trieb sich nicht an eine Vorstellung heften oder nicht als ein Affektzustand zum Vorscheinkommen)
(Ivi, p. 80)
Quando parliamo di “moto pulsionale inconscio o rimosso” si tratta–sostiene Freud- di “un’innocua negligenza linguistica”; di fatto:
1 Se si accetta, come vedremo più avanti, l’equiparazione tra corporeo-quantitativo e psichico qualitativo, si comprende come mai la pulsione abbiabisogno di una rappresentazione anche nell’inconscio: questo è infatti descrittocome un sistema psichico reale e, in quanto tale, implica quindi giàun’organizzazione qualitativa, una certa traduzione o, appunto,rappresentazione. A ciò si aggiunga che il punto di vista è quello dellacoscienza-mente che si rapporta e cerca di “sapere” qualcosa dell’inconscio-corpo, ovvero che l’inconscio pulsionale in quanto tale non è mai accessibile insé e per sé alla coscienza che cerca di conoscerlo.
“ci riferiamo certamente a un moto pulsionale la cui rappresentanza ideativa èinconscia, perché d’altro non può trattarsi”
(Wir können nichts anderes meinen als eine Triebregung, deren Vorstellungsrepräsentanz unbewußt ist,denn etwas anderes kommt nicht in Betracht)
(Ibidem)
Da ciò segue che: solo l’affetto e la rappresentazione possono arigore dirsi “inconsci”, perché solo questi possono essere rimossi.
Domanda: Può pesare su quest’affermazione l’identificazioneancora quasi sostanziale tra inconscio e rimosso?L’attribuzione del carattere inconscio a qualcosa è infattiancora molto legata al destino della rimozione.
Ma Freud insiste nel chiedersi come mai, nella prassipsicoanalitica, si parli di “odio e amore inconsci”, “angoscia ecolpa inconsce” ecc. Invero, posto che faccia parte della naturadel sentimento il fatto che esso sia avvertito e quindi noto allacoscienza, seguendo il senso comune, sembra impossibile uno “statoinconscio” per sentimenti, affetti e sensazioni (Gefühlen, Affekten undEmpfindungen).
“Può però accadere che un impulso affettivo o emotivo (Affekt oder Gefühlsregung) siapercepito ma misconosciuto. La rimozione di ciò che propriamente lo rappresental’ha costretto a congiungersi con una rappresentazione diversa ed esso è ora
considerato dalla coscienza come una manifestazione di quest’ultima”
(Sie ist durch die Verdrängung ihrer eigentlichen Repräsentanz zur Verknüpfung mit einer anderenVorstellung genötigt worden und wird nun vom Bewußtsein für die Äußerung dieser letzteren gehalten)
(Ivi, p. 81)
In questo caso possiamo senz’altro dire che l’impulso affettivo(Affektregung) originario è inconscio, ma non che lo è l’affetto(Affekt) in quanto, a ben vedere, è soltanto stata rimossa la suarappresentazione (Vorstellung). Verrebbe da dire che, in questo caso,l’emozione non ha trovato parola.
Scrive Freud:
“l’uso delle espressioni affetto inconscio e sentimento inconscio si richiama aidestini in cui è incorso il fattore quantitativo del moto pulsionale in seguito
alla rimozione”
(Der Gebrauch der Ausdrücke »unbewußter Affekt« und »unbewußtes Gefühl« weist überhaupt auf dieSchicksale des quantitativen Faktors der Triebregung infolge der Verdrängung zurück)
(Ibidem)
L’ambiguità per ora deriva dal fatto che il termine “affetto” siaassociato al fattore quantitativo, laddove quest’espressione èresa invece dal tedesco Affektbetrag e non già da Affekt o Gefühl. Mal’ambiguità è forse insopprimibile visto che si tratta di duefacce della stessa medaglia: la prima quantitativa e la secondaqualitativa.
Facendo un passo indietro al saggio sulla rimozione, ci siricorderà del seguente passo in cui Freud definisce il concetto di“rappresentanza pulsionale” (Triebrepräsentanz):
“Nelle considerazioni fatte finora ci siamo occupati della rimozione di unarappresentanza pulsionale intendendo con questa una rappresentazione o un gruppo
di rappresentazioni che sono state investite, ad opera della pulsione, di uncerto ammontare di energia psichica (Libido, Interesse)”
(In den bisherigen Erörterungen behandelten wir die Verdrängung einer Triebrepräsentanz und verstandenunter einer solchen eine Vorstellung oder Vorstellungsgruppe, welche vom Trieb her mit einem bestimmten
Betrag von psychischer Energie (Libido, Interesse) besetzt ist).
(Ivi, p. 60)
La rappresentanza pulsionale sarebbe cioè una rappresentazionecaricata, un pensiero corporeo, un conoscere che sente.
A ciò si aggiunga che, poco più avanti, Freud definisce nel modoseguente il termine Affektbetrag:
“esso corrisponde alla pulsione nella misura in cui quest’ultima si è staccatadalla rappresentazione e trova un modo di esprimersi proporzionato al suo valore
quantitativo in processi che vengo avvertiti sensitivamente come affetti”
(Es entspricht dem Triebe, insofern er sich von der Vorstellung abgelöst hat und einen seiner Quantitätgemäßen Ausdruck in Vorgängen findet, welche als Affekte der Empfindung bemerkbar werden).
(Ibidem)
L’affetto cioè sarebbe la sensazione corrispondente al processomediante cui la pulsione trova una sua autonoma (perché staccatadalla rappresentazione) espressione, espressione proporzionata alsuo valore quantitativo. La pulsione, in quanto rappresentantepsichico, ha perciò due elementi (che sono i due elementi dellaRepräsentanz): la rappresentazione e l’affetto. E tuttavia, comevedremo, a seconda di quale elemento la compone, si ha una logicae un ordine del rappresentare distinto.
Di nuovo, la sovrapposizione semantica tra Affekt e Affektsbetragsembrerebbe fondarsi sul fatto che, presi assieme, i due terminiindicano rispettivamente, l’aspetto psichico-qualitativo e quellocorporeo-quantitativo della stessa energia pulsionale.
Sempre nel saggio sulla rimozione, per i due elementi vengonoillustrati due destini diversi: per la rappresentazione ideativaessa, è detto, “scompare dalla coscienza se prima era cosciente, oviene tenuta lontana dalla coscienza se era in procinto didiventare cosciente” (Ivi, p. 61). Diversamente, il destino delfattore quantitativo (o affetto) può essere di 3 tipi:
“la pulsione può essere totalmente repressa (..) oppure essa si manifesta comeun affetto con una coloritura qualsivoglia di tipo qualitativo oppure si tramuta
in angoscia”
(Das Schicksal des quantitative Faktors der Triebrepräsentanz kann ein dreifaches sein, wie uns eineflüchtige Übersicht über die in der Psychoanalyse gemachten Erfahrungen lehrt: Der Trieb wird entwederganz unterdrückt, so daß man nichts von ihm auffindet, oder er kommt als irgendwie qualitativ gefärbter
Affekt zum Vorschein, oder er wird in Angst verwandelt).
(Ibidem)
E Freud aggiunge che questi ultimi due destini rappresentano unanuova possibilità rispetto a quelli precedentemente elencati:
“il nuovo destino in cui possono incorrere le pulsioni sarebbe quello di vedertrasformate le proprie energie psichiche in affetto (angoscia in particolare)” (Die beiden letzteren Möglichkeiten stellen uns die Aufgabe, die Umsetzung der psychischen Energien der
Triebe in Affekte und ganz besonders in Angst als neues Triebschicksal ins Auge zu fassen.)
(Ibidem)
Quindi l’affetto non è energia. Piuttosto, le ultime duepossibilità rappresentano il caso in cui la pulsione, staccatasidalla rappresentazione, trova una sua propria e adeguataespressione avvertita dall’organismo sottoforma di affetto. Edunque, affetto come traduzione qualitativa dell’energia(quantificabile) non mediata da rappresentazione. Purarappresentanza.
Sorge a questo punto un’altra ambiguità: i due elementi dellaRepräsentanz sembrano escludersi a vicenda: o rappresentazione, oaffetto. Detto altrimenti: solo se si stacca dallarappresentazione, la pulsione può trovare espressione adeguata intermini di affettività. Ma quest’ambiguità sarà sciolta piùavanti.
A ciò si aggiunga che, affermando che il destino dell’ammontareaffettivo della rappresentanza pulsionale (das Schicksal des Affektbetragsder Repräsentanz) sia di gran lunga più importante di quello dellarappresentanza ideativa, Freud sembra riferirsi a quanto affermeràpoco più in là, ovvero che:
“i diversi meccanismi della rimozione hanno in comune per lo meno un fattore: lasottrazione dell’investimento energetico (o libido se si tratta delle pulsioni
sessuali)”
(daß den Mechanismen der Verdrängung wenigstens eines gemeinsam ist, die Entziehung derEnergiebesetzung (oder Libido, wenn wir von Sexualtrieben handeln).
(Ivi, p. 63)
La sottrazione dell’investimento-carica energetica-ammontareaffettivo è dunque il bersaglio numero uno. La pura e sconnessarappresentazione non è un pericolo come dimostra l’analisi delladementia praecox.
Approssimandoci a un parziale scioglimento si può affermare che ilfatto che la rappresentanza pulsionale sia una rappresentazionecaricata (Ivi, p.60) allude alla presenza dei due elementi, deiquali però uno presenta un carattere essenzialmente duplice(quantitativo-qualitativo).
Riprendendo il saggio sulla rimozione, nel capitolo terzo Freudafferma che i destini del fattore quantitativo possono essere ditre tipi:
- l’affetto permane immutato- l’affetto si trasforma in un ammontare affettivo
qualitativamente diverso (einen qualitativ anderen Affektbetrag),soprattutto angoscia
- l’affetto viene represso
e che la “repressione dello sviluppo affettivo” (Affektentwicklung)costituisce il vero e proprio compito della rimozione (non era laliquidazione del fattore quantitativo o sottrazionedell’investimento? È lo stesso?)
Freud continua dicendo che “in tutti i casi in cui la rimozioneriesce a inibire lo sviluppo degli affetti (Affektentwicklung) noidiciamo che quegli affetti (Affekte) sono inconsci”. Vale a direogni volta che viene inibita la traduzione della quantità inqualità? È questo che si intende con l’espressione “sviluppoaffettivo”?
Il quadro si complica quando, riprendendo i due diversi destini incui incorrono i due elementi della rappresentanza, scrive che:
“rispetto alla rappresentazione (Vorstellung) inconscia esiste la seguentesignificativa differenza: dopo la rimozione, la rappresentazione (Vorstellung)inconscia continua a sussistere come struttura reale nel sistema Inc, mentre
all’affetto inconscio corrisponde, in quella stessa sede, solo una potenzialità(Ansatzmöglichkeit), uno spunto che non ha potuto dispiegarsi”
(Ivi, p. 81)
Conseguentemente, sebbene l’espressione “affetto inconscio” siaineccepibile, non ci sono dunque affetti (Affekte) inconsci nellostesso modo in cui ci sono rappresentazioni (Vorstellungen) inconsce.
“Tuttavia –continua Freud- nel sistema Inc ci possono essere benissimo dellestrutture affettive (Affektbildungen) che, al pari di altre strutture, diventano
coscienti. Tutta la differenza deriva dal fatto che le rappresentazioni sonoinvestimenti –sostanzialmente di tracce mnestiche- mentre gli affetti e isentimenti corrispondono a processi di scarica le cui manifestazioni ultime
vengono percepite come sensazioni”
(Der ganze Unterschied rührt daher, daß Vorstellungen Besetzungen –; im Grunde von Erinnerungsspuren –;sind, während die Affekte und Gefühle Abfuhrvorgängen entsprechen, deren letzte Äußerungen als
Empfindungen wahrgenommen werden).
(Ivi, p. 82).
La rimozione può pertanto impedire la conversione del motopulsionale in una manifestazione affettiva (die Umsetzung derTriebregung in Affektäußerung zu hemmen). Può cioè liquidare l’Affektsbetrag?Fosse, ancora e di nuovo, che la liquidazione coincidesse conl’impedimento della traduzione del quantitativo nel qualitativo,impedimento il cui primo passo sembrerebbe coincidere conl’inibizione del processo di scarica?
Dall’analisi condotta nel terzo capitolo emergono i seguentiaspetti:
> La rimozione ha più valore in quanto il suo esito non coincidesoltanto con la messa al bando di qualcosa dalla coscienza, maanche col trattenere il dispiegamento degli affetti e lamotivazione all’attività muscolare (sondern auch von der Affektentwicklungund von der Motivierung der Muskeltätigkeit aufzeigt).
> L’affettività si manifesta perciò essenzialmente come scaricamotoria da cui risulta una alterazione (interna) del corpo(affetto), senza rapporto col mondo esterno. La motilità siesprime invece in azioni destinate a modificare il mondo esterno(Die Affektivität äußert sich wesentlich in motorischer (sekretorischer, gefäßregulierender)Abfuhr zur (inneren) Veränderung des eigenen Körpers ohne Beziehung zur Außenwelt, dieMotilität in Aktionen, die zur Veränderung der Außenwelt bestimmt sind)
> Il sistema C sembrerebbe controllare sia la motilità chel’affettività, sebbene quest’ultima con maggior difficoltà.
> L’importanza del sistema C per l’accesso allo sfogo affettivo eall’azione (Affektentbindung und Aktion) ci fa capire meglio qualefunzione spetti alla rappresentazione sostitutiva nel determinarela forma morbosa. Invero, quando lo sviluppo affettivo(Affektentwicklung) procede direttamente dall’Inc (senza essere cioèmediato dalla C-linguaggio), esso ha allora sempre il caratteredell’angoscia, la quale prende il posto di tutti gli affetti
rimossi (verdrängten Affekte)2. Quando invece il moto pulsionale(Triebregung) è mediato da una rappresentazione sostituiva(Ersatzvorstellung), esso trova la parola, si raffredda e si determinaqualitativamente anche in altri modi.
“In questo caso lo sviluppo dell’affetto può avvenire soltanto a partire daquesto sostituto cosciente la cui natura determina il carattere qualitativo
dell’affetto stesso”
(Dann ist die Affektentwicklung von diesem bewußten Ersatz her ermöglicht und der qualitative Charakterdes Affekts durch dessen Natur bestimmt)
(Ivi, p. 83)
Conclusioni: nel caso della rimozione si verifica una separazionedell’affetto (Affekt) dalla rappresentazione (Vorstellung) e così sisottrae l’investimento visto che l’affetto è sempre la traduzionequalitativa-soggettiva della dimensione quantitativo-oggettivadella pulsione, ma di regola, scrive Freud, il processo è ilseguente:
“un affetto non si esprime fintanto che non è riuscito a conquistarsi qualcosadi nuovo che lo rappresenti nel sistema C”
(daß ein Affekt so lange nicht zustande kommt, bis nicht der Durchbruch zu einer neuen Vertretung imSystem Bw gelungen ist).
(Ibidem)
3) IL RICONOSCIMENTO DELL’INCONSCIO (breve sintesi dei paragrafi5-6-7)
- Il nucleo dell’inconscio è caratterizzato da rappresentanzepulsionali (Triebrepräsentanz) che aspirano a scaricare ilproprio investimento, dunque da moti del desiderio 3 . Questimoti sono tra loro coordinati, esistono gli uni accanto agli
2 Alla luce anche delle più recenti acquisizioni in ambito psichiatrico, questosembrerebbe essere il caso in cui non si è sviluppata la funzione riflessiva, incui cioè la mentalizzazione non è avvenuta. È per questo infatti che siamoassaliti da un marasma sensoriale senza-nome e tale assalto è contrassegnato inprimo luogo da angoscia profonda.3 Freud lo paragona alla “popolazione preistorica della psiche” (Ivi, p. 98)
altri senza influenzarsi e non si pongono in contraddizionereciproca (cfr. formazioni di compromesso).
- In questo sistema non esiste la negazione, né il dubbio, nélivelli diversi di certezza: tutto ciò viene introdotto solodal lavoro della censura tra Inc e Prec.
o Es. Negazione= sostituto rimozione a un più altolivello
- Nell’Inc ci sono solo contenuti forniti di un investimentopiù o meno forte Mobilità
- Processo primario = spostamento e condensazione = meccanismicon cui le rappresentazioni cedono o acquistano il loroinvestimento
- I processi del sistema Inc sono atemporali (anche larelazione temporale è legata a C) e non tengono conto dellarealtà: sono soggetti al principio di piacere e il lorodestino dipende soltanto dalla loro forza e dal fatto chesoddisfino o meno alle richieste del meccanismo che regola ilrapporto piacere-dispiacere.
Ricapitolando quindi i caratteri dell’inconscio sono:
ASSENZA DI RECIPROCA CONTRADDIZIONE PROCESSO PRIMARIO (MOBILITA’ INVESTIMENTI) ATEMPORALITA’ SOSTITUZIONE DELLA REALTA’ ESTERNA CON LA REALTA’ PSICHICA
(PROCESSO PRIMARIO) INTENSA INFLUENZA SUI PROCESSI SOMATICI (che l’atto cosciente
difficilmente raggiunge)
L’inconscio si configura quindi come un sistema i cui contenutisono i rappresentanti delle pulsioni, contenuti regolati daimeccanismi propri del processo primario (condensazione espostamento).
Rispetto a questo la nevrosi e il sogno appaiono essere le unichecondizioni in cui, in virtù di una riduzione-regressione dideterminati processi del sistema superiore a una fase precedente,i processi inconsci diventano accessibili alla conoscenza. Essi
sono altrimenti inconoscibili in sé e per sé, incapaci diesistenza.
Per contrapposizione ai caratteri sovramenzionati del sistemaInc, quelli del Prec risultano essere essenzialmente:
- Inibizione alla scarica (energia legata)- Capacità di rendere possibile la comunicazione tra diversi
contenuti- Temporalità, ordine cronologico- Introduzione dell’esame di realtà
Per quanto concerne la comunicazione tra i due sistemi Freudafferma che:
- Il rapporto è vivo e non è solo di rimozione. In particolare,l’Inc è vivo, si prolunga nelle sue propaggini, si lasciacondizionare dalle vicende dell’esistenza, influenza ed èinfluenzato dal Prec.
- Le propaggini del sistema Inc sono diverse, alcune simili alC altre affatto.
- La censura è da immaginarsi sia tra Inc e Prec (vs Inc) siatra Prec e C (vs propaggini): la censura è cioè presente adogni passaggio a un livello superiore4. Detto altrimenti, ciòche viene liquidato è l’idea di una successione continua dinuove trascrizioni.
- La consapevolezza, precisa Freud, non è affatto un criteriodi distinzione tra i sistemi. Non è l’unico aspetto/sintomo,sebbene sia l’unica caratteristica della psiche che ci sirivela con immediatezza.
Rispetto alla comunicazione dell’Inc con gli altri sistemi èda rilevare come:
- Alle radici dell’attività pulsionale i sistemi comunicano traloro nel modo più intenso
4 Questa successione fa luce anche sulla verticalità dell’organizzazionepsichica.
- Tra l’Inc e la percezione esterna vi è una comunicazionelibera
- Si dà la possibilità di una relazione tra inconsci di diversiindividui che elude il C
CONCLUSIONE PROVVISORIA: il contenuto della sfera cosciente derivain parte dall’attività pulsionale (attraverso la mediazionedell’Inc) e in parte dalla percezione.
Nel settimo paragrafo Freud ci invita però a prendere inconsiderazione, accanto alla vita onirica e alle nevrosi ditraslazione, i risultati degli studi sulle nevrosi narcisistiche,in quanto è così possibile, a suo avviso, ricavare ulterioriinformazioni su questo sistema altrimenti davvero enigmatico eoscuro. E questo soprattutto focalizzando l’attenzione sul ruoloche in queste ultime svolge l’investimento oggettuale.
Nelle nevrosi di traslazione, l’investimento oggettuale è ingenere mantenuto, nonostante la rimozione o, per meglio dire,in virtù di essa. In effetti la capacità di traslazionepresuppone proprio un investimento oggettuale inalterato.
Nella schizofrenia, la libido sottratta agli oggetti non necerca di nuovi e si ritira piuttosto nell’Io ripristinandocosì uno stato primitivo di narcisismo privo di oggetti incui domina l’antitesi Io-Mondo. Interessanti, in questapatologia, sono le mutazioni del linguaggio5.
“Nella schizofrenia le parole sono sottoposte allo stesso processo che trasformai pensieri latenti del sogno in immagini oniriche ovvero, al processo psichicoprimario. Esse vengono condensate e, in virtù dello spostamento, trasferisconointeramente i loro investimenti l’una sull’altra. Questo processo può spingersifino al punto che un’unica parola, a ciò predisposta dalla molteplicità dellesue relazioni, si assuma la rappresentazione di un’intera catena di pensieri
(parole come cose)”
(Ivi, p. 102)
5 Si veda l’esempio di Tausk: linguaggio d’organo il rapporto con l’organorappresenta l’intero contenuto del pensiero.
A conferire alla formazione sostitutiva e al sintomo schizofrenicoil loro carattere peregrino è, per Freud, il predominio delrapporto verbale su quello reale. La sostituzione cioè non èdettata dalla somiglianza delle cose indicate, quanto piuttostodall’uguaglianza dell’espressione linguistica. E questo èpossibile perché si è abbandonato l’oggetto6.
Freud può ora rispondere all’annosa questione sollevata nei primiparagrafi del saggio sull’Inconscio circa il significato dellatrasposizione di un atto psichico da un sistema a un altroaffermando che non si tratta né di una trascrizione, né di unmutamento di stato.
Scrive:
“Ciò che abbiamo potuto chiamare la rappresentazione conscia dell’oggetto siscinde ora nella rappresentazione della parola e nella rappresentazione della cosa;
quest’ultima consiste nell’investimento, se non delle dirette immagini mestichedella cosa, almeno delle tracce mestiche più lontane che derivano da quelleimmagini. Tutto a un tratto pensiamo di aver capito in che cosa consista ladifferenza fra una rappresentazione conscia e una rappresentazione inconscia.
Contrariamente a quanto avevamo supposto, non si tratta di due diversetrascrizioni dello stesso contenuto in località psichiche differenti, e neanchedi due diverse situazioni funzionali dell’investimento nella stessa località; la
situazione è piuttosto la seguente: la rappresentazione conscia comprende larappresentazione della cosa più la rappresentazione della parola corrispondente,mentre quella inconscia è la rappresentazione della cosa e basta. Il sistema Inccontiene gli investimenti che gli oggetti hanno in quanto cose, ossia i primi eautentici investimenti oggettuali; il sistema Prec nasce dal fatto che questa
cosa viene sovrainvestita in seguito la suo nesso con le relativerappresentazioni verbali. Abbiamo il diritto di supporre che siano tali
sovrainvestimenti a determinare una più alta organizzazione psichica, e renderepossibile la sostituzione del processo primario con il processo secondario che
domina nel Prec”
(Ivi, p. 105)
6 In relazione all’abbandono degli investimenti oggettuali tipico dellaschizofrenia, tutto questo significa che sono gli investimenti dellerappresentazioni cosali degli oggetti a essere abbandonati e non dellerappresentazioni verbali degli stessi. Si crea così una sconnessione.
Il sistema Inc contiene quindi gli investimenti che gli oggettihanno in quanto cose (ossia i primi e autentici investimentioggettuali) e il sistema Prec nasce dal fatto che questarappresentazione della cosa viene sovrainvestita in seguito al suonesso con le relative rappresentazioni verbali
Sovrainvestimento organizzazione psichica superiore
“A questo punto siamo in grado di indicare con precisione cos’è la rimozionericusa nelle nevrosi di traslazione alla rappresentazione respinta: le ricusa la
traduzione in parole destinate a restare congiunte con l’oggetto. Larappresentazione non espressa con parole, o l’atto psichico non sovrainvestito,
resta allora nell’Inc, rimosso”
(Ibidem)
CONCLUSIONI:
- Il Linguaggio si configura così come quel sovrainvestimentoche è condizione di possibilità del passaggio alla coscienza.
- La congiunzione di rappresentazione di cosa e di parola èpropria solo del Prec.
- Sia nelle nevrosi di traslazione che nella schizofrenia, ilprocesso di rimozione è caratterizzato da una fuga dell’io,tentativo che si esprime in una sottrazione dell’investimentocosciente.
- Nella schizofrenia le cose concrete vengono trattate come sefossero astratte
- La nostra attività psichica si muove lungo due direzioni:dalle pulsioni, attraverso il sistema Inc, verso l’attivitàcosciente del pensiero; dalle sollecitazioni esterne,attraverso il sistema Prec e C, fino agli investimentiinconsci dell’io e degli oggetti (cfr. il caso dellaschizofrenia: dalle parole alle cose).
4) CARTOGRAFIE DELL’IRRAGGIUNGIBILE: LA REPRÄSENTANZ
Nel terzo capitolo, in cui è affrontata la questione dei sentimenti edegli affetti, troviamo il concetto di Vorstellungsrepräsentanz. Lacontrapposizione di conscio e inconscio – sottolinea Freud- non riguardala pulsione, che non può mai diventare oggetto di coscienza. Solo l'ideache la rappresenta lo può. Ma anche nell'inconscio - aggiunge - lapulsione è rappresentata da un'idea. La rappresentazione che rappresenta lapulsione è, appunto, una Vorstellungsrepräsentanz. Questa nozione è peròdiversa dalla Triebrepräsentanz perché, come stiamo per vedere e abbiamoannunciato, i due ordini del rappresentare rimandano a due logichediverse.
La ragione per cui la pulsione necessita di una rappresentanzapsichica è individuabile nella concezione freudiana dellopsichismo inconscio come kantiana cosa in sé. La pulsione habisogno di una rappresentanza psichica non perché sia un processosomatico, ma perché è quella X sconosciuta di cui possiamoprendere coscienza solo attraverso i suoi rappresentanti, checonsistono nella rappresentazione (Vorstellung) e nell'affetto(Affekt). In tal modo, è possibile una "traduzione cosciente" dellopsichismo inconscio, in se stesso inconoscibile. La pulsione è intanto una X sconosciuta in quanto è da sempre una barriera dicontatto tra il soma e la psiche, tra corpo e mente. Corpo e mentesono per Freud copresenti ma eterogenei ed è per questo motivoche, per descrivere il loro rapporto, il padre della psicoanalisipreferisce alla più classica nozione di Vorstellung, ossia dirappresentazione come “stare davanti a”, quella ben diversa e diorigine politica di Repräsentanz. Lo statuto proprio dellarappresentanza è infatti espresso dalla capacità di qualcosa oqualcuno di stare al posto di qualcosa o qualcun altro, dicostituire perciò una delega, laddove un rapporto diretto intermini di partecipazione e conoscenza è interdetto. Invero,possiamo avere una qualche forma di conoscenza dellarappresentanza rimossa, come si è visto più volte, ripercorrendoin senso inverso il cammino della rimozione mediante le libereassociazioni e il lavoro analitico in generale, mediante cioè unlavoro di traduzione infinito. Ma ciò che legittima il lavorodelle libere associazioni e rende possibile comprendere i segnidel linguaggio dell'inconscio, coglierne le interdipendenze e lerelazioni con il conscio, è proprio la Repräsentanz, che è il primoanello della catena associativa, mediante il quale lo psichico siinscrive nel piano delle significazioni decifrabili.
-----------------------------------------------------------
Per chi già possiede una certa familiarità con i testimetapsicologici freudiani non è difficile evidenziare, brevemente,le trasformazioni più rilevanti che la teoria freudiana subiscenel passaggio dalla sua prima visione dell’apparato psichico allaseconda, in quel trascorrere appunto dalla prima alla secondatopica che si consuma agli inizi degli anni ’20. Il passaggio dalmodello articolato secondo la distinzione Inconscio-Preconscio-Conscio all’articolazione in Es-Io-Super-io è scandito da unabbandono della prima tipologia delle pulsioni, per la quale le“pulsioni libidiche” si opponevano alle “pulsioni diautoconservazione dell’Io”, a favore di una dialettica, che,sottraendo ogni carica pulsionale originaria all’Io, vede oraunicamente nell’Es inconscio il deposito affettivo-emozionaledella personalità, strutturato a sua volta secondo un antagonismo,profondamente diverso da quello precedente e che ora è quello traEros e Thànatos, tra “pulsioni di vita” e “pulsioni di morte”. Inconseguenza di questa nuova filosofia pulsionale, l’inconscio noncoincide più e non si esaurisce nel rimosso ma diviene il luogodove originano il desiderio e le passioni, luogo radicato nelcorpo che se ne fa rappresentante emozionale nella mente. Come neconsegue ancora che le tre “stanze” della prima topica, o luoghidella mente, in ciascuna delle quali si gioca una logica e unafunzionalità diversa del rappresentare/pensare, divengano ora, apartire dalla nuova tipologia delle pulsioni, più che luoghi,“istanze” – vale a dire, quasi persone – secondo il cui diversodesiderare e pensare si scinde e si compone la personalità.
Ma ciò che permane come fondamento immutevole dell’interosvolgersi della riflessione di Freud, includendo perfino ilperiodo preanalitico di studi e di ricerche neurologiche, è laconcezione biologica dell’essere vivente basata sul fisicalismoenergetico da un lato e la teoria della rappresentazione/pensieroche ne consegue dall’altro: d’assumere, quest’ultima, quale“chiave di volta” della configurazione dell’apparato psichicocomplessivo, o detto con parole d’oggi, quale chiave di volta delrapporto mente-corpo.Volendo cioè dire che la teoria del corpo vivente e la teoria, adessa connessa, della genesi e del modo di funzionare della menterimane l’architrave di tutta l’opera di Freud: in un intreccio trail biologico e mentale il cui acume e la cui profondità è stato
troppo frequentemente trascurato, vuoi per l’imperialismo che sulproblema del conoscere a lungo ha preteso di esercitare lafilosofia, vuoi per il campo limitato che in genere è statoimposto alla psicoanalisi quale terapia, capace al massimod’intervenire sui disagi e le patologie della psiche, ma non ingrado di tradursi e di eccedere in teoria.
Per quanto concerne la biologia e la fisiologia del corpo umanoFreud è rimasto fedele per tutta la sua vita a quella connessionestrettissima tra scienza del vivente e scienza fisica della naturaa cui, fin dai suoi primissimi anni di studio presso la Facoltà diMedicina dell’Università di Vienna, era stato introdotto dal suomaestro E.W. Brücke, il quale con H. Helmholtz ed E. du BoisReymond aveva dato vita a Berlino ad una famosa PhysikalischeGesellschaft fondata su un programma riduzionistico dell’interaarticolazione delle scienze alla fisica e su una nettacontrapposizione alla filosofia romantica della natura,d’ispirazione invece vitalistica e teleologica. Così per Freud lavita del corpo umano è connotata dall’insorgere ciclico dibisogni, che producono nell’organismo un aumento progressivo ditensione – cioè, in termini fisici, di “energia” e, in termini ditrascrizione psichica, di sentimento di mancanza o di “dispiacere”– che tende necessariamente e meccanicamente verso la scarica,ossia verso lo svuotamento energetico e, con ciò, in termini divita della mente, verso il sentimento di soddisfacimento e dipiacere. Anche quando Freud, dopo la stesura incompleta del Progettodi una psicologia (1895), abbandonerà il tentativo di ricondurre tuttolo psichico nel biologico-fisico considerato da un punto di vistasolo quantitativo, ossia alla neurofisiologia del cervello basatasui neuroni come unità costitutive e sulla dinamica di moto e diquiete di quantità di energia nervosa, pure non verrà mai menonella sua visione la concezione biologica della pulsione comeaccumulo di energia che tende alla scarica e, dunque, al ritornoad una condizione originaria di quiete e di assenza di tensione.La biologia freudiana rimane di fondo una biologia meccanicistico-quantitativa.
-------------------------------------------------
La pulsione ha un’origine somatica, nasce nel corpo e vive secondouna dimensione fisico-quantitativa: in quanto aumento odiminuizione, crescita o decrescita di “quantità” di energia.Mentre lo psichico per Freud è il regno del qualitativo e
all’ordine della qualità appartiene appunto l’ambito psichico delcomplesso “desiderio/ rappresentazione/pensiero”.
Ora l’originalità della teoria freudiana sta nel concepire ilnesso tra corpo e mente, ossia tra ordine quantitativo e ordinequalitativo della vita, né secondo casualismo materialistico,secondo cui la vita della mente sarebbe tutta causata e riducibilealla vita del corpo, né secondo parallelismo. Bensì secondo unacuriosa applicazione nel campo della biologia e della psicologiadi una relazione, propria delle istituzioni e della filosofiapolitica, qual è quella di “rappresentanza”. L’ordine quantitativodell’eccitazione del soma che, come tale, non entra nell’ordinequalitativo della mente, entra a far parte dello psichico soloattraverso un suo rappresentante delegato, che Freud chiamarappresentante psichico, formato a sua volta da due elementi: chesono da un lato l’affetto (Affekt), ossia il sentimento di piacere odi dispiacere che, essendo sentire e non conoscere, dellarappresentanza psichica costituisce il livello più prossimo al“rappresentato” somatico, e dall’altro il rappresentante ideativo(Vorstellungsrepräsentanz) , ossia la scena presente alla mente –costituita da oggetto, persona, mondo esterno – che consente larealizzazione-scarica dell’affetto/desiderio.
Il concetto di rappresentazione (Vorstellung) mentale in Freudimplica dunque tanto la presenza di fronte a sé dell’oggetto ideatodel desiderio (vor-stellen) quanto la rappresentanza , attraversodelega assunta dall’affetto, della biologia del corpo nella vitadella mente. Ed appunto tale connessione tra sentire e conoscere,tra quota di affetto e rappresentazione pensata, esclude perprincipio che per Freud l’essere umano sia un essere volto inprimo luogo a vedere-conoscere e a relazionarsi in modo neutraleal mondo. Va inoltre considerato che Freud, coll’istituire la basedell’apparato psichico sull’istituto della rappresentanza, giungea concepire il nesso corpo-mente secondo una dimensioneessenzialmente verticale, secondo la quale un evento bio-fisicoche accade a un determinato livello dell’apparato – e secondo lalogica specifica di organizzazione di quel livello – viene, ad unlivello superiore, mantenuto, ma contemporaneamente trasformato,perché inserito in un ordine ulteriore di relazioni la cui logicaorganizzativa non può che essere eterogenea rispetto a quella dellivello inferiore. In questo senso l’affetto, ovvero la traduzionequalitativa dell’ammontare energetico, rappresenterebbe un livello
inferiore o comunque precedente a quello della messa in parola orappresentazione ideativa.
Ma la teoria della rappresentazione e della vita dell’apparatopsichico non si limita in Freud alla sola connessione trarappresentante quantitativo e rappresentante ideativo-qualitativo.Essa si complica e si arricchisce dell’ulteriore distinzione tra“rappresentazione di cosa” (Sachvorstellung o Objektvorstellung) e“rappresentazione di parola”(Wortvorstellung): una coppia concettualela cui presenza attraversa e accompagna l’intera opera freudiana.Tanto che, per avere qualche dilucidazione su di essa – così come,va aggiunto, per la dinamica quantitativo-economicadell’eccitazione corporea e la tendenza idraulica al suosvuotamento – è al Freud del periodo neurologico che dobbiamorivolgerci. Ricordando, a proposito dell’importanza di taleperiodo nella vita di Freud e degli interessi ad essi connessi,che gli studi di Freud sul sistema nervoso sono duratiininterrottamente per vent’anni almeno dalla fine del 1876, quandoentrò come allievo ricercatore nell’Istituto di Fisiologiadell’università di Vienna, diretto da E.W. Brücke, fino al 1897con lo scritto dedicato alla paralisi cerebrale infantile (Dieinfantile Cerebrallähmung)7.
7 È allo studio su L’interpretazione delle afasie del 1891 che dobbiamo infatti lateorizzazione più chiara ed analitica della distinzione/connessione trarappresentazione di cosa (Sachvorstellung o Objektvorstellung) e rappresentazione di parola(Wortvorstellung). In questa operetta, in cui Freud, confrontandosi con laletteratura internazionale più accreditata di neuropatologia sui disturbi dellinguaggio, studia le connessioni possibili tra i diversi tipi di afasie e lastruttura del cervello, argomenta che in una condizione non patologica delparlare quell’unità elementare del linguaggio che è la parola risulta sempreessere connessa a una rappresentazione di cosa. “La parola è […] una complessarappresentazione […], alla parola corrisponde un intricato processo associativoin cui vengono a immettersi gli elementi già menzionati, di provenienza visiva,acustica e cinestetica. Ma la parola acquista la sua portata per l’annodarsi conla ‘rappresentazione d’oggetto’ [Objektvorstellung] per lo meno se ci limitiamo allaconsiderazione dei sostantivi”.
Sia la Wortvorstellung che la Sachvorstellung risultano comporre ciascuna, oltre allaloro connessione reciproca, una struttura di relazioni specifica. Ognirappresentazione di parola forma un processo associativo in cui confluisconoquattro componenti corrispondenti a diverse funzioni dell’attività dilinguaggio: l’«immagine acustica», l’«immagine visiva di una lettera»,l’«immagine dei movimenti di fonazione» e l’«immagine dei movimenti discrittura».
L’analisi del saggio del 1915 ci ha mostrato quanto centralerimanga, oltre tali prime riflessioni di contestualizzazioneneurologica, lo snodo della funzione linguistica a fondare ladistinzione, nella psiche umana, tra conscio e inconscio, e aderivarne la dualità delle logiche che ne derivano e di cui quellaattinente all’inconscio si caratterizza come una logicacaratterizzata dall’assenza di linguaggio. La tesi sintetizzatanell’ultimo paragrafo del saggio è quanto mai esplicita: ilpassaggio tra quei due diversi modi di rapportarsi della menteagli affetti del proprio mondo pulsionale (che Freud definiscerispettivamente “processo primario” e “processo secondario”) èscandito dall’intervento del linguaggio, dalla funzione cioè dellaWortvorstellung, la quale sarebbe in grado d’immettere e tradurre ilcomplesso rappresentativo-pulsionale in questione da un modo difunzionare della mente ad uno più elevato e con una diversamodalità d’articolazione. È dunque la presenza o meno dilinguaggio che segna quindi per il Freud della prima topica ladifferenza più chiara tra Inconscio e Preconscio-Conscio.
Sembra dunque di poter dire che la differenza che Freud hastabilito tra processo primario e processo secondario siadefinibile anche come differenza tra pensiero capace solo delconcreto e pensiero capace dell’ astratto e che a questo nesso didistinzione tra astratto e concreto corrisponda una diversaeconomia e dinamica dell’affetto. Ossia nel senso che nel pensierocapace di astrazione la rappresentazione di cosa connessa a unaffetto sarebbe connessa a una rappresentazione verbale a suavolta connessa, per il sistema della lingua, a una catena disignificanti che consentirebbero di raffreddare e relativizzare l’affetto, agganciandolo a una scena più ampia e contestualizzatache lo sottrarrebbe da una presenza e un’urgenza irrelata e
La parola, da un punto di vista neuro-fisiologico, non è dunque unarappresentazione semplice bensì una «complessa rappresentazione che si presentacomposta di elementi acustici, visivi, cinestetici» . Di quattro elementi,rispettivamente due sensoriali e due motori. Quelli sensoriali sono l’immaginemnestica della parola udita e l’immagine ottica della parola vista, mentrequelle motorie sono costituite dalla rappresentazione motoria della parolapronunciata e dalla rappresentazione motoria della parola scritta.
Così come, per suo verso, anche la rappresentazione di cosa, risulta essere uncomplesso associativo formato da componenti visive, acustiche, tattili,olfattive e di gusto, cinestetiche.
pressoché assoluta. È cioè la discorsività del linguaggio, qualefunzione per eccellenza della mente conscia, che appare tradurrein Freud la freie Energie (energia libera) del processo primario,tendente all’immediata soddisfazione, in gebundene Energie (energialegata), cioè in un movimento più ritardato e controllato che,capace di una relativizzazione tra pulsioni interne e ambienteesterno, appartiene a una strutturazione più elevata dell’apparato psichico e che, con la sua trasformazione di ciò che èliberamente mobile in ciò che è dinamicamente contenuto, richiama quelladistinzione tra rappresentazioni aperte e rappresentazioni chiuse cheil Freud dell’Interpretazione delle afasie aveva usato per designarerispettivamente la Sachvorstellung e la Wortvorstellung8.
--------------------------------------------
Nell’ambito della nostra ricostruzione, non può essere per altrodimenticato, facendo ora un passo indietro, quanto già il Freuddella Interpretazione dei sogni avesse concepito sulla modalità inconsciadi comporre pensieri, quale si manifesta nella produzione onirica,e di quanto, nella visione freudiana, la logica di composizionedel pensare onirico differisca profondamente dalla logica delpensare propria della modalità conscia. In particolare, sulla tesiper cui il pensiero onirico è un tipo di pensiero che associa ecompone fondamentalmente senza linguaggio, Freud per altro si esprimecon estrema chiarezza. Con l’attività del sogno, al pensierocapace di concettualizzazione e discorsività –afferma- subentra unsistema associativo fatto di immagini e percezioni sensoriali.
“Chiamiamo regressione il fatto che nel sogno la rappresentazione siritrasforma nell’immagine sensoriale da cui è sorta in un momento qualsiasi”9
8 Per il Freud dell’Auffassung der Aphasien, allorché si dà la significazionesimbolica, si mettono in relazione un insieme chiuso, qual è per lui larappresentazione di parola, e un insieme aperto, qual è la rappresentazione diparola. La Sachvorstellung, la rappresentazione di cosa, infatti per Freud, nellasua insorgenza mentalistica e intrapsichica, non desume forma ben delimitata edeterminata del suo apparire dalla mimesi o dal riflesso di oggetti esterni o dipresunte cose in sé. Essa è bensì un complesso interiore di sensazioni, di variaorigine sensoriale come si diceva (visiva, acustica, tattile, etc.), il qualetanto più acquista confine e spessore di delimitazione quanto più replica nellamedesima trama associativa immagini sensoriali, altrimenti capaci diassociazioni nuove e illimitate. La rappresentazione di cosa è perciò un insiemeaperto, costituito da un confine potenzialmente sempre pronto ad aprirsi peraltri percorsi associativi, mentre la rappresentazione di parola si strutturacome un insieme ben chiuso dalla serie finita delle sue quattro immaginicostitutive (immagine acustica, visiva, di lettura e di scrittura).
Il processo primario, quale si esprime attraverso il sogno,appare curvato e concluso in un orizzonte fondamentalmentepercettivo-sensoriale, a dominanza rappresentativo-visiva. Maproprio ciò implica che il pensiero senza linguaggio dell’inconsciopossieda un linguaggio specifico e determinato. Ossia che il tipopeculiare di pensiero che si forma nella parte inconscia dellamente utilizzi metodi (nel senso etimologico di percorsi) determinati dicostruzione, di associazione e di sintesi che non sono quellipropri della verbalizzazione.
“Se guardiamo al processo onirico come a una regressione all’internodell’apparato psichico da noi adottato, possiamo senz’altro spiegare il fatto,stabilito per via empirica, che nel lavoro onirico tutte le relazioni logichedei pensieri onirici vanno perdute o trovano soltanto espressione travagliata.Secondo lo schema, queste relazioni logiche non sono contenute nei primi sistemiTmn, ma in altri situati più avanti, e nella loro regressione sino alle immaginipercettive perdono di necessità la loro espressione. Nella regressione la struttura dei
pensieri del sogno viene disgregata nella sua materia prima [corsivo di Freud]10
Nella parte inconscia della psiche vengono meno le relazioni dellogos -ossia del pensiero che lega e raccoglie attraverso le catenelinguistiche– e rimane un contenuto che va legato e compostoaltrimenti.
“L’apparente pensare del sogno riproduce il contenuto dei pensieri del sogno, noni loro reciproci rapporti, nella cui istituzione consiste il pensare”11.
Insomma la parte inconscia della mente appare per Freud esserecaratterizzata da una assenza della funzione linguistica nel sensodi un’assenza della possibile connessione discorsiva erelativizzante dei propri contenuti emozionali. Tant’ è che lostesso linguaggio, quando è presente –come a tutti accade dinotare nel sognare– sembra che vi sia per Freud solo nei terminidi una scenografia rappresentativa che tratta i significantiverbali alla stregua di rappresentazioni di cosa e che dunquetratta le parole, o la singola parola, secondo norme e sensiassociativi che sono del tutto eterogenei rispetto alle catenesemantico-sintagmatiche del linguaggio vero e proprio.
“Per quanti discorsi e controdiscorsi possano esserci nei sogni, assurdi osensati che siano, l’analisi ci mostra ogni volta che il sogno ha colto
effettivamente dai suoi pensieri frammenti di discorsi effettivamente fatti o
9 S. Freud, L’interpretazione dei sogni, tr. it. di E. Facchinelli e H. TrettlFacchinelli, in Opere, 3, Torino 1980, p. 49610 Ivi, p. 146.11 Ivi, p. 288.
uditi, procedendo poi con essi in modo estremamente arbitrario. Non soltanto liha strappati dal loro contesto e ridotti a frammenti, accogliendo ne uno escartandone un altro, ma spesso li ha connessi in modo nuovo, cosicché il
discorso del sogno, apparentemente coerente, all’atto dell’analisi si scomponein tre o quattro frammenti. In questa utilizzazione esso ha spesso lasciato daparte il significato che le parole avevano nei pensieri del sogno ed è riuscito
a ricavare dal testo un significato completamente nuovo”12
“Condensazione” e “spostamento” (Verdichtung/Verschiebung) agiscono nonsolo sulle rappresentazioni visive ma anche su quelle auditive:giacché ogni immagine sensoriale, nella sua dissoluzione da ognipiano concettuale e proprio nella sua dominanza e origine di sensospecifica, è contenuto congruo e disponibile per la sintesidell’inconscio.
“Il lavoro di condensazione del sogno riesce particolarmente evidente quandosceglie a suoi oggetti parole e nomi. Infatti il sogno tratta spesso le parole comecose e le sottopone alle medesime combinazioni delle rappresentazioni di cose. Ne
risultano creazioni verbali bizzarre e inconsuete”13
Con la conseguenza assai di rilievo che il cosiddetto principio di noncontraddizione, posto nella Metafisica aristotelica a base del pensierodiscorsivo e dell’intera logica occidentale, per Freud manifestainvece una validità limitata alla sola parte conscia della mente,indicando con il suo limite il darsi di un’altra logica e di unaltro modo di funzionare del pensiero. Il principio di noncontraddizione non si può estendere all’attività inconscia dellamente, giacché qui è appunto possibile, proprio per il lavorodella condensazione e dello spostamento, che in una stessaimmagine e nella medesima unità di tempo siano compresenti duecontrari o, se si vuole, due catene ideative di significatoopposto, o, ancora, che una medesima scena stringa insieme duesignificati, uno normale e palese, l’altro straordinario edobliquo.
----------------------------------------
“Processi consci alla periferia dell’Io – scrive Freud – e tutto il resto che ènell’Io inconscio: sarebbe questa la situazione più semplice che dovemmo
supporre. Può darsi che in effetti le cose stiano così per gli animali, ma pergli uomini si aggiunge una complicazione in virtù della quale anche alcuni
processi interno dell’Io possono acquistare la qualità della coscienza. Ciò èopera della funzione linguistica, la quale stabilisce uno stretto collegamento
12 Ivi, p. 383.13 Ivi, p. 274.
fra i contenuti dell’Io e i residui mnestici delle percezioni visive, e piùancora con quelli delle percezioni auditive”14.
La continuità concettuale di questa pagina del 1938 con le paginedegli scritti neurologici del 1893-95 è assai evidente offrendocon la sua chiarezza una testimonianza di poco dubbio su quanto ilpensiero di Freud sia rimasto immutato, nell’intero arco del suosviluppo, per quanto concerne la collocazione del ruolo dellinguaggio nell’articolazione della vita psichica. Ma non solo.Giacché la riaffermata centralità della funzione linguistica neltransito dall’inconscio al conscio ci dice anche, insieme allealtre tesi metapsicologiche riassunte nel Compendio, quale sia lastruttura teorica invariante, e di fondo, che il Freud,dell’intero periodo psicoanalitico, ha definito e mantenuto nellasua indagine metapsicologica sull’apparato psichico consideratonella sua complessità: al di là delle trasformazioni, pureestremamente rilevanti, in termini di teoria delle pulsioni chesegnano il passaggio dalla prima alla seconda topica.
Ancora dalle pagine del Compendio emerge infatti la configurazionedi un sistema psichico basato sulla compresenza di tre ordini, che sipossono qualificare rispettivamente l’ordine dell’affetto, l’ordinedella rappresentazione di cosa e l’ordine della rappresentazionedi parola. O meglio come la compresenza di tre diverse modalità efunzioni del rappresentare, visto che la rappresentazione – nelsenso della presenza/avvertenza di un contenuto nel contenitoredella mente – costituisce l’elemento indispensabile a che si diavita psichica.
I tre ordini della rappresentazione che mantengono inalterata lacomposizione dello psichico in Freud dai primi scrittipsicoanalitici fino alla conclusione della sua opera risultanoessere i seguenti:
I) Rappresentazione come “Triebrepräsentant” o rappresentantepulsionale; logica quantitativo-diffusiva
II) Rappresentazione come “Sachvorstellung”, o rappresentazione dicosa; logica qualitativo-associativa
III) Rappresentazione come “Wortvorstellung”, o rappresentazione diparola; logica simbolico-discorsiva
14 S. Freud, Compendio di psicoanalisi, tr. it. di R. Colorni, in Opere, 11,Boringhieri, Torino 1979, p. 388
Questi sono nello svolgimento dell’intera opera freudiana le trecomponenti che concorrono a formare quell’atto elementare dellavita della mente che Freud chiama rappresentazione (Vorstellung). Trecomponenti o è meglio dire tre funzioni che nella diversità delloro agire, nella diversità delle loro tre logiche, spiegano perFreud la mente dell’essere umano come sintesi di due relazioni chesono rispettivamente la relazione verticale della mente con ilproprio corpo e la relazione orizzontale della stessa mente conun’altra mente.
I) Il Triebrepräsentant (o nel lessico freudiano anche Triebrepräsentanz),sta a significare fondamentalmente l’Affektbetrag, ossia l’importo oil carico di affetto, che si lega a una qualsiasi scenarappresentata e pensata della mente. L’ambito dell’affettocostituisce per Freud l’ambito che più propriamente coincide conil corpo: ma, si badi, con un corpo che è già anche tradotto edavvertito quale risonanza emozionale interna ad una mente (come siè visto è proprio il fatto di essere sempre il corpo di una menteo sempre una mente che sente e pensa il corpo che fa sì che lapulsione abbia quel carattere di X inconoscibile sovramenzionato).Tale natura originariamente bina, duale (perché al confine tra corpoe mente) dell’affetto, o pulsione, io credo si possa connotarecome l’ambito intermedio tra quantità e qualità, cioè come l’ambitodella traduzione di variazioni quantitative di energiacinestetica, elettro-fisica ed elettro-chimica, di naturasomatica, in processi qualitativi avvertiti dalla mente comeemozioni. La Triebrepräsentanz, o rappresentazione pulsionale, èdunque una “rappresentanza” (secondo il significato politico diquesto termine di cui si diceva già all’inizio di quest’ultimoparagrafo), la quale traduce ed esprime, in termini di sentimenti,processi e modificazioni di natura somatica. Scandita, per dirlaschematicamente, secondo i due estremi, del piacere e deldispiacere, rappresenta, il luogo e la fonte del senso, nelsignificato di sentire se stessi. È l’ordine del sentire, e nondel rappresentare o del pensare, perché ci viene dato e imposto daquel corpo che è l’esteriorità della nostra interiorità e come tale è lavera fonte inesauribile del significato del vivere: nella suainesauribilità e verità mai completamente riducibile alla mente.
La Triebrepräsentanz può dunque essere interpretata, usando unlinguaggio filosofico, come il luogo e la genesi “materialistici”della trascendenza: quale trascendersi di una soggettivitàall’interno di sé. Riguardo alle altre due funzioni o luoghi
“rappresentativi” della mente, l’ordine dell’affetto, o dellapulsione, può essere definito come un ordine della mente di naturané eidetico-percettivo né linguistico. Infatti l’affettopulsionale, nel complesso dell’opera freudiana, viveessenzialmente secondo il modo idraulico della diffusione. Per la suanatura originariamente quantitativa, esso si muove e si trasformalungo delle scale di diminuzione o di crescita non sottoponibili asegmentazioni o articolazioni discontinue. È il luogo dell’energiaemozionale, che Freud caratterizza come “energia libera”, la qualecorre liberamente, e quanto più rapidamente possibile, verso ilsoddisfacimento del piacere o alla fuga precipitosa daldispiacere.
II) Se nella Vorstellung freudiana il Triebrepräsentant è strutturato sulsenso interno, la funzione che Freud definisce Objektvorstellung oSachvorstellung è la funzione della mente strutturata sui cinque sensiesterni, capace di dar vita a rappresentazioni percettive di varianatura, con una dominanza eidetico-visiva. Ma non è solo la mancanza dilinguaggio ciò che caratterizza la Sachvorstellung. È anche l’essereuna rappresentazione “aperta”, come la definisce Freud, nel sensoche la mente, per concepire l’idea dell’esistenza extramentale diun oggetto, per rappresentarsi cioè la parvenza durevole e laconsistenza di una cosa, oltre che percepire delle sensazioniattuali ed effettive in un momento determinato – sensazioni chesono per altro assai fuggevoli e rapsodiche – deve poterviincludere la percezione di una permanente possibilità che nelfuturo analoghe impressioni si vengano ad associare nel medesimomodo, nella stessa catena associativa. Aperta cioè, larappresentazione di cosa nel senso teorizzato da John Stuart Mill,la cui Logica Freud nello scritto sulle afasie esplicitamente cita,e secondo cui l’innumerevole possibilità di sensazioni future cheripeteranno la medesima associazione è più determinante neldefinire l’esistenza di un oggetto che non le sensazioni attuali.
La logica che costituisce tale ambito del rappresentare –rappresentare cosale o figurale, a dominanza eidetico-visiva– nonè quella quantitativo-diffusiva dell’affetto, bensì quella dellaarticolazione-configurazione qualitativa di figure e datisensibili, come suoni, odori, sensazioni tattili, che sidefiniscono, si relazionano, si associano e si oppongono tra diloro attraverso contiguità spaziale o temporale, attraversoanalogie o discordanze di forma, attraverso concordanze di colori,attraverso gradi e intensità di suoni.
III) Infine la Wortvorstellung, o rappresentazione di parola,identifica la funzione simbolico-linguistica della mente. Adifferenza della logica quantitativo-diffusiva e della logicaqualitativo-associativa per similarità sensoriali, rispettivamentedella prima e della seconda funzione rappresentativa, la logicadella rappresentazione di parola è simbolico-discorsiva. Si svolgeattraverso l’associazione di nessi linguistici e attraverso laverbalizzazione consente l’accesso alla coscienza degli altri dueordini.
La compresenza, la mediazione, la sintesi di tali tre funzioni checompongono la Vorstellung costituisce per Freud il funzionamento non-patologico della vita della mente nel suo rapporto con il corpo.Il legame tra affetto, rappresentazione della scena disoddisfacimento o di dispiacere, attraverso cui quell’affetto sirisolve, e loro messa in parola attraverso il linguaggio,struttura la forma del pensare che Freud definisce “processosecondario”, ossia la capacità della mente di legare attraverso illinguaggio l’energia aperta che invece nel “processo primario”, oforma inconscia del pensare, fluisce liberamente verso la suarisoluzione. L’effetto di linguaggio, per la sua valenza simbolicae discorsiva di simboli linguistici che “stanno al posto di”,ossia sostituiscono le cose e gli affetti che simboleggiano,sembra dunque poter dire che per Freud consista fondamentalmentein un effetto di raffreddamento, di eclisse degli affetti, come sidiceva, e delle scene pulsionali da quelli scritte e sceneggiate.E fa ciò, in una sorta letterale di Aufhebung alla Hegel, agganciando la rappresentazione di cosa affettivamente investitaalle catene delle parole: le quali, nel momento in cui neimbrigliano l’energia, contemporaneamente la relativizzano,prendendone appunto distanza attraverso la loro capacità disimbolizzazione.
Così attraverso la rappresentazione di “parola” e la rete diparole a cui essa è strutturalmente legata nella struttura piùgenerale della “lingua”, l’urgenza del processo primario, cheobbedisce solo al principio di piacere/dispiacere, viene moderata,mitigata e alla risoluzione coatta della pulsione subentra unbenefico raffredamento pulsionale che consente di guardarsiattorno, fare entrare in gioco anche il principio di realtà, eattraverso un pensiero che tiene conto anche del mondo esterno,cercare il soddisfacimento più opportuno e meno obbligato della
tensione affettiva: un soddisfacimento, non solo immaginato oallucinato, ma concretamente possibile e reale.
----------------------------------
Quello che si è voluto soprattutto sottolineare con questopercorso veloce e schematico sulla funzione del linguaggionell’opera di Freud è che dalle argomentazioni di Freud sullinguaggio emerge un sistema psichico basato sulla compresenza ditre ordini, che sono rispettivamente l’ordine dell’affetto, l’ordinedella rappresentazione di cosa e l’ordine della rappresentazionedi parola.
L’ordine dell’affetto appare istituirsi come un ambito di naturanon solo a-linguistica ma in qualche modo anche a-rappresentativa.Costituisce per Freud l’ordine che più propriamente coincide conla corporeità: ma con una corporeità che è già anche avvertitacome risonanza emozionale, interna ad una mente. Per tale naturaoriginariamente bina l’ambiente dell’affetto è definibile anchecome quello della traduzione della quantità in qualità, dellatraduzione cioè di stati quantitativi di energia elettro-fisica edelettro-chimica in presenze avvertite dalla mente. Larappresentazione affettiva è dunque, a ben vedere, una rappresentanza,la quale traduce in termini di sentimento processi e modificazionidi natura somatica. Basata sull’affezione emozionale, chetrascorre dal sentimento di piacere a quello di dispiacere eviceversa, essa è senso interno. E come tale è eterogenea rispettoalla rappresentazione di cosa, fondata sui sensi esterni e adominanza eidetico-percettiva. Infatti l’affetto viveessenzialmente secondo il modo della diffusione, ossia per la suabase quantitativa si muove e si trasforma lungo una scala didiminuzione o di crescita non sottoponibile a segmentazioni oarticolazioni discontinue15. Laddove la rappresentazione di cosavive essenzialmente secondo il modo dell’articolazione e delladivisibilità: ossia secondo una logica combinatoria profondamentediversa da quella, appunto diffusiva, dell’affetto-quantità. Ma sela rappresentazione di cosa possiede una struttura articolabile escomponibile in parti, essendo già per il Freud neurologo unasintesi di un molteplice di immagini sensoriali, tanto più ciòvale per la rappresentazione di parola, decomponibile, com’è noto,
15 Da qui anche la difficoltà a renderne contro mediante coscienza e linguaggioche abbiamo testé incontrato.
per la linguistica moderna in parti, fino a quelle unità minimaligeneralmente definibili come monemi.
Ciò che è in questione nel nesso corpo-mente, per l’antropologia ela clinica freudiana, è appunto il coordinamento di tali treordini rappresentativi: la congruenza cioè di una rappresentazioned’affetto nella sua connessione con una rappresentazione di cosa enella sua elaborazione attraverso una rappresentazione di parola.Con la tesi che ne consegue che lo specifico venir meno delrapporto tra Sachevorstellung e Wortvorstellung produce necessariamenteuna fissazione della rappresentazione affettiva allaSachevorstellung. Tale fissazione emozionale può essere definitaanche come reificazione: nel senso di appartenenza a un orizzontepropriamente desimbolizzato in cui una rappresentazione di cosa,priva dell’aggancio alla rete linguistica, vale appunto, con tuttala pesantezza e l’immobilità di una cosa, a connettere a sé inmodo coattivo e non elaborabile l’affetto. Per cui si può giungerea intendere la rimozione come una vera e propria distruzione dilinguaggio, cioè come esclusione radicale di una parte della mentedall’ambito linguistico-comunicativo. E concepire perciò il mondopsichico del rimosso come un mondo sostanzialistico e pietrificatoche, sottraendo al nesso rappresentanza d’affetto-rappresentazionedi cosa l’intermediazione e il distanziamento del segnolinguistico, dà vita a una scena dominata dal principio d’identità(A è A), ossia alla ripetizione tautologica di un contenutoemozionale-ideativo che ripropone un motivo che è sempre lostesso.
Così il nesso corpo-mente può valere come sintesi non problematicadi natura e cultura solo quando una funzionalità profonda edestesa del linguaggio garantisca la connessione degli ordinirappresentativi qui considerati. Altrimenti quando tra essi si dàdestrutturazione e il conseguente prevalere dell’uno sugli altri,tra natura e cultura si apre un’asimmetria, per cui la natura puòdivenire invasiva e distruttiva mentre la cultura farsimoralistica e anaffettiva. Alla distruzione del linguaggionell’ambito della coscienza individuale corrisponde d’altro cantol’intensificazione ipostatizzante del linguaggio, fino al suodeporsi estenuato nella deformazione ideologica del senso comune.A mezzo tra i due piani, dell’inconscio individuale edell’inconscio collettivo, sta perciò la forza di una coscienzache attraverso l’intreccio delle sue relazioni, intersoggettive einfrasoggettive, sia capace di affrontare e fare buon uso di