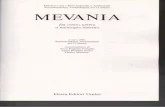Osvaldo Armanni (1855-1929), in 1861-1939 L'architettura della Perugia postunitaria, a cura di P....
Transcript of Osvaldo Armanni (1855-1929), in 1861-1939 L'architettura della Perugia postunitaria, a cura di P....
-
1861
-193
9 L
’arc
hite
ttur
a de
lla P
erug
ia p
ostu
nita
ria
1861-1939L’architetturadella Perugia postunitaria
ingegnere e dottore di ricerca, è ricercatore di Disegno presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, dove insegna Disegno dell’architettura.
ingegnere, è professore associato di Di-segno presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia, dove insegna Rilievo dell’architettura; è direttore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.
ingegnere e dottore di ricerca, è ri-cercatore di Disegno presso il Dipartimento di In-gegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia, dove insegna Disegno dell’architettura.
architetto, è professore ordinario di Disegno presso il Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di Genova, dove in-segna Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva e Disegno dell’architettura.
architetto e dottore di ricerca, collabora all’attività di ricerca del Dipartimento di Ingegne-ria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia.
ingegnere e dottore di ricerca, colla-bora all’attività di ricerca del Dipartimento di In-gegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia ed è docente a contratto di Laboratorio di Progettazione digitale.
architetto, è professore associato di Storia dell’architettura presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università dell’Aquila, dove insegna Storia del-l’architettura.
architetto e già profes-sore ordinario di Restauro presso l’Università di Firenze, ha insegnato Restauro architettonico.
architetto, è ricercatore di Storia dell’architettura presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” del-l’Università di Roma “Tor Vergata”, dove insegna Storia dell’architettura.
architetto, è professore associato di Restauro presso il Dipartimento di Storia, Di-segno e Restauro dell’architettura dell’Università di Roma ”La Sapienza”, dove insegna Restauro architettonico e Consolidamento degli edifici storici.
ingegnere e dottore di ricerca, col-labora all’attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia.
architetto, ha insegnato Disegno e Progettazione presso l’Istituto Tecnico per Geo-metri di Perugia e ha svolto attività di ricerca e col-laborazione professionale nei settori della storia urbana e dell’archeologia industriale.
architetto e dottore di ricer-ca, è ricercatore di Storia dell’architettura pres-so il Dipartimento di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dove insegna Storia dell’architettura.
storico dell’architettura, è profes-sore ordinario di Storia dell’architettura presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura dell’Università di Roma ”La Sa-pienza”, dove insegna Storia dell’architettura con- temporanea.
architetto e già responsabile dell’Uf-ficio Urbanistico per i Centri Storici del Comune di Perugia, è presidente dell’Istituto Interregionale per gli Studi Storico-Urbanistici.
architetto, è professore ordinario di Restauro presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura dell’Università Poli-tecnica delle Marche, dove insegna Restauro ar-chitettonico.
ingegnere e dottore di ricerca, collabora all’attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Perugia.
ingegnere e dottore di ricerca, è ricercatore a tempo determinato di Disegno presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Am-bientale dell’Università di Perugia, dove insegna Rilievo dell’architettura.
architetto e già professore ordinario di Storia dell’architettura presso l’Università di Camerino, ha insegnato Storia dell’architettura.
storico dell’arte, è ricercatore di Storia dell’arte contemporanea presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università di Perugia, dove insegna Storia dell’arte contemporanea.
architetto, dottore di ricerca e speciali-sta nel restauro architettonico, è ricercatore di Re- stauro presso il Dipartimento di disegno, storia e restauro dell’architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”, dove insegna Restauro architettonico.
è ricercatore di Storia econo-mica presso il Dipartimento di Scienze Storiche dell’U-niversità di Perugia, dove insegna Storia economica.
architetto, è professore ordinario di Restauro presso il Dipartimento di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dove insegna Restauro architettonico.
architetto e dottore di ricerca, collabora al-l’attività di ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ed è funzionario della Soprintendenza BB.AA.PP. per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia.
Cristiana Bartolomei
Paolo Belardi
Fabio Bianconi
Maura Boffito
Alessia Bonci
Simone Bori
Simonetta Ciranna
Giuseppe Cruciani-Fabozzi
Maria Grazia D’Amelio
Fabrizio De Cesaris
Marco Filippucci
Maria Grazia Fioriti
Antonella Greco
Paolo Lattaioli
Fabio Mariano
Luca Martini
Valeria Menchetelli
Maria Luisa Neri
Stefania Petrillo
Simona Salvo
Manuel Vaquero Piñeiro
Claudio Varagnoli
Enza Zullo
Raffaele Giannantonio
ISBN 978-88-6778-002-0
1861-1939L’ARCHITETTURADELLA PERUGIA POSTUNITARIA
a cura diPaolo BelardiSimone Bori
prefazioneGiuseppe Cruciani-Fabozzi
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:00 Pagina 3
Il volume presenta gli esiti del progetto di ricerca 1861-1939.L’architettura della Perugia postunitaria
Gli esiti intermedi della ricerca sono stati presentati in occasione dell’omonimo convegno svoltosi a Marsciano il 24 marzo 2012
Progetto grafico, impaginazioneStudio Fabbri, Perugia
Realizzato con il sostegno di
Comune di Marsciano
Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte
© 2013 Fabrizio Fabbri srlVia G. Dottori, 8506132 S. Sisto, PerugiaTel. 075 5271050 - Fax 075 5271060
ISBN 978-88-6778-002-0
Disegno di copertina:Fernando Gigliarelli, Progetto di decorazione per il soffitto di un teatro,1873 (Perugia, Archivio dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”,Fondo didattico Ornato, inv. 224).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:00 Pagina 4
GLI ARCHITETTI DELLA PERUGIA POSTUNITARIA
Giovanni Santini (1802-1868)Paolo Belardi, Luca Martini
Coriolano Monti (1815-1880)Cristiana Bartolomei
Alessandro Arienti (1833-1896)Maria Luisa Neri
Nazareno Biscarini (1835-1907)Valeria Menchetelli
Guglielmo Calderini (1837-1916)Antonella Greco
Giulio De Angelis (1845-1906)Enza Zullo, Claudio Varagnoli
Osvaldo Armanni (1855-1929)Simonetta Ciranna
Riccardo Haupt (1864-1950)Maura Boffito
Cesare Bazzani (1873-1939)Raffaele Giannantonio
Giuseppe Marrani (1885-1954)Alessia Bonci
Ugo Tarchi (1887-1978)Simone Bori
Pietro Angelini (1892-1985)Simona Salvo
Giovanni Battista Massini (1897-1967) Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Maria Grazia Fioriti
Indice delle opere citatea cura di Valeria Menchetelli
Indice
Presentazioni
Alfio TodiniSindaco del Comune di Marsciano
Carlo ColaiacovoPresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Paolo BelardiResponsabile scientifico del progetto di ricerca
PrefazioneGiuseppe Cruciani-Fabozzi
LA PERUGIA POSTUNITARIA
Profilo storico dell’architettura umbra dell’Ottocento. Dal palazzo Comunale di Foligno al palazzo del Governo di PerugiaPaolo Belardi
Giuseppe Sacconi e la pratica del restauro eclettico in UmbriaFabio Mariano
Tra edilizia ed economia a Perugia alla fine dell’OttocentoManuel Vaquero Piñeiro
Evoluzione urbanistica di Perugia, capitale dell’Umbria, nel periodo postunitario tra il 1860 e il 1939. Storia di riuso e rigenerazione urbanaPaolo Lattaioli
Perugia dopo l’unità d’Italia: materiali e tecniche costruttiveMaria Grazia D’Amelio, Fabrizio De Cesaris
Le arti decorative a Perugia tra Otto e NovecentoStefania Petrillo
9
11
125
141
151
171
185
197
209
229
241
257
267
279
297
313
13
17
23
51
71
79
97
109
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:00 Pagina 5
Osvaldo Armanni, progetto di restauro di Porta San Pietro a Perugia, 1872-1873 (ASPg, Armanni, c. 23).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 208
L’architetto perugino Osvaldo Armanni (1855-1929)1 è presente nella pubblicistica dell’archi-tettura quasi esclusivamente per la realizzazionedel nuovo Tempio Israelitico di Roma. In tale edi-ficio, il cui progetto vincitore nel concorso del lu-glio 1889 sarà modificato ed eseguito tra il 1901e il 1904, Armanni è affiancato dall’ingegnere ro-mano Vincenzo Costa (1848-1924), altra perso-nalità quasi sconosciuta, con il quale l’architettocondivise l’attività professionale svolta tra l’Um-bria e il Lazio2. Soltanto il testo pubblicato dal fi-glio Armando a un anno dalla morte del padretratteggia, in termini chiaramente elogiativi, l’at-tività di professionista e docente di Armanni3;scritto al quale si è sempre appoggiata la pubbli-cistica successiva, che ha fissato l’intera produ-zione di Armanni nell’ambito di una ricerca di“forme architettoniche di una moderata solen-nità, conforme agli ideali retorici e celebratividell’architettura ufficiale del tempo”4. L’avvio di un’indagine diretta di architetture rea-lizzate dal progettista in Umbria5 e nel Lazio, e lostudio del fondo archivistico dell’architetto6 apro-no a una conoscenza più ampia dell’opera di Ar-manni, in un contesto ormai consolidato di mag-giore interesse della storiografia specialistica più
recente nei confronti dell’architettura italianadell’Ottocento postunitario7. Un contesto storico eculturale nel quale si costruisce l’immagine ‘mo-derna’ della nazione a scala architettonica e ur-bana, in cui si dibatte sull’individuazione di unlinguaggio nazionale per arrivare al superamentodell’architettura storicista e, ancora, in cui si de-finiscono i profili scolastici e professionali dell’ar-chitetto e dell’ingegnere.
La formazione
La formazione di Armanni è strettamente legataa Perugia, città in cui dal 1870 al 1874 segue icorsi dell’Accademia di Belle Arti avendo come in-segnante di Architettura elementare e superioreteorica e pratica e di storia dell’arte l’architetto-ingegnere Guglielmo Calderini8. Professionista dispicco nonché funzionario del Genio Civile, delMinistero dei Lavori Pubblici e poi Soprintendenteai Monumenti per le province di Roma, L’Aquilae Chieti, Calderini è un figura di riferimento peril giovane Armanni sia nell’istruzione accademicasia nella pratica didattica e professionale9. La suaspiccata attenzione alle questioni funzionali del-
209
Osvaldo Armanni (1855-1929)
Simonetta Ciranna
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 209
l’architettura affonda probabilmente le basi nelleesperienze maturate dal 1871 al 1875, quando fre-quenta “con assiduità e profitto” lo studio di Cal-derini, “esercitandosi continuamente in progettiarchitettonici ed in copie di macchine sotto la suadirezione”, sostituendo talvolta il maestro nelcorso di Architettura10. A lui, forse, il giovane studente deve anche i sug-gerimenti a seguire, nell’anno scolastico 1870-1871, le lezioni di Letteratura Italiana tenute dalprofessore don Raffaele Marchesi (1810-1871)11
presso l’Istituto Tecnico di Perugia, e quelle di Fi-sica Sperimentale svolte dal professore Enrico DalPozzo di Mombello12 nell’Istituto di Agronomia.Qui l’anno seguente frequenterà le lezioni di Al-gebra e Geometria del professore ingegnere Gia-como Calderoni.I numerosi riconoscimenti ottenuti identificanoArmanni come un allievo brillante e versatile neldisegno e nella composizione architettonica13, ca-pace di ottenere nel dicembre del 1874 la patentedi abilitazione all’insegnamento del disegno nelleScuole Tecniche, Normali e Magistrali del Regno,rilasciatagli dal Presidente dell’Accademia delleBelle Arti di Firenze. Soltanto il 24 maggio del1899, gli verrà riconosciuta la laurea di architettonella Regia Scuola di Applicazione degli Inge-gneri di Roma14, mentre già nel 1895 aveva rice-vuto la nomina ad Accademico di merito nell’Isti-tuzione perugina che lo aveva formato.
I primi concorsi
Anche i primi concorsi lo collegano alla sua cittànatale. Nel concorso accademico per il restaurodi Porta San Pietro a Perugia del 1872-1873, Ar-
210
Osvaldo Armanni, Armatura per la costruzione di una cu-pola a curva catenaria del diametro di m. 24, 1872 (Peru-gia, Archivio dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”,Fondo didattico Architettura, inv. 890).
Osvaldo Armanni, Studio d’ombre su elementi architettonicicon un tempio classico, 1872 (Perugia, Archivio dell’Accade-mia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, Fondo didattico Prospet-tiva, inv. 267).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 210
211
Progetto di restauro dell’Arco Etrusco o d’Augusto di Perugia, prospetto (da CALDERINI 1862b, tavola n.n.).
Osvaldo Armanni, progetto di restauro dell’Arco Etrusco o d’Augusto di Perugia, 1875, prospetto, saggio del primo anno della borsaStanzani dell’Artistica Congregazione dei Virtuosi al Pantheon (ASPg, Armanni, c. 18).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 211
manni propone il completamento in forme quat-trocentesche della porta urbica ponendosi in sin-tonia con le vicende storiche del monumento.Infatti, nel 1458 è il maestro di pietra BartolomeoMattioli15 ad assumere l’incarico di completarela ricostruzione ‘alla moderna’ della Porta nelborgo di San Pietro, avviata nel 1447 da MariottoBaglioni e Nicolò di Paolo di Pietro e poi conti-nuata alla morte di Mattioli da Agostino di An-tonio di Duccio16. Nel 1875 Armanni vince il Concorso NazionaleStanzani indetto dalla Insigne Artistica Congre-gazione dei Virtuosi al Pantheon; un successoelogiato da Calderini nei giornali locali e che de-terminerà il trasferimento a Roma del giovanegrazie alla borsa quadriennale premio per il per-fezionamento nello studio dell’architettura17. Èin tale contesto che esegue, come saggio delprimo anno, il progetto di restauro dell’ArcoEtrusco o d’Augusto, uno degli otto varchi prin-cipali delle mura etrusche di Perugia18. Diversa-mente dal criterio adottato nella quattrocentescaPorta San Pietro, qui Armanni prevede la libera-zione del monumento dalle più tarde aggiunte el’inserimento di una linea di merli19; una solu-zione, quindi, che riprende quanto già propostodal maestro Calderini nel 186220. Ancora come pensionato, nel maggio del 1877Armanni è impegnato sul “progetto di ristaurodel grandioso e celebre tempio di Vulcano inOstia, del quale fedelmente e con ogni diligenzaha misurato e ritratto sul luogo le maestoseruine”21. Si tratta del rilievo e della restituzionegrafica della forma originaria del tempio; disegnicon i quali conquisterà la medaglia di bronzoall’Esposizione Umbra Artistica, Industriale, Agri-cola, del 187922.
L’11 dicembre 1879 Armanni ottiene, per pub-blico concorso, la cattedra di disegno nel RegioIstituto Tecnico Leonardo da Vinci di Roma, ed èin questa nuova veste che partecipa al bando delcomune di Vicenza del 1880 per il ‘nuovo pro-spetto a tramontana’ del Teatro Olimpico23. Comedesigna l’autore, la facciata riprende ‘lo stile pal-ladiano’ con un impaginato tripartito costituitoda un corpo centrale a due piani, di cui il supe-riore a loggiato con timpano e statue e quello ter-reno bugnato con tre portali a tutto sesto, cheavanza rispetto le due ali simmetriche a un solopiano, anch’esse a bugnato e concluse da unabalaustra con statue.
I grandi Concorsi nazionali
La ricerca di uno stile nazionale attraversa nelcorso dell’Ottocento l’intera Europa, dove ognisingolo Stato è impegnato a rafforzare la propriaidentità e a conseguire autorità in ambito inter-nazionale24. Nella costruzione dell’iconografiaufficiale, le competizioni per la progettazione dimonumenti, edifici pubblici civili e religiosi, o direstauri o completamenti di fabbriche storicherappresentano un’occasione privilegiata di con-fronto tra architettura e opinione pubblica. Laprassi del concorso – oltre cento ne vengono ban-diti in Italia tra il 1860 e il 1914 – assume unruolo importante nell’immaginario collettivo inciò che si vuole elevare a patrimonio monumen-tale della giovane nazione25. In tale contesto siinserisce il complesso programma di costruzionedella Roma capitale, al quale concorre anche Ar-manni a iniziare dalla partecipazione ai dueconcorsi per la realizzazione di uno dei simboli
212
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 212
213
Osvaldo Armanni, tavola dei dettagli del tempio di Vulcano in Ostia, 1877-1879 (ASPg, Armanni, c. 18).
Osvaldo Armanni, progetto del concorso nazionale per il Teatro Olimpico di Vicenza, Nuovo prospetto a tramontana, 1880 (ASPg,Armanni, c. 23).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 213
dello Stato unitario: il monumento a VittorioEmanuele II.Nel primo e controverso concorso del 1880, in cuial fianco di professionisti di fama internazionalesi misurano anche dilettanti di provincia26, ottienenel 1883 la medaglia d’argento dalla Commis-sione Reale presieduta dal primo ministro Ago-stino Depretis. Nella relazione allegata alle duetavole del progetto27, Armanni chiarisce i due cri-teri principali a cui risponde la sua proposta, ossia“il luogo in cui erigere il monumento e la formaed il concetto storico di esso”, volutamente nonvincolati nel regolamento del concorso. Circa lacollocazione, scrive Armanni, “dovendo il monu-mento al nostro Re rammentare un avvenimento,che è il risultato di fatti antichi e moderni, un av-venimento moderno, a cui fanno capo anticheaspirazioni, non pare ammettere dubbio l’oppor-tunità di erigere il lavoro in un punto di Romanuova”, ossia nella piazza delle Terme Dioclezia-nee28. Tale area è prescelta “primariamente perchéad essa fa capo la gran via Nazionale, che dallastazione giungendo al centro di Roma, apre l’in-gresso ai forestieri, secondariamente perché que-sta piazza è rimasta del tutto disadorna in mezzoalle molte opere edilizie moderne: anzi nello statopresente non è degna di star a fronte della piùgrande e bella via di Roma redenta”. Riguardoalla composizione, Armanni concepisce il monu-mento come la trasformazione dell’invaso esi-stente in una ‘piazza ornamentale’, ossia “ungran portico semicircolare, diviso nel mezzo dal-l’imboccatura di via Nazionale, dinanzi alla qualesorge alla distanza di m 72 l’arco di trionfo visibileancora dal fondo di detta via”. In quanto allo stileArmanni si attiene “in generale al Romano, per-ché il più grandioso e il più conveniente per l’ec-
celsa città; ma talvolta è stato costretto a seguirequalche forma del Cinquecento, poiché altrimentila parte decorativa sarebbe rimasta troppo limi-tata”. Valutazioni che appaiono consapevoli delleidee espresse da Camillo Boito negli scritti suRoma del 187529, e che conducono Armanni auna soluzione non molto distante da quella delfrancese Henry Paul Nénot, vincitore di questaprima fase progettuale.Nel 2° Concorso internazionale, il regolamentoemesso nel dicembre del 1882 definisce sia la loca-lizzazione sia il tipo: il monumento consisterà diuna statua equestre e un fondale architettonico edovrà porsi nel Campidoglio. In un contesto moltopiù omologante da cui risulterà vincitore il progettodi Giuseppe Sacconi, la proposta di Armanni è an-cora premiata con medaglia di merito (1885)30.Dalla frenetica attività progettuale di questi ini-ziali anni ottanta emerge la prima certa collabo-razione tra Armanni e Costa, autori tra il 1882 eil 1883 di un edificio residenziale di proprietà diNestore Guarnieri e Giuseppe Valteroni sito in viaMilazzo nel quartiere Macao a Roma31. La parte-cipazione ai concorsi nazionali resta tuttavia pre-minente in questo scorcio di secolo. Tra il1888-1889 Armanni partecipa al 2° Concorso perla sede del Parlamento a Roma.Nel 1871, nel trasferimento della capitale a Roma,il governo di destra aveva optato per una colloca-zione degli uffici governativi nelle storiche sedidella città papalina. A questa politica risale lascelta di insediare la sede del Parlamento italianonel Palazzo della Curia Pontificia a Montecitorio.Dopo i primi riadattamenti operati dall’ingegnerePaolo Camotto, nel 1879 si avviò un concorso de-stinato all’ampliamento dell’edificio e alla costru-zione di un’aula parlamentare in muratura. Dopo
214
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 214
alterne vicende, il 30 ottobre 188832 si decise perla realizzazione di una nuova sede del Parla-mento nel rione di Magnanapoli, nell’area deli-mitata dalla Torre delle Milizie, i giardini di VillaAldobrandini e gli orti posti in corrispondenza delsito su cui l’architetto Gaetano Koch edificherà lasede della Banca d’Italia (1888-1892)33. Il pro-gramma richiedeva che l’edificio sorgesse isolatocon il prospetto principale su via Nazionale, afronte di un’ampia piazza, e con strade di colle-gamento alle vie Nazionale e Cavour, e che fossecomposto da tre distinti corpi di fabbrica destinatirispettivamente alla Camera, al Senato e allagrande sala del trono. La proposta progettuale diArmanni appare, nel disegno del fronte princi-pale34, come risultato di una mediazione tra lagrandeur del classicismo delle capitali interna-zionali e un più misurato rinascimento italiano.La Commissione giudicatrice, composta, tra glialtri, da Alfredo D’Andrade, Luca Beltrami e Cal-derini, porta avanti i lavori fino ad arrivare al-l’approvazione del finanziamento. Tuttavia,l’ambizioso programma non viene attuato e nel1897 s’indice l’ennesima prova di concorso ritor-nando all’adattamento del Palazzo di Monteci-torio.
215
Osvaldo Armanni, progetto del primo concorso nazionale per il monumento a Vittorio Emanuele II, prospetto, 1880 (ASPg, Armanni,c. 23).
Attestato del conferimento della medaglia d’argento ad Ar-manni nel 1883 per il progetto avanzato al primo concorso na-zionale per il monumento a Vittorio Emanuele II (ASPg,Armanni, c. 23).
Osvaldo Armanni, progetto del secondo concorso nazionale peril monumento a Vittorio Emanuele II, prospetto, 1882 (ASPg,Armanni, c. 23).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 215
216
Osvaldo Armanni, Vincenzo Costa, edificio a uso residenzialenel quartiere Macao a Roma, fronte su via Milazzo, 1882-1883(ASC, Titolo 62, prot. 5354).
Osvaldo Armanni, Vincenzo Costa, edificio a uso residenzialenel quartiere Macao a Roma, foto d’epoca (ASPg, Armanni, c.18).
Osvaldo Armanni, progetto per il 2° Concorso per la sede del Parlamento a Roma, prospetto, 1888-1889 (ASPg, Armanni, c. 23).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 216
Non sono soltanto i grandi concorsi romani a co-stituire il banco di prova per Armanni. Alla metàdegli anni novanta egli partecipa alla prima fasedella competizione (1895-1896) per il completa-mento della facciata del duomo di Arezzo, rimastainterrotta agli inizi del XIV secolo. Il progetto ècontrassegnato con il motto Simplex, a indizio diuna semplicità che doveva rispondere alla richie-sta del bando di attenersi “allo stile e alle lineegenerali dell’edificio non dipartendosi dal mate-riale di cui è rivestito all’esterno”. Le scelte formalitrovano una sintesi nel giudizio del contempora-neo Torquato Broglio, che scrive “buono il dise-gno per la sua massa, buona la decorazione dellaparte inferiore: i piloni sono lisci e semplici. L’au-
tore ha omesso le nicchie ai lati dei piloni permantenere la severità e la sobrietà di forme”35.
Il Tempio Maggiore di Roma (1889-1904)
Nel luglio 1889 l’Università israelitica redige ilprogramma di concorso per il progetto di unTempio Israelitico atto a ospitare mille persone,di un oratorio di mq 100, scuole maschili e fem-minili e uffici per la comunità36. La costruzionedella sinagoga maggiore di Roma è espressionenon solo delle vicende urbanistiche inerenti allacostruzione di Roma capitale, in particolare lademolizione del ghetto prevista nel piano rego-
217
Osvaldo Armanni, progetto del primo concorso per il completamento della facciata del duomo di Arezzo, prospettiva,1895-1896 (ASPg, Armanni, c. 18).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 217
218
latore del 1873 e realizzata tra il 1886-1889, ma,anche, della svolta storica dell’ebraismo romanonegli anni dell’emancipazione dalla soggezionedello Stato Pontificio. L’architettura del nuovoTempio deve avere – come precisa il bando –“carattere monumentale e severo”, essa dovràessere simbolo da un lato dell’identità tradizio-nale dell’ebraismo, dall’altro dell’integrazionenazionale. Tra i ventisei gruppi partecipanti alconcorso risultano vincitori a pari merito il bi-nomio Armanni-Costa e l’ingegnere Attilio Mug-gia. Dopo il fermo imposto, tra l’altro, dallaprofonda crisi economica che investe la giovanenazione italiana a seguito del crac della BancaRomana, nel 1897 il Comune e l’Università ar-rivano a un accordo sulle aree da destinare alcomplesso. Nel gennaio del 1898 l’Università in-vita i due vincitori del 1889 a presentare un pro-getto rivisto sulla base di un nuovo programma.Muggia si ritira criticando alcuni articoli delnuovo bando, lasciando praticamente la vittoriaagli altri due progettisti. La prima pietra è postail 20 giugno 1901 e nell’estate del 1904 il Tem-pio è ultimato37. Rispetto alla soluzione primitiva, la modifica piùrilevante introdotta da Armanni-Costa nel pro-getto conclusivo è la sostituzione della coperturaa ziggurat con una più ‘familiare’ cupola a padi-glione. L’intero linguaggio utilizzato negli esterniabbassa il tono più marcatamente orientalista eleggiadro del primo disegno, più affine agliesempi internazionali e italiani successivi al-l’emancipazione, a iniziare da quelli delle due excapitali Torino e Firenze38. Nella soluzione finalei progettisti utilizzano stilemi frutto di un ecletticosincretismo, fantasiosamente definiti da loro stessi‘asiatici’ o ‘assiri’, ma in realtà ricomposti entro
Osvaldo Armanni, Vincenzo Costa, progetto della sinagoga diRoma, sezione con cupola a ziggurat (ASPg, Armanni, c. 18).
Osvaldo Armanni, Vincenzo Costa, progetto della sinagoga diRoma, sezione con cupola a padiglione (ASPg, Armanni, c. 18).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 218
una matrice classicista e una volumetria staticae monumentale.L’impianto a croce greca con navata maggioreoblunga orientata a est verso Gerusalemme segueil rito italiano39, con un interno che alleggeriscela pesante architettura con un’esuberante deco-razione scultorea e pittorica anch’essa ispirata amotivi greco-assiri. Le capacità tecniche del pro-gettista – come rilevato – emergono nella realiz-zazione della imponente cupola eseguita “concentine in ferro a traliccio, con l’estradosso inmattoni tubolari su cui sono applicati due strati,uno di intonaco ed un altro di cemento idraulicoper consentire la caratteristica copertura con la-mine in alluminio sottile e durevole nel tempo”40.Tra gli autori delle decorazioni degli interni, oltreal giovanissimo maestro di vetrate romano CesarePicchiarini (1871-1943), figurano due tra i più
brillanti e fortunati pittori perugini: DomenicoBruschi (1840-1915) e Annibale Brugnoli (1843-1915). Quest’ultimo41 collabora anche alla fini-tura di una delle altre due più piccole sinagogheromane affidate negli stessi anni ad Armanni eCosta dal presidente delle comunità israeliticheitaliane Angelo Sereni. Si tratta della decorazionedella sala di preghiera dotata di ampi matroneidell’Oratorio Di Castro in via Cesare Balbo aRoma, realizzato tra il 1912-1914; solo quattroanni prima i due progettisti avevano ultimato la
219
Roma, Tomba della famiglia Di Cave nel cimitero israeliticodel Verano, Osvaldo Armanni (foto Simonetta Ciranna).
Osvaldo Armanni, progetto della tomba Tranquillo-Pontecorvonel cimitero israelitico del Verano a Roma, prospetto (ASPg, Ar-manni, Elaborati grafici n. 35).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 219
nuovo edificio viene costruito tra il 1909-191546,a Reggio Calabria dal 1911 al 1917, a Mantovanel 1916. La realizzazione delle Poste di Perugiaè in stretta relazione con le trasformazioni urbaneche interessano il centro storico di questa città apartire dall’unità nazionale e, tra queste, l’aper-tura di una nuova via normale al Palazzo deiPriori (ora via Cesare Fani)47.Il 16 aprile 1909 il conte Valentini, sindaco dellacittà, incarica Armanni “di studiare se nell’areacompresa fra la via Mazzini, la piazza Garibaldi,la proprietà Mancini ed il soppresso vicolo dettodelle Meretrici” fosse possibile sistemare il Palazzodelle Poste e Telegrafi per una superficie non in-feriore a mq 1.400. Già negli anni precedenti sierano seguite diverse ipotesi progettuali dell’edi-ficio su aree prossime alla piazza Garibaldi (l’an-tica piazza del Sopramuro, ora Giacomo Matteot-
costruzione dell’Oratorio spagnolo a LungotevereSanzio (1910)42. La fiducia conquistata tra imembri della comunità è inoltre confermatadalle diverse sepolture affidate in quegli anni aidue professionisti43.
I Palazzi delle Poste e telegrafi e la questionedello stile
La sinagoga rappresenta per Armanni la consa-crazione dell’impegno professionale profuso neidue decenni precedenti; a testimoniarlo – oltrealle partecipazioni alle competizioni – è la varietàdei lavori svolti in area laziale e umbra44. Ormaiarchitetto affermato45, Armanni ottiene impor-tanti incarichi dalle pubbliche amministrazionitra le quali le Poste e i Telegrafi: da Perugia, il cui
220
Osvaldo Armanni, palazzo delle Poste e telegrafi di Perugia, 1909-1915,prospettiva (ASPg, Armanni, c. 23).
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 220
ti). Armanni si inserisce e risolve scelte urbane ededilizie già avviate e in fase di stallo; a confer-marlo, oltre all’articolo apparso in “La Tribuna”del 10 novembre 1909, è lo stesso progettista, nellarelazione redatta in quegli stessi giorni48. In talerapporto Armanni sottolinea come la costruzionedel palazzo offra al Comune la possibilità di unmiglioramento della qualità urbana ed edilizia;infatti il progetto “propugnato dall’ing. Bellini dicreare una strada che dalla piazza Garibaldi per-mettesse la visuale della porta del Palazzo Comu-nale, trova una naturale ed ovvia attuazione”. Contale via “oltre al potersi dare un conveniente pro-spetto al Palazzo delle Poste da questo lato, almettersi in evidenza il monumentale ingresso delpalazzo Comunale, ed alla probabilità di riporre
221
in luce le costruzioni del palazzo Vajani, vienesoppressa la viuzza del Forno, che al suo sboccosulla nuova via prende l’aspetto di una bottega.Tali miglioramenti edilizi avvantaggerannoanche le condizioni igieniche di quella zona tantocentrale ed attorniata da nobili edifici, ma detur-
Reggio Calabria, palazzo delle Poste e telegrafi, Osvaldo Ar-manni, 1911-1917, foto d’epoca (ASPg, Armanni, c. 25).
Mantova, palazzo delle Poste e telegrafi, Osvaldo Armanni, 1916,foto d’epoca (ASPg, Armanni, c. 25).
pata da indecenti ed anguste viuzze, offesa al-l’estetica ed alla igiene”. Economia e funzionalitàsono i caratteri che egli sottolinea49, osservandoin merito allo stile e alle decorazioni da adottareche Perugia ha “carattere notabilmente medioe-vale” anche se conserva “ragguardevoli esem-plari” di epoche successive. Pertanto “tali condi-zioni non possono, in chi si accinge ad ideareun’opera di architettura per questa città, non in-cutere rispetto e non generare il timore di far cosache possa turbare l’armonioso ed artistico insiemee possa non accordarsi con quel carattere medioe-vale che è nota predominante nelle costruzioniperugine. Ciò è tanto da tenersi in considerazionenel caso presente, a cagione del luogo in cui ilnuovo edificio dovrebbe sorgere, di fronte cioè a
palazzi che già decorano la piazza Garibaldi epresso la residenza comunale che dalla stessapiazza diverrebbe visibile. Ma il riprodurre servil-mente, allo scopo di accordarsi coll’ambiente,qualcuno dei tipi architettonici ricordati, oltre agenerare fastidiosa monotonia ed a riporre sot-
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 221
t’occhio temi già magistralmente trattati, po-trebbe anche contrastare colle necessità pratichedella costruzione in progetto. Mi proposi quindi,mettendo da parte ogni concetto troppo modernood esotico, di adottare un tipo decorativo, che, ispi-rato all’arte che fiorì fra il cadere del medesimoevo ed il sorgere del rinascimento, fosse in pienoaccordo col carattere generale della città, si adat-tasse a tutte le esigenze dell’uso e si prestasse aduna trattazione di sentimento moderno, ad esserecioè, per così dire, modernizzato”. Le scelte lin-guistiche dell’edificio, nel 1915 ormai comple-tato50, non trovano particolare apprezzamentonella stampa locale, beffarda anche sull’uso dellapietra caciolfa (dalla cava presso Foligno) e de-cisamente critica circa il ‘dente’ creatosi lungo lanuova via a causa del mancato allineamento trail fronte laterale delle poste e il palazzo Ajò51.A chiarire ulteriormente la posizione di Armannisullo stile è la relazione allegata al progetto del1911 per le Poste di Reggio Calabria, la cui rea-lizzazione è connessa alla ricostruzione post sismadel 1908. Scrive Armanni al paragrafo ‘Stile’: “ainostri tempi la grande varietà di materiali posti adisposizione del costruttore, la facile conoscenzadi tutte le forme adottate in tutti i paesi ed in tuttele epoche, la somiglianza e quasi la identità deicostumi di tutto il mondo civile, fanno si che l’ar-chitetto non si senta più vincolato ad un tipo sti-listico speciale, ma divenga, quasi forzatamente,libero ed eclettico. Nel presente caso, l’uso del ce-mento armato poteva forse invitare alla adozionedi forme speciali, indipendenti da ogni altro pre-concetto. Ma qui sorge un altro ordine di conside-razioni che a mio avviso, tendono a limitare talesconfinata libertà e a fissare un indirizzo più de-terminato. Infatti in una regione dove la classica
arte greca ha fiorito in modo singolare, in unpaese in cui brillò la sua nobile e severa fisiono-mia, poteva sembrare inopportuno che, troncandobruscamente la tradizione, s’innestasse, quasipianta esotica, un tipo che troppo da quella si al-lontanasse. E poiché il cemento armato facilmentesi piega alla rappresentazione di qualunqueforma, anzi direi quasi ad ogni capriccio dell’ar-chitettura, si preferì dare alla progettata costru-zione uno stile che, pur rispondendo alle esigenzedei nostri tempi, s’ispirasse alla civiltà che fiorì inquelle regioni, quando ancora tutta l’Europa eraimmersa nella barbarie e ricordasse così l’anticanobiltà che Reggio può vantare come le sue sorelledell’Italia Meridionale”52. Una palese dichiara-zione di disinteresse nei confronti delle prime spe-rimentazioni del cemento armato che nel palazzodelle Poste di Reggio Calabria furono condottedalla società dell’ingegnere Giovanni Antonio Por-cheddu, agente e concessionario del sistema Hen-nebique.
Conclusioni: le scuole e l’attività didattica
A chiusura di questa non certo esaustiva restitu-zione dell’opera di Armanni non può che collo-carsi la sua intensa attività dedicata sia allacostruzione di edifici scolastici sia, con particolarededizione e continuità, all’insegnamento.La prima di queste sembra avere inizio già nel-l’ultimo decennio dell’Ottocento ad Anagni conil Collegio Regina Margherita, risultato della ri-strutturazione del convento di San Giacomo, peril quale Armanni pare seguire insieme a Costa ladirezione dei lavori53; lavori progettati dall’archi-tetto Giulio De Angelis54. Gli incarichi più impor-
222
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 222
223
Assisi (Pg), Regio Convitto Nazionale Principe di Napoli,Osvaldo Armanni, foto risalente alla fine degli anni venti delNovecento (ASPg, Armanni, c. 25).
tanti giungono dopo la notorietà nel secondo eterzo decennio del Novecento, a iniziare dall’Or-fanotrofio Truzzi di Genzano (1910-1918), perseguire con la scuola elementare Garibaldi aUmbertide (1914-1917)55 e il Regio Convitto Na-zionale Principe di Napoli ad Assisi, inauguratonel 192756. Si tratta di tre complessi di grandi di-mensioni, che denotano la propensione del pro-gettista ad ‘armonizzarsi’ con i caratteri domi-nanti delle architetture circostanti, oscillandoquindi senza apparente interesse dal neorinasci-mento al neomedioevo57. Un approccio che adAssisi sarà aspramente criticato da GiovanniAstengo, redattore nel 1958 del piano di questacittà, il quale giudicherà l’edificio come una“enorme massa di pietra, ad archi e bifore, pa-rodia gigantesca delle modeste, graziose ed au-tentiche case medievali demolite per far posto almostruoso casermone”58.Quanto emerge nelle scelte linguistiche di Ar-manni trova ampio riscontro nell’attività di do-cente da lui intrapresa sin dal dicembre del 1879
con la cattedra di disegno nel Regio Istituto Tec-nico “Leonardo da Vinci” di Roma, poi tenutafino al 190759. Lui stesso chiarisce il suo pensieroin una relazione redatta nel passaggio dall’inse-gnamento del disegno a quello specifico del dise-gno dell’architettura60. Armanni, titolare da piùlustri di tale cattedra, pone al centro dell’insegna-mento rivolto ai “giovani studiosi dell’arte archi-tettonica, le manifestazioni tipiche dell’arte stessa,raggruppandole in quattro parti, corrispondentiagli stili architettonici principali, quali sono ilgreco, il romano, il gotico (ogivale) e lo stile delrinascimento”. Egli intende impartire ai suoi al-lievi “le prime nozioni di architettura e renderlicapaci a proseguire con profitto gli studi superiorinel medesimo campo presso le R.R. Università”. A suo parere lo studio “dei capolavori dai più re-moti tempi fino ai nostri giorni” educa al “senti-mento artistico; nessuna arte mai e nessunascienza è nata ex novo. Ogni idea, ogni fatto, ognimetodo è frutto di quanto precedette ed è alla suavolta origine di quanto si produrrà in seguito.Tutti i fenomeni, non esclusi quelli estetici, sonosoggetti alla legge progressiva, ma graduale, del-l’evoluzione: bisogna rivolgere lo sguardo nonsoltanto sopra alcune pagine quasi privilegiatedella vita dell’arte, ma tutte leggerle e studiarlesuccessivamente, per notarne il reciproco legame,il filo che tutte le unisce”61. A partire dal 1907 e fino al 1929 Armanni ricoprela cattedra di disegno di ornato e di architetturapresso la Scuola di disegno dell’Università diRoma in San Pietro in Vincoli, sempre coerente-mente “guidato nelle sue attività di docente e diarchitetto da criteri di semplicità e di temperatoclassicismo”62. Immutato è, infatti, il suo pensiero,come conferma una sua missiva inviata al preside
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 223
1 Osvaldo nasce a Perugia da Armanno Armanni e StellaPaolotti.2 Armanni si trasferisce a Roma appena ventenne.3 ARMANNI 1930.4 BATTAGLINI DI STASIO 1962.5 Tra cui il lavoro svolto dal professore Paolo Belardi nel-l’ambito del corso di Rilievo dell’Università degli Studi diPerugia.6 Il fondo è conservato nell’Archivio di Stato di Perugia; rin-grazio, per la cortesia e la disponibilità con le quali ha se-guito le mie ricerche, la dott.ssa Marina Regni alla quale si
224
Osvaldo Armanni, Corso di disegno architettonico, copertina(ARMANNI 1932, ASPg, Armanni, cc. 11-12 dispense).
Osvaldo Armanni, Lezioni di disegno architettonico del Prof.O. Armanni, copertina (ARMANNI s.d.)
della facoltà nel 1928: “i criteri didattici nellascuola di disegno ornamentale ed architettonico,variano, si può dire, in rapporto ad ogni singoloallievo, secondo la diversa attitudine dell’alunnoagli studi dell’arte. Per concretare adunque il mioprogramma generale per l’anno accademico1928-29 posso dire soltanto che, come negli annipassati, nel 1° Corso di facoltà per gli aspirantiingegneri, farò compiere esercizi di disegno orna-mentale fin dai primi elementi. La scolaresca pas-serà poi allo studio delle ornamentazioni a mezzamacchia, per terminare colle copie di riprodu-zione di ornati in fotografia. Nel 2° Corso inizieròpure dai primi elementi l’insegnamento dell’ar-
chitettura, per condurre gradualmente gli allieviin fin d’anno a disegnare e riprodurre edifici disvariati stili, dando preferenza allo stile greco eromano, e a quello del rinascimento”63.
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 224
225
deve la redazione di un inventario provvisorio del cospicuofondo di disegni, foto e documenti di Osvaldo Armanni.7 Premesse essenziali, queste, per rompere i vincoli e l’om-bra caduta sull’attività di Armanni e di ‘tecnici’ che comelui hanno contribuito a costruire la città e i suoi principaliedifici pubblici nei decenni di messa a punto dello StatoItaliano, dall’Unità agli anni venti del Novecento.8 Tra i disegni conservati nell’Archivio Storico dell’Acca-demia di Belle Arti di Perugia (ASABAP), Fondo didattico,Disegni: Scuola di Prospettiva, cartelle I-V, n. inv. 186, v.inv. 267, Armanni Osvaldo, 1872 e n. inv. 192, v. inv. 276,Osvaldo Armanni, 1873; Scuola di Architettura, cartelle I-XXII, n. inv. 804-805, n. inv. 890-891, Armanni Osvaldo,1872; Scuola di figura, cartella XIII, n. inv. 38, v. inv. 38,Armanni Osvaldo, 1873; e di non certa attribuzione Scuoladi figura, n. inv. 43, [Osvaldo Armanni] 1870.9 Sull’attività di Calderini (1837-1916) si vedano, tra glialtri: CALDERINI 1917; MARCONI 1974; BOCO, KIRK, MURATORE
1995; BOCO 1996.10 Nel Fondo Armanni si conservano alcune dichiarazioniautografe di Calderini che certificano l’attività svolta daOsvaldo nel suo studio e come sostituto nella sua cattedrain Accademia, cfr. ASPg, Fondo Osvaldo Armanni (da oraASPg, Armanni), b. 1, Documentazione personale (1874-1926). Si precisa che le collocazioni archivistiche sonoprovvisorie e relative al momento della consultazione.11 Sulla figura di questo sacerdote, insegnante, patriota eletterato si veda TOSTI 2007.12 La cui visione positivista, materialista ed evoluzionistasi ritroverà molti anni dopo nelle idee di Armanni sullosviluppo dell’arte e dell’architettura.13 Tra le diverse medaglie ottenute in Accademia: nel Con-corso Annuale del 1870-1871, la Facoltà di Architettura gliassegna il primo premio con medaglia d’argento nella 3aclasse di ornato, il primo premio con medaglia d’argentonella 1a classe di architettura; nel Concorso Annuale del1871-1872, la Facoltà di Architettura gli attribuisce la me-daglia d’argento nella 4a classe di architettura e la meda-glia di bronzo nella 1a classe di Prospettiva, la Facoltà diPittura la medaglia di bronzo nella 1a classe di ornato pla-stica; nel Concorso Annuale del 1872-1873, la Facoltà diArchitettura gli conferisce la medaglia del valore di LireCento nella Classe Superiore di Architettura e la medagliadi bronzo nella 2a Classe di Prospettiva, la Facoltà di Pitturala medaglia di bronzo nella 1a Classe di Disegno, quella diPittura e Scultura la medaglia di bronzo nella 1a Classe diScultura; nel Concorso Annuale del 1873-1874, la Facoltàdi Architettura lo premia con la medaglia d’argento per laprospettiva nella 3a Classe e la medaglia d’argento per l’Or-
nato 3a Classe; la Facoltà di Pittura con la medaglia dibronzo per la scultura nella 2a Classe. 14 Per equipollenza agli studi del corso complementarescientifico già istituito nella stessa scuola per i licenziatidagli Istituti di Belle Arti.15 Cfr. CIRANNA 2009.16 GROHMANN 2003, pp. 72-73. Sui numerosi e controversiprogetti che interessarono questo monumento a partiredal 1841 cfr. RICCI 1921.17 Nel Corriere dell’Umbria del 1° luglio di quell’anno Cal-derini vanta il risultato del suo allievo a dimostrazionedella validità dell’insegnamento dell’Accademia. Le paroledi Calderini forse favorirono la decisione del Consiglio Co-munale assunta nella seduta del 7 febbraio 1876, di elar-gire ad Armanni un assegno di L. 800 secondo alcunecondizioni da stabilirsi dall’Accademia. In ASABAP, Car-teggio amministrativo organizzato per titolario, b. 37,n. 84 “Armanni Osvaldo dal 1875 al 1878”. L’Accademiafisserà la consegna di un saggio di rilievo e restituzionegrafica probabilmente del tempio di Giove Statore; non èchiaro se Armanni consegnò mai tali disegni.18 Costruita in blocchi di travertino nella seconda metà delIII secolo a.C. e ristrutturata da Augusto nel 40 a.C., laporta è fiancheggiata da due torri a pianta trapezoidale ascarpa, in quella sinistra alla base è addossata una fonteseicentesca mentre nel coronamento è sovrapposto un log-giato rinascimentale. Cfr. GROHMANN 2003, p. 11. 19 Le aggiunte sono considerate incongrue superfetazioniin coerenza a una metodologia di restauro più ‘rispettosa’dell’originaria unità formale dei monumenti appartenentiall’antichità. In ASPg, Armanni, ci sono due disegni (38/2,38/3) dove nel primo si riporta “Progetto di restauro del-l’Arco della Via Vecchia in Perugia, Roma - Pensione Stan-zani - Anno I. II saggio trimestre [?]”. Ivi, nell’albumfotografico dal titolo Progetti di architettura e lavori ese-guiti dall’architetto Osvaldo prof. Armanni sono presentiquattro foto, due relative a questo restauro e due a quellodella Porta San Pietro. In entrambi i casi la prima è unariproduzione Alinari e documenta lo stato ante-operam,la seconda riprende il disegno di progetto. 20 Infatti, già nel 1862 Calderini aveva studiato e progettatoil restauro di quest’arco, cfr. CALDERINI 1862b, contenenteanche il disegno di progetto. 21 ASABAP, Carteggio amministrativo organizzato per ti-tolario, b. 37, n. 84.22 Nell’attestato rilasciatogli risulta premiato come espo-sitore di “disegni ornamentali di progetti architettonici”,in ASPg, Armanni, cartella 23. Armanni scrive inoltre diaver ottenuto una medaglia d’argento nella stessa esposi-
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 225
Scole corrispondenti ai diversi riti di appartenenza dellacomunità ebraica romana.37 COSTA, ARMANNI 1904. Il 2 luglio di quell’anno il re VittorioEmanuele III visita la sinagoga e in tale occasione nominaCosta e Armanni Ufficiali della Corona d’Italia; il 27 lugliouna solenne cerimonia religiosa consacra l’edificio e ilgiorno successivo ha luogo l’inaugurazione civile alla pre-senza delle autorità. Vedi inoltre ASC, Titolo 54, prot.16566, a. 1903.38 CALABI 1992.39 Non estraneo all’organizzazione liturgico-tipologicadella tradizione cristiana; la stessa arca riprende lo sceno-grafico impaginato degli altari barocchi romani.40 RACHELI 1983.41 Autore di grandi cicli decorativi in prestigiosi interni diarchitetture, quali a Roma la decorazione della cupola del-l’attuale teatro dell’opera, dei magazzini Bocconi (ex laRinascente), di sale al Senato, al Quirinale, nei palazziRuspoli e Salviati. A Perugia lavora con Calderini raggiun-gendo una dei suoi massimi livelli nella Sala Brugnoli(1901) del Palazzo Cesaroni, in cui lavorò anche Bruschi,autore delle figure femminili che ornano gli specchi e deifinti arazzi. In accordo a quanto sostenuto da GiuseppeMiano (MIANO 1996, p. 45), gli artisti “perugini, più omeno solidali tra loro, formarono una squadra della qualeCalderini fece parte, anche se con un certo distacco e inuna posizione alquanto defilata”; un distacco che sembravalere anche nei confronti di Armanni.42 MIGLIAU 2004. Cfr. inoltre ASC, Titolo 54, LungotevereSanzio, prot. 91981, a. 1908.43 Tra queste le tombe nel cimitero israelitico del Veranodella famiglia Di Cave, oggi in forte degrado, e Tranquillo-Pontecorvo. Entrambe sono presenti tra i numerosi disegnie foto relativi a monumenti sepolcrali in ASPg, Armanni.Tra le altre tombe realizzate nella parte cattolica del Veranoè quella del noto scultore Giulio Monteverde (1837-1917)sita nel Pincetto Nuovo, contenente la copia dell’Angelodella Resurrezione (detto anche di Monteverde) il cui ori-ginale (1881), considerato uno dei massimi esempi discultura di genere, orna la tomba monumentale della fa-miglia Oneto nel cimitero di Staglieno di Genova.44 Valgano a esempio: i lavori di consolidamento e riatta-mento condotti nell’edificio della Banca Popolare Coope-rativa di Assisi nel 1891; la realizzazione di due villini e laricostruzione di due case a Nemi per l’avvocato L. Mor-purgo tra il 1885 e il 1896; i lavori di architetto svolti peril comune di Rocca di Papa dal 1891 al 1897; l’altare interracotta e i restauri eseguiti nella chiesa di Maria SS.delle Grazie nel 1876 a Magliano Sabino, comune per il
zione tenutasi nel 1899: ivi, relazione firmata da Armannie datata Roma aprile 1907.23 Classificandosi, egli sostiene, tra i tre migliori concor-renti, in ibidem.24 CIRANNA, DOTI, NERI 2011, passim.25 MANGONE 2002.26 BRICE 1986.27 ASPg, Armanni, busta 3.2. Progetti. Roma, Descrizionee perizia del progetto per il monumento da erigersi inRoma in onore a V. Emanuele II. 28 “Riserbando alla decorazione l’ufficio complessivo dellemolteplici allusioni”.29 Boito è peraltro membro della Commissione giudicante.Cfr. BOITO 1875; wILLIAMS 1996, in particolare pp. 15-16;SELVAFOLTA 1997, in particolare p. 51. 30 In realtà il rapporto di Armanni con il monumento aVittorio Emanuele II prosegue nel Novecento. Con letteradel 28 Novembre 1904 il Ministro dei Lavori Pubblici no-mina Armanni membro del Collegio arbitrale in meritoalla vertenza tra il Ministero e l’impresa Davide Lombardiassuntrice per contratto 25 marzo 1903 della fornitura dimetà circa della pietra occorrente per il monumento, inASPg, Armanni, b. 3.2.31 Un’area compresa nel piano di espansione di Romalungo via Castro Pretorio, destinata ad appartamenti di af-fitto per la media borghesia. In Armanni, b. 3.1 è conser-vata la dichiarazione di Nestore Guarnieri, datata 20novembre 1899, il quale attesta che i due professionisti trail 1882-1883 “progettarono e diressero un Casamento dimia proprietà in via Milazzo e ciò con mia piena soddi-sfazione tanto sul lato artistico che dal lato tecnico-am-ministrativo. Tale risultato mi consigliò di servirmi dellaloro opera in varie liquidazioni di importanti lavori da meeseguiti in varie epoche, il quale compito venne dagli stessiesaurito con intelligenza e amore”. La licenza edilizia n.62 è concessa il 12 ottobre 1883, l’abitabilità n. 52 è rila-sciata il 21 maggio 1884, in ASC, Titolo 62, prot. 5354, viaMilazzo 28, a. 1883.32 Data della pubblicazione del programma per un secondoconcorso nazionale con scadenza 31 ottobre 1889.33 Vedi SANTINI 2011. 34 In ASPg, Armanni, cart. 23.35 Nella commissione giudicatrice è nuovamente presenteCalderini. Cfr. BROGLIO 1898. Le nicchie “a pieno sesto conl’interno adorno di costoloni, nelle quali Niccolò aretinocollocò due statue” erano parte dell’appena iniziato rive-stimento della facciata riconducibile al XIV secolo.36 Cfr. da ultimo Il Tempio Maggiore 2004. Nel 1887 eranostati espropriati gli edifici in cui avevano sede le Cinque
226
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 226
227
quale esegue restauri nel palazzo municipale, a porta Sa-bina (non più esistente) e nella chiesa di San Michele Ar-cangelo nel 1898.45 Come già detto, nel 1899 Armanni ottiene la laurea diarchitetto presso la Regia Scuola di Applicazione per gliingegneri in Roma (per riconosciuta equipollenza ai li-cenziati dagli Istituti di Belle Arti) e nel giugno del 1901risulta iscritto all’Albo Municipale degli Architetti di Roma. 46 Prima di Perugia vanno ricordati due progetti legati adAssisi, documentati in ASPg, Armanni. Il primo riguardala casa colonica modello costruita in località vocaboloMontenero, premiata con medaglia d’argento dal Mini-stero di Agricoltura Industria e Commercio nel 1907. Il se-condo concerne l’incarico assegnatogli dal sindaco nelmarzo del 1910 per la sistemazione del Teatro ComunalePietro Metastasio (demolito nel 1955). 47 Sulle storia dell’edificio si rinvia a TRABOLOTTI, VICARELLI
2003. Cfr. inoltre BELARDI 2009, in particolare BONCI, FILIP-PUCCI, MENCHETELLI, MERLI 2009.48 Nell’articolo a firma di V. Mariani (MARIANI 1909) è pub-blicato il disegno prospettico del fronte dell’edificio supiazza Garibaldi. La relazione, non datata, è in ASPg, Ar-manni, b. 6.49 Così scrive: l’edificio “è progettato in pietra con ricorsiin mattoni. La zona inferiore esterna per un altezza mediadi circa m. 2,00 è rivestita di pietra da taglio” e così per m.3 gli stipiti, i pilastri e tutta “la parte soggetta ad esser piùfacilmente danneggiata”. I solai sono previsti di travi diferro e volticelle. Le decorazioni esterne eccetto i rivesti-menti detti e le colonnine dei pilastrini delle finestre tuttiin pietra, saranno “in istucco e cemento, materiale che haormai dato prove sufficienti di solidità”. 50 Armanni esegue i disegni di progetto nel suo studio ro-mano e si affida molto nell’esecuzione al direttore dei la-vori e suo amico l’ingegnere Marzio Picconi, cfr. le lettereinviate da Armanni a Picconi conservate in ACPg, ProgettiPalazzo delle Poste e telegrafi, b. 1. Dall’incartamento sideduce che Armanni nel 1914 ha in corso un altro cantierea Foligno: si tratta quasi certamente dell’edificio sede dellaCamera di Commercio, da lui progettato nel 1913 e con-cluso nel 1917, in ASPg, Armanni, b. 3.2.51 TRABOLOTTI, VICARELLI 2003, in particolare pp. 28-30.52 Aggiungendo: “poiché io penso che a noi Italiani in-comba quasi un duplice dovere, di non restare (...) indietroa nessuno nell’adottare qualunque cosa che sia di miglio-ramento e di progresso sul passato, anzi, se possibile far-sene maestri e banditori, ma nello stesso tempo nonspezzare gli anelli della secolare catena che lega il nostropresente ai più remoti tempi dell’antichità per non lasciare
spegnere quell’aureola di lunga operosa vita che la nostranazione può vantare”.53 Nel gennaio del 1897 Armanni e Costa ricevono un com-penso, rimborso per le spese sostenute negli otto anni di di-rezione dei lavori al collegio Regina Margherita e deinumerosi progetti (molti non realizzati) ad Anagni in ASPg,Armanni, b. 3. Ancora il 19 gennaio 1911 il Rettore dellaRegia Università degli Studi di Roma scrive ad Armanni in-vitandolo a presentare un documento dal quale risulti chevenne incaricato di redigere i progetti di massima dei collegiPrincipe Umberto di Napoli in Assisi e Regina Margherita inAnagni come lui afferma, ivi, b. 2/1 Corrispondenza. 54 Su questa personalità di spicco del secondo Ottocento,anch’essa formatasi presso l’Accademia di Belle Arti di Pe-rugia cfr. ZULLO 2005, su Anagni pp. 79-80; cfr. anche, inquesto stesso volume, il saggio di Enza Zullo e Claudio Va-ragnoli, pp. 197-207.55 Su questa una prima indagine storica e il rilievo sonoin TIRONZELLI 2009-2010.56 Armanni si era interessato di questo edificio già nel 1907;ampia è la documentazione conservata in ASPg, Ar-manni.57 Caratteristiche peraltro riprodotte anche nei progetti perla Scuola elementare a Gualdo Tadino e nel 1928 per iconvitti di Caritza e Tirana in Albania, in ASPg, Armanni.58 Citato in GROHMANN 1989, p. 172.59 L’11 marzo 1881 è reggente e nel gennaio-febbraio del1884 viene promosso titolare.60 A seguito di un provvedimento del Ministero della Istru-zione Pubblica l’insegnamento generico del disegno è so-stituito da quello specifico dell’architettura, posto alsecondo biennio della Sezione fisico-matematica. Rela-zione non datata in ASPg, Armanni, b. 2 Corrispondenza.61 Evidente qui l’eco dell’insegnamento del prof. EnricoDal Pozzo di Mombello.62 Così è delineato il suo profilo in SPANO 1935, p. 188.63 ASPg, Armanni, b. 2 Corrispondenza, lettera inviata alpreside della facoltà da Assisi nel luglio del 1928 a pochimesi quindi dalla sua morte.
L'architettura della Perugia postunitaria-Impaginato_Layout 1 11/06/13 10:02 Pagina 227








































![[Federica Dallasta e Fabrizio Tonelli], Il culto della Ghiara e la sua diffusione extra estense 1596-1700: geografia e cronologia dei miracoli, luoghi di stampa d’immagini e di libri](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632fae51b48f2d9cd804e209/federica-dallasta-e-fabrizio-tonelli-il-culto-della-ghiara-e-la-sua-diffusione.jpg)