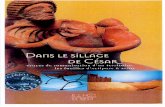“More filiorum”: il problematico inserimento dei giovani esposti in una familia ospedaliera del...
Transcript of “More filiorum”: il problematico inserimento dei giovani esposti in una familia ospedaliera del...
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MEDIEVALI “CECCO D'ASCOLI”
I GIOVANI NEL MEDIOEVOIDEALI E PRATICHE DI VITA
Atti del convegno di studiosvoltosi in occasione della XXIV edizione del
Premio internazionale Ascoli Piceno
(Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 29 novembre-1 dicembre 2012)
a cura di
ISA LORI SANFILIPPO e ANTONIO RIGON
ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVOROMA 2014
III serie diretta daAntonio Rigon
Comune di Ascoli Piceno Fondazione Cassa di Istituto storico italianoRisparmio Ascoli Piceno per il medio evo
© Copyright 2014 by Istituto Superiore di Studi Medievali “Cecco d’Ascoli” - Ascoli Piceno
Coordinatore scientifico: ISA LORI SANFILIPPO
Redattore capo: SALVATORE SANSONE
Redazione: SILVIA GIULIANO
ISBN 978-88-98079-23-0
Stabilimento Tipografico «Pliniana» - V.le F. Nardi, 12 - Selci-Lama (Perugia) - 2014
Il progetto è stato realizzato con il contributo dellaFondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Michele PelleGrini
“More filiorum”: il problematico inserimento dei giovaniesposti in una familia ospedaliera del tardo medioevo
le pratiche di tipo adottivo in età medievale – tema del progetto a mar-gine del quale nascono queste riflessioni – costituiscono un oggetto diricerca che, pur già esplorato da molteplici prospettive1, dischiude ancoraun ventaglio quanto mai vasto di interrogativi. Mettendo difatti in luce,anche nella storia della società bassomedievale, una gamma variegata diesperienze nelle quali il trasfert d’enfant si lega a processi di costruzione dimenage familiari non esclusivamente fondati su matrimonio e procreazio-ne, la ricerca sulle pratiche dell’‘adozione’ medievale spinge ad interrogar-si sul senso, prima ancora che sull’incidenza quantitativa, di quelle dinami-che familiari allargate. Un interrogativo che necessariamente rinvia al piùvasto orizzonte problematico dei rapporti tra famiglia biologica e famigliaspirituale e, dunque, alla complessa interrelazione tra ‘legami di sangue’ e‘legami d’anima’ che caratterizzò, allora, tanto il vissuto di individui e fami-glie quanto la vitale costruzione di forme associative ed esperienze comu-nitarie di stampo religioso.
in questa prospettiva, proprio le reti relazionali che si intesserono den-tro e attorno alle grandi strutture assistenziali urbane dell’italia tardo-comunale si segnalano senz’altro come uno dei terreni in cui più opportu-na e fruttuosa può riuscire l’indagine. Si tratta – come è noto – di struttu-re spesso promosse da famiglie e gestite da gruppi di laici dell’uno e del-l’altro sesso che, profondamente radicati nel tessuto sociale e politico della
1 i principali riferimenti del più recente dibattito storiografico sono individuabili inL’adoption. Droits et Pratiques. thème coordonné par d. lett et c. lucken («Médiévales»,35 [1998]), Paris 1999; F. roumy, L’adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle,Paris 1998; Adoption et Fosterage, sous la direction de M. corbier, Paris 1999, cui siaggiunge ora Pratiche dell’adozione in età bassomedievale e moderna, cur. M. Garbellotti -M.c. rossi, «Mélanges de l’École française de rome. italie et Méditerranée», 124/1 (2012),pp. 120-271, che raccoglie i primi frutti del progetto di ricerca, coordinato da Maria clararossi, cui si fa riferimento in apertura. al contributo della stessa rossi in questo medesimovolume si rinvia per una più approfondita rassegna.
Michele PelleGrini62
propria città, in ragione di quell’impegno caritativo e degli ideali religiosiche lo sostenevano si associavano, ora in forme confraternali, ora in espe-rienze comunitarie più totalizzanti e strutturate, connotate cioè da unapiena adesione allo stato religioso pur se non sempre nei termini di com-piuta accettazione della vita regularis2. Uomini e donne, dunque, che senzanecessariamente rinunciare alla vita coniugale e, quindi, alle logiche dellasolidarietà interna al nucleo familiare e al ceto cui appartenevano, speri-mentavano tuttavia la contemporanea appartenenza a una famiglia artifi-ciale – quella ospedaliero-confraternale – fondata su un vincolo spiritualee sulla asserita apertura dei suoi membri alle logiche di una solidarietàdiversa, se non opposta, rispetto a quella del sangue. Strutture assistenzia-li e famiglia appaiono dunque, almeno nella storia delle società urbane deltardo medioevo italiano, come i termini di una relazione non scontata, chesi riflette prismaticamente in aspetti molteplici e diversi tra loro.
È stato ormai largamente messo in luce, ad esempio, il ruolo preminen-te, pur se non esclusivo, che gli enti assistenziali preposti alla cura dell’in-fanzia abbandonata svolsero, sul finire del medioevo, come interlocutoridelle famiglie nell’instaurazione di prassi di accoglimento all’interno delnucleo domestico di infanti e fanciulli3. Grazie a una ricca tradizione di
2 Per un aggiornato quadro d’insieme: Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testi-monianze, cur. M. Gazzini, Firenze 2009. Sulle realtà ospedaliere gestite da comunità diuomini e donne raccolti in esperienze di semireligiosità vale la pena di segnalare, gli ormaiclassici studi di a. rigon, S. Giacomo di Monselice nel medio evo. Ospedale, monastero, col-legiata, Padova 1972; d. rando, “Laicus religiosus” tra strutture civili ed ecclesiastiche: l’ospe-dale di Ognissanti in Treviso (sec. XIII), in Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoliXII e XIII, cur. G.G. Merlo, torino 1987, pp. 43-84. Sullo stato di semireligiosità v. K. elm,“Vita regularis sine regula”. Significato, collocazione giuridica e autocoscienza dello stato semi-religioso nel Medioevo, in Regulae - Consuetudines - Statuta: studi sulle fonti normative degliordini religiosi nei secoli centrali del Medioevo. atti del Seminario internazionale di Studiodel centro italo-tedesco di Storia comparata degli ordini religiosi (Bari/noci/lecce, 26 -27 ottobre 2002/castiglione delle Stiviere, 23-24 maggio 2003), Munster 2005, pp. 407-422;c. de Miramon, Les “donnés” au Moyen Âge. Une forme de vie religieuse laïque (v. 1180 - v.1500), Paris 1999 (pp. 344-386 per gli oblati ospedalieri).
3 Per alcuni casi beni indagati: l. Sandri, La richiesta di figli da adottare da parte dellefamiglie fiorentine tra XIV e XV secolo, «annali aretini», 3 (1995), pp. 117-136; Sandri,Fanciulli e fanciulle «posti con altri» all’ospedale degli Innocenti di Firenze: note per una sto-ria del lavoro minorile nella seconda metà del Quattrocento, in Senza famiglia. Modelli demo-grafici e sociali dell’infanzia abbandonata e dell’assistenza in Italia (secc. XV-XIX), cur. G.da Molin, Bari 1997, pp. 221-252; Sandri, L’Ospedale di S. Maria della Scala di S.Gimignano nel Quattrocento: contributo alla storia dell’infanzia abbandonata, Firenze 1982,pp. 175-189; G. albini, L’abbandono dei fanciulli e l’affidamento: il ruolo dell’OspedaleMaggiore di Milano (sec. XV), in albini, Città e ospedali nella Lombardia medievale, Bologna1993, pp. 154-183; c. Minoli, La cura degli esposti alla fine del Quattrocento, in L’OspedaleRodolfo Tanzi di Parma in età medievale, cur. r. Greci, Bologna 2002, pp. 252-255.
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 63
studi che ha indagato, proprio attraverso l’esame delle fonti ospedaliere,molteplici aspetti della storia dell’infanzia abbandonata4, è altresì ben notocome per alcuni almeno di quegli esposti che non fossero stati stabilmenteaccolti da famiglie ‘adottive’, o rivendicati e restituiti ai genitori naturali, altermine del baliatico – che comportava comunque, di norma, il tempora-neo trasferimento del lattante all’interno del nucleo familiare della balia,protratto talora fino al quarto o al sesto anno di vita5 – si apriva il tempodi una fanciullezza e un’adolescenza durante le quali l’ambito e i riferimen-ti ordinari e, per così dire, domestici della vita, delle relazioni e della stes-sa affettività erano necessariamente costituiti dall’ente assistenziale che liaveva accolti, dagli uomini e dalle donne che in esso, a vario titolo, viveva-no e avevano responsabilità della loro educazione.
indagare il peculiare rapporto che si instaurava tra questi esposti, segui-ti nel passaggio dall’infanzia alla giovinezza, e la particolare familia – quel-la appunto costituita dalle comunità ospedaliere – che li aveva accolti infan-ti e ora, al termine del baliatico, li riaccoglieva al proprio interno, appunto,come figli, non è parso, così, fuori luogo nel quadro della riflessione assailarga che si va conducendo sui presupposti ideali ed il senso che poteronoavere, nelle società urbane del tardo medioevo, tutte quelle esperienze di
4 Si segnalano qui solo alcuni tra i contributi e le occasioni di confronto che, insiemeai lavori di cui alla nota precedente, hanno segnato la crescita di questo campo di studi apartire dal libro, a suo modo fondativo, di John Boswell, L’abbandono dei bambini inEuropa occidentale, Milano 1991 (ediz. or. 1988); Enfance abandonée et société en Europe:XIVe-XXe siècle. actes du colloque international (rome, 30-31 janvier 1987), rome 1991;‘Benedetto chi ti porta, maledetto chi ti manda’. L’infanzia abbandonata nel Triveneto (seco-li XV-XIX), treviso 1997; Senza famiglia. Modelli demografici cit.; n. terpstra, AbandonedChildren of the Italian Renaissance. Orphan Care in Florence and Bologna, Baltimore 2005;Per la storia dell’infanzia abbandonata in Europa. Tra Est e Ovest: ricerche e confronti, cur.F. lomastro - F. reggiani, roma 2013. Fornisce una buona guida per un più compiutoorientamento bibliografico nella ricchissima produzione degli ultimi decenni un capitolointroduttivo di F. Bianchi, La Cà di Dio di Padova nel Quattrocento. Riforma e governo diun ospedale per l’infanzia abbandonata, Venezia 2005.
5 Sul tempo del baliatico e la gestione del ‘mercato del latte’ per la toscana del tardomedioevo cfr. in particolare G. Pinto, Personale, balie e salariati dell’ospedale di San Gallo,«ricerche storiche», 2 (1974), pp. 113-168; ch. Klapisch-Zuber, Parents de sang, parents delait. La mise en nourrice en Florence 1300-1530, in Mères et nourrissons, «annales dedémographie historique», (1983), pp. 33-64 (trad. it. Genitori di sangue, «genitori» dilatte. Andare a balia a Firenze, in Klapisch-Zuber, La famiglia e le donne nel Rinascimentoa Firenze, roma-Bari 1988, pp. 213-252); l. Sandri, Baliatico mercenario e abbandono deibambini alle istituzioni assistenziali: un medesimo disagio sociale?, in Donne e lavoronell’Italia medievale, cur. M.G. Muzzarelli - P. Galetti - B. andreolli, torino 1991, pp. 93-103; ed il iii capitolo del volume di t. takahashi, Il Rinascimento dei trovatelli. Il brefotro-fio, la città e le campagne nella Toscana del XV secolo, roma 2003, pp. 75ss.
Michele PelleGrini64
convivenza e affezione familiare volontariamente costruite tra persone nonlegate dal vincolo di sangue; esperienze cui proprio le pratiche d’accogli-mento in fosterage, affiliazione o vera adozione degli esposti da parte di cop-pie, individui e comunità diedero allora frequente occasione.
l’assunzione di funzioni di ‘genitorialità sostitutiva’ da parte di entiassistenziali che si dedicarono anche od esclusivamente all’accoglienza del-l’infanzia abbandonata può dirsi infatti, almeno per la fase propriamentemedievale, una realtà più nota che indagata, e questo tanto riguardo alleforme in cui tali espressioni di autorità genitoriale furono concretamenteesercitate, quanto in ordine ai modi in cui quello stesso ruolo genitorialevenne pensato e compreso dai protagonisti di quelle relazioni. Gettar lucesu questi aspetti è, appunto, quanto mi propongo di fare, coniugando l’in-dagine privilegiata di uno specifico contesto documentario con la discus-sione delle suggestioni desumibili su questo tema da una tanto ricca quan-to disomogenea bibliografia, fatta di molti studi monografici su singolerealtà ospedaliere e alcune proposte di sintesi sul piano problematico.
il mio primo riferimento documentario è costituito dalle fonti trasmes-se dalla vitale realtà ospedaliera senese d’età medievale, già da tempo inda-gata anche in relazione a temi contigui al nostro6, ma che costituisce anco-ra un case study prezioso per almeno due ragioni: da un lato la cronologiadella documentazione, che ci dà occasione di indagare per il XiV secolotemi e vicende che di norma è dato seguire solamente dal Quattrocento e,spesso, dal Quattrocento inoltrato; dall’altro quello di rinviarci ad un con-testo peculiare, nel quale figura come attore principale una comunità ospe-daliera – quella di Santa Maria della Scala – che mantiene, per tutto il
6 Per la fase tardomedievale dell’assistenza all’infanzia nell’ospedale senese – cui giàprestavano larga attenzione G. Piccinni - l. Vigni, Modelli di assistenza ospedaliera traMedioevo ed età moderna. Quotidianità, amministrazione, conflitti nell’ospedale di SantaMaria della Scala di Siena, in La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medie-vale, cur. G. Pinto, Firenze 1989 – si rinvia all’ampia indagine condotta da M. Martellucci,I bambini di nessuno. L’infanzia abbandonata al Santa Maria della Scala. Secoli XIII-XV,«Bullettino senese di storia patria», 108 (2001), pp. 9-221; per l’età moderna: l. Vigni,Aspetti del fenomeno dell’infanzia abbandonata e mobilità territoriale degli esposti all’ospe-dale senese di Santa Maria della Scala nel XVIII secolo, in La demografia storica delle cittàitaliane, Bologna 1982; Vigni, Gli esposti all’ospedale senese Santa Maria della Scala (1763-68), «Bullettino senese di storia patria», 92 (1985) pp. 198-235; Madri e figli nella Sienagranducale: l’assistenza dell’ospedale alla maternità e all’infanzia abbandonata 1775-1860.catalogo della mostra documentaria organizzata dal centro culturale delle donne MaraMeoni (Siena, 15 dicembre 1984-13 gennaio 1985), Siena 1984; c. Buccianti, Infanziaabbandonata e gravide occulte a Siena nel periodo napoleonico, «Miscellanea storica dellaValdelsa», 100 (1994), pp. 121-138.
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 65
trecento ed oltre, una sua notevole corposità e una indiscutibile vitalità econservò di conseguenza una diretta responsabilità sul governo e gli indi-rizzi gestionali dell’ente oltre che un ruolo essenziale nell’esercizio dei ser-vizi assistenziali7, tra i quali ebbe sempre primaria rilevanza l’assistenza deigettatelli.
nell’organizzazione di questa esperienza comunitaria senese nellaquale – come in tante altre esperienze che tra Xii e Xiii secolo vedonouomini e donne coesistere in un’unica comunità8 riconoscendosi tra sécome fratelli e sorelle e sottomettendosi in obbedienza all’autorità di unpadre (rector o magister) – esercitò un peso importante la riproduzione dimodelli relazionali di tipo familiare. nella comunità ospedaliera senese,inoltre, l’incidenza di quei modelli viene ulteriormente arricchita del ruolo,né trascurabile né secondario, svolto all’interno di quella comunità dallereali famiglie di quegli oblati che accedevano all’esperienza di conversionein coppia, o comunque mantenendo, dello stato di vita matrimoniale, ilegami e gli obblighi verso il coniuge e la prole. Questi fratres e sororesextrinseci – che conservavano un domicilio autonomo, talora occupandocase o abituri vicini o contigui al complesso ospedaliero – rimasero sempreattivi nella gestione dell’ente e nell’esercizio dei servizi ospedalieri al paridei loro confratelli che vivevano a convento, assoggettati cioè alla vitacomune negli spazi, rigidamente separati per gli uomini e le donne, delcomplesso ospedaliero9.
Fino almeno dal principio del Xiii secolo, dunque, quella che a Sienaaccoglieva un gran numero di esposti è una comunità religioso-assistenzia-le che si organizzava, si pensava e si auto-definiva come una famiglia spiri-tuale, ma che al contempo ci appare attraversata al proprio interno dal per-manere, tra alcuni suoi membri, di relazioni sponsali e vincoli parentali disangue: legami e solidarietà di parentela che l’oblazione e l’ingresso nella
7 alla comunità religiosa dell’ospedale di Santa Maria della Scala di Siena – oggettogià negli anni Settanta di una prima indagine da parte di odile redon – ho dedicato alcu-ni miei lavori degli ultimi anni: M. Pellegrini, La comunità ospedaliera di Santa Maria dellaScala e il suo più antico statuto (Siena, 1305), pref. a. Bartoli langeli, Pisa 2005; Pellegrini,L’esperienza religiosa dei fratres e delle sorores di Santa Maria della Scala: una “comunitàestesa” nella società senese fra Due e Trecento, in Beata Civitas. Pubblica pietà e devozioniprivate nella Siena del Trecento. atti del convegno internazionale di studi (Siena, 28-30ottobre 2010), in corso di stampa.
8 Su tali dinamiche comunitarie cfr. da ultimo Uomini e donne in comunità, «Quadernidi storia religiosa», 1 (1994).
9 Per queste presenze cfr. Pellegrini, La comunità ospedaliera di Santa Maria della Scalacit., pp. 36-46;
Michele PelleGrini66
famiglia ospedaliera, andavano a modificare, ma non recidevano affatto.anzi, in più di un caso attestato, proprio la volontà di perpetuare ed assi-curare quelle relazioni di affezione e cura sembra costituire una delle moti-vazioni più forti della stessa conversione: accade così, ad esempio, nelpieno trecento a diversi uomini o donne che, rimasti vedovi, chiedono edottengono d’essere accolti tra i frati o le donne conventuali dell’ospedalepur mantenendo con sé figli o nipoti orfani di cui hanno cura e responsa-bilità10: casi, dunque, in cui la famiglia spirituale cui si accede è esplicita-mente chiamata ad integrare e perpetuare quella cura nei confronti di sog-getti deboli che la famiglia biologica, ferita dalle circostanze della vita,teme di non riuscire a garantire.
Retorica della famiglia e costruzione dell’autocoscienza dell’esperienza ospe-daliera senese fra Due e Trecento
non sorprende che una “retorica della famiglia”, ricca di rinvii esplici-ti ai modelli ideali rappresentati dalle relazioni familiari, sia presente edoperante fin dal principio nei testi più solenni ed ufficiali prodotti da quel-l’esperienza. Già nei primi anni Quaranta del duecento il prologo che apreil primo cartulario dell’ospedale magnifica la figura del rettore che l’avevavoluto per la sua sollecitudine verso i poveri esplicitata anzitutto in «pupil-los orphanos et proiectos recipiendo et alendo, lacteque pascendo et edu-cando affectione paterna»11.
d’allora in avanti proprio il richiamo all’accoglienza degli esposti e allacura dell’infanzia e dei giovani senza famiglia – che era e rimase sempreuna, e una soltanto, delle molte funzioni assistenziali dell’ente – sarebberiemersa con decisa amplificazione in scritture e testualità tra loro diverse,ma tutte parimenti identificabili come momenti qualificanti dell’autoco-scienza della comunità, investita nel corso del duecento da un deciso pro-cesso di rapida crescita. Sul finire di quel secolo, ad esempio, quando nel
10 Si vedano i casi trecenteschi citati in Martellucci, I bambini di nessuno, pp. 74-75.11 così il proemio del cartulario: «Vir egregius cacciaconte quondam Beringerii nobi-
li in civitate Senensi prosapia ortus, hospitalis Sancte Marie Senensis rector ydoneus qui adserviendum deo viventi se optulit et curam habuit pauperum diligentem, nec umquam ineorum obsequiis fessus inventus est sive piger, immo valde sollicitus, hospitando eosdem,cibando manibus propriis et potando, misericorditer visitando, vestiendo nudos, pupillosorphanos et proiectos recipiendo et alendo lacteque pascendo, educando affectione pater-na et verecundis pie provvidendo egenis» (Siena, archivio di Stato [d’ora in poi aSS],Ospedale 70, c. 1).
1298 giunge a termine una fase qualificante dei lavori di ampliamento dellastruttura ospedaliera, il rettore ed il capitolo del Santa Maria fanno appor-re sulla nuova facciata della struttura prospiciente la cattedrale una lapi-de12 il cui testo non solo permetteva all’osservatore di identificare quellanuova fabbrica come “domus pro gittatellis”, cioè il complesso di localiappunto destinati ad accogliere gli esposti, ma si premurava anche di pre-cisare che i bambini assistiti «in eo tempore sunt in numero ccc gitatelliet plus».
Si tenga conto che neppure dieci anni prima un’altra iscrizione – piùessenziale – era stata apposta sullo stesso prospetto a memoria del comple-tamento del cosiddetto ‘palazzo del rettore’, primo vero ampliamento delpiù antico nucleo ospedaliero sul fronte verso la cattedrale13. non è privodi interesse ai fini del nostro ragionamento constatare come, con quelprimo ampliamento, l’ospedale avesse scelto di dotarsi di un edificio dirappresentanza proprio fornendo una abitazione confacente al rettore ealla sua personale famiglia.
la questione richiede un pur sommario approfondimento: si era allo-ra alla vigilia di un tornante decisivo nella storia dell’ospedale, che duran-te il ventennio successivo avrebbe maturato, anche attraverso un teso con-flitto con il nuovo reggimento popolare della mezzana gente, nuove formedi inserimento nella dialettica sociale e nel sistema istituzionale della città.Quel tornante implicava nondimeno trasformazioni profonde anche nel-l’organizzazione della comunità e nella stessa esperienza religioso-assisten-ziale abbracciata dai conversi ospedalieri; trasformazioni già in atto, chel’elaborazione dei primi statuti dell’ospedale avrebbe di lì a poco provatoa governare14. nel quadro di tale metamorfosi anche il ruolo del rettore e
12 l’iscrizione recita «hec domus facta est pro gittatellis in anno dominiMcclXXXXViii in quo tempore sunt in numero ccc gitatelli et plus». Sull’epigrafe cfr.F. Gabbrielli, Gli indicatori cronologici utilizzati nello studio degli elevati del Santa Maria,in Santa Maria della Scala, Archeologia e edilizia sulla piazza dello Spedale, cur. e. Boldrini- r. Parenti, Firenze 1991, pp. 97-112: 103. Sulla domus pro gittatellis, nel contesto dell’am-pliamento del complesso ospedaliero in quei decenni cfr. B. Sordini, Dentro l’antico ospe-dale. Santa Maria della Scala. Uomini, cose e spazi di vita nella Siena medievale, Siena 2010,pp. 43-50.
13 Sull’edificio e la sua realizzazione cfr. Gabbrielli, Siena medievale. L’architettura civi-le, Siena 2010, pp. 141-142; Sordini, Dentro l’antico ospedale cit., pp. 44-45.
14 il testo delle due redazioni dello statuto ospedaliero, entrambe stese per gramatica eper volgare, è edito nella sola versione volgare: la più recente e corposa venne pubblicata dal. Banchi, Statuto dello Spedale di Santa Maria di Siena. 1318-1387, in Statuti senesi scrittiin volgare ne’ secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del Regio Archivio di Stato inSiena, iii, Bologna 1877 (d’ora in poi Statuto 1318); della prima redazione del 1305 – già
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 67
la sua posizione rispetto al resto della comunità mutarono profondamente:l’accresciuta esigenza, per la comunità ospedaliera, di esprimere un verticecapace di rappresentare in modo autorevole ed indipendente gli interessidell’ente di fronte al sempre più aggressivo governo popolare e all’interoapparato amministrativo del comune; tutto ciò spinse ad enfatizzare, tra irequisiti del rettore ideale, quello di un chiaro profilo aristocratico posse-duto per provenienza familiare, prima e oltre che per la milizia conferitagli.
d’allora in avanti, in effetti, i nuovi rettori sarebbero stati scelti dalcapitolo non più tra i frati ospedalieri già attivi, ma tra le «discrete perso-ne oneste e savie» appartenenti alle famiglie più in vista della città. il chevalse a dire, per quasi tutto il trecento, personaggi provenienti dai grandicasati magnatizi, sempre attivi protagonisti della vita pubblica e, all’indo-mani delle leggi antimagnatizie, controparte essenziale della nuova élitepopolare nel contesto del gioco politico proprio dell’età ‘novesca’. il retto-re eletto avrebbe certo dovuto, per accedere alla carica, entrare a far partedella comunità mediante un formale atto di oblazione, ma nei fatti glivenne assicurata la possibilità di mantenere un regime di vita – così comeuna capacità patrimoniale – largamente autonomi e nettamente distinti daquella conventuale. Si produsse in questo modo, insieme ad un chiaro scol-lamento della figura del rettore dal resto della comunità, anche l’avvio diun’inedita ed intensa relazione tra questa e il nucleo familiare formato da‘messere’ e dalla sua sposa, occasionalmente arricchita dalla presenza diqualche loro figlia (dato che l’obbligo di trasmettere il proprio asse eredi-tario all’ospedale restringeva nei fatti l’accesso al rettorato ai soli gentiluo-mini privi di discendenti maschi). Quella famiglia, chiamata nel suo insie-me a un ruolo attivo nel governo dell’ente come nella sua interlocuzionecon la città, divenne dunque, d’allora in avanti, la più rilevante e autorevo-le presenza di un nucleo famigliare naturale all’interno della più ampiafamilia artificiale costituita dalla comunità ospedaliera, andando a confer-mare e rinnovare la dialettica già esistente tra la comunità conventuale e ilvariegato mondo dei fratres extrinseci. la scelta di destinare proprio allafamiglia del rettore i nuovi spazi edificati sul fronte verso la cattedrale, edancor più le forme in cui si volle approntata quella nuova facciata – formeche non a caso risultano pienamente confacenti agli standard e agli stilemi
edita in Statuti volgari de lo Spedale di Santa Maria Vergine di Siena, scritti l’anno MCCCV,ed. l. Banchi, Siena 1864 – ho curato una nuova edizione in M. Pellegrini, La comunitàospedaliera di Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto (Siena, 1305), Pisa 2005; rin-vio all’introduzione di quest’ultimo lavoro (part. pp. 61-68) per una più coerente contestua-lizzazione delle redazioni statutarie in questa stagione cruciale della storia dell’ente.
Michele PelleGrini68
cui sarebbero sempre più chiaramente allineate tanto le nuove dimore deilignaggi egemoni, così come la grande edilizia pubblica trecentesca15 – sve-lano l’importanza che questa inedita presenza stava assumendo nell’auto-coscienza della comunità e nel suo rappresentarsi all’esterno.
da un lato, dunque, una casa per la famiglia del rettore, additata comevertice e figura dell’intera comunità ospedaliera; dall’altro la ‘casa dei get-tatelli’ che, accogliendo i ‘figli dell’ospedale’, ne visualizzava immediata-mente l’asserita natura di famiglia spirituale, accogliente e protettiva.nell’ultimo decennio del duecento, le scelte operate dall’ospedale senesenel decidere il nuovo volto architettonico con cui, d’allora in avanti, essosi sarebbe affacciato sulla città ci parlano con forza, mi sembra, del pesoche il richiamo al modello familiare stava assumendo nella percezione di sédella comunità ospedaliera, rinviando in modo inequivoco a quella ‘retori-ca della famiglia’ da cui avevamo preso le mosse.
È in questa stessa prospettiva che possono essere messe in luce moltealtre tracce dell’uso pubblico che l’ospedale senese fece del proprio ruolo‘genitoriale’. in modo particolare andrà osservato come l’aperto richiamoe, in certo senso, la rivendicazione dell’esercizio delle funzioni caritativesvolte a favore dell’infanzia e dei giovani senza famiglia, emergano condecisione in tutte le testualità ufficiali destinate a rappresentare l’esperien-za di fronte a un pubblico che, se nel corso del duecento coincide ancoraessenzialmente con la società urbana di Siena, si dilata progressivamentenel corso del trecento ai centri maggiori della toscana, quindi all’interaarea centroitalica per poi aprirsi sull’orizzonte vastissimo delle corti e dellecapitali dell’europa mediterranea che sul finire del medioevo all’ospedalesenese guardarono, come è noto, come ad un modello.
l’esplicito richiamo alle cure prestate agli esposti e l’orgogliosa esibi-zione del loro numero ricorre, ad esempio, nel testo di alcune supplicherivolte alla sede apostolica tra gli ultimi anni del duecento ed i primi
15 Si vedano le riflessioni proposte da Fabio Gabbrielli (Siena medievale cit., pp. 122-168) che segnala il Palazzo del rettore tra i casi più significativi di una fase ‘sperimentale’nella quale si elabora un nuovo linguaggio architettonico che prelude e conduce alla gran-de stagione del ‘gotico senese’. evidenzia perfettamente la perdurante importanza avuta dalprofilo aristocratico che connota, sul piano architettonico, il Palazzo del rettore, anche iltesto della relazione sull’ospedale presentata al duca di Milano nel 1456 (edita da F.leverotti, L’ospedale senese di S. Maria della Scala in una relazioni del 1456, «Bullettinosenese di storia patria», 91 [1984], pp. 276-291: 287): «sciendum est ergo quod habitatiorectoris […] est pulcra et nobilis habitatio, ita quod quilibet miles honorabilis staret ibibene».
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 69
decenni del trecento16, in una delle quali si ha cura di precisare che i bam-bini «qui ad dictum hospitale prohiciuntur non solum de civitate et dioce-si Senensi verum etiam et de terris et diocesis circumvicinis, ad presens addicti hospitalis expensas sunt ccccXXX»17. Ma nel pieno trecento il temanon mancherà di essere ripreso e valorizzato anche nelle lettere patenti concui il rettore ed il capitolo dell’ospedale presentano i propri questuarii aiprelati o ai rettori delle città in cui questi sono inviati per organizzare laraccolta di elemosine18.
il richiamo ai modelli relazionali propri della struttura familiare, nellalinea verticale (genitori-figli) oltre che in quella orizzontale (fratres-soro-res), colorisce inoltre i testi normativi che la comunità ospedaliera seneseelabora nel corso del primo trecento19. Si pensi, in relazione al nostro spe-
16 «cum autem hospitale predictum, ratione infirmorum et pauperum qui ad dictumhospitale concurrunt, tam etiam ratione gittatellorum qui ad dictum hospitale prohiciunturnon solum de civitate et diocesi Senensi verum etiam et de terris et diocesis circonvicinis,qui gittatelli ad presens ad dicti hospitalis expensas sunt ccccXXX et plures, maximasexpensas faciant ad honorem Virginis gloriose ita quod vix potest ad ista sufficere nisi foretbonorum subsidium»: così nel testo della minuta di una supplica alla sede apostolica perottenere l’esenzione dalle procurazioni per i legati, oggi conservata in aSS, Diplomatico,Ospedale, sec. XiV (2), databile agli ultimi anni del duecento; la cura degli esposti assumeparticolare risalto anche nella descrizione degli hospitalitatis obsequia contenuta nel testo diuna più tarda supplica che si legge, con alcune varianti, ibid., Ospedale, sec. Xiii (2); secXiV (1): «Significant S.V. magister et fratres hospitalis sancte Marie ante gradus Senensisquod ipsi circa obsequia infirmorum et pauperum et cetera hospitalitatis obsequia deputa-ti tam in hospitali predicto quam in aliis hospitalibus sibi subiectis […] pauperes et infir-mos illuc undique confluentes recipiunt, infantes ibidem expositos, mares et feminas, piavoluntate suscipiunt eisque pro victu et vestitu necessaria subministrant, puellas quoque ininfantili etate ibidem expositas quam primum ad nubiles annos perveniunt propriis eorun-dem fratrum oportunitatibus subtrahentes maritare procurant, omniaque bona hospitalispredicti […] in hospitalitatis opera et substentationem pauperum erogare procurant».
17 aSS, Diplomatico, Ospedale, sec. XiV (2).18 Si veda in particolare il testo della patente risalente al rettorato di Giovanni di tese
tolomei (1314-1339), in cui l’ospedale è presentato come casa nella quale si esercitano lesette opere di misericordia, ai meriti delle quali si offre di rendere partecipi i benefattoriche versino almeno 3 denari l’anno d’elemosina; l’elenco delle opere di misericordia pre-sentato dal testo, assai diverso da quello tradizionale, ricorda al terzo posto l’accoglienzadelle «mulieres volentes ibi iacere in partu», e al quarto «quod pueri masculi et femine quiprohiciuntur ibi aluntur et nutriuntur, et puelle cum pervenerint ad etatem nuptui tradun-tur honorifice» (aSS, Diplomatico, Ospedale, sec. XiV (13). il testo di altre credenziali rila-sciate dallo stesso rettore a due accaptatores si legge invece in aSS, Ospedale 86, cc. 16r-17r(1314 novembre).
19 la redazione del 1318 dedica specificamente 4 capitoli a regolare le modalità d’as-sistenza dei gittatelli e della loro cura, colmando un vuoto lasciato dalla prima e più breveredazione statutaria – essenzialmente centrata sulla organizzazione interna ed il governodella comunità religiosa formata dai fratres et dalle sorores dell’ospedale. il testo dei capi-
Michele PelleGrini70
cifico interesse, alla rubrica dello statuto ospedaliero del 1318 che, orga-nizzando la vita dei gettatelli divezzi all’interno degli spazi conventualiriservati alle donne, limita a 6 il numero dei fanciulli affidabili alla respon-sabilità di ciascuna oblata20: a riprodurre, appunto, per ciascuno di queigruppi, una dimensione non troppo dissimile da quella familiare, che ren-desse possibili un’accudimento di tipo materno e l’instaurarsi di relazioniaffettive tra quei fanciulli e la donna che ne era responsabile; figure chenon a caso gli ordinamenti tardocinquecenteschi avrebbero definite aper-tamente come ‘madri’21.
tra gli ultimi anni del XiV secolo ed il pieno Quattrocento, la descri-zione della cura paterna che l’ospedale riservava agli esposti avrebbe infinetrovato ampio spazio, come momento qualificante dell’attività e dell’iden-tità stessa dell’esperienza senese, nel testo delle relazioni informative chel’ospedale spedisce alla corte viscontea di Milano, in aragona, in Sicilia edin altre città, in risposta alle sollecitazioni presentate da signori e governiche al sistema ospedaliero senese guardano, con ammirazione, come aduno dei modelli cui informare la riorganizzazione dei servizi assistenzialidelle loro città22. esemplare in tal senso è il testo – risalente anch’esso aglianni della dominazione viscontea (1398-1404) – della relazione sull’ospe-dale inviata a Barcellona23, nella quale, dopo aver ricordato le modalità di
toli in questione è in Statuto 1318, pp. 106-110; per un ampio commento cfr. da ultimoMartellucci, I bambini di nessuno cit., pp. 21-23.
20 Statuto 1318, cap. 115 (pp. 109-110). lo stesso rapporto tra assistenti e assistiti èattestato, da fonti più tarde, anche per altri contesti: si veda ad esempio quanto accade nel-l’ospedale di San celso di Milano stando alla relazione primocinquecentesca del Gilinocitata da albini, L’abbandono cit., p. 170; cfr. anche albini, I bambini nella società lombar-da del Quattrocento: una realtà ignorata o protetta?, in La famiglia e la vita quotidiana inEuropa dal ’400 al ’600. atti del convegno internazionale (Milano, 1-4 dicembre 1983),roma 1986, pp. 23-60: 37.
21 cfr. archivio di Stato di Siena, Archivio dell’Ospedale di S. Maria della Scala.Inventario, cur. G. cantucci - U. Morandi, roma 1960-62, i, p. lXV.
22 Un ampio elenco delle iniziative di riforma ospedaliera che – in italia e oltralpe –fecero esplicito riferimento al modello senese è fornito da Gabriella Piccinni in Piccinni -l. travaini, Il Libro del pellegrino (Siena, 1382-1446). Affari, uomini, monete nell’Ospedaledi Santa Maria della Scala, napoli 2003, pp. 20-21; Piccinni, Il banco dell’Ospedale di SantaMaria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento, Pisa 2012, pp. 282-283.Qui anche i riferimenti al testo della nota relazione sull’ospedale senese inviata a Milano,del 1456 ma ricalcata su una più antica del 1399, nella quale la cura degli esposti è ricorda-ta al primo posto tra le attività caritative svolte dall’ospedale (v. supra nota 15).
23 la relazione, conservata presso l’Arxiu capitular de la catedral de Barcelona, è incorso di studio da parte di carles Vela aulesa. la menzione nel testo dei dodici membri delcollegio di governo chiamato a confermare l’elezione del nuovo rettore spinge a datare iltesto, più che agli anni dell’esperienza ‘dodicina’ (1355-1360) seguita al governo dei nove,
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 71
accoglimento dei gettatelli, le cure loro riservate durante il baliatico e nelperiodo successivo, la costituzione della dote per le fanciulle e l’avviamen-to al lavoro dei maschi, si tiene a precisare come la cura e le funzioni geni-toriali esercitate dall’ospedale verso di loro non si esauriscano col loro defi-nitivo congedo, dato che, anche una volta resisi autonomi, gli uni «semperin ipso hospitale more filiorum amicabiliter tractantur», le altre «in dictohospitali quando veniunt more filiarum amicabiliter et benivole recipiun-tur»24.
L’ospedale e i suoi figli: tra asserita genitorialità, spazi di inserimento, pro-spettive di affidamento
descrivendosi volentieri, nel corso del trecento, come efficace soste-gno dei fanciulli e dei giovani che accoglie ed alleva, la comunità ospeda-liera senese si pensa, ed ama farsi percepire, come genitore premuroso diquelli che non esita ormai a chiamare “suoi figli”: una funzione genitoria-le esplicitamente asserita, che gli studi specifici hanno sottolineato conforza, enfatizzando talora la portata di uno schema concettuale sotteso allessico utilizzato delle fonti. Per precisarne i contorni ed i contenuti risul-
al periodo in cui il collegio dei Priori contò appunto dodici membri (1298-1299), numeroche rimase invariato anche durante la luogotenenza viscontea (1399-1404). ringrazio toniconejo da Pena per aver messo a disposizione la foto-riproduzione del documento.
24 «est etiam in dicto hospitali quedam pila de marmo in qua pueri tam masculi quamfemine qui et que exponuntur in hospitali predicto ponuntur et mictuntur, quidam cumscriptura sui nominis si battiçatum est, quidam vero cum sale in signo quod non est battiça-tum, qui expositi statim de ipsa pila per unum officialem ad hoc deputatum extrahuntur, etqui non sunt battiçati vel in dubio sunt de ipsorum batismate statim mictuntur ad plebemad battiçandum; et cum sollecitudine mictuntur et dantur baiulis et nutricibus ad nutrien-dum et gubernandum, apud quas nutruces stant tempore trium vel quattuor annorum. etpostea reducuntur ad hospitalem predictum et dantur dominabus et mulieribus dicti hospi-talis ad gubernandum, et ibi morantur masculi usque ad etatem sex annorum, mulieres verousque ad nubilem etatem. Masculi vero ponuntur ad legendum et scribendum, et subse-quenter ad alias artes ad quas sunt acti et quas se velle facere dicunt, et cum sunt etatis XXV
annorum si volunt discedere ab hospitali predicto recipiunt a dicto hospitali de pecuniaipsius hospitalis pro quolibet ipsorum XXV libras denariorum. et semper in ipso hospitalimore filiorum amicabiliter tractantur. Femine vero instruhuntur in dicto hospitali per mulie-res et dominas ibi existentes circa mores et bonam vitam et ad filandum, suendum, tessen-dum et ad alia que eisdem placent honesta facienda quousque venerint ad nubilem etatem,et tunc si volunt maritari vel monasterium ingredi recipiunt a dicto hospitali pro suis doti-bus pro qualibet ipsarum l libras denariorum, et omnes earum pannos tam laneos quamlineos et tovagliolas et sciugatoria et sic maritantur vel monasterium mictuntur et in dictohospitali quando veniunt more filiarum amicabiliter et benivole recipiuntur».
Michele PelleGrini72
ta dunque opportuna una riflessione più puntuale sulle fonti e sulla termi-nologia in essa impiegata.
Si parta, ad esempio, dai cosiddetti ‘privilegi di legittimazione’ chel’ospedale tra la fine del trecento e il pieno Quattrocento chiese ed otten-ne per i suoi fanciulli; fonti già meritoriamente segnalate25, e talora in ter-mini tali da lasciar adito ad interpretazioni estensive, che li configurereb-bero quasi come strumenti volti a dare veste giuridica al rapporto di filia-zione artificiale instaurato tra l’ospedale e i suoi gettatelli. e il caso inprimo luogo della bolla richiesta in corte di papa ed ottenuta da Urbano Vinel dicembre del 138726, che lo stesso registro di deliberazioni del capito-lo ospedaliero di quell’anno descrive come «uno privileggio de la legittima-tione de’ nostri fanciulli» ed in riferimento al quale si è detto – non senzaapparenti appigli – che «su richiesta dell’ospedale il papa dichiarò legitti-mi i bambini in esso accolti»27. Si tratta, in realtà, di una concessione daicontenuti ben più circoscritti, che nulla ha a che fare con la legittimatio perrescriptum talora concessa dai pontefici. il testo allora ottenuto è difatti unsemplice mandato con cui il papa, su richiesta dell’ospedale, impone prohac vice al vescovo di Siena di concedere senz’altro ad alcuni esposti ladispensa dall’impedimento canonico ex defectu natalium, permettendoloro l’accesso all’ordinazione e al conferimento di benefici ecclesiastici,anche curati. Un intervento circostanziale28, dunque, inteso a favorire lariuscita e la sistemazione di qualche gettatello avviato alla professioneecclesiastica. lungi dal corrispondere all’aspirazione a veder riconosciutoper tutti i ‘figli dell’ospedale’ un qualche status di legittimità, la dispensaottenuta per pochi finiva semmai per configurare tutti quei giovani comeportatori di un defectus natalium, sottolineandone esplicitamente lo statuspresuntivo di illegittimi e l’incapacità giuridica di cui soffrivano non tantoin ragione dell’abbandono, quanto – per stare alle parole del formulario –del poter esser nati ex damnatu coitu.
altra fonte su cui interrogarsi sono senz’altro le registrazioni battesi-mali, disponibili per Siena – che vanta il primato delle testimonianze più
25 Martellucci, I bambini di nessuno cit., pp. 17, 181-182; Piccinni - Vigni, Modelli diassistenza cit., p. 137.
26 aSS, Diplomatico, Ospedale, 1387 novembre 27. il testo della deliberazione capito-lare è citato in Martellucci, I bambini di nessuno cit., p. 17 nota 32.
27 Piccinni-Vigni, Modelli di assistenza cit., p. 137 nota 19.28 la natura occasionale e non permanente della concessione pontificia del 1387 è
chiaramente espressa dal testo, e del resto non mancarono interventi successivi per ottene-re nuove dispense, come quelle del 1454 e 1464 citate da Martellucci, I bambini di nessunocit., p. 181.
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 73
risalenti relative ad una pieve urbana – a partire dal 138029. Sin da allora,come è stato più volte rilevato, ricorrono tra le registrazioni con una certafrequenza notizie relative al sacramento impartito a bambini ‘gittati’ alSanta Maria, così come del resto di infanti nati od accolti presso il vicinoospedale di Monna agnese30. analizzando tali registrazioni risulta eviden-te come a Siena, per gli esposti presentati al fonte dall’ospedale di SantaMaria, corra fin da subito l’uso di annotare la loro ‘appartenenza’ all’entenel luogo che la struttura della registrazione destinava al nome del genito-re, laddove in altri contesti – ad esempio nelle quattrocentesche registra-zioni bolognesi – non si esitava a sottolineare (con annotazioni come: cuiusparentes ignorantur) l’assenza di informazioni disponibili. certo: anchenelle registrazioni battesimali senesi, come in quelle pisane31, non mancanodesignazioni suggestive, quali «figlio de la vergine Maria»; ma queste fin dasubito tendono ad accompagnarsi alla menzione dell’ente32 e sono di fre-quente le pìu asciutte espressioni «de lo Spedale de la Schala» o «de loSpedale Sante Marie» a completare i nomi dei gettatelli presentati al fonte;non di rado, poi, anche queste lasciano spazio alla più esplicita dizione«figliolo de lo Spedale Sante Marie»: testimonianza eloquente di un mododi pensare, prima che di dire, la relazione esistente tra l’ente e i suoi espo-sti. lo stesso schema, del resto, che soggiace alla dizione «generodell’ospedale» per indicare i mariti delle gettatelle dotate, espressione, nonusualissima, che pure non ricorre solo nella documentazione ospedaliera33,
29 Un quadro comparativo su questo genere di fonti è ora ricostruibile attraverso i con-tributi presentati al convegno organizzato dal centro studi sugli archivi ecclesiastici diFiorano e Modena su Le registrazioni pretridentine nei battisteri tra Emilia Romagna eToscana, tenutosi a Modena l’8 ottobre 2013, i cui atti sono in corso di pubblicazione.
30 Un elenco completo delle occorrenze nel primo registro della serie Battezzati inBiccherna (aSS, Biccherna, 1131) in l. Brunetti, Agnese e il suo ospedale (Siena, XIII-XVsecolo), Pisa 2005, pp. 63-66, che evidenzia la frequenza di annotazioni relative a infanti«nati ne lo spedale di Monna agnesa», del tutto inconsuete invece per le coeve registrazio-ni relative a esposti del Santa Maria. Per queste ultime cfr. Martellucci, I bambini di nessu-no cit., pp. 65-67.
31 i dati relativi alle note e ben indagate registrazioni battesimali pisane sono accessi-bili attraverso l’archivio on line curato da M. luzzati, l. carratori, e. Baldi e ivaPuccinelli, la quale in particolare segnala la presenza di espressioni «come “figlio di dio”,“nato di ventura” e simili per indicare gli illegittimi, che, solitamente, sono però contraddi-stinti da uno spazio bianco – spesso punteggiato – nella posizione in cui avrebbe dovutoessere scritto il nome del padre». cfr. http://battesimi.sns.it/notiziesullafonte.html
32 ad esempio: «Jachoma figliola de la vergine Maria de lo Spedale de la Schala» (12maggio 1425).
33 cfr. Piccinni - Vigni, Modelli di assistenza cit., pp. 139-140; Martellucci, I bambinidi nessuno cit., p. 57 nota 159.
Michele PelleGrini74
ma ritrovo, almeno una volta, già al principio del trecento anche in unafonte ‘esterna’34. largamente attestate dalle registrazioni battesimali, seb-bene non ancora indagate nelle possibili implicazioni35, sono poi le relazio-ni di parentela spirituale che si creano, attraverso il battesimo, tra gli espo-sti e quei membri della comunità ospedaliera che di norma, almeno finoagli ultimi decenni del Quattrocento, li presentano al fonte e ne divengo-no padrini: «figli dell’ospedale», dunque, ma insieme anche (e potremmodomandarci in quale misura) ‘figli d’anima’ di uno e due tra gli uomini e ledonne che nell’ospedale o attorno ad esso vivono ed hanno cura di loro.
certo l’esegesi di queste ed altre consimili testimonianze, e ancor piùla corretta interpretazione degli schemi concettuali sottesi al lessico in esseutilizzato, richiedono misura e sempre ulteriori approfondimenti. Pur contutte le cautele, tuttavia, mi sembra senz’altro possibile affermare che nelcaso del maggiore ospedale di Siena siamo di fronte ad un modello comu-nitario solido, solidamente improntato tanto alla riproduzione quantoall’accoglienza al proprio interno di legami di tipo familiare; un modello,proprio per questo, fortemente inclusivo, che spinge a percepire anchel’esposto divezzo e riaccolto ‘in casa’ non più tanto come oggetto o desti-natario di un servizio caritativo, quanto come parte integrante e membroeffettivo della composita familia ospedaliera, cui lo lega un rapporto reci-proco di figliolanza e paternità spirituale che si è consolidato col tempo,crescendo – per così dire – insieme al fanciullo. Una relazione di parente-la non biologica e d’appartenenza a una famiglia spirituale che non sembraammettere – se non come soluzione residuale – percorsi di uscita, col pienotrasferimento del fanciullo da quella famiglia artificiale che è l’ente, ad unadiversa famiglia, quella adottiva che, appunto, lo riceverebbe ut filio.
alla forza di questa peculiare esperienza comunitaria, idealmentemodellata come famiglia spirituale ed arricchita dalla costante ed attivapresenza tra i suoi membri di reali famiglie biologiche va infatti collegato,a mio avviso, anche il carattere “residuale” che, nell’ospedale senese, sem-bra avere la cessione degli esposti a famiglie esterne desiderose di acco-glierli come figli quale soluzione al problema posto dall’onere della loro
34 Un Benvenutus chorsus calçorarius, gener hospitalis è censito in un catasto di MassaMarittima del primo trecento: Grosseto, archivio di Stato, Estimo massa 90, c. 20r (cfr. M.Pellegrini, Prima nota sul frammento d’un catasto di Massa Marittima del primo Trecento, inHonos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, ii, in corso di stam-pa, alla nota 19).
35 cfr. Martellucci, I bambini di nessuno cit., pp. 66-67 e, per i battesimi dei bambininati od accolti nell’ospedale di Monna agnese, Brunetti, Agnese e il suo ospedale cit., p. 67.
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 75
cura. esempi di questo genere di affidamenti definitivi, ovvero di cessione‘in adozione’ di infanti e bambini sono, certo, attestati anche per gli espo-sti del Santa Maria della Scala, ma in misura tale da non lasciar adito adubbi sulla loro incidenza residuale tanto sul piano numerico – sia in pro-porzione alle più frequenti restituzioni, sia in termini assoluti – quanto sulpiano dell’impegno riversato dall’ente per la loro formalizzazione docu-mentaria ed il loro controllo.
l’analisi della documentazione tardomedievale dell’ospedale senese,già indagata per questi temi in modo approfondito, permette infatti di met-tere in luce oltre a un piccolo numero di casi, anche l’iter documentarioposto in atto dall’ospedale senese in questo genere di concessioni. Propriola ricostruzione di queste prassi documentarie può aiutarci a scioglierealcuni interrogativi sulle ragioni del silenzio delle fonti, fugando legittimidubbi sulla possibile casualità delle informazioni oggi disponibili e, dun-que, sulle reali possibilità di interpretare correttamente le emergenze e,ancor più, le evidenze negative. almeno dal pieno trecento, infatti, la ces-sione di infanti o fanciulli a famiglie disposte ad accoglierli ed allevarli«chome loro figliuoli» sembra infatti sempre passare, nel caso senese,attraverso uno specifico pronunciamento del capitolo ospedaliero, e lascia-no dunque traccia di sé nei registri di deliberazioni. a tale pronunciamen-to rimandano anche le registrazioni accessorie che tali concessioni posso-no produrre nei registri contabili dell’ospedale in ragione delle loro fre-quenti implicazioni patrimoniali, come ad esempio quelle relative allegaranzie richieste per l’impegno a dotare le bambine adottate. rinvii alladeliberazione annotata nel «libro del chapitolo» sono in effetti rintraccia-bili già negli sporadici riferimenti alla cessione di fanciulli36 contenuti neiprimi «libri a ricogliare»37 rimastici, di qualche decennio più antichi dellapur precocissima serie delle delibere capitolari, il cui primo volume risale
36 Si prenda ad esempio il caso – già segnalato in Martellucci, I bambini di nessuno cit.,p. 141 – dell’affidamento di lucia a una coppia di coniugi nel 1367, attestato nel Libro aricogliare segnato C: «Giovanni di Pietro detto lalla, charnaiuolo, e monna tofana di nerisua donna del popolo della Badia nuova, fulle concieduto per miss. Galgano di lolo e perlo suo chapitolo addì xxi d’aprile anno mille treciento sesanta sette che avessero una dellefanciulle allevate dello Spedale, la quale à nome lucia, di tempo quasi di due anni, la qualefanciulla debono alevare e nutrichare sicome loro figliuola e per la dote della detta luciaobrigharsi a lo Spedale in ciento lire di denari di qui a dodici anni quando sarà da marita-re […] a dì xxv d’aprile anno detto, s’obrigharo ne le dette ciento lire e promisero tuttosicome di sopra si contiene, carta per mano di ser Bartolomeo di Franciesco tellini nostronotaio. tutte le dette cose apaiono a libro de chapito[lo] per mano del detto serBartolomeo fo. lXXXXVi»: aSS, Ospedale 516, c. 134v.
37 Si tratta dei registri in cui l’ospedale annota i propri crediti nei confronti di terzi.
Michele PelleGrini76
al 1379. Questo potrebbe bastare a rassicurare sull’attendibilità del datodesumibile, a partire da quell’anno, dai registri delle deliberazioni; fonteche, come anticipato, ci informa di sporadiche e non molto numerose con-cessioni di infanti a coppie o individui interessati a riceverli come figli38.
anche in questi casi, inoltre, l’ospedale senese sembra non curarsi di farredigere dal proprio notaio e conservare atti che documentino in modo spe-cifico il trasferimento del fanciullo e della responsabilità su di lui39, né ricor-rendo alle forme contrattuali largamente attestate a questo scopo per altricontesti, né tantomeno al formulario proprio dell’adoptio/adrogatio diascendenza romana. istituto, quest’ultimo, che per altro sappiamo con cer-tezza essere noto ed utilizzato anche a Siena nel corso del Quattrocento40.tenendo poi conto della organizzazione già articolata e complessa assuntadal sistema di produzione e conservazione delle scritture amministrative edocumentarie dell’ospedale senese nel corso del pieno e del tardo trecento,si dovrà dunque anche constatare come, anche in ragione del loro numeroridotto, il Santa Maria della Scala non avverta affatto il bisogno di predi-sporre una qualche specifica registrazione di questo genere di affidamenti:e questo in un contesto archivistico che, per il tre e il Quattrocento, appa-re sufficientemente denso da far parlare anche i silenzi.
38 recuperiamo delibere in tal senso a partire dal secondo registro di deliberazioniconservato (1381-1402): le segnala Martellucci, I bambini di nessuno cit., pp. 141-145. Peril primo registro abbiamo solo una notizia indiretta di affidamento, peraltro fallito, di unafanciulla alle cure di un’oblata (cfr. aSS, Ospedale 20, c. 29v; ora ed. in r. lugarini, IlCapitolo dell’ospedale di Santa Maria della Scala. Aspetti istituzionali e riflessi documentari[Siena, fine XII-XIV secolo], Pisa 2011, p. 190).
39 nel caso citato supra a nota 36, ad esempio, la charta menzionata nella registrazionee redatta dal notaio dell’ente Bartolomeo di Francesco tellini, corrisponde a un sempliceatto di obbligazione a garanzia della somma pattuita per la dote della fanciulla, obbligazio-ne alla quale segue senz’altro la promessa, da parte dei coniugi adottanti, di «ipsam luciamtenere et nutrire et alimentare bene et diligenter ut eorum filiam». l’ospedale, inoltre, nonmostra di tenere a conservare nel proprio archivio l’atto in questione: il contratto infattivenne rogato dal notaio nel suo quaderno privato (oggi aSS, Notarile antecosimiano 145,nel quale l’obligatio si legge alla c. 15v) e non nel registro di imbreviature tenuto pro factispropriis hospitalis Sancte Marie della Scala de Senis, destinato a rimanere nell’archivio ospe-daliero (si tratta di aSS, Ospedale 90 d).
40 Per la Siena quattrocentesca è noto, sebbene non pienamente indagato sotto questoprofilo, il ricorso all’adoptio nel contesto dello stretto legame di solidarietà professionale edumana esistente tra il pittore taddeo di Bartolo e il suo allievo Gregorio di cecco: dopo lastipula nel 1421 di un accordo di collaborazione e di coabitazione, taddeo aveva difattiproceduto all’adoptionem sive adrogationem del suo allievo, che dettando testamento nel-l’agosto del 1422 aveva quindi istituito, in quanto filium adoptivum, proprio erede. dopola morte di Gregorio, nel luglio del 1424 la vedova di taddeo avrebbe a sua volta procedu-to ad «adoptare sibi et tenere in filium» il fratello del figlio adottivo scomparso, andrea,
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 77
rimangono certamente aperte, da questo punto di vista, le non pochequestioni poste dalle interferenze possibili ed esistenti tra queste forme ditransfert d’enfant – finalizzate alla permanente affiliazione del fanciulloentro il nucleo familiare che lo ha richiesto – e quelle invece legate all’ap-prendistato, che prevedeva anch’esso assai spesso il temporaneo trasferi-mento del fanciullo «posto ad arte» presso la famiglia del maestro e l’im-pegno di quest’ultimo a trattarlo ‘come figlio’. la mancata conservazionedei registri in cui, stando ad un’addizione tardotrecentesca allo statutoospedaliero41, gli allogatori incaricati di «porre ad arte e’ gittatelli si maschicome femmine» avrebbero dovuto «scrivare la postura di che’ cotali», hasinora precluso, per l’ospedale senese, la possibilità di un’indagine sistema-tica del fenomeno dell’apprendistato dei gettatelli42, come è invece statopossibile fare per l’ospedale dipendente di San Gimignano43. arduo se nonimpossibile, allo stato degli studi, cogliere in quale misura il rapporto conla famiglia del maestro poteva incidere nel concreto vissuto dei giovaniesposti ed anche quali legami d’affezione parentale e quali occasioni diinserimento familiare tale esperienza poteva dischiudere loro. Se da unlato, però, non possiamo che lamentare la perdita dei libri dell’allogagionisenesi, dovremo tuttavia constatare come la presenza nei libri del Capitolodi deliberazioni concernenti la cessione di bambini ‘in adozione’ testimoniimplicitamente una qualche avvertenza della diversa portata di questogenere di trasferimenti rispetto a quelli, più ordinari, relativi all’apprendi-
che per parte sua si impegnava a sostituire il fratello defunto nel «reverere et obedire dic-tam dominam Simoninam tamquam matrem et ut filius eius et dicti olim magistri taddei etalia facere prout facere debebat dictus Gregorius circa dictam filiationem». le testimonian-ze di questa interessante vicenda – tratte dal ricco notarile senese e dai registri della Gabelladei contratti – sono edite in appendice ad a.G. corti, La compagnia di Taddeo di Bartolo eG. di C., con altri documenti inediti, «Mitteilungen des Kunsthistorischen institutes inFlorenz», 25 (1981), pp. 373-377.
41 Si tratta del primo comma dell’addizione – che compare in margine sia del testo lati-no che di quello volgare – apposta al capitolo 111 del secondo Statuto (segnalata in Statuto1318, p.106 nota 3) con la quale si dispone l’istituzione di officiali incaricati di organizzarein modo sistematico l’affidamento in apprendistato dei giovani allevati si maschi come fem-mine. Per la datazione dell’addizione cfr. infra nota 51.
42 riferimenti all’apprendistato dei gettatelli senesi in Piccinni - Vigni, Modelli di assi-stenza cit., pp. 137-138; Martellucci, I bambini di nessuno cit., pp. 143-147 che segnala alcu-ni casi sulla scorta dei registri di deliberazioni capitolari e – in parte – dei protocolli dei notaidell’ente. Una sistematica ricognizione del ricco notarile dell’ospedale potrebbe, in tal senso,chiarire le modalità di formalizzazione documentaria degli affidamenti in apprendistato.
43 Segnala un libro dell’allogagioni della dipendenza sangimignanese, con materiale tre-centesco, il lavoro già citato di l. Sandri. L’Ospedale di S. Maria, p. 14. Sulle prassi d’ap-prendistato nel brefotrofio valdelsano, pp. 178-180.
Michele PelleGrini78
stato per i gettatelli posti ad arte, che invece paiono di norma non richie-dere alcun esplicito pronunciamento del capitolo.
in definitiva mi sembra che da un esame complessivo, anche se suscet-tibile di ulteriori approfondimenti, della documentazione ospedalierasenese emerga con sufficiente chiarezza come fra tre e Quattrocento ilSanta Maria della Scala, pur senza escluderne tassativamente la possibilità,non propenda affatto per la concessione a famiglie adottive dei propri get-tatelli, diversamente da quanto invece sappiamo accadde allora non solo aFirenze ma, ad esempio, a Parma, dove nel tardo Quattrocento l’ospedalerodolfo tanzi optò con decisione per questa soluzione, individuata comela più idonea «tam pro bono dictorum puerorum quam pro alleviationeexpense ipsius hospitalis»44, o a Padova, dove la ca’ di dio gestisce questiaffidamenti anche tramite contratti di adozione ‘piena’, con intervento delpotere pubblico45.
È del resto probabilmente la stessa peculiare struttura comunitaria delgrande ospedale senese a rendere possibile – e dunque a far percepire comepreferibile – una lunga permanenza di garzoni e cittelle allevati all’internodella famiglia ospedaliera. la quale, per la sua stessa struttura, offriva già alproprio interno occasioni propizie all’inserimento familiare: penso in primoluogo alla realtà di quelle famiglie di oblati extrinseci che – come affermaancora la relazione inviata al duca di Milano e come va ora emergendo conmaggior chiarezza da una specifica analisi delle scritture contabili e ammi-nistrative – risiedono in abitazioni separate poste nei pressi, o all’internostesso dell’edificio ospedaliero46 e che, come abbiamo visto, in alcuni casi
44 cfr. G. albini, L’assistenza all’infanzia nelle città dell’Italia padana (secoli XII-XV),in Città e servizi sociali nell’Italia dei secoli XII-XV, Pistoia 1990, p. 140: nel 1492 i deputa-ti deliberano di dare gli esposti «aliquibus bonis personis eos acceptare volentibus et tampro suis filiis et heredibus quam ad bene allevandum, nutriendum et gubernandum, tampro bono dictorum puerorum et spurium utriusque sexus, quam pro allevatione expenseipsius hospitalis».
45 cfr. F. Bianchi, Health and Welfare Institutions in Renaissance Italy: Selected Sourcesfrom the Veneto, in Quellen zur europäischen Spitalgeschichte in Mittelalter und FrüherNeuzeit - Sources for the History of Hospitals in Medieval and Early Modern Europe, cur. M.Scheutz - a. Sommerlechner - h. Weigl - a.S Weiß, Wien-München 2010, p. 232.
46 così la relazione milanese (di cui supra, nota 15) «et circumcirca (alla casa del ret-tore) resident multe et pulcre habitationes in quibus habitant fratres predicti et unusquis -que divisim, videlicet illi qui non habent expensas per conventum». Già al principio deltrecento, del resto, il capitolo 43 del più antico statuto ospedaliero interdiceva ai cappel-lani non espressamente autorizzati l’ingresso nelle «case di frati del detto spedale li qualiabbiano mollie o fillia o vero fancelle», espressione che lascia intravedere una diffusa pre-senza di fanciulli e giovani a diverso titolo presenti in questi contesti familiari e domesticiinterni o prossimi all’ospedale. Per una più compiuta analisi dei «tanti modi di abitare nel-
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 79
già tengono con sé ed allevano fanciulli e giovani del proprio sangue. Per il1379 sappiamo, ad esempio, che monna Margarita, «donna che fu di fratecherichetto» e abitante in una casa sulla piazza dell’ospedale, ha avuto perstare seco ella una fanciulla, peraltro più tardi rinviata «a stare nello speda-le coll’altre»47; mentre due anni dopo monna Ghita vedova, commessa eoblata dell’ospedale in Grosseto, ha con sé «una fanciulla che à tenuto etiene per l’amore di dio», e che vuole personalmente dotare48.
l’instaurarsi, probabilmente non infrequente, di questo genere di rela-zioni di accoglienza di alcuni almeno degli allevati da parte di queste par-ticolari famiglie confluite, ma non scioltesi, dentro la comunità ospedalie-ra rimane tuttavia, sul piano delle fonti, all’interno del cono d’ombradeterminato dalla mancata necessità di formalizzare attraverso specifichescritture questi trasferimenti, in qualche modo tutti interni alla famigliaospedaliera. appare perciò arduo per non dire impossibile ricostruireun’immagine definita o censire anche solo approssimativamente il numerodi questi giovani di casa, garzoni o fanciulle de’ nostri a vario titolo tenutiin casa da oblati o familiari vestiti dell’abito.
al di là di queste difficoltà, che la stessa struttura delle fonti pone alnostro desiderio di precisare contorni e incidenza d’un genere di relazioniche solo è dato intravedere, la documentazione tardomedievale dell’ospe-dale senese addita abbastanza chiaramente almeno un’altra evidenza. Sequella esercitata dall’ente appare per certi versi una genitorialità forte – eanche per questo conciliabile solo a fatica con la prospettiva del definitivotrasferimento dei suoi fanciulli a famiglie adottive estranee alla rete vastadi relazioni d’appartenenza alla comunità ospedaliera – non di meno talegenitorialità risulta, per molti versi, problematica, e di certo configura unamorfologia tutt’altro che univoca del rapporto instaurato tra l’ospedale-genitore e i suoi giovani ‘figli’.
Da membri della familia a figli disutili: uno slittamento trecentesco
la cosa appare evidente soprattutto quando si prova a seguire il desti-no degli esposti maschi, destino che, peraltro, è di necessità meno accessi-
l’ospedale» si rinvia ora a B. Sordini, Dentro l’antico ospedale. Santa Maria della Scala,Uomini, cose e spazi di vita nella Siena medievale, Siena 2010, pp. 265-269.
47 aSS, Ospedale 20, c. 29v (ed. in lugarini, Il Capitolo cit., p. 190).48 Ibid., c. 133r-v (ed. in lugarini, Il Capitolo cit., p. 289), cfr. Martellucci, I bambini
di nessuno cit., p. 143.
Michele PelleGrini80
bile e, dunque, meno noto rispetto a quello delle fanciulle. non solo aSiena infatti l’onus dotandi che, proprio nella sua veste di genitore sostitu-tivo, incombeva all’ospedale nei confronti delle esposte, diede occasionead una vasta gamma di scritture documentarie e amministrative che hannolasciato, nella documentazione ospedaliera del tardo medioevo, una trac-cia più profonda e leggibile di quella relativa ai gettatelli maschi.
estremamente significativa appare in tal senso l’evoluzione della nor-mativa ospedaliera senese relativa al destino degli esposti al termine delbaliatico: un’evoluzione rimasta sinora in ombra, e che invece mi pare evi-denzi con chiarezza il compiersi, nel corso del trecento, d’un mutamentoprofondo nel modo in cui l’ente interpreta ed esercita il proprio ruologenitoriale nei confronti dei propri esposti non più lattanti, ma ormai fan-ciulli, ragazzi, giovani.
Per gli esposti maschi il testo originario del secondo statuto ospedalie-ro, redatto attorno al 1318 prevedeva che, dopo il baliatico esterno chepoteva protrarsi anche fino al sesto anno, i rientrati fossero nutriti fino a18 anni. durante quel tempo essi sarebbero stati posti ad arte: il guadagnoricavato dal loro lavoro sarebbe stato ricevuto e incamerato dall’ospedaleche, tuttavia avrebbe dovuto tenere conto, in un’apposita posta dei libricontabili intestata a ciascuno di loro, delle somme introitate. al compi-mento del diciottesimo anno l’esposto avrebbe quindi ricevuto in un’uni-ca somma, stabilita sulla base dell’apposita contabilità, il «lucratus tam desalario quam de alio modo de arte», somma cui si sarebbe aggiunto undono di 5 lire «de denariis hospitalis» e una veste di pari valore. con que-sta dote essi sarebbero stati congedati, con l’obbligo di «suam fortunamprosequi extra hospitale», salvo la possibilità per l’allevato giudicato «suf-ficiens et necessarius» e che volesse essere accolto a qualche titolo nellafamilia ospedaliera di essere ricevuto, previo consenso del rettore e delcapitolo49.
Questa normativa dovette dimostrarsi subito inadeguata, e per piùragioni, alla reale situazione e fu dunque oggetto di una complessa serie dipesanti modifiche ed interventi correttivi. in un primo tempo il limite tas-sativo dei 18 anni venne cassato e sostituito dall’arbitrio del capitolo50: cri-
49 È questo l’originario il disposto del capitolo rubricato de gittatellis masculis in hospi-tale tenendis nel testo latino del secondo statuto ospedaliero (aSS, Ospedale 1, cc. 73r-74r,parzialmente trascritto in Statuto 1318, p. 108 nota 1).
50 la modifica venne apportata in un primo tempo per i soli maschi, cassando nel codi-ce contenente il testo latino il passo che disponeva che i gittatelli dovessero «teneri et edu-cari et nutriri usque quod pervenerint ad tempus sive etatem decem et octo annorum» sosti-tuiti, tramite riscrittura su rasura, con l’espressione «usque ad tempus quod videbitur rec-
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 81
terio elastico, che, consentendo tanto di prolungare quanto di abbreviarela permanenza di ciascun giovane, testimonia chiaramente come la relazio-ne esistente tra l’ospedale e i suoi figli fosse tutt’altro che uniforme. nonmolto dopo questo primo intervento, si addivenne inoltre a una più drasti-ca revisione della norma: vennero difatti interamente cassate le originariedisposizioni sulla contabilizzazione separata dei proventi del lavoro deigettatelli posti ad arte, e sulla loro restituzione al momento del congedo.l’ospedale, dunque, avrebbe da quel momento in avanti semplicementeintroitato quelle somme, incamerandole nel proprio bilancio per esserespese «in utilità del detto ospedale». i giovani esposti perdevano così ognidiritto sul frutto del proprio lavoro di apprendisti51.
nel marzo del 1336, una delibera capitolare avrebbe introdotto nuoveprassi: si concedeva ai gettatelli maggiori di 20 anni il termine di sei mesiper risolversi a lasciare la casa «e procacciare di far bene». a coloro che «diconcordia e con amore» si fossero risolti al distacco sarebbe stata data unadote o sorte ormai slegata dal lucrato durante l’apprendistato e fissata in 25lire. allo scadere del termine, i rimasti sarebbero stati messi periodicamen-te a scrutinio in capitolo: gli approvati avrebbero ancora potuto rimanereper qualche tempo, mentre quelli che avessero ricevuto il voto sfavorevoledi due terzi dei 25 frati del capitolo, sarebbero stati cacciati e stavolta senzaalcuna dote52. l’idea dello scrutinio periodico degli allevati più grandisarebbe stata peraltro ripresa e inasprita più tardi, quando una nuovamodifica allo statuto avrebbe stabilito di porre sistematicamente a scruti-nio almeno una volta l’anno, cacciando i non approvati senza alcunasomma, non solo tutti i gettatelli che avessero compiuto i 18 anni, maanche i familiari, i serviziali, i raccomandati e gli altri comedentes, cioè tutti
Michele PelleGrini82
tori sive fratribus dicti hospitalis», formulazione recepita nel volgarizzamento. la stessamodifica venne poi apportata anche al successivo capitolo relativo alle gettatelle, ma inter-venendo direttamente sul testo volgarizzato, anch’esso modificato e riscritto su rasura, cfr.Statuto 1318, pp. 108-109 n. 1.
51 anche in questo caso la modifica venne apportata sul testo latino, e recepita diret-tamente al momento del volgarizzamento (cfr. Statuto 1318, p. 108 nota 1). È senz’altrosuccessiva a questa prima riforma, ma non necessariamente di molto più tarda (come inve-ce ipotizzato dal Bianchi, che propone di datarla «al cadere del secolo XiV») l’istituzionedella figura degli ‘allocatori ad arte’ e l’imposizione del ‘segno’, disposte dall’addizione alcapitolo 111, che figura in margine sia del testo latino che di quello volgare (cfr. supra nota41 e infra nota 55).
52 il testo della delibera capitolare del 1236, esemplata prima del 1352 in una paginarimasta bianca del codice contenente il testo volgare dello statuto, si legge in Statuto 1318,pp. 126-127.
quelli che partecipavano alla mensa conventuale pur senza essere veri fratio suore oblati53. Un capitolo che, in modo assai significativo, sarebbe statorubricato più tardi, forse negli anni Settanta del Trecento, col titolo: «De’gittategli e altri inutili da cacciare»54.
Mi sembra quanto mai significativo che questi bruschi cambiamenti –databili al secondo e terzo quarto del Trecento – siano contestuali ad un’al-tra innovazione normativa che interessa direttamente il nostro tema: quel-la che obbligava gli allevati a portare «ne vestimenti, da la parte dinanzi nelpetto, sì che pubricamente si vegga» un segno specifico55. Si tratta di unemblema – la scala gialla senza croce – simile, ma significativamente diver-so da quello ordinario – la scala sormontata dalla croce – che portavanocucito sull’abito i fratres, le sorores, i familiares e tutti i membri accolti avario titolo nella comunità56. Un segno che, mi sembra, ha funzioni in granparte diverse da quei segni, ben indagati, che alla Pietà di Venezia57, inmolti brefotrofi quattrocenteschi, e a Siena stessa nell’avanzata età moder-na58 veniva impresso in modo indelebile sulla pelle degli esposti al momen-to del loro ingresso, per impedire sostituzioni e frodi durante il baliatico,oltre che come eloquente segno identitario e di tutela. Nel nostro caso ilparticolare signum hospitalis riservato agli esposti, pensato principalmente
53 Statuto 1318, pp. 121-122 n. 3. Anche in questo caso la cronologia degli interventiè desumibile dal confronto tra i due testimoni, latino e volgare, dello statuto ospedaliero:questa addizione fa infatti parte di un blocco coerente di quattro provvedimenti originaria-mente redatti per gramaticam, ed annotati nel codice contenente il testo latino. Il loro vol-garizzamento (è il testo edito in Statuto 1318, pp. 121-123 nn. 2-5) e la loro scrittura nelcodice contenente il testo volgare sono senz’altro successivi al 1341, e furono effettuati nelcontesto di una complessiva riorganizzazione delle varie innovazioni normative introdottesotto il rettorato di Giovanni Tolomei, verosimilmente compiuta all’inizio del governo diCione Montanini (1351-1356).
54 Cfr. Statuto 1318, p. 121 n. 1.55 È quanto dispone la seconda parte dell’addizione al capitolo 111 (di cui supra, nota
51) che si legge in Statuto 1318, pp. 106-107 n. 3: «a die qua eiecti fuerint in antea usquequo pervenerint ad tempus xiiii annorum et plus, si plus videbitur rectori et capitulo hospi-talis predicti, portent et portare debeant in vestimentis sui ex parte antea in pectore, itaquod publice videatur, signum dicti hospitalis, scalam giallam videlicet sine cruce».
56 Sull’uso del «signum de scala cum cruce consuetum dicti hospitalis» cfr. Pellegrini,La comunità ospedaliera cit., p. 59 nota 88.
57 Cfr. C. Grandi, P come Pietà: i segni corporei dell’identità istituzionale sugli espostidi Santa Maria della Pietà di Venezia (secoli XVII-XIX), in «Benedetto chi ti porta, maledet-to chi ti manda». L’infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX), Treviso 1997, pp.242-256.
58 Cfr. D. Balestracci - G. Piccinni; L’ospedale e la città, in D. Gallavotti Cavallero, LoSpedale di Santa Maria della Scala in Siena. vicende di una committenza artistica, Pisa 1985,pp. 19-42: 35.
“MORE FILIORUM”: IL PROBLEMATICO INSERIMENTO DEI GIOVANI ESPOSTI 83
per i riaccolti dopo il baliatico e ‘posti ad arte’, visualizza certo un’appar-tenenza che produce protezione; ma al tempo stesso serve ad evidenziareuna precisa differenza di status all’interno dell’unica familia ospedaliera.la scala mancante della croce materializzava, per questi ‘figli d’ospedale’,un’appartenenza anch’essa in qualche modo manchevole59. ad essereimplicitamente sottolineato era, a mio avviso, il carattere involontario dellaloro adesione alla famiglia artificiale che li aveva accolti, e di cui pure eranoparte; ma che era invece abituata a riconoscere il nesso costitutivo delsenso d’appartenenza tra i suoi membri in un mutuo atto volontario: l’au-todedizione religiosa col dono di se et sua da parte dell’oblato e l’accetta-zione dello stesso da parte della comunità, che lo riceveva in confratremammettendolo «ad ea beneficia que habent alii fratres dicti hospitalis».
ne conseguiva, mi sembra, che in qualche modo condizionato e nonpieno finiva per apparire anche il diritto di questi “figli” – che un marchiospecifico includeva tra i membri della famiglia e insieme segnalava comedistinti dagli altri – a partecipare di quei benefici che, per gli altri, che inve-ce portavano il “vero” segno della Scala, derivano da un dono volontaria-mente portato.
nel corso del pieno trecento, del resto, le trasformazioni del formula-rio degli atti d’oblazione e l’accentuarsi della loro natura pattizia mostranochiaramente come proprio l’accesso ai beneficia hospitalis, – ‘visualizzati’ inprimo luogo dalla partecipazione alla mensa conventuale, ma sostanziatidagli accordi specifici di mantenimento stabiliti, sempre più spesso, tra l’en-te e ciascun suo nuovo membro in rapporto all’entità della dote portata ealla qualità della persona – stesse diventando elemento centrale nel modostesso di comprendere e definire la relazione d’appartenenza tra l’ospedalee tutta la varia ed indefinibile gamma dei suoi membri: frati, conversi,donne, famigliari, oblati, commessi e via dicendo60. ed è naturale che, alla
59 non senza significato potrebbe essere, in tal senso, anche la scelta del colore delsegno degli esposti, il giallo comune a molti segni distintivi dal valore infamante; si pensi ades., per il tardo medioevo, alle croci gialle imposte agli eretici (cfr. G.G. Merlo, Il “sermogeneralis” dell’inquisitore: una sacra rappresentazione anomala, in Vite di eretici e storie difrati. A Giovanni Miccoli, Milano 1988, pp. 203-220) o alla rotella agli ebrei (d. Sansy,Marquer la différence: l’imposition de la rouelle aux XIIIe et XIVe siècles, in La rouelle et lacroix, «Médiévales», 41 [2001], pp. 15-36: 30ss.). cfr. per questo M. Pastoreau, Formes etcouleurs du désordre: le jaune avec le vert, in Ordre et désordre «Médiévales», 4 (1983), pp.62-73.
60 Su tale evoluzione cfr. M. Pellegrini, L’Ospedale e il Comune, immagini di una rela-zione privilegiata, in Arte e assistenza a Siena, Le copertine dipinte dell’Ospedale di SantaMaria della Scala, cur. G. Piccinni - c. Zarrilli, Pisa 2003, nota 45.
Michele PelleGrini84
luce di questa evoluzione, gli esposti, che la più antica visione portava adincludere idealmente nel perimetro identitario della familia, finissero inve-ce per essere sospinti verso la scomoda categoria degli inutili comedentes.
l’inclusione di gettatelli allevati nella familia ospedaliera, pur forte-mente ribadita sul piano ideologico, assume dunque tratti contraddittori:la partecipazione al sistema di relazioni affettive e di concreto sostegno, apartire dalla partecipazione alla mensa comune della familia, che per glialtri membri è stabile frutto di un reciproco atto volontario, per i “figlid’ospedale” non sembra darsi come condizione stabile: non conseguenaturalmente dalla ‘genitorialità’ dell’ente, ma è percepita come concessaa termine e soggetta a molte condizioni. così anche la perdita, da parte delgarzone allevato dall’ospedale, di ogni diritto sul frutto del proprio lavoro,se da un lato lo penalizza palesemente, rendendone meno agevole l’eman-cipazione, dall’altro lato parrebbe giustificarsi proprio in ragione di quellagenitorialità forte esercitata dall’ente, che incamera nel patrimonio comu-ne della familia i guadagni del suo gettatello così come i beni privati deisuoi frati. Ma da tale asserita genitorialità non consegue naturalmente, pergiovane gettatello maschio ormai diciottenne, alcun diritto reale, né quelload una più piena e stabile inclusione né quello ad una dote che accompa-gni e compensi la sua emancipazione, in qualche modo comparabile aquella assicurata alle gettatelle in ragione dell’onus dotandi che incombeall’ente, tamquam pater.
Va sottolineato che questo inasprimento dell’atteggiamento nei con-fronti dei figli d’ospedale che si registra con chiarezza nel corso deltrecento, può e deve esser messo in relazione con più profonde trasforma-zioni che andavano allora compiendosi nella fisionomia e nella composi-zione della comunità ospedaliera. non certo per caso le norme in questio-ne sulla segnatura e il destino dei gettatelli sono, infatti, contestuali a duealtri interventi nella normativa che riguardano da vicino proprio il mante-nimento, da parte di alcuni membri della comunità, di propri legami diparentela biologica o spirituale. il primo è quello relativo alla abolizionedelle quote riservate agli intrinseci e agli extrinseci nelle elezioni dei frati acerti offici o negozi61; distinzione di parole, che – si affermava – inducevaoramai confusione e «prout iacent, ita possint minime observare». chiaratestimonianza, mi sembra, del progressivo perdere d’importanza di unaarticolazione in celibi e coniugati del nucleo di frati più attivi nel governodella comunità; articolazione che andava evidentemente attenuandosi, in
61 l’addizione, già presente tra le prime aggiunte al testo latino, si legge nella stesuravolgare in Statuto 1318, p. 121, al n. 2.
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 85
una fase in cui il profilo ancora abbastanza definito dei «frati del detto spe-dale li quali ànno mollie» e, perciò, «dimorano nelle loro case», cui facevariferimento lo statuto di inizio trecento, andava sciogliendosi all’interno diun profilo sempre più lasco e volutamente indefinito di ‘frate d’ospedale’,esteso ormai ad includere anche le confuse situazioni di tanti usufruttuariammessi a vestire l’abito, e a vivere alle spese dell’ospedale – ‘a convento’o nelle case ‘di fuori’ – sulla base di «oferaçioni, chommessioni e donagio-ni»62 tra loro sempre diverse per natura, entità, clausole e accordi di man-tenimento previsti.
il secondo intervento normativo, coevo e in qualche modo collegatoall’inasprimento della normativa sui gettatelli cui facevo riferimento, èquello relativo alla proibizione per tutti i fratres et sorores di stabilire rela-zioni di padrinaggio senza il consenso del rettore63. indizio eloquente deiproblemi che generava e delle difficoltà che incontrava il governo di quel-la complessa rete di molteplici legami di sangue e d’anima e di sovrappo-ste appartenenze a più circuiti di parentela biologica o legale, che avevapermesso a questa comunità doppia, composita e irregolare di pensarsi nelsuo insieme come soggetto collettivo e inclusivo improntato al modellodella famiglia.
nel corso del quattordicesimo secolo si spezza dunque qualcosa in unequilibrio difficile che, sino ad allora, aveva anche garantito ad alcunialmeno di questi “figli d’ospedale”, spazi di inserimento tra le maglie dalvariegato tessuto di relazioni di parentela spirituale e biologica di cui eraintessuta la familia ospedaliera.
non meraviglia che, in tale frangente, un’analisi ravvicinata delle storieindividuali di questi esposti metta in luce un tenore e una qualità del rap-porto instaurato tra di essi e l’ospedale-genitore quanto mai disomogenei.
62 È questa l’espressione adottata nell’intitolazione – «in questo libro saranno iscrittetutte l’oferaçioni, chommessioni e donagioni fatte e che ssi faranno ne lo spedale santeMarie per qualunque persona» – dall’estensore del primo Libro dell’offersioni conservato(aSS, Ospedale 62), avviato nel 1347 appunto per annotare le particolarità ed i termini esat-ti degli accordi volta per volta pattuiti con quanti, a vario titolo, venivano accolti a vestirel’abito. il registro in questione va messo in relazione con quanto disposto dal capitolo 48dello statuto del 1318, che prescriveva la tenuta di un libro nel quale fossero «scripti li nomie li soprannomi delli frati e delle suore del detto ospitale […] e le loro possessioni le qualidonaro […] e li pacti e le convenzioni ovvero convegne, li quali e le quali essi o esse ànnodal detto ospitale».
63 nell’originaria redazione latina (aSS, Ospedale 1, c. 73v): «quod nullus ex fratribusseu sororibus obblatis intrinsecis vel extrinsecis dicti hospitalis debeat vel possit ullo modoeffici compater vel comater alicuius persone absque expressa licentia et voluntate rectoriset capituli». Statuto 1318, pp. 122-123, al n. 5.
Michele PelleGrini86
Per il 1344, anno per cui s’è fortunatamente conservata la contabilità det-tagliata tenuta dal camerlengo dell’ospedale64, posso ricostruire con unacerta precisione i rapporti intercorsi tra l’ospedale e sette suoi allevati.Quelle di questi giovani “figli d’ospedale” sono storie molto diverse l’unadall’altra: la vita di quattro di essi sembra gravitare intensamente sull’ospe-dale, per cui svolgono incarichi molto diversi per impegno e responsabili-tà65. Solo due di loro sono indicati dalle fonti anche come famegliari, matutti e quattro hanno però una loro ‘ragione’ nel libro de la famellia, il regi-stro in cui venivano annotati i salari versati a tutti coloro che svolgevanostabilmente servizi per conto dell’ente. le somme che ricevono a titolo disalario nell’arco dell’anno s’aggirano attorno alle 10 lire, ma restano diver-se per entità e frequenza nei pagamenti; ad uno di loro, quello col salariopiù basso, il rettore ha fatto un piccolo prestito66. Gli altri tre allevati,esclusi da quei ruoli e dunque da un vero salario, ricevono tuttavia com-pensi e rimborsi per spese vive sostenute in occasione di lavori che hannofatto per la casa: uno, oltre a fare riparazioni legate al suo mestiere di bar-lettaio, ha organizzato i lavori per la costruzione d’una capanna in unpodere67; un’altro, pittore, dipinge il segno della scala su oggetti e sullepareti d’un mulino68, un altro ancora, ha comprato le colle per l’organo69:l’ospedale non gli versa un salario, ma uno dei frati, che forse ha con lui unrapporto speciale, gli ha prestato tre fiorini d’oro70. Si tratta di storie mini-
64 Si tratta del registro aSS, Ospedale, 851: «libro dell’escite di frate andrea carbonekamarlengo facto in kalende genaio anni domini mcccxliii al tempo di misser Mino di cinonostro rectore».
65 Salvino “allevato” e “nostro famegliale in chorte” che svolge lavori presso il cellie-re; Michele “nostro allevato”, che come “famegliale al granaio” sta a “conciare el grano”(ivi, cc. 59v, 62r, 73r, 75v, 98r, 114); Giovanni “nostro allevato” (c.91v); e Francesco, dettoanche Franceschino, “allevato” (c.114v), che una volta il camerlengo chiama Franceschinonostro e invia in più luoghi con compiti diversi: ad ampugnano, per curare il trasporto delfieno (c.89r), a Poggibonsi a «portare lettere di messere» (c. 50r), durante il raccolto «elmandamo per li mezaiouli di frate Bartolomeio di frate Ghezzo» (c. 96v) in autunno a orga-nizzare il taglio al «nostro boscho da Montesenese» (c. 126r).
66 «Salvino di messere ebbe i quali li prestò, al detto memoriale vecchio fo 2, 1 lib.» (c. 95r).67 Si tratta di ciampolo, “nostro allevato”, che fa lavori come barlettaio ma soprinten-
de per conto dell’ospedale anche a lavori per la costruzione d’una capanna e per la raccol-ta presso la pieve di corsano (cc. 50, 80r, 93r, 94v).
68 «lucha nostro allevato, dipintore, ebe per Vii oncia d’indacho che chonprò per sen-gniare le tasche v sol.» (c. 55r).
69 «cristofano, nostro allevato, ebe per cholle che chonprò per li nostri orghani dichiesa […] soldi, Vi denari» (c. 57v).
70 «cristofano nostro allevato ebbe i quali prestò frate iacomo Ghini, sicome apparescritto a sua ragione a libro a richogliare nuovo fo lxxxxii, iii fiorini d’oro» (c. 49v).
“More FiliorUM”: il ProBleMatico inSeriMento dei GioVani eSPoSti 87
me, ma anche di storie tutte diverse: non è dunque la condizione di “figlid’ospedale” a garantire di per sé a quei giovani né una reale inclusionenella familia ospedaliera, né gli stessi vantaggi e lo stesso tipo di protezio-ne, che quell’appartenenza avrebbe potuto idealmente comportare.
riprendendo il titolo provocatorio che christiane Klapisch ha dato,vent’anni fa, alla sua lettura delle pratiche di tipo adottivo attestate nellaFirenze del primo rinascimento71 si dovrà dunque dire: una adozioneimpossibile, anche questa – tutta particolare – degli esposti ormai giovanida parte della comunità, che li ha accolti, nutriti, li definisce suoi figli, maal tempo stesso non può o non riesce spesso a riconoscere loro gli stessidiritti dei membri legittimi della familia ospedaliera? certo, se non impos-sibile, anche la storia dell’integrazione dei figli abbandonati in queste par-ticolari famiglie artificiali che furono le comunità ospedaliere del tardomedioevo, appare segnata da difficoltà, faticose contraddizioni, doloroseambiguità. Ma nondimeno ci dischiude una gamma vastissima di storieconcrete di vita, di relazioni e di affetti, che resta ancora, in gran parte, daricostruire e interpretare.
71 ch. Klapisch-Zuber, L’adoption impossible dans l’Italie de la fin du Moyen Âge, inAdoption et Fosterage. actes du colloque de Paris (mai 1993), dir. M. corbier, Paris 1999,pp. 321-337.
Michele PelleGrini88