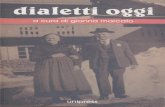La rappresentazione dei giovani in televisione
Transcript of La rappresentazione dei giovani in televisione
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Le rappresentazioni sociali dei giovani in Italia, Roma, Carocci, 2002, pp. 41-75.
LA RAPPRESENTAZIONE DEI GIOVANI IN TELEVISIONE
di Pina Lalli*
Premessa Studiare le rappresentazioni sociali applicandole a testi televisivi è un’impresa che ha
richiesto un approfondimento sia della portata teorica di tale approccio sia dell’impianto metodologico da privilegiare.
L’ipotesi del nostro lavoro parte dall’idea che le rappresentazioni sociali reperibili nei media fossero da considerare come indicatori-operatori di senso comune. In altre parole, rispetto a studi che sottolineano l’influenza delle rappresentazioni veicolate dai mezzi di comunicazione di massa per rafforzare la dipendenza da modelli dominanti o ideologicamente egemoni, qui abbiamo invece voluto esplorare il ruolo duplice e per molti versi ambivalente che in particolare la televisione può assumere da questo punto di vista. Se assumiamo almeno in via provvisoria il suggerimento di Thompson (1998) circa la “quasi-interazione mediata” che l’esperienza televisiva propone, l’analisi delle rappresentazioni sociali in essa prodotte può aprire piste di riflessioni interessanti sui loro molteplici livelli di elaborazione e interpretazione.
Uno in particolare è senza dubbio tra i più importanti, anche se esula dall’oggetto di questo studio: la rielaborazione nei contesti di ricezione. E’ un ambito di ricerca sicuramente ricco di sviluppi: anche qui, perché no, metodi e interrogativi d’analisi potrebbero affinare alcuni strumenti di rilevazione e interpretazione alla luce di una brillante intuizione di Moscovici (1997) sulla rilevanza spesso trascurata delle pur effimere “influenze molecolari” derivanti dalle persuasioni reciproche esercitate negli scambi comunicativi tipici della vita quotidiana, dove è possibile trovino riconfigurazione le stesse ”influenze di massa”.
Esistono tuttavia altri piani di analisi che, come sappiamo, meritano attenzione, non solo dal punto di vista strettamente testuale, ma considerando la rete di implicite aspettative reciproche di significato in cui la rappresentazione televisiva immette la sua trama produttrice e ri-produttrice. L’accento posto da Moscovici sulla produzione in fieri delle rappresentazioni * Dipartimento Discipline della comunicazione, Università di Bologna. Il testo sintetizza i dati di ricerca realizzati da un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato – in un’ottica multidisciplinare - altri colleghi e dottorandi, con la collaborazione anche di studiosi esterni e studenti. In particolare, per la stesura di questo saggio ci si è basati sui contributi forniti da: Saveria Capecchi, Cristina Demaria, Valeria Iotti, Federico Montanari, Maria Pia Pozzato, Lucio Spaziante, Maria Teresa Torti. Cogliamo l'occasione per ringraziarli. All’Unità di ricerca hanno inoltre partecipato Fabrizio Bercelli e Nora Rizza.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
2
nel corso dell’interazione e quindi sul loro potenziale dinamismo ci potrebbe spingere a considerarle anche nel contesto della quasi-interazione (o quasi-esperienza) mediata messa in scena in televisione. Lo stesso potremmo dire a proposito del riconoscimento di una sorta di “pensiero magico” (v. Moscovici 1994) tutto occidentale e moderno che trova nelle rappresentazioni il modo di raggiungere conclusioni affrettate ma efficaci per gestire le esperienze quotidiane di senso comune. Pur ribadendo la loro tendenza a costituire scappatoie strategiche verso un qualche ordine socio-cognitivo che si nutre di stereotipi e pregiudizi (v. ad es. Cigoli 1997), tale approccio permette di osservare che le gradazioni e le modulazioni di questo ordine e delle regole che lo orientano siano non solo possibili e intrinsecamente dinamiche, ma esse stesse soggette a influenze “molecolari”, di per sé non prevedibili in quanto connesse a reciprocità complesse che attivano in modi molto diversi fondi di conoscenza socialmente approvati (v. Schütz 1979). In altre parole, salvo tornare di nuovo ai contesti di ricezione, potremmo ipotizzare l’esistenza non solo o non tanto di mere “influenze selettive” da parte dei mezzi di comunicazione di massa, quanto piuttosto di “rappresentazioni selettive” socialmente rielaborate e rielaborabili, che rientrano nel quadro di tensione e competitività tra arene diverse che contribuiscono alla costruzione dei problemi sociali (cfr. Hilgartner e Bosk 1988)1. Uno dei nodi del problema sta forse proprio nell’aspetto ri-produttivo del senso comune che le rappresentazioni sociali costituiscono: se lo riferiamo al piano della produzione mediatica, supponendolo finalizzato ad una “quasi-esperienza mediata”, possiamo provare a considerare le rappresentazioni messe in scena come la ri-produzione - certo artificiale ma che pretende di apparire tendenzialmente verosimile se non addirittura “genuina” - di alcuni punti chiave di ancoraggio sociale selettivamente trasposti dall’elaborazione quotidiana a quella detta “di massa” (o, meglio, prototipica, riferita ad un “gruppo” più o meno vasto o a diversi gruppi impliciti di riferimento).
E’ come se potessimo vedere in talune rappresentazioni televisive una simulazione sul piano immaginario –che auspica di apparire il più possibile “realistica” – delle interazioni socialmente fondate sul serbatoio di aspettative reciproche di significati di cui parla ad esempio Schütz, e del quale esse costituirebbero sia indicatori sia rafforzatori o addirittura operatori2. In tale prospettiva, lo studio delle rappresentazioni sociali nei media potrebbe non limitarsi a cercare di capire quali contenuti veicolano per la socializzazione, fissandosi sui significati in quanto tali… ma capire il gioco, la dinamica con cui si propongono in quanto rappresentazioni mediante cui si ‘interagisce’ (virtualmente o mediante artifizi tecnici nuovi) con il pubblico.
1 Questo aspetto di tensionalità competitiva che può caratterizzare talune rappresentazioni trova riscontro anche nell’analisi dell’approccio moscoviciano proposto da Duveen (1988). 2 Per un approfondimento del tentativo di coniugare gli approcci di Moscovici e Schütz per lo studio del senso comune e delle arene pubbliche, cfr. Lalli (2000; 2001).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
3
Il piano immaginario delle quasi-esperienze mediate In un’analisi dedicata alle funzioni del “come se” su cui si fonda l’immaginario,
Octave Mannoni (1972, pp. 81 ss.) allude ai mezzi di comunicazione di massa evocando uno spostamento significativo di scena: la trasposizione mediatica delle vicende umane costituirebbe un passaggio dalla commedia “divina” di dantesca memoria ad una più triviale “commedia umana” anticipata dagli scritti di un romanziere come H. de Balzac. Niente più eroi dotati di poteri eccezionali emanati da una qualche forza trascendente, bensì personaggi immanenti, nei confronti dei quali lo spettatore può supporre di dirsi: “si tratta di uno qualunque come me, a cui tuttavia possono accadere cose interessanti, garantite dal solo fatto di ‘apparire’ in televisione; sì, lo so che non è proprio vero, ma comunque”… L’altrove immaginario rispetto alla meschina banalità della vita quotidiana non è mitizzato o divinizzato, ma solo rappresentato come tale, una sorta via di fuga interna alla vita quotidiana stessa. I personaggi dei talk show, ad esempio, costituirebbero altrettanti travestimenti che rendono possibile l’espansione dello spettatore-personaggio in ruoli che rinunciano ad un vero e proprio ideale dell’Io extra-contestuale, per confrontarsi invece con modulazioni differenti di un io-self che si muove agilmente tra maschere differenti3.
Tutto questo, certo, rimane sempre su un piano immaginario, dove la cosa più importante è che l’illusione sia perfetta: un po’ come lo spettatore incredulo davanti al prestidigiatore di turno: sì, lo so che è un’illusione, ma pretendo che sia perfetta4. E se anche l’esperienza smentisce la credenza, essa, grazie al meccanismo del diniego – sostiene sempre Mannoni – non viene necessariamente rimossa o cancellata, ma lascia un ricordo che può combinarsi, spostarsi, aggregarsi su altro o su altri. In effetti, parlando di media, potremmo dire con Mannoni che “è come se vivessimo in un ambiente in cui fluttuano delle credenze che nessuno apparentemente sembra volersi attribuire” (Mannoni 1972, pp. 14-15, ss.) e dove si scelgono di volta in volta i soggetti che per noi si fanno sostenitori della credenza: le casalinghe, ad esempio, i facilmente creduli, i supposti non alfabetizzati della Tv, i bambini, etc. Anzi, la televisione stessa, facendosi ri-produttrice di “pensiero magico” moderno, quali appunto sono le rappresentazioni sociali (v. Moscovici 1992), si fa supporto della credenza: chiaramente tende ad ossificarla, cristallizzarla, divellerla dal suo contesto situazionale,
3 Una proposta analoga circa la de-epicizzazione degli eroi-personaggi televisivi si trova in Featherstone (1992) 4 Non ci si può qui soffermare sugli spunti che si possono trarre da un’analisi dell’immaginario che ricomprenda alcuni suggerimenti della psicoanalisi; ci pare tuttavia una pista di lavoro interessante, soprattutto nell’ottica di Mannoni e del suo contributo al meccanismo del “diniego” nel rapporto credenza-esperienza di disconferma da parte della realtà. Per una riflessione sul termine immaginario si rimanda a Lalli (1995).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
4
poiché propone non l’esperienza diretta di un’interazione fisicamente co-presente bensì, comunque, di quasi-interazione (v. Thompson 1998); come dire il “fantastico” (fantasmatico-autocostruzione.... tecnologie della costruzione del sé...) in luogo della “fantasia”. Nonostante il fatto che, se teniamo conto anche dei processi e delle reti di ricezione in cui comunque incappa, la stessa televisione possa, nelle analisi etnografiche, essere a sua volta considerata fonte di un altro tipo di esperienza. Tuttavia, dal punto di vista della sua “messa in scena”, potremmo qui vederne e cercare di isolarne gli aspetti di cristallizzazione o vera e propria scarnificazione dei meccanismi di ricostruzione di credenze, illusioni, ideali immanenti di personaggi che aspirano ad una meta-comunicazione socializzante e al tempo stesso singolarizzante. Lévi-Strauss (1980) notava come per arrivare alla costituzione delle “identità” si cerchi sempre di eliminare uno scarto differenziale che costituisce invece un limite invalicabile e irriducibile per l’esperienza; salvo, potremmo aggiungere, nell’esperienza mediata dai media, che intrinsecamente devono porsi “come se ci si potesse far capire da tutti allo stesso modo”. La modulazione di questo “come se” potrebbe essere di per sé oggetto di studio, ipotizzandone differenze effettuali a seconda della rete di aspettative reciproche di significato in cui si ri-produce per questo o quel gruppo sociale, in questo o quel contesto storico-culturale. Inoltre, sottoposta com’è al marketing e alla concorrenza fra produttori televisivi, rischia di costituire la posta in gioco di analisi (o scommesse) via via più sofisticate dei simulacri più o meno avvincenti delle configurazioni sociali emergenti. L’impegno o il coinvolgimento che viene richiesto allo spettatore non penso derivi tanto da possibili patti di tipo razionale o utilitaristico, quanto piuttosto dalla capacità o no di individuare i prototipi più o meno significativi suscettibili - in un momento dato - di incarnare o anche solo di sollecitare questa o quella aspirazione immaginaria. Oppure questo o quel desiderio di interazione5. Un gioco di interpretazione costante, dunque, nel quale l’unica vera regola per ora difficilmente
5 Sia detto per inciso, ma si pensi ad esempio ad uno degli eventi mediatici recenti: il Grande Fratello, da molti considerato semplice segno di voyeurismo televisivo. Ma potrebbe darsi, invece, che esso abbia anche costituito un’arena di quasi-interazione e quasi-esperienza che proponeva una proiezione immaginaria e ipersocializzante su scala tecnologica espansa di un importante esercizio che coinvolge ciascuno di noi nell’interazione quotidiana: è quello che Simmel chiamava “avido, spionesco appropriarsi” dei segreti impliciti dell’altro e che cerchiamo di trovare dissimulati nell’intonazione, nell’arrossire, nella postura impropria attribuita a possibili retroscena o facce negative che riteniamo di aver colto in modo imprevisto. In effetti, nella sua dimensione di gioco, il Grande Fratello ha dato una pur relativa opportunità di praticare, divertendosi, il gioco immaginario del sociale più elementare: a seconda delle situazioni, dei diversi istanti e palcoscenici che compongono la circolarità circadiana del tempo domestico di una casa, disvelare in pubblico e così "eroicizzare" il quotidiano. Mettendo in scena la rappresentazione di una vita quotidiana “finalmente” svelata nelle sue facce negative e private le più intime, mostrando giovani rampolli della nostra società sotto l’occhio vigile di una telecamera implacabile: il pubblico a casa. Prendendo in prestito una metafora tratta da un romanzo di fantascienza celebre per la sua portata critica nei confronti dei rischi potenziali connessi alla modernità tecnologica, l’occhio televisivo del Grande Fratello di casa nostra propone che, dai retroscena dei propri ambiti domestici, tutti possano democraticamente osservare il segreto e i retroscena di una soap opera “vera”: sconvolgere l’ordine dell’interazione nella quasi-interazione con alcuni prototipi di giovani finalmente raccolti a uso e consumo degli scienziati esperti e dei pensatori dilettanti che abitano la vita quotidiana quali grandi esperti di senso comune e di spionaggio socio-culturale.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
5
mutabile consiste nel saper rimescolare le carte al momento giusto. Non foss’altro per mantenere l’illusione almeno temporaneamente “perfetta”.
Rappresentazioni in TV Sondare talune di queste boe immaginarie intorno alle quali si ancorano e s'incarnano
(dal punto di vista non tanto fisico, ma retorico e metaforico) modelli prototipici di racconto identitario "giovanile" è stato dunque il nostro obiettivo. Ci siamo quindi proposti un’analisi di rappresentazioni televisive per cercare sì contenuti, ma in primis prototipi dati per scontati o pre-supposti (e in questa supposizione reciproca consiste gran parte del nodo interpretativo), finalizzati a costituire un serbatoio possibile dinamico di senso comune proposto come "giovanile". Nelle rappresentazioni sociali della quasi-interazione mediata in tv abbiamo ipotizzato si potesse trovare un processo di cristallizzazione di luoghi comuni (e messi in comune), proprio perché proposti in un contesto in cui erano, di fatto, sottratti all’esperienza vissuta ma messi in scena nelle realistiche (e potenzialmente, o virtualmente, onnipotenti) quasi-esperienze mediate. Nello stesso tempo, tali rappresentazioni potrebbero anche costituire cartelli indicatori dei contesti sociali a cui si rivolgono. Non ci preoccuperemo dunque tanto della distorsione o degli intenti più o meno manipolatori dei contenuti, quanto dei nodi di ancoraggio e oggettivazione che sono sottratti alle tensioni tipiche del vissuto sociale e si ripropongono su un piano immaginario quale supporto artificiale delle credenze.
In questo gioco immaginario fondato su una sorta di reciproco "facciamo come se fosse vero" - implicitamente assunto e condiviso da produttori e destinatari delle trasmissioni - si punta ad eliminare gli scarti differenziali e si rende quasi-tutto possibile: sospensione virtuale delle inibizioni, fluttuazione delle maschere dei personaggi, sostegno simultaneo sui vincoli simbolici della “realtà” - nel nostro caso costituita da relazioni sociali fra gruppi di pari che si riconoscono come giovani - e sulle risorse immaginarie che consentono di fare a meno delle sue insidie effettuali. Si giocherà così "ad interagire" servendosi delle tecnologie a distanza della virtualità televisiva, telefonica, internettiana, radiofonica, che rendono possibili cerchie potenziali di amici prototipizzati e luoghi immaginari di incontro in cui ascoltare musica "insieme", chiacchierare del più e del meno su argomenti e con linguaggi autoreferenziali ed omocentrici, evocare e rilanciare nell'arena pubblica del personaggio la rete prossemica degli amici vicini dedicando un videoclip o una canzone a Mario o a mia cugina Monica, e così via.
Tuttavia, da un punto di vista, potremmo dire, strutturale, non occorre necessariamente pensare che le cornici forti della significazione sociale trovino qui le proprie poste in gioco
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
6
verosimili. La dinamica riguarda piuttosto il piano immaginario delle identificazioni possibili e dei nessi di significato attivabili entro risorse e macroscenari che esulano dalla nostra trattazione. Dobbiamo quindi fare attenzione a non prendere troppo sul serio, alla lettera, né i prototipi né le ossificazioni delle aspettative sociali deificate artificiosamente dalla scena televisive idolatrate negli pseudo-rituali delle comunità televisive o radiofoniche dei talk show analizzati. Sia i produttori, sia i registi sia gli spettatori restano in primo luogo attori sociali fisicamente legati a rapporti, relazioni, situazioni che non possono certo sottrarsi alle irrimediabilità delle esperienze e delle interazioni vissute. E quindi dovranno confrontarsi con i propri contesti ermeneutici possibili ma non infiniti, con i vincoli e le dinamiche degli ordini d'interazione diversificati in cui coesistono e coabitano vivendo in società. Persino lasciarsi ammaliare dal successo riscosso dalle credenze sul potere panottico dei media rischia di restare intrappolato nel meccanismo illusionistico della riproduzione immaginaria dell’interazione. A tale proposito ha forse ragione Anthony Giddens, quando ci invita a non lasciarci confondere e a non scambiare le pratiche routinarie di fruizione dei media con adesioni normative da parte degli attori sociali. Rischio a cui sembra invece volerci votare Jean Baudrillard, il quale tende a teorizzare un simulacro riuscito, col suo versante di impostura che attanaglierebbe una realtà sociale inerme facendola addirittura implodere nel buco nero dell'artificio puro (o del "delitto perfetto", per riprendere il titolo di un suo libro). Riteniamo al contrario che non solo persiste ma è fondamento della stessa cultura sociale contemporanea (con il suo corollario di incertezza, lucidità tentate e altre appena abbozzate, senso tragico della precarietà delle esperienze, rifessività insidiosa, etc.) una differenza forte seppur mai definitiva e chiarificatrice tra sapere e credenza, intesi qui come sapere intersoggettivo dell'esperienza vissuta (v. Jedlowski 1995), da una parte, e credenza nel sapere dell'esperienza mediata. Con una forzatura del linguaggio psicoanalitico potremmo dire che la scena massmediatica occupa, per l'attore sociale, una sorta di spazio onirico - a rischio di feticismo, certo, visto che in esso la questione della realtà può non porsi affatto; ma, se si pone, essa passa attraverso il filtro imprescindibile dell'ermeneutica e incontra gli interrogativi tipici della rilevanza tratti dalle esperienze vissute: riguarda perciò la ri-costruzione di informazioni e bagagli di senso comune che dispongano in modo adeguato all'agire (o, meglio, all'inter-agire).
In un linguaggio più socio-antropologico, tornano in mente alcune parole di Lévi-Strauss (1980) circa la coabitazione - alla superficie del sociale, una superficie di cui fanno parte oggi anche le culture massmediatizzate - fra molteplici sfaccettature di maschere, personaggi e attori che mantengono un "campo in agitazione permanente", costituendo di per sé un fremito e una tensionalità possibile, dalla cui diversificazione e - oseremmo aggiungere - dissonanza dipende ogni possibile dinamismo e mutamento.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
7
Ma chi sono i giovani televisivi? Come ricorda nel suo saggio qui contenuto Santambrogio, citando le varie ricerche sul
tema, i "giovani non sono (...) una classe sociale; non sono una classe di età; non sono un gruppo
sociale", sono al massimo, riprendendo Mannheim, "un'unità generazionale" che potrebbe aver
condiviso una medesima esperienza... Certamente, i ragazzi di oggi convidono l'accesso ad una
pluralità di forme di comunicazione che utilizzano tecnologie diverse: interazione faccia a faccia,
forme ibride di comunicazione mediata mediante telefono, telefonino, SMS, chat-line, forme
anch'esse ibride di quasi-interazione mediata (televisione, radio, cinema, con i vari corollari
tecnologici in via di sviluppo), etc. E talvolta pare condividano l'idea (sotto certi aspetti mitica)
portata avanti anche da alcuni studiosi che far legame sociale e fare esperienza del sociale sia
possibile in televisione, in radio, al cinema, via Internet o via telefonino, e in via quasi residuale
"faccia a faccia". Essi condividono così forme espressive e creative di linguaggi autoreferenziali
che li distinguano dalle cerchie generazionali e li facciano sentire soggetti di un'azione collettiva
propria, quasi in competizione con i padri e le madri che raccontano loro di epoche di grandi
ideali e grande creatività (il '68, il '77, i movimenti, etc.) collettiva che - si racconta - venivano da
questa nuova strana entità oggi chiamata "giovani"; e da queste epoche giustamente essi traggono
(o ereditano) parte dei loro miti e aree di riferimento, in termini musicali, di comportamento, di
mode di abbigliamento, di liceità di violazione di talune norme, etc. Naturalmente, ci sono
rielaborazioni, innovazioni più o meno radicali in questo o quel campo, linguaggio compreso; ma
il tutto all'insegna della riconferma e del ri-conoscimento di una identità sociale che si vorrebbe
molto precisa e che si traduce nel "siamo giovani".
In questa nostra parte di ricerca abbiamo voluto allora rilevare quali tratti stilizzati, quali
modalità di ancoraggio e oggettivazione talune rappresentazioni sociali mediate dalla televisione
proponessero al riconoscimento immaginario di un'audience costituita da gruppi e individui
convenzionalmente definiti giovani di oggi. Nel considerare questo particolare tipo di
rappresentazione sociale come al tempo stesso indicatore e operatore di processi sociali di
costruzione di significato, ci siamo chiesti se fossero individuabili aspetti prototipici, agevolmente
rilevabili nella veste cristallizzata del "come se" televisivo al cui gioco erano invitati a partecipare
"target" detti giovanili. Non cercavamo né la rappresentazione dell'impegno né tanto meno quella
- quasi-satura, ormai - del disagio imputato a tale età supposta di transito; volevamo soltanto
reperire eventuali stilemi, parole d'ordine o "rappresentazioni convenzionali" intorno a cui mezzi
comunicativi mediati e massificati invitavano talune cerchie sociali che, abbandonati i panni degli
attori reali di scenari seriosi, erano chiamati a ricoprire un'identità sociale comune assumendo il
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
8
ruolo e la parte di "giovani che amano cose giovani e divertenti", giovani che chiacchierano, che
hanno opinioni "giovani", che giocano - letteralmente - a fare i giovani e a definirsi come tali,
come se fosse vero; tanto è solo televisione...
Arene ludiche di loisir quotidano «Vorrei, ma non posso, anche se, sì lo so, ma comunque... forse potrei, chissà»... Intanto, giochiamo a stare insieme, chiacchieriamo per dare un senso al nostro stare
insieme, ascoltiamo musica, sogniamo amori impossibili e forse un giorno possibili, e intanto discutiamo, discutiamo, discutiamo... Per dire cosa? Beh, in primo luogo che siamo giovani e che ci tocca studiare, - ma che noia - diamoci una pausa, divertiamoci un po', facciamo a far finta di essere belli, ricchi e famosi e magari cerchiamo anche di imparare come si fa a diventarlo... Sogni nel cassetto, identificazioni virtuali con il divo del momento; e per carità, cambiamo, cambiamo, troviamo cose nuove, ma non troppo, perché la cosa più importante è ritrovarsi senza troppi problemi, riconoscersi senza troppe tematizzazioni, sapere che siamo un bel gruppo, una banda di amici in compagnia.
Del resto, nell'ottica pragmatica delle routines quotidiane, chi riuscirebbe a ritenere appropriato se, durante una serata dedicata alle barzellette, qualcuno si mettesse a disquisire che so, su Hegel? O sul significato profondo dell'essere di destra o di sinistra?
Nella differenziazione crescente di ambiti, funzioni, compiti, competenze, le televisioni spesso presentano, coi loro palinsesti, una specie di condensato - prototipico, cristallizzato e avulso dal contesto interattivo fisico del faccia a faccia quotidiano - delle varie esperienze che possono attraversare la vita quotidiana di un attore sociale che viva nella tarda modernità. L'individuo blasé di una virtuale metropoli televisiva può pensare di sostituire con lo zapping o con una scelta volontaria di questo o quel programma le passeggiate senza meta del flaneur di baudelariana o benjaminiana memoria; contemplare in modo estetizzante disagi fini a se stessi, indugiare di tanto in tanto per indignarsi o compatire questo o quello (v. Boltanski), ma anche semplicemente godersi di tanto in tanto un po' di loisir, semplicemente divertendosi a giocare (o prendersi ogni tanto una bella sbornia) con questa o quella maschera, con questo o quel gioco di specchi e di illusioni che lo aiutano comunque a sentirsi parte di un mondo in movimento o di un mondo in qualche modo 'sociale'.
Certo, come si concilia tutto questo con le sue azioni sociali nel contesto d'interazione fisica in cui vive o coabita con altri?
Difficile rispondere in modo esauriente a questa domanda; stupisce tuttavia che il più delle volte sia data per già risolta e che gruppi di studiosi e intellettuali inorridiscano di fronte
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
9
ai "modelli di socializzazione" che un certo tipo di televisione disimpegnata proporrebbe, o di fronte alle "distorsioni della realtà" che esse renderebbero possibili e che solo degli "idioti culturali" come masse anonime e analfabete sembrerebbero, chissà perché, prendere sul serio (salvo poi accorgersi quanto sia difficile individuare concretamente questa contagiosa "idiozia"). .Solo in Giddens6, come abbiamo visto, sembra trovarsi la semplice, lapalissiana, evidente osservazione secondo cui occorrerebbe stare ben attenti a non scambiare le routines con vere e proprie adesioni normative... Perché scandalizzarsi se ci si commuove davanti ad una lacrimevole e stuccosa soap opera? Perché scandalizzarsi se s'inventano trasmissioni dove giovani sedicenti tali s'ingegnano a far mostra di sé con telefonate stupidelle in cui si parla ammiccando di sesso, di cantanti in voga più o meno belli che fanno moda e c'insegnano come vestire, di soldi, di espressioni gergali e giochi linguistici riduttivi, etcetera etcetera? Forse pensiamo che, quando le mamme e le nonne e le trisavole c'imponevano gonne lunghe o corte, grembiuli e divise di vario genere a scuola o in collegio, pantaloni corti o lunghi a seconda delle età e senza interesse alcuno per i rigori invernali o le calure estive, o colli inamidati, o busti steccati o sottogonne pesantissime, o mutandoni coprenti, etcetera etctera, non fosse davvero molto meno cogente, meno trendy e meno "gruppale" tutto questo!... Pensavamo forse che una riflessiva e lucida modernità avrebbe trasformato magicamente i suoi cittadini dilettanti in soggettività singolari, sempre autocritici, impegnati e razionalmente condotti ad una tematizzata visione della sfera pubblica? Oppure che tutti gli incontri quotidiani si trasformassero in discussioni da salotto tra individui razionali e liberi da ogni interesse pratico, in nome solo della "cosa pubblica"? Ci sembra troppo banale osservare che ci sono persone a cui, nel loisir, piace guardare in tv le partite di calcio7, altri le partite di basket, altri (spesso altre) le soap opera, altri ancora (i giovani 'adolescenziali' o, secondo alcuni, demenziali e analfabeti di ritorno...) i talk show videoinframmezzatidamusicatrendyrotocalchi etcetera etctera.
Ecco perché, in questa ricerca sugli aspetti di rappresentazione sociale giovanile per e con il senso comune, abbiamo voluto privilegiare come corpus di analisi proprio uno spazio che possiamo provvisoriamente definire ludico d'intrattenimento e di chiacchiera, messa in scena esplicita di una pseudo-interazione ordinaria: il talk show. E' stato un po' come se avessimo cercato proposte di non coinvolgimento televisivo impegnato, focalizzandoci su quella che, estrapolando liberamente da Boltanski (2000) potremmo chiamare una versione rovesciata della "topica estetica" del flâneur epicizzato da Baudelaire. Rovesciata perché se
6 Ma si veda anche l'allettante appello di A. Abruzzese, "Analfabeti di tutto il mondo uniamoci" (1996). 7 Con bonaria ironia, verrebbe da chiedersi quanti esperti di communication studies si siano applicati a mostrare le "influenze selettive" o le "distorsioni" o i modelli di socializzazione manipolabili che "passano" attraverso le cronache sportive... Certo, oggi i giornalisti sportivi si sentono impegnati quando stigmatizzano gli striscioni considerati "razzisti", intervistano il callciatore famoso perché sostenga e influenzi televisivamente questa stigmatizzazione...
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
10
nell'accezione di Boltanski il flâneur rinuncia all'azione collettiva per scelta, per una sorta di rivolta radicale contro gli schematismi pietistici o rivendicativi della società, nel caso del ludico giovanile in Tv si tratta invece di un’estetizzazione del trendy, del riconoscimento esortativo in una gruppalità sia pur di tipo nuovo, come vedremo. Potremmo forse dire che questa versione eufemistica ed edulcorata delle commedie umane disegna una topica estetizzante ed ipertrofica piuttosto che meramente estetica e minoritaria,quale è invece quella analizzata da Boltanski nel descrivere le tre modalità di rappresentare la "sofferenza a distanza".
I talk show qui presi in considerazione sono in gran parte trasmessi su reti televisive commerciali – Uomini e donne, Amici, Kitchen, Select, Tempi moderni, Fuego, Affari di cuore, quest’ultima su Rai2. In essi sono presenti i “giovani” (nel ruolo di “pubblico in studio” e di “ospiti in studio”) o vengono trattate soprattutto tematiche riguardanti i giovani. Non sono, come si diceva, talk show "impegnati": l’immagine giovanile appare innestata sulla quotidianità ordinaria più che su una sfera pubblica intesa in senso tradizionale. Anzi, potremmo dire con Thompson (1988) che proprio la trasformazione della “visibilità” di tali prospettive giovanili nello spettacolo dei modi quotidiani di parlare, agire, presentare il corpo, mostrare la capacità (apparente) di trasferire sulla ribalta persino i retroscena privati della televisione ha costituito un oggetto d’indagine importante per reperire i modelli d’identificazione narrativa e immaginaria8.
Un aspetto rilevante che abbiamo tenuto presente nell’utilizzare la rappresentazione come fenomeno è il suo riferimento non a qualcosa di stabile e di statico, ma a delle pratiche, seppure televisive: riproduzioni sociali di una comunicazione orchestrale (cfr. Winkin 1981; 1996) che, simulando quella tipica della vita quotidiana, mette insieme più strumenti espressivi e punta ancor più che nella vita ordinaria a mostrare combinazioni unitarie di scenografie e significati non sempre a prima vista congruenti. Anzi, trattandosi nel nostro caso di "giovani" che s'incontrano per il solo gusto estetizzante di riconoscersi come tali, la posta in gioco rappresentativa diventa il più delle volte proprio una sfida costante e ripetuta di combinare, accessoriare, aggiungere, innovare, rendere fluido e flessibile, passare da un registro all'altro, mantenendo inalterato l'effetto quasi-magico dell'intendersi comunque. Diventa infatti irrilevante, nei contesti televisivo-ludici da noi analizzati, che le persone rappresentate come "giovani" siano appartenenti a gruppi, a cerchie differenti: televisivamente possono riconoscersi come grande tribù allargata, che al massimo rinegozia continuamente i confini della inclusione o nel gruppo dei giovani, o in quello dei "più giovani" o in quello
8 Un altro aspetto del lavoro - a cui qui rimandiamo solo in modo molto parziale - ha riguardato la radio giovanile per eccellenza, Radio DJ, la cui analisi - coordinata da M. T. Torti - è stata utilizzata soprattutto per un controllo importante dei numerosi scambi che molte delle trasmissioni televisive hanno rivelato avere sia con il mezzo radiofonico, sia con il medium musicale.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
11
avverso dei "non giovani". In definitiva si rappresenta una tribù nomadica, al tempo stesso effimera e fusionale (cfr. Maffesoli 1988), la quale in primo luogo si ritrova nei rituali riprodotti artificialmente del consumo interazionale dello stare insieme dentro, con e mediante le proprie trasmissioni televisive, caratterizzate da vedere, ascoltare, parlare, mescolando parole, immagini, musica, atteggiamenti, travestimenti, giochi di nascondimento e disvelamento ammiccante di ribalte e retroscena.. Come sostengono Montanari e Spaziante nell'elaborazione della nostra ricerca (2002), «essi poi mettono in circolazione e fanno proprie tali diverse materie in termini sia di espressione (musiche, suoni, immagini, capigliature, abbigliamenti) sia di contenuto (temi, argomenti, titoli di canzoni, gruppi musicali, appuntamenti, indirizzi e-mail, numeri di telefono, top ten o hit parade). Sono persone che nel ruolo di attori sociali al tempo stesso fruiscono di tali programmi, vi sono rappresentati e messi in scena e sono a loro volta "ascoltati". Infatti, uno degli elementi fra i più tipici nei programmi analizzati è la continua, ostentata e rappresentata, parossistica ricerca di un "feedback con il pubblico"». Proprio l'interazione - intesa come modalità di contatto intimo e disinibito - costituisce un nodo cruciale di ancoraggio: nei termini moscoviciani, accade nel suo caso che, decontestualizzata dall'universo "reificato" degli attrezzi concettuali della scienza sociale, si ri-costruisce nell'ordinarietà mediatica come messa in comune gergale, collegandosi alle nuove possibilità tecnologiche della comunicazione e fino a diventare un invito esplicito che scorre a mo' di sottotitolo nel corso di una trasmissione o un vero e proprio appello verbale: "ehi, dai, su, interagiamo!" (ivi), che si oggettiva poi nella chiacchierata ostentatamente informale, nel dibattito accalorato e pregiudizievole o nella dedica musicale e quindi nell'ascolto "comune" di personaggi e stili "comuni" (spesso, rigorosamente trendy e mai o quasi mai eccessivamente stranianti, almeno rispetto allo stile della rete o del programma).
Nel lavoro di ricerca - attraverso la visione critico-analitica di alcune puntate campione delle suddette trasmissioni9 - abbiamo puntato ad evidenziare eventuali forme di ancoraggio e oggettivazione significative10. Vedremo che l'apparire del corpo e la messa in scena di un piano di spontaneità nelle relazioni amicali sono i nuclei centrali identificabili.
Dal punto di vista socio-semiotico, l'analisi ha esplorato due principali tematizzazioni emergenti: «1. l’immagine del pubblico proposta dalla tv nei suoi vari generi, dal talk-show alla fiction, mediante esibizione di identità giovanili che il programma si incarica di “estrarre”
9 Complessivamente circa 20 trasmissioni, registrate nel corso del 2000. All'analisi delle trasmissioni si è affiancata anche, a cura di N. Rizza, la conduzione di alcune interviste con testimoni privilegiati del mondo televisivo (produttori, sceneggiatori, etc.). Per una descrizione più dettagliata dei metodi e del corpus d'analisi si rimanda al già citato volume a cura di Lalli (in corso di stampa, 2002). 10 Circa l'uso dei termini oggettivazione e ancoraggio si rimanda a quanto contenuto nel saggio di Santambrogio sulle rappresentazioni sociali in questo stesso volume. V. anche Moscovici (1979).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
12
dal quotidiano o di creare tout-court; 2. l’immagine indiretta del giovane » (Demaria e Pozzato 2002).
Pozzato e Demaria hanno così notato una «diversa modalizzazione relativa all'immagine del pubblico»: un voler essere (immagini idealizzanti, prototipi di bellezza, di abilità, etc., presenti ad esempio in programmi tipo come Miss Italia); un dover essere (immagini propositive, didattiche, indicazioni di tipo pratico); infine «una non modalizzazione, cioè un essere e illustrare ciò che si è, senza produrre modelli, in una specie di ostensione problematica o ludica del mondo giovanile». «Altri livelli interessanti sono costituiti dalla differenza maschile/femminile e per fasce d’età. Molto in generale, si nota un affievolimento sia dell’una che dell’altra differenza. I ragazzi e le ragazze vengono equiparati in nome del fitness, della bellezza fisica, della logica del successo. Fanno eccezione i “casi umani” del talk show dove invece si riproduce una differenza di genere spesso tradizionalista. Per quanto riguarda le fasce d’età, la fascia del “giovane” si è allargata indefinitamente, comprendendo anche quarantenni “giovanili” e bambini che, in appositi programmi, si atteggiano a giovani adulti mediatizzati» (ivi).
Nella prospettiva del prototipo “giovane” presente nei testi televisivi, i programmi musicali o quelli che vanno in onda presso emittenti più specificamente rivolti ad un target giovanile, mostrano – in particolare nella già citata analisi di Pozzato e Demaria - livelli più alti di adesione e quindi di identificazione del soggetto con il mezzo. Nello stesso tempo, emergono rappresentazioni di gruppi di giovani diversi, a seconda anche dei talk show analizzati. Nell’opera di selezione e di semplificazione immaginaria e spesso estetizzata delle esperienze in Tv vediamo, da una parte, diffondersi un'attenzione sempre maggiore ai "giovani" che fa indubbiamente proliferare trasmissioni con giovani, sui giovani e per giovani (pensiamo alle reti come Mtv o VideoMusic o ai talk show qui analizzati). Si dà voce ai giovani attribuendo loro un ruolo che viene messo in scena ed evidenziato come attivo: i giovani in questi programmi sembrano valorizzati: possono intervenire, esprimere le loro opinioni, fare appello alla loro esperienza, costituire attori sociali "à part entière".
Al pubblico in studio “giovane” di Uomini e donne e Amici è attribuita ad esempio la facoltà di giudicare e di consigliare gli ospiti in studio più o meno giovani che espongono il loro problema. In questi talk show sono proposte quindi almeno due immagini di giovani: i giovani “maturi” e i giovani che devono ancora crescere e riflettere su se stessi; i giovani “maturi” hanno in genere la funzione di aiutare quelli meno maturi a ragionare11. Ma quali sono i confini entro cui il gioco del talk show definisce questa libertà di espressione? In effetti, pur mostrando vesti talora ostentate di spontaneismo o lasciati intrufolare nello spettacolo dei retroscena televisivi, è evidente che i personaggi presenti stiano comunque
11 Lo spunto per queste osservazioni discende in particolare dall'analisi condotta nelle schede di ricerca da S. Capecchi.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
13
recitando una parte (indipendentemente dalla verosimiglianza o dalla falsità voluta o no delle esperienze raccontate): il gioco del "come se" rende evidente che stanno rappresentando un prototipo di ruolo, e, per quanto riguarda il pubblico in studio in taluni talk show, ognuno si costruisce il proprio personaggio fisso nel tempo che tende a pensare allo stesso modo, non foss'altro per rassicurare e proporre un prototipo credibile e volutamente ’perfetto’ (si ricordi che la cosa importante è che l'illusione sia comunque perfetta). Le immagini degli ospiti sono quindi accuratamente monitorate: specie in talk show come Amici le tipologie sono selezionate, i problemi da raccontare anche e il pubblico a casa dopo avere visto qualche puntata deve poter sapere cosa aspettarsi dai vari “personaggi”, con il sapiente dosaggio di qualche nota d'imprevisto, come in ogni interazione ordinaria. Inoltre i giovani che costituiscono il pubblico in studio, ponendosi come attori sociali che rivendicano una valorizzazione a pieno titolo, saranno anche scelti ed esplicitamente abbigliati per rimandare un’immagine “per bene”, “ripulita” dei giovani (di giovani appunto “saggi e maturi”): ad esempio appaiono piuttosto sobri nel vestire, senza eccessi come capelli colorati, tatuaggi o piercing, e manifestano un'ostentata naive “spontaneità” nell’esprimere la propria opinione. I giovani ospitati in studio spesso presentano invece qualche eccesso stravagante nel vestire o nel comportamento (ad esempio stanno in silenzio, fanno fatica ad esprimersi, si mettono a piangere, ecc.) che li rende più "immaturi" e suscettibili d’aiuto. Vedremo più avanti quanta importanza rivesta quest’attenzione all’equilibrio dell’immagine presentata, con valorizzazioni positive dell’armonica combinazione di elementi pur eterogenei ma resi flessibili da nuove competenze di presentazione del sé, e la sanzione di rigidi eccessi fini a se stessi.
I talk show di questo tipo possono essere considerati come arene comunicative in cui non solo "giovani" ma anche "giovani" e "adulti" si scambiano punti di vista su determinati temi proposti. Le dinamiche interattive che si vengono a creare consentono la ri-produzione di un senso comune già largamente diffuso riguardante la categoria “giovani”: dal confronto con la categoria “adulti” emergono infatti stereotipi dei giovani piuttosto consolidati e scontati. Ma nello stesso tempo i “conflitti generazionali” così messi in scena lasciano in qualche caso intravedere tentativi di scardinare luoghi comuni associati ai giovani fornendo nuove chiavi di lettura e, soprattutto, facce molteplici di problemi solitamente guardati sotto una sola angolatura. Si verifica cioè una visibilità maggiore che, seppur rinviata all'interno di una pseudo-interazione e incorniciata in prototipi facilmente condivisibili, propone comunque interrogativi e risorse ulteriori di rappresentazione. Come può accadere, appunto, nel corso delle chiacchiere ordinarie nei luoghi più o meno prevedibili delle interazioni faccia a faccia.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
14
I salotti televisivi della nostra analisi Cominciamo dunque a delineare meglio, in termini operativi, le domande che
vogliamo porci: quali sono le aspettative reciproche di significato che contribuiscono a definire i “giovani” rappresentati in tali programmi e i "giovani" a cui presumono di rivolgersi? Come viene costruita la categoria “giovani”, quali nuclei di significato sono proposti e quali le ramificazioni/innovazioni di senso derivabili dai nuclei figurativi più consolidati? In modo sintetico, proviamo perciò a riportare alcuni degli aspetti significativi emersi a questo proposito in alcune trasmissioni analizzate12.
1. Cominciamo con Amici e Uomini e donne. Amici è un programma rivolto ad un pubblico generalista ma soprattutto ai giovani (di
solito si parla di problemi giovanili e di conflitti genitori-figli); inizialmente il pubblico in studio era composto solo da ragazzi e ragazze (possiamo considerare il pubblico in studio come il simulacro dello "spettatore" che si vuole coinvolgere), poi si aggiunge anche il pubblico in studio degli adulti. In Uomini e donne è avvenuta la stessa cosa rovesciata: è un programma rivolto principalmente ad un pubblico (femminile) adulto (i temi trattati sono le relazioni di coppia) e inizialmente il pubblico in studio era composto da uomini e donne adulti, mentre poi si è aggiunto il pubblico in studio dei giovani. In entrambi i programmi, condotti da Maria De Filippi, i pubblici in studio sono composti in genere dalle medesime persone le quali, come si diceva prima, interpretano ormai un ruolo fisso nella messa in scena dei conflitti generazionali o di posizioni assunte riguardanti le varie tematiche affrontate. Si tratta quindi di due programmi in cui si cerca di coinvolgere due differenti generazioni in un vero e proprio “gioco” di problem solving che in realtà non cerca esito risolutorio, ma punta essenzialmente a stimolare la discussione. Il «repertorio di conflitti è abbastanza costante: lui e lei; figli e genitori; italiani e stranieri», con i vari possibili incroci di multiproblematicità. Dal punto di vista dell'interazione rappresentata si rileva la messa in scena di una conflittualità mai ricomposta, che si alimenta senza soluzione, in una sorta di andamento a spirale. Non occorre pervenire ad una qualche condivisa definizione psicologica, sociologica, politica o altro: l'importante è esibire un problema e mostrarne le facce conflittuali. Spesso, anche le dinamiche della chiacchierata si svolgono quasi come un dibattimento con tanto di giudizi vicendevoli, in un ambito che autoalimenta la discussione tra parti che continuano a contrapporsi; talora vorrebbero rimandare a possibili "etichette" di un'opinione che dovrebbe
12 Le osservazioni che seguono sono il frutto di discussioni e contributi derivanti da schede e analisi incrociate condotte con alcuni già citati componenti del gruppo di ricerca (S. Capecchi, C. Demaria, M.P. Pozzato, V. Iotti, F. Montanari, L. Spaziante).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
15
attribuirsi ad un modo "giovane" di pensare, ma - aspetto significativo - non necessariamente l'età anagrafica e l'esperienza ostentata da questo o quel "personaggio" coincidono con essa.
Emerge una rappresentazione in cui sono protagonisti non esperti in senso stretto (o 'tecnico' del termine), ma veri e propri "esperti di senso comune", che parlano in base alla propria esperienza vissuta, a cui spesso si accenna raccontando - nel giudicare e nell'argomentare l'opinione - aneddoti presentati come vissuti ed evocati come base empirica che fonda la ragionevolezza di quanto si sta sostenendo. E' un dibattito che mette in scena la molteplicità e l'inconciliabile singolarità delle esperienze possibili in un mondo diversificato, in cui le stereotipie fungono spesso da tattiche più o meno momentanee di condivisione, scappatoie socio-cognitive per trovare modi comuni di certezza ed esperienza, se non travestimenti opportuni per sostituire un ricorso a valori che si ha paura siano obsoleti o impositivi. Si delinea in tal modo una propensione marcata per temi che esaltino equazioni consolidate secondo cui giovinezza = magrezza = bellezza = sex appeal = vitalità, contrapposta a vecchiaia = decadimento = lasciarsi andare...
A rappresentare l'etichetta “giovane” è però anche un’interessante ambivalenza: da un lato, l'alea della "irresponsabilità" (i giovani sono immaturi, devono ancora imparare tanto dalla vita, sono spensierati, non hanno voglia di crescere, etc.), dall'altro, la reiterata e rivendicata libertà (e quindi responsabilità) di scelta individuale rispetto a modelli e regole di tipo tradizionale e impositivo. In quest'ambito si possono in effetti intravedere spazi di negoziazione per un cambiamento non tanto della rappresentazione dei giovani (come persone portatrici di una mentalità più “moderna” rispetto agli adulti, che è poi un altro pur recente luogo comune: giovani = il nuovo = modernità), quanto della rappresentazione del gender e del rapporto tra i generi. E' un po' come se, attraverso la messa in scena di questi ospiti fissi-esperti-del-senso-comune, il talk show televisivo monitorasse non solo i luoghi comuni consolidati ma anche i mutamenti in fieri e li considerasse componenti a pieno titolo delle arene ordinarie di dibattito ed esperienza.
2. Tempi moderni, condotto da Daria Bignardi13, si rivolge a giovani e meno giovani e
il pubblico in studio è composto da giovani e adulti senza separazioni formali-scenografiche. Le tematiche trattate hanno a che fare con il concetto di “modernità” che nel programma si collega a quello di “giovane” o a quello - per certi versi più implicito - di (comportamento, mentalità) “giovane”. Possiamo dire che il programma si pone quindi come una forma ‘giovane’ di sensibilizzazione e informazione del pubblico giovanile su alcuni problemi, “trappole della vita”, ecc. In tal senso, è abbastanza didattico, presenta storie di rinascita, di
13 Ricordiamo che ci stiamo riferendo all'edizione 1999-2000, che è stata successivamente modificata. Gli aspetti che qui si rilevano sono dovuti soprattutto alle schede di S. Capecchi (v. cd-Rom allegato a Lalli, in c.so di stampa, 2002).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
16
salvezza o quanto meno di presa di coscienza dei problemi. Qui intervengono anche "esperti" di questo o quel campo specialistico.
Con Tempi moderni, il concetto di “giovane” si sgancia in modo più esplicito dall’età anagrafica, e va a connotare chiunque (uomini e donne di ogni età) sia in possesso delle seguenti caratteristiche: vitalità, volontà di rompere i luoghi comuni, di trasgredire le regole, di dare espressione libera ai propri sentimenti e desideri, di vivere giorno per giorno. Non solo (e non tutti) i giovani secondo questo programma sono dunque “moderni”, ma è moderno chi rompe con la tradizione e rimane “giovanile” nello spirito, anche se ha settant’anni. La modernità viene espressa attraverso le storie di vita “trasgressive”, “inusuali”, “eccezionali” delle persone ospiti in studio, e spesso proprio di quelle non più giovani anagraficamente. Le persone ospiti in studio spesso sono abbigliate in maniera eccentrica, particolare, esagerata, si esplorano le mode come i tatuaggi, i piercing, i marchi a fuoco, e vengono esibiti vari tipi di look “costruiti”. In questo programma non ci sono dunque i giovani “qualunque” e “normali” messi in scena negli altri due talk show, ma si selezionano i giovani “eccessivi” in tutto ciò che fanno. Anche nel pubblico in studio ci sono giovani rappresentanti di varie mode e sottoculture giovanili: quelli con tantissimi piercing, quelli eleganti ma stravaganti, i dandy, ecc. La volontà di stupire e di naturalizzare certi comportamenti poco comuni rappresenta cerca in tutti i modi di colpire l’attenzione proponendo la rappresentazione di esperienze che si distacchino in modo dichiarato dalla quieta ordinarietà della vita quotidiana. Tra questi comportamenti “anomali” sono presentate anche inversioni di ruoli uomo-donna, donne che guadagnano di più dei loro partner e stanno con uomini molto più giovani o uomini che esprimono fortemente il desiderio di paternità, relazioni omosessuali, bisessuali, ecc. Siamo insomma di fronte ad un'arena in cui i protagonisti propongono i cambiamenti e le rotture degli stereotipi come pseudo-interazioni fondanti. Resta invece immutato lo schema prototipico del modo "giovane" di apparire: chi vuole rimanere giovane, oltre a coltivare uno spirito libero deve curare molto il proprio corpo e il proprio look. La parola d’ordine associata ai giovani/giovanili “moderni” è appunto apparire, andare in palestra, avere abiti belli e ben coordinati, belle macchine, saper richiamare l’attenzione, essere dei “tipi”.
3. In Kitchen il “giovane” è il conduttore stesso, Andrea Pezzi, che dice spesso “noi”
intendendo un pubblico giovanile del programma. L’ospite di turno deve preparare un piatto mentre conversa con Pezzi su argomenti vari. Il giovane Pezzi pone domande ad un ospite più o meno illustre che può anche essere meno giovane; non ha un atteggiamento deferente, arrivando a interrompere l’ospite quando il discorso rischia di farsi troppo impegnativo. Questo programma è rivolto in modo esplicito ad uno spettatore giovane, sia per il tipo di linguaggio spesso gergale utilizzato, sia per il tono scanzonato degli argomenti. L'aspetto più
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
17
appariscente è la “naturalezza” e lo spontaneismo che sono ostentati come quadro di riferimento comune dato quasi per scontato: s'indugia a mostrare che cosa accade nel retroscena del "dietro le quinte" quando vanno in onda gli intervalli musicali, proponendo una logica di “trasparenza” del mezzo televisivo: siamo amici, stiamo giocando insieme, ti facciamo vedere tutto, vedi non stiamo recitando, anzi, facciamo a come se fosse vero e se fossimo tutti autentici... Ciò, grazie anche ad una scenografia che ritrae lo spazio ‘intimo’, domestico e privato di una cucina nella quale si invita il "personaggio illustre" a fare come se mostrasse la sua "faccia negativa", le sue competenze e gaffe domestiche, aspetti insoliti e inediti del suo ruolo sociale pubblico. Invitiamo a casa nostra, dunque, questo o quel personaggio famoso del teleschermo (sia detto per inciso, la cucina la si indicava proprio come 'ca' o 'casa' nelle fattorie di campagna dei bei tempi andati dove spesso costituiva l'unico ambiente riscaldato e di accoglienza dell'ospite). La conversazione viene inframmezzata da videoclip14. Certo, rispetto ai più costruiti e professionali talk show visti in precedenza, Kitchen può apparire, secondo l'analisi di Demaria e Pozzato, più “sfilacciato”, improvvisato; d'altro canto, però, occorre osservare che proprio tale caratteristica gli consente di mettere in scena una pseudo-interazione giovanile ludica quasi allo stato puro: non rispettare rigidamente turni di parola, approfondire gli argomenti ma in modo "rigidamente" e ostentatamente informale, articolando persino la regia su moduli momentanei.
4. Anche in Select, che si presenta come contenitore di richieste di videoclip, si
accentua molto il carattere giovanilistico di "chiacchiera" rivolta ad una grande famiglia di giovani, sino a caratterizzarsi come un vero e proprio programma di chiacchiere, di "chat" (citando quasi esplicitamente i canali internettiani di chat), insieme all'utilizzo di un modello tipicamente radiofonico, delle radio commerciali15: tutto - la dedica, il brano musicale, il tempo, ecc. diventa la base per legare e mantenere la comunicazione. Al tratto giovanile si collega dunque il computer e alle sue risorse di flessibilità, manipolabilità, velocità, plasticità delle forme. Tratto che tornerà anche – come vedremo – nella cornice iniziale di Fuego. Nel complesso, Montanari e Spaziante (2002) rilevano che il carattere generale di questa trasmissione stia nella sua "enfatico-fàtica", nel suo continuo affermare, come accennavamo sopra, la richiesta e il rilancio continuo della parola d'ordine "interagiamo", garantita soprattutto dal telefono. «Il conduttore, anche in questo caso molto giovane e trendy, 14 Come hanno notato Montanari e Spaziante, si presuppone uno spettatore abituale di Mtv, che si aspetta un breve parlato alternato spesso da musica; va detto inoltre che tale stile è importato nella trasmissione televisiva dall’organizzatore di Radio DJ, che proprio su questo gioco tra personaggio e musica aveva centrato la propria immagine, rivolta a giovani e ‘non più giovani’. 15 Si ringraziano qui per il loro contributo soprattutto i già citati F. Montanari e L. Spaziante, e in particolar modo M. T. Torti, la cui competenza nell'ambito degli stili di vita giovanili e in particolare sui gusti musicali e radiofonici è stata essenziale. Si veda per un'analisi davvero completa e illuminante sul mondo giovanile negli ambiti tipici della musica e del ballo il suo Abitare la notte (1998).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
18
affiancato di volta in volta da giovani ospiti di successo (cantanti), riceve, con stile da DJ di radio commerciale, le telefonate e commenta con gli ospiti quanto raccontato dalle persone al telefono. Oltre all'appello "interagiamo" [espresso attraverso modalità sia orali sia scritte], si propone un insistente "siamo qui, siamo insieme", con un forte ed accentuato tratto di "contemporaneità". Non c’è bisogno di affrontare temi o argomenti specifici, proprio per la sua natura di chiacchiera pura. Il nucleo fondamentale è quello della "pressione all'interazione", allo "stare insieme", ascoltando musica e scambiandosi informalmente informazioni "personali"» (ibidem). Inoltre, come in Kitchen, la scenografia appare povera ma essenziale: niente orpelli televisivi e artificiosi, lo spontaneismo ostentato e l'autenticità assicurata anche dall'uso costante del nome di battesimo sono aspetti irrinunciabili dello star insieme fra giovani. Il gioco di prestigio immaginario del "come se" appare in una veste quasi esplicita. Tanto più che il tipo di musica, la stessa emittente televisiva sono tutti chiaramente orientati a tale riconoscimento "giovanile", in cui l'interazione vissuta e quella rappresentata sembrano tendere a rincorrersi a vicenda, in una sorta di gioco di specchi, dove anche il pubblico attraverso forme di comunicazione mediata dal telefono, dalle e-mail, si fa protagonista della ribalta che contribuisce a mettere in scena; anche se - ben consapevole delle regole proprie di un "come se" dichiaratemente condiviso - le "scelte", le dediche, le canzoni sono tutte perfettamente "in linea" con quelle lanciate da trasmissioni del genere, dalle radio o da reti come Mtv16. E anche se la musica in questa trasmissione gioca un ruolo importante, essa non è l'attore principale, ma l'aiutante, per il mantenimento dei contatti, delle chiacchiere e dell'interazione. Come molta programmazione di Mtv, Select si costituisce come flusso di "sottofondo" che ha bisogno quasi dei richiami continui all'interazione e alla contetsualizzazione spazio-temporale dello "stiamo qui ora insieme".
5. Per quanto riguarda Fuego, è «abbastanza accentuato il carattere di "rotocalco", ed
in particolare il suo stare "dietro alle quinte", cercando di mostrare facce inedite e rese "pubbliche" soltanto per noi che stiamo qui insieme a chiacchierare. Ad esempio: "andiamo a vedere cosa sta combinando quell'attore o quel personaggio o quel musicista", contattando personaggi legati ad un gusto generalmente giovanile, ma in modo per cosi dire secondario: è più la chiacchiera che conta, quello che "di segreto" possiamo svelare insieme» (ibidem). I modelli prevalenti dei personaggi proposti sono orientati al successo (fisico e simbolico) e alla competizione necessaria per arrivarci o anche all'allenamento che occorre perseguire per ottenere il premio ambito. Qui si estrinseca quanto si diceva prima a proposito del personaggio anti-eroe della moderna commedia umana: il messaggio implicito sembra 16 Come osservano Montanri e Spaziante, la top ten che appare nel corso della trasmissione è fatta da scelte che avvengono su quanto è promosso e presentato (anche nella veste grafica, come dicevamo sopra, "da sito" in cui è quasi possibile cliccare il proprio videoclip). Il cortocircuito è sempre più rapido.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
19
appunto essere "anche voi ce la potete fare", anche se non tutti possono farcela... Il mezzo primo per arrivare e al tempo stesso per mostrare il successo ottenuto è sicuramente il corpo e il suo apparire; un corpo che va "mantenuto giovane"= in forma (messo in forma). Ma la giovanilità non si ferma qui: è importante anche l'ostentata allegria, la manifesta e rapida fluidità con cui si passa - "di palo in frasca" senza preoccuparsi troppo di possibili dissonanze - da un argomento all'altro, da un personaggio all'altro, la convivialità di dialogo col pubblico a casa e con l'ospite di turno.
Inoltre, notano sempre Montanari e Spaziante (2002), «laddove la sessualità, ad esempio il corpo delle modelle, o dei modelli, è subito tradotta in caratterizzazioni da "fitness" - l’unico caso di "rappresentazione" di un corpo sessuato (ma ‘astratto’, virtuale) è nella sigla di apertura: significativamente, essa riporta l'icona di un corpo femminile disegnato con tratti digitali, come uno schema al computer. Astratta e robotizzata, resa flessibile e modellabile dal computer, la corporeità appare dunque come cornice iniziale ».
6. Vediamo infine l’unica trasmissione Rai analizzata: Affari di cuore17. Una coppia
“in crisi” partecipa alla trasmissione per decidere se portare avanti o meno il rapporto. Affari di cuore, per metterli alla prova, organizza per entrambi una serata con un nuovo partner: lo scopo è permettere il confronto fra i due partner (quello consueto e quello inedito) in modo tale da convincere la coppia a restare unita o a dividersi, verdetto che verrà emesso al termine del programma.
La conduttrice è “giovane”, così come le coppie che intervengono. Anche il pubblico, inquadrato però raramente, e ascoltato spesso solo per il tramite della conduttrice, è composto da ragazzi/e. Le coppie ospitate vengono fatte accomodare su due divani e ha subito inizio la “chiacchierata”. La gestione dei turni di parola è rigida e totalmente nelle mani della conduttrice: il dialogo è strutturato in una sequenza di domande e risposte, argomenti e tempi del dialogo sono definiti dalla conduttrice stessa. Nonostante questo, la rilassatezza delle posizioni assunte dagli ospiti (seduti “liberamente” sul divano) e l’uso di un linguaggio colloquiale, con abbondanza di formule gergali, creano, comunque, l’impressione di una chiacchierata fra amici, nella quale la conduttrice ha il compito di facilitare il dialogo nella coppia in crisi permettendo un chiarimento, con un ruolo da “sorella maggiore”.
Per quanto riguarda l’aspetto delle coppie ospiti, mancano (“naturalmente”) i completi o gli abiti interi a favore di abbinamenti t-shirt/pantalone, canotta/gonna oppure maglie e gonne a più “strati” per le ragazze (canotta sopra la maglia oppure maglie e gonne formate da più strati di stoffa, di diverso colore o materiale). Per i ragazzi, prevale un abbigliamento comodo, pratico: camicie e pantaloni larghi o jeans, scarpe da ginnastica. Per entrambi,
17 Fonte dell'analisi di questa tramissione si deve alla scheda di ricerca effettuata da Valeria Iotti (v. cd-Rom già citato).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
20
grande cura per i dettagli: la “riga” fra i capelli a zig zag per lei, il pizzetto biondo o “disegnato” per lui. L’impressione generale è che “si sentano a proprio agio”, che non siano stati truccati o vestiti “apposta” per la televisione, ma che il loro abbigliamento o comportamento sarebbe verosimile in un contesto quotidiano.
La telecamera scorre da un viso ad un altro seguendo i turni di parola, che mantengono sempre alto il ritmo nel corso della trasmissione. Tutto è consumato velocemente: i ragazzi in una sera hanno avuto modo di verificare se poteva andare meglio con un altro/a partner, si confrontano nei pochi minuti della trasmissione e decidono seduta stante cosa fare della propria storia. La conduttrice incalza gli ospiti, si precipita sugli aspetti più “delicati” (per esempio cosa è successo con lo/a sconosciuto/a la sera prima) e sollecita una decisione. Il ritmo e la velocità diventano così - ancora una volta - caratteristiche distintive di una trasmissione "giovane", che strutturalmente impedisce silenzi e tempi morti (anche a questo proposito, è interessante la scelta della conduttrice, ancora una volta proveniente da esperienze radiofoniche, dove, ovviamente, il silenzio è ancora più sanzionato che in televisione).
La struttura del programma valorizza dunque la velocità, il ritmo e la capacità di prendere decisioni in tempi brevi. Questo si lega anche al fatto che nessuna delle situazioni descritte viene vissuta come definitiva.
Proviamo ora a enucleare alcuni tratti distintivi. L’immagine di giovane nello spazio
ludico-estetizzante dei talk show considerati, oltre ad esprimere modalizzazioni salienti e stereotipizzate della nostra società (consumismo, edonismo, parità tra i sessi e di libertà di scelta individuale), è soprattutto associato a caratteristiche di ruolo costruito (e per certi versi implicato da variabili macrostrutturali che hanno ad esempio a che fare con le cosiddette ‘flessibilità’ del mercato del lavoro): esse lasciano dunque al “giovane” lo spazio della non determinatezza definitiva della decisione, della non responsabilità, del desiderio d’indipendenza, del comportarsi al di fuori delle regole, a patto di sottostare all’obbligo di apparire.
Potrebbe a prima vista sorprendere in queste stereotipie televisive l’accurata messa in disparte delle stravaganze o dei presunti tipici ‘eccessi’ giovanili. Prevale un tendenziale conformismo anche nelle trasgressioni: conformità ad una cerchia di ‘pari’ che muta e può mutare in continuazione, ma che mantiene una sorta di equilibrio tra le parti. Stereotipia accentuata dai ritmi, dai tempi e dall’ “incorniciatura” attesa dall'arena immaginaria proposta in tv, che tende a costruire di volta in volta versioni semplificate ed estetizzate di una realtà che si dà per scontato sia più complessa. Ma bisogna pure distendersi un po' e giocare a capirsi, almeno provvisoriamente, sui termini che impieghiamo quando facciamo le nostre
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
21
chiacchierate. «Se è vero che, di volta in volta, sembrano prevalere, o confliggere fra loro, diversi programmi modali - come il "voler essere altrimenti" (desiderio di trasformare se stessi e il corpo, attraverso l'adozione di dati stili di comportamento e dell'abbigliarsi), o, ad esempio, il "dover essere" (conformandosi a dati modelli, ecc.), o, ancora, la "pura apparenza" o "ostensione" di dati tratti o caratteri - accompagnati da "fare" pratici di realizzazione, tuttavia è proprio attraverso le diverse forme di presentazione della corporeità che tali sottoprogrammi si presentano» (Montanari e Spaziante 2002).
Il prototipo individuato. Oltre e dentro la chiacchiera, il corpo Data la centralità evidente della rappresentazione del sé mediante l’apparire, abbiamo
dunque focalizzato l’attenzione sul corpo in quanto forma simbolica particolarmente significativa in relazione alla messa in scena televisiva del giovane. Corpo inteso non tanto in virtù delle scelte di moda o di travestimento accessorio, ma in quanto luogo di relazioni, crocevia di tensioni e richieste rivolte al soggetto nell’ambito delle interazioni alle quali partecipa e che inducono a manipolarlo allo scopo di renderlo il più possibile adatto a supportare una efficace presentazione del sé sul piano immaginario che prima assegnavamo alla ribalta televisiva. La nostra ipotesi è che nei talk show esaminati sia rintracciabile – forse proprio grazie alla neutralizzazione esercitata dalle stereotipie rese necessarie dalle cristallizzazioni dell'immaginario - una sorta di prototipo di corpo giovane18.
«Intendere il corpo come crocevia di tensioni e la rappresentazione del corpo giovane come un insieme di prototipiche istruzioni per l’uso di questi stessi rapporti permette di andare al di là dei suoi caratteri contingenti per capire quali aspettative ricadano su chi a questo modello si adegua. E’ come se da “corpo proprio”, nell'accezione quasi psicologica del termine, in quanto cioè pertinente alla soggettività più intima del sé, si sia passati all'esplicitazione sociologistica del corpo in quanto luogo d’inscrizione dell’identità sociale presentata all’altro e prescritta dall’aspettativa dell’altro sociale: il corpo è lo strumento attraverso il quale il soggetto sociale può gestire le impressioni (in senso goffmaniano) che gli “altri” si fanno di lui, confermare o meno ruolo e status sociale» (Iotti 2002).
Il corpo giovane deve apparire in primo luogo come flessibile e plastico. I prototipi di corpo giovane offerti nelle trasmissioni analizzate (in particolar modo i due poli a prima vista contrapposti Kitchen e Amici) si condensano intorno a due caratteri di base: equilibrio e differenza, entrambi frutto di una pratica di trasformazione e ricombinazione svolta con la
18 Le osservazioni che seguono in tutto il paragrafo sono frutto di un lavoro di scambio e, in parte, di stesura comune con Valeria Iotti. L’interconnessione dei reciproci contributi rende tuttavia difficile indicare di volta in volta il contributo specifico. Assumo naturalmente la responsabilità del quadro complessivo di lettura del fenomeno. Per una rielaborazione firmata da Iotti, si veda il suo saggio nel volume in corso di pubblicazione a cura di Lalli (2002).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
22
massima efficienza che diventa criterio discriminante fra ciò che può essere incluso nella categoria di giovane e ciò che rimane al di fuori dei suoi confini. L’equilibrio appare essere l’esito di un appropriato adattamento situazionale delle molteplici modalità espressive e comunicative, che devono mostrare di saper combinare anche aspetti eterogenei in una forma (una messa in forma) in grado di dare un'impressione di coerenza: nessun elemento preso singolarmente deve prendere il sopravvento sull'insieme. Perfino nella "sfilacciata" cucina di Kitchen regna un ordine disordinato, popolato di oggetti attesi o attendibili, punteggiato da ritmi di parola e di musica prevedibili, abitato da soggetti che interagiscono con studiata appropriatezza situazionale: basta tener conto del fatto che si sta mettendo in scena una domesticità presunta o auspicata, una familiarità al tempo stesso ordinaria e festiva, caratterizzata com'è dalla straordinarietà (immanente) del personaggio di turno, del quale si spiano le gaffes e i segreti in modo quasi esplicito e dunque non ha più "faccia negativa", nei termini goffmaniani.
La flessibilità e la plasticità richieste al corpo "giovane" implicano una vera e propria competenza sociale (nei termini anche di risorsa identitaria) a saper combinare elementi eterogenei senza produrre effetti di dissonanza (nel senso, qui, di "inquietante estraneità", il freudiano perturbante, sintomo cogente di qualcosa che non va, stona con l'equilibrio atteso). L'equilibrio al quale invece il prototipo di corpo giovane perviene costituisce una sorta di alchemico processo di trasformazione che attraverso la quasi-esperienza della ribalta televisiva realizza una sapiente opera di bricolage in grado di smontare e rimontare puzzle con forme in apparenza diverse e al tempo stesso rassicuranti, perché, in fondo, solo camaleontiche, sempre uguali ai modelli - a loro volta cangianti - delle attese reciproche. Salvo incappare nei terreni di semina pluralistici dei contesti prossemici di ricezione19.
In altre parole «l’equilibrio è anche capacità di conformarsi agli altri e all’ambiente per essere adeguati e tempestivi quando gli stimoli sono molteplici e in rapida successione: il conflitto, al contrario, è antieconomico perché presuppone la messa in discussione dei rispettivi punti di vista (ivi). Il corpo giovane è dunque il corpo che è capace di trasformarsi ed adeguarsi alle richieste dei diversi contesti, sfruttandoli al meglio: la differenziazione e la pluralità dei ruoli ordinari e degli ambiti di vita sociale contemporanea fanno sì che «la capacità di trasformarsi al loro ritmo diventi una chiave determinante di successo». Ma allora, sul piano immaginario della quasi-interazione televisiva, il suggerimento implicito è che valga o quanto meno sia possibile anche il reciproco di questa affermazione: il corpo che "si mantiene flessibile, plastico e camaleontico è giovane", e dunque, alcuni anagraficamente giovani possono sembrare vecchi, mentre altri anagraficamente "vecchi" possono "apparire" 19 Ma non è questo, qui, il nostro ambito di riflessione, come sin dall'inizio abbiamo precisato. Circa la metafora della semina paragonata ai contesti di ricezione mediatica, cfr. l'analisi della parabola del buon seminatore che ottiene frutti diversi a seconda del terreno, suggerita da P. Fabbri (1998, p. 68) come ”ottima metafora dell’ascolto”.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
23
giovani. Il gioco della negoziazione costante (e relazionale) dei confini dell'uno e dell'altro gruppo di appartenenza è fatto. E così anche è assicurato l'imperativo che ne discende: la valorizzazione in positivo della flessibilità e della plasticità implica l'esigenza o quasi la cogenza sociale di un corpo giovane, che sappia "stare insieme", "interagire", rispondere all'appello esortativo di una società aperta, dinamica e globalizzante.
Ma il corpo giovane della nostra ludica arena televisiva tutta improntata alla convivialità, alla chiacchiera, alla musica e all'interazione non è solo flessibile e plastico; è anche "spontaneo", "naturale". La spontaneità viene messa in scena eliminando in modo ostentato e ammiccante le contraddizioni fra gli elementi che compongono la ribalta televisiva, trasformando le violazioni di ordini rituali formali in vera e propria regola del gioco: "siamo tra amici, possiamo fare a meno di rispettare turni di parola rigidi, contegni e deferenze inamidate, anzi vi mostriamo continuamente segreti, nostri, del personaggio, delle quinte televisive, siamo qui apposta per essere 'autentici', per fare come se fossimo autentici"... La retorica televisiva della spontaneità giovanilistica ammiccante punta a riconfermare quello stereotipico versante identitario in cui si suppone che la "falsità" sia la maschera formale dei ruoli socializzati; ci si diverte dunque a ostentare (e a godere) del cosiddetto "istintivo", del non (ancora) del tutto addomesticato dalla socializzazione, quel che resta del 'buon selvaggio' che rivelerebbe la natura più intima dell'individuo, passando attraverso la parola gergale, la parolaccia, l'evocazione di odori e umori socialmente nascosti dal corpo socializzato, il gesto quasi-appositamente inappropriato rispetto alla recita ingessata del ruolo televisivo, la risata eccessiva, il sorriso riparatorio ma ammiccante e comprensivo di fronte ad una violazione troppo forte dell'ordine dell'interazione, etcetera. Anzi, la trasmissione di Mtv sembra suggerire persino che si può essere spontanei e contemporaneamente disciplinati: il conduttore e l'ospite sono "spontanei" (diversi, originali) e rispettosi dei reciproci ruoli standardizzati; oppure, la "spontaneità" diventa una maschera o un ruolo che "fa" televisione, buca lo schermo e contribuisce a creare il personaggio. La parola d’ordine potrebbe essere: giochiamo ad essere spontanei. E’ come se la retorica televisiva della spontaneità supponesse, implicitamente, che la “falsità” sia la maschera dei ruoli socializzati: ci si diverte a ostentare (e a godere) dell’ “istintivo”, del non (ancora) addomesticato dalla socializzazione, quel che resta del buon selvaggio che rivelerebbe la natura più intima dell'individuo, passando anche attraverso l’ignoranza prototipizzata, la parola gergale, l'evocazione di odori e umori socialmente nascosti dal corpo socializzato, il gesto quasi-appositamente inappropriato rispetto alla recita ingessata del ruolo televisivo (o della fiction quotidiana)20.Spesso in trasmissioni del genere si ha l'impressione che attore e
20 Ancora una volta notiamo per inciso che trasmissioni come il Grande Fratello siano la messa in scena quasi-esplicita di questa dimensione seminascosta dell’interazione privatistico-spontanea.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
24
personaggio debbano coincidere, che l'attore si diverta davvero ad interpretare il ruolo primario di recitare se stesso. Qui si nota in particolare lo scambio della modalità sperimentata in radio dai dj prima ancora che in televisione: giocare a "parlare come ti viene", a giocare con il linguaggio, al limite della costruzione di un gergo ‘per pochi intimi’, si combina con l’effettiva strutturazione del palinsesto, con le domande orientate, con la prevedibile girandola di nonsense e la parodia del ‘personaggio famoso’ che tale diventa davvero. Personaggio amico (v. Thompson 1988) che parla ad una cerchia ristretta di amici, nonostante – o forse proprio grazie a - la platea radiofonica o televisiva21.
In definitiva, equilibrio dinamico e spontaneità giocano con diverse espressioni simboliche all'interno di un processo costante di presentazione camaleontica del sé: una pratica combinatoria e ri-combinatoria, una pratica incalzante, rapida e disponibile alla provvisorietà, pronta a includere ed escludere il più o meno trendy, il più o meno riconoscibile per la cerchia di amici virtuale che si vuole costituire. Lo svolgersi di questa pratica di trasformazione sembra definirsi come il nucleo intorno al quale si snoda la quasi-esperienza televisiva del soggetto. Non più sapere cumulativo ma reticolo-circolare, reiterazione prototipica di una pratica efficace di definizione ed espressione della propria identità sociale attraverso l'apparire al tempo stesso "spontaneo", "informale" e messo esplicitamente in scena: una faccia "positiva" rivolta alla cerchia sconosciuta di "amici" lontani chiamati a riconoscersi come simili. Tale pratica semi-esperienziale di trasformazione sembra voler inglobare le due facce del soggetto messo in scena: sia in quanto riflesso del contesto specifico in cui il soggetto si mostra in quel momento, sia in quanto riflesso della successione di esperienze, di ambienti che il soggetto ha incontrato e che possono cristallizzarsi in alcuni oggetti o combinazioni di oggetti, che acquisiscono una nuova valenza immaginaria per rappresentare la sua "identità" proposta nel mezzo televisivo. In tal modo sembra operarsi la magia o il gioco di prestigio grazie al quale il prototipo di questo ludico giovane televisivo appare capace di esprimersi con un linguaggio che al tempo stesso dev'essere "proprio" ("personale") ed esortare al riconoscimento collettivo di una quasi-comunità virtuale.
La messa in scena del prototipo di corpo giovane sfrutta dunque l'apparire come opportunità di ricombinare continuamente in modo flessibile elementi che sfidano la dissonanza, lo sfilacciamento, la trasgressione (sepppur non eccessiva22), l'ostentata 21 Si noti peraltro lo scambio tra personaggi radiofonici, o anche organizzatori e conduttori o responsabili di trasmissioni televisive come Tempi moderni per Italia 1 o un intero canale come Mtv. La radio, inoltre - come ci ha suggerito M. T. Torti nella sua analisi - gioca sul parlato-musicale anche per riconoscere cerchie di amici diverse: i non più giovani che sono ancora giovani anche perché continuano fedelmente ad ascoltare una radio di 20 anni che costituisce la loro ‘memoria’, concretizzata nelle figure stesse dei dj. 22 A proposito di quest’attenzione a non esagerare nell’eccesso di trasgressione, a conferma di questo tratto rilevato nelle immagini giovanili nella televisione italiana, si pensi che, da prime analisi comparative sul fenomeno “Big Brother” in diversi paesi, la versione italiana di tale formato internazionale appare particolarmente contenuta e rispettosa rispetto invece
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
25
"naturalezza" mostrando la possibilità di "tenere" grazie alla virtuale omogeneità collettiva delle cerchie di simili lontani nello spazio ma richiamati continuamente sulla scena immaginaria (che poi le tecnologie possano rendere praticabile l'interazione con telefonate, fax, webcam, e quant'altro ci riserva la fantasia tecnologica, da questo punto di vista non cambia molto: è l'esortazione ad un'appartenenza ostentamente immaginaria che conta). E questa possibilità di ordine ed equilibrio anche nella flessibilità combinatoria ci pare collegarsi strettamente e basare molto del suo "pensiero magico" sui materiali simbolici messi a disposizione dall'immaginario della tarda modernità. Il prototipo corpo giovane, infatti, tende a coniugare alcuni dualismi irrimediabili della modernità e ne permette la coesistenza:
- il corpo è al tempo stesso durata e cambiamento (ma cambiamento monitorato, controllato, addomesticato dalle esigenze di continuare a mostrarsi giovani in quanto snello, sano e curato anche nella ostentata trasandatezza, in cui le competenze di gusto nei confronti degli accessori sono altrettanto essenziali dell'etichetta di stile classico);
- presente (dato per scontato e configurato tautologicamente come "essere giovani", acerbi, sani, snelli e belli,in uno spazio ludico "giovane" apparentemente privo di coinvolgimento) e futuro (nel senso, piuttosto, di "conquista del presente", come affermava qualche tempo fa Maffesoli (1983), accettazione del fluire di un tempo quasi-frattale in cui esistono sfere temporali separate: gli anni passano, l'apprire giovane può restare, il corpo presente può essere conquistato asservendolo alle esigenze forti dell'apparire proptotipico, privato delle differenze lascaite dai tradizionali segni del tempo, persino talora di quelle sessuali, tanto la sua flessibilità può raggiungere modelli di esile per quanto ambigua androginia);
- individuale (luogo di espressione "spontanea" nella recita a soggetto della quasi-esperienza mediata sulla scena televisiva) e sociale (regole ostensive di riconoscimento reciproco con le tribù nomadi e virtuali dello zapping televisivo).
Si mostra, dunque, una pratica di trasformazione che àncora i prototipi di corpo giovane alle tautologie gioventù=bellezza=magrezza=.... e che si oggettiva nell’equilibrio e nella spontaneità come risultato finale e ottimale di un percorso di adattamento flessibile all’ambiente. Forse proprio questi aspetti possono contribuire a farci comprendere un fenomeno che negli ultimi decenni ha condotto all’esaltazione progressiva di tutto ciò che è giovane, quel fenomeno che qui si è scelto di definire ipertrofia del giovane.
a versioni più ostentamente trasgressive, come in particolare nel caso inglese (cfr. Joanna Thornborrow, The language of the diary room, comunicazione al convegno “Watching Big Brother: cross cultural perspectives/Guardare il Grande Fratello: prospettive a confronto”, Università di Bologna, Dipartimento Discipline della comunicazione e Centro Studi Linguaggi specifici, Bologna, 29 giugno 2001.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
26
In primo luogo, il corpo si pone come sintesi di quelle determinazioni che costruiscono il prototipo di identificazione di ciò che è giovane. La pratica di trasformazione struttura il corpo (immagine e comportamenti) perché sia in grado di presentare in modo equilibrato il proprio sé nell’ambito dei più diversi contesti interazionali. Intendere il corpo come luogo di relazioni significa individuare nelle pratiche e nelle rappresentazioni che lo caratterizzano la traccia del modo con cui un determinato sistema sociale e culturale interpreta la relazione fra individuo, da una parte, e ruolo, situazione, spazio e tempo, dall’altra. La rappresentazione che il mezzo televisivo costruisce di corpo giovane non solo propone un modo specifico per strutturare queste relazioni, ma, mettendo in scena (in particolare in “Amici”) altri modi e creando le condizioni per il loro confronto, fa emergere la sua definizione di corpo giovane come quella capace di garantire il miglior esito possibile (equilibrio e spontaneità).
Ora, l’equilibrio nell’immagine e nei comportamenti è funzionale all’inserimento altrettanto equilibrato del soggetto sociale nella situazione, il che significa indossare la maschera giusta e saper stare al proprio posto. Come l’eccesso nella costruzione della propria immagine viene sanzionato (se ci sono elementi troppo appariscenti o fuori luogo), così il porre l’accento su di sé andando al di là del proprio ruolo in termini di tono e comportamenti è una forma di eccesso valutata altrettanto negativamente. La trasformazione è funzionale alla definizione di relazioni reciproche il cui equilibrio deve essere mantenuto attraverso un pieno rispetto del proprio ruolo. In sintesi, la pratica di trasformazione che si applica al corpo diventa in generale strategia di inserimento nei diversi contesti relazionali ed essendo versatilità, flessibilità e capacità di trasformarsi l’ancoraggio ultimo della categoria di giovane, il corpo racchiude in sé e nelle pratiche realizzate attraverso di esso il prototipo di inclusione e esclusione rispetto alla categoria di “giovane”.
La plasticità del corpo diventa espressione della plasticità del pensiero nel momento in cui il corpo si propone quale luogo apparente di esperienza: da un lato, in quanto riflesso del modo di interpretare la situazione e quindi il proprio ruolo; dall’altro, come modalità narrativo-espressiva ove è possibile mostrare, mediante segni epidermici, accessori vestimentari, acconciature, ornamenti, etc., la sedimentazione di tracce di eventi che costituisce una sorta di resoconto biografico reso accessibile a tutti dalla visibilità della comunità televisiva. Questa tattica di inscrizione combinatoria della memoria reificandola su un corpo addomesticato che può asservire la temporalità e attraversarla annullandone limiti e confini, appare impregnata di una “logica contraddittoriale”, riprendendo la celebre definizione di Lupasco: di fronte all’impossibilità di trovare un filo conduttore univoco, sociale, morale o religioso, capace di durare cumulativamente nel tempo e di rivendicare la forza delle esperienze sedimentate, laddove invece esso non sarebbe più in grado di dare senso ai molteplici e cangianti ambienti ai quali il soggetto deve tener testa nella nostra
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
27
contemporaneità, ci si affida ad uno spazio ludico in cui sia possibile mettere in scena il gioco del come se. Come se fosse possibile rimanere sempre giovani, ad esempio; come se fosse possibile (e dipendesse solo da sé) diventare belli e famosi senza abbandonare le proprie certezze attuali; come se fosse possibile non ammalarsi mai e non morire mai, senza annoiarsi e senza pensare troppo...
Ci si esorta, perciò, nelle arene delle quasi-interazioni mediate, a ricostruirsi a seconda delle situazioni, dei diversi istanti e palcoscenici che compongono la circolarità del tempo della vita quotidiana, mettendo in scena ed "eroicizzando" proprio le chiacchiere del quotidiano, le gergalità dell'informale, gli ammiccamenti al divo o alla canzone famosa, i luoghi comuni dei conflitti più tradizionali, il gossip verbale e non verbale dell'ultima moda trendy del momento... Per tenersi aggiornati, presenti a se stessi e ad altri non minacciosi perché lontani, ma a cui si è virtualmente uniti dall'artificio della telefonata in diretta, del monitor elettronico del computer divenuto attore televisivo, del fax letto in diretta radiofonica, etcetera. In un fluire di forme comunicative che sfruttino e mostrino la possibile copresenza di molteplici mezzi, dai più tradizionali dell'interazione orale ai più artificiali della realtà virtuale nelle sue vesti via via più avanzate.
Il problema delle dissonanze eventuali è ostentato, quasi-cinicamente manifestato e persino esposto allo sguardo in quanto tale: uno ‘spettacolo a distanza’, tuttavia, a distanza emotiva e a distanza spaziale. Si ricordi, infatti, che le trasmissioni qui analizzate sono per lo più ludiche e d'intrattenimento, non esplicitano proposte di coinvolgimento impegnato (spesso si propongono o sanno di poter essere fruite come sottofondo parlato-musicale di altre attività routinarie); salvo quella del riconoscimento reciproco, dell'appello esortativo alla quasi-inetrazione mediata...
Gli eccessi sono aggirati, sanzionati, non le dissonanze, che anzi possono essere occasione di mostrare la propria maggiore-minore competenza alla flessibilità (quasi fosse un maggiore minore grado di giovanilità): non sono tanto i conflitti e le contraddizioni a spaventare, basta solo trovar loro una forma equilibrata di apparire in modo spettacolarmente fruibile e abbastanza competente da potersi rapidamente adattare alle esigenze del contesto (questo è forse il retroscena della spontaneità e della naturalezza così pervasivamente ostentata nelle oggettivazioni del gergo-comportamento amicale e in apparenza da retroscena).
La plasticità del corpo giovane ha così il suo corrispettivo in un pensiero “giovane”, che cambia i suoi parametri a seconda delle circostanze: la logica combinatoria che secondo il ritmo imposto dalla girandola di ruoli e situazioni permette al corpo di trasformarsi – non in senso cumulativo ma occasionale – tende a plasmare anche l’immagine di processi socio-cognitivi che per sostenere le molteplici interpretazioni di ruoli e situazioni diverse si
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
28
rappresentano come capacità di far fronte ad equilibri parziali o precari fra elementi anche eterogenei e in apparenza contraddittori o competitivi; supponendosi sempre potenzialmente “in fieri” – come l’essere giovane autorizza a legittimare – si valorizza dunque in primo luogo la competenza alla plasticità, al cambiamento dinamico e fluttuante.
Come il corpo si àncora ad una pratica di trasformazione costante che ne stabilizza il continuo mutare, così accade anche all’esperienza, la quale diventa una sorta di matrice individualizzante che orienta la scelta delle diverse combinazioni di valori e punti di vista da mettere in gioco a seconda delle circostanze. In pratica, il bricolage che combina i pensieri e mescola i linguaggi, allo stesso modo del bricolage che combina l’immagine, pare lasciare uno spazio all’espressione della singolarità perché porta con sé la traccia – quanto effimera sarebbe da studiare - di colui che lo ha eseguito. Così, la pratica di trasformazione alla base della rappresentazione televisiva di corpo giovane costituisce, a sua volta, l’oggettivazione di un approccio complessivo del soggetto e delle sue relazioni intersoggettive nei confronti degli scenari frammentati della tarda modernità: l’essere giovani presuppone una mente e un corpo altrettanto plastici e capaci di trasformarsi per rispondere efficacemente alle richieste (o imposizioni) di flessibilità che giungono al soggetto a livello sociale, culturale ed economico.
Se quanto caratterizza la rappresentazione del prototipo di corpo definito giovane può essere visto come il criterio generale capace di distinguere ciò che è giovane da ciò che non lo è, si può cercare di capire perché il giovane sia oggi il prototipo di attore sociale più idealizzato dai mezzi di comunicazione, ma ormai anche nel senso comune. L’ipotesi è che esista una significativa corrispondenza tra la versatilità, l’ambivalenza, la flessibilità e la multiformità che costituiscono il nucleo di senso sul quale si articola la rappresentazione di (corpo) giovane e le richieste che arrivano al soggetto sociale dal sistema socio-culturale della tarda modernità. Pensiamo ad esempio a due punti di vista particolarmente critici che spesso la caratterizzano: la velocità che essa impone al cambiamento delle sue forme e la segregazione come risultato estremo della frammentazione che produce nei contesti sociali. Sulla base di questi due punti è possibile sintetizzare le ragioni della sintonia fra quell’insieme di determinazioni che il mezzo televisivo ha coagulato intorno alla propria rappresentazione di giovinezza e la modernità, verificando se e come ciò che è definito giovane sia anche predisposto per gestire al meglio queste criticità.
In primo luogo, la velocità. Suggerendo il ruolo del corpo come luogo moderno dell’apparire in cui si esercita la possibilità di mettere in scena la sintesi temporanea delle esperienze, possiamo richiamarne anche le caratteristiche riflessive: la riflessività introduce la circolarità nel sapere e rettifica l’idea di un progresso lineare e univoco (v. ad. Giddens 1991). Il sapere circolare della tarda modernità si definisce nella ripetizione: il turbinio sulla superficie della modernità sembra rimettere continuamente in circolo situazioni e
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
29
rappresentazioni già note, che variano solo per la forma che assumono, ma non per la loro struttura23. Il corpo diventa ancora una volta sede “contraddittoriale” di queste ambivalenze: la costruzione dell’immagine e la selezione dei comportamenti situano i resoconti biografici raccontati in un dato momento (v. Thompson 1988) all’interno di un processo riflessivo, disposto a riorganizzarsi e ri-presentarsi continuamente.
La compresenza di pratiche molteplici che si danno come sottintese al divenire continuo della superficie permette di dare voce nell’abitudine e nella ripetizione all’esperienza, che andrebbe altrimenti dispersa nella frenesia del cambiamento (v. Jedlowski 1995). La circolarità dell’esperienza rimanda ad un eterno ritorno di istanti completi in se stessi che definiscono il kairos, il tempo delle occasioni. La plasticità - prototipizzata nel “giovane” - mostra di sapersi ben inserire nella temporalità circolare della tarda modernità perché è in grado di compiere un continuo processo di ristrutturazione. Il tempo dell’occasione è il tempo composto di istanti determinanti, in ognuno dei quali si ridefiniscono i confini e i rapporti di potere fra i soggetti sociali in una rappresentazione la cui completezza rende l’istante che la ospita così compiuto e finito in se stesso da esorcizzare l’esistenza stessa del suo limite. Gli istanti puntuali del kairos si fondono nella fluidità di un tempo circolare, nel quale ognuno rimanda ai precedenti e ai successivi, eventi puntuali basati sulla ripetizione di rappresentazioni dalle logiche analoghe. Per usare la terminologia di Goffman, ognuno di questi istanti è fatidico e impone coerenza ed equilibrio (inteso come risultato di un riuscito adattamento al ruolo). Il prototipo di corpo giovane è costruito per agire nel kairos, per “tenere testa agli eventi” e volgerli a proprio vantaggio: la velocità propria della modernità diventa turbinio di situazioni e ruoli, ai quali la pratica di trasformazione connaturata alla definizione di corpo giovane permette di conformarsi nel modo più efficace.
La plasticità implicata nel prototipo di giovane proposto dalla rappresentazione televisiva è lo strumento per affrontare anche il secondo aspetto critico della modernità: la “segregazione”, l’esistenza di una molteplicità di contesti separati nei quali il soggetto sociale si immerge quotidianamente, ciascuno recante un particolare ruolo da sostenere e, quindi, un’immagine specifica e determinati comportamenti. Le rappresentazioni sociali di corpo giovane così delineate propongono un paradigma di comportamento ed una logica di gestione del proprio corpo strutturate ad hoc per permettere di passare da un ruolo ad un altro, da un contesto segregato ad un altro mettendo in scena la massima naturalezza: capacità di rivestire i molteplici ruoli legati ai diversi contesti frammentati, capacità di trasformarsi al ritmo con il quale questi ruoli si avvicendano.
23 Ciò ricorda l’ipotesi simmeliana di una modernità a due velocità, coesistenza contraddittoria di durata e cambiamento. Ma cfr. anche la nozione di agency in Giddens (ad es. 1991), o il rapporto evento-struttura in Crespi (1999).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
30
Il fatto che queste capacità siano decisive nell’ambito delle diverse interazioni è dimostrato dalle strategie identificate da Goffman per gestire al meglio la presentazione del sé al fine di produrre negli interlocutori l’impressione voluta. Per farlo, occorre realizzare tre condizioni: dimostrare la propria “lealtà drammaturgica”, cioè calarsi così tanto nella parte da non tradire il fatto di indossare una maschera; mantenere una certa disciplina drammaturgica, cioè seguire con coerenza il copione; infine, la circospezione drammaturgica, cioè sapere quando indossare la maschera e quando si ha la possibilità di rilassarsi. Il prototipo di corpo giovane realizza pienamente queste tre condizioni perché, attraverso la pratica di trasformazione, suggerisce una strategia che ha come obiettivo ultimo rendere il soggetto sociale modello di una perfetta aderenza al ruolo. La flessibilità del corpo giovane deve portare, infatti, alla definizione di un’immagine e alla scelta di comportamenti coerenti, alla conservazione della struttura relazionale di partenza e alla creazione di un effetto complessivo di armonia e spontaneità (esattamente quanto accade in Kitchen). Così, il corpo giovane diventa risorsa preziosa, quindi, soprattutto in relazione alla moltiplicazione ed alla reiterazione dei contesti e dei ruoli della nostra contemporaneità, che tuttavia possono presentarsi come separati e non accessibili o contigui per tutti e nello stesso modo o momento (v. anche Hannerz 1998).
L’adesione alle richieste dei diversi ruoli sociali a cui si è chiamati a rispondere appare "indifferente" e quasi distaccata dal punto di vista normativo: l'aspetto importante è che a realizzarla nel modo migliore sia proprio il corpo giovane. La rappresentazione proposta dal mezzo televisivo sintetizza qui le logiche della quotidianità e le richieste della tarda modernità, individuando nella pratica di trasformazione lo strumento più adatto a ricoprire efficacemente i ruoli differenziati che la tarda modernità implica e definendo sulla sua base un paradigma comportamentale capace di definire un prototipo di esclusione e inclusione esaustivo rispetto alla categoria di giovane, che si articola proprio sulla base della capacità di soddisfare al meglio le condizioni di flessibilità e cambiamento. La rappresentazione televisiva del quotidiano, attraverso la messa in scena di frammenti di relazioni, radicalizza i contrasti per polarizzare punti di vista e comportamenti e permettere l’individuazione del prototipo valorizzato positivamente. Questo processo (evidente in Amici) ha costruito ad esempio il prototipo idealizzato di corpo giovane, come strumento di un successo che nasce nei microcosmi delle messe in scena che strutturano il sottobosco delle relazioni quotidiane ma che si scopre adatto a tutte le ribalte moderne.
Del quotidiano il corpo giovane condensa anche un “cinismo” ostentato, che potremmo leggere nei termini suggeriti da Maffesoli: un’indifferenza nel ricoprire ruoli liturgici e routinari dei quali, sul piano normativo, si rifiutano i principi fondanti. Infatti, la condizione di massima flessibilità è l’assenza di qualsiasi rigidità, anche a livello morale: il
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
31
corpo giovane si rimette in gioco in ogni contesto, cambia la propria superficie radicalmente a seconda delle necessità, seguendo il ritmo del mutamento costante sulla superficie della modernità. Se l’obiettivo è l’equilibrio, l’adattamento, il compromesso come condizione per indossare perfettamente la maschera e adeguarsi al copione e al palcoscenico, il rischio è ridurre ai minimi termini le proprie qualità al fine di minimizzare le occasioni di contrasto.
Il prototipo di corpo giovane non si propone più solo come luogo ostentato di relazioni, ma il paradigma di comportamento che implica è strutturato per la mediazione e sanziona negativamente qualsiasi tipo di conflittualità. Così, quegli indizi simbolici capaci di ricondurre il singolo ad un dato gruppo sociale di appartenenza o a qualsiasi carattere “congelato” che stabilisca confini di individuazione-differenza (sesso, età, razza) vengono accantonati o recitati solo come ruolo momentaneo per ostentare conflitti spettacolarizzati; ma sono nascosti in quanto potenziali fonti di contrasto normativo, proprio in virtù della loro non convertibilità, della maggiore resistenza che oppongono al processo di trasformazione che l’equilibrio e la mediazione implicano.
Paradossalmente, definire in questi termini il corpo “giovane” e, in generale, ciò che è giovane svuota questa categoria del suo tradizionale elemento forte di riferimento (l’età) rendendo il giovane dello spazio ludico televisivo un prototipo di successo virtualmente accessibile a chiunque, a prescindere dall’età.
Si può, in conclusione, osservare come il prototipo così definito sembri contenere la soluzione per i suoi punti più critici. L’equilibrio nella continuità di una pratica trasformatrice costante garantisce stabilità al soggetto, così come il bricolage alla base di questa combinazione lascia spazio alla singolarità di esprimersi: è come se il prototipo avesse metabolizzato, prevedendo uno spazio per la loro soluzione, il rischio duplice di disorientamento derivante da un lato dal mutamento e dal rischio di omologazione, dall’altro. Assicura così, proprio nelle neutralizzazioni delle stereotipie, un punto di riferimento stabile per ancorare il primo e predispone un canale seppur limitato di espressione della singolarità (la competenza in termini di logica combinatoria), per allontanare il fantasma della seconda.
L’ipertrofia del giovane si spiega in relazione alla corrispondenza fra le rappresentazioni proposte di ciò che è giovane e le richieste in termini di flessibilità e capacità di trasformarsi che vengono dal sistema sociale, culturale e economico. Lo sganciamento dei nuclei di senso sui quali si costruisce la rappresentazione televisiva di corpo giovane da precise coordinate anagrafico-generazionali permette a chiunque (nella pseudo-interazione mediata o, forse meglio, virtuale) di modellare il proprio corpo e i propri comportamenti sulla base del paradigma che definisce ciò che è giovane, costruito per essere garanzia di successo, strumento adeguato e coerente per affrontare i contesti peculiari della complessità moderna.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
32
Se la competizione nel corso dell’azione interpersonale si gioca a colpi di atteggiamenti, cioè punti di vista sul mondo, modi di rappresentarsi la situazione e reagire di conseguenza, la televisione offre un prototipo di corpo giovane che racchiude modelli e paradigmi legati alle strategie di selezione dei comportamenti che orientano l’approccio alla situazione, istruzioni per l’uso pragmatico dei contesti segregati della tarda modernità.
E’ come se la televisione ludica d'intrattenimento avesse assimilato il continuo mutare e l’indefinitezza tradizionalmente proprie dell’età non adulta e le avesse restituite sotto la forma di un modello vincolante di manipolazione (e padronanza) del corpo e del proprio modo di interpretare i contesti sociali. Il corpo diventa strumento per l’adesione (routinaria più che normativa?) al ruolo e supporto sorvegliato per la costruzione di identità sociali efficaci per consentire reciproca riconoscibilità e capacità di avere a che fare con gli altri promiscui del grande villaggio metropolitano. L’ipertrofia del giovane propone un modo prototipico di gestire tempo, spazio e relazioni, annullandoli ma al tempo stesso rendendone possibile la sussistenza e coesistenza in sfere frattali contigue; un modo coerente con la riflessività propria di questa nuova fase: nel tempo delle occasioni, l’abilità fondamentale risiede nella capacità di individuarle, leggendo fra le pieghe dei diversi contesti, e coglierle, negoziando potere, identificazioni e successi nell’ambito dei confronti fra le posizioni reciproche che strutturano le interazioni. Il prototipo di corpo giovane coniuga quindi le esigenze di flessibilità e successo che attraversano l’epoca attuale proponendo un paradigma basato sulla composizione di ruoli e differenze: l’esaltazione dell’armonia in Kitchen e dell’immagine “equilibrata” in Amici corrisponde alla celebrazione della mediazione come tattica di ottimizzazione delle proprie risorse, immaginate a loro volta molteplici, mutevoli a piacimento e virtualmente smisurate. Ma allora, in tutta questa girandola di giochi virtuali e piani immaginari d'identificazione non coinvolta, il giovane appare, di per sé, “senza qualità”: i suoi caratteri sono riassorbiti dalla rappresentazione televisiva estetizzante e trasformati in prototipo, paradigma vincolante in termini di comportamento e immagine, raggiungibile da chiunque attraverso la pratica di trasformazione e desiderabile da chiunque proprio perché "socialmente" efficace.
Riferimenti bibliografici
Abruzzese, A. 1996 Analfabeti di tutto il mondo uniamoci, Genova, Costa & Nolan. Boltanski, L. 2000 Lo spettacolo del dolore, Milano, Raffaello Cortina. Capecchi, S. 2002 L’immagine amorosa dei giovani, in Lalli (in corso di stampa) Cigoli, V. 1997 Astuzia, giocosità, ingegno: la psicologia sociale in azione, in Moscovici (1997, pp. xii-xli).
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
33
Crespi, F. 1999 Teoria dell’agire sociale, Bologna, Il Mulino. Demaria, C. E Pozzato, M.P. 2002 L’immagine televisiva nella programmazione televisiva italiana contemporanea in Lalli (2002, in
corso di stampa). Duveen, G 1988 The Psychosocial Production of Ideas: Social Representations and Psychologic, in “Culture &
Psychology”, vol. 4 (4), pp. 455-472. Featherstone, M. 1992 Heroic Life and Everyday Life, in M. Featherstone (ed.), Cultural Theory and Cultural Change, London, Sage, pp. 159-182. Fabbri, P. 1998 La svolta semiotica, Roma-Bari, Laterza. Giddens, A. 1991 Modernity and Self-Identity, Cambridge, Polity Press. Hannerz, U. 1992 Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Bologna, Il Mulino. Hilgartner, S. e Bosk, C.L. 1988 The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model, in “American Journal of Sociology”,
vol. 94, pp. 53-78. Iotti, V. 2002 La televisione costruisce prototipi, in Lalli (in corso di stampa). Jedlowski, P. 1995 Il sapere dell’esperienza, Milano, Il Saggiatore. Lalli, P. 1995 Immaginario, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, XXXVI, n.2, p. 279-292. 2000 Rappresentazioni sociali e senso comune. Due itinerari possibili per lo studio della
comunicazione quotidiana, in “Rassegna Italiana di Sociologia”, XLI, n.1, p. 53-79. 2001 Le arene comunicative del senso comune ovvero il cittadino meta-informato, in QuotidianaMente.
Studi sull’intorno teorico di Alfred Schütz, a cura di M. Protti, Lecce, Pensa Multimedia. 2002 (a cura di) Giovani virtuali. Come i media immaginano i giovani, Roma- Bari, Laterza (in c.so di
stampa). Lévi-Strauss, C. 1980 L’identità (seminario diretto da), Palermo, Sellerio. Maffesoli, M. 1983 La conquista del presente. Per una sociologia della vita quotidiana, Roma, Ianua. 1988 Il tempo delle tribù, Roma, Armando. Mannoni, O. 1972 Le funzioni dell’immaginario, Roma-Bari, Laterza. Montanari, F. e Spaziante, L. 2002 in Lalli (in corso di stampa). Moscovici, S. 1989 Le rappresentazioni sociali come fenomeno, in Rappresentazioni sociali, a cura di R. A. Farr e S.
Moscovici, Bologna, Il Mulino. 1992 La nouvelle pensée magique, in “Bulletin de Psychologie”, n. 42, ppp. 250-290. 1997 (a cura di) La relazione con l’altro, Milano, Raffaello Cortina. Schütz, A. 1979 Saggi sociologici, Torino, Utet.
Testo pubblicato in F. Crespi (a cura di), Identità e rappresentazioni dei giovani, Roma, Carocci, 2002.
34
Thompson, J.B. 1998 Mezzi di comunicazione di massa e modernità, Bologna, Il Mulino. Torti, M. T. 1998 Abitare la notte, Genova, Costa & Nolan. Winkin, Y. 1991 (a cura di), La nouvelle communication, Paris, Seuil. 1996 Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain, Paris-Bruxelles, De Boeck.