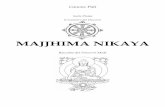IL CASO ILVA: LA "TENSIONE" TRA POTERI DELLO STATO ED IL BILANCIAMENTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI
Il percorso dei miracoli
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Il percorso dei miracoli
149
annali 2014
IL PERCORSO DEI MIRACOLIL’ANTICA PROCESSIONE DI SANT’ANTIOCO
archeologia
di Walter Massidda e Pier Giorgio Testa
La solenne processione che raggiungeva il san-
tuario di S. Antioco sito nell’omonima isola, per
potervi almeno una volta all`anno tenere la fe-
sta del Santo, partiva dal palazzo vescovile at-
tiguo al Duomo di Iglesias sin da tempi remoti
e veniva frequentata con solenne devozione sia
prima che dopo il rinvenimento delle reliquie
(18 marzo 1615), perché antica e profonda era
la fede verso il Martire Sulcitano in tutta la Sar-
degna e non solo.
I monaci Vittorini, che quasi certamente ave-
vano costruito questo e altri santuari sardi e vi
abitavano, tra il 1089 e il 1118, avevano anche
scritto o trascritto la Passio, cioè la storia glo-
riosa del Santo, che si rifaceva a una tradizione
orale vecchia di alcuni secoli, mentre la strut-
tura originaria della chiesa, che fu l`antica cat-
tedrale dei vescovi di Sulcis, la stessa tomba di
Antioco e le catacombe, le uniche in Sardegna,
vengono fatte risalire agli albori del cristiane-
simo.
Le origini della processione verso l’isola sul-
citana e il santuario del Martire, luoghi tanto
cari già agli Iudices callaritani Mariano II, detto
Torcotorio (1124), e Benedetta di Lacon Mas-
sa (1226), è probabilmente da ricondursi alle
vicende legate allo spostamento della sede di
residenza del vescovo, trasferitosi a Tratalias a
causa delle sempre più frequenti incursioni dei
musulmani e a seguito della costruzione della
chiesa di Santa Maria, ivi avvenuta nel 1213.
Papa Onorio III, nell’ottobre del 1218, stabilì
che la sede della cattedrale doveva rimanere
nell’isola sulcitana anche se il vescovo, come
attestato da una lettera del 1267, risiedeva sta-
bilmente a Tratalias. Il vescovo sulcitano in se-
guito si trasferì a Iglesias, anche se la data non
è certa; le fonti del 13581 e del 13602 già parlano
di “vigilia di S. Antioco” e “festa di S. Antioco”,
ma non chiariscono il luogo della residenza del
vescovo, che invece sembra essere Iglesias, città
principale, costruita lontana dalle coste e muni-
ta da robusta cinta muraria. Dopo le controver-
se e sanguinose vicende tra il Regno d’Arborea
e i catalano-aragonesi, con la vittoria di questi
ultimi, dal 1410 il vescovo era ormai stabile a
Iglesias, ma la formalizzazione di detta trasla-
zione da Sulci avvenne solo nel 1503.
Nelle descrizioni di tanti letterati della seconda
metà del ’500 e del ’600, sono riportate le me-
morabili feste e il gran concorso di gente pro-
veniente da tutte le parti della Sardegna, ma
anche da altre nazioni che partecipavano con
grande orgoglio, gioia e commozione ai riti e al
pellegrinaggio in onore del Patrono della Sar-
degna.
L’itinerario di questa processione e della annua-
le festa, che più volte all’anno portava da Igle-
sias il Vescovo, il Capitolo, i Governanti e tanta
gente, lo si è potuto ricostruire grazie alla me-
moria conservata nei documenti ufficiali, nella
toponomastica e soprattutto grazie alle fonti
religiose riguardanti essenzialmente località ci-
tate come luoghi di “miracoli”, rigorosamente
150
storia e archeologia sulcitana
riportati in alcuni manoscritti di fine ’500 e del
’600. Nelle carte geografiche compilate dal De
Candia-Lamarmora nel 1844, quando ancora si
svolgeva la processione, si può ritrovare l’itine-
rario principale che da Sant’Antioco, centro ur-
bano ripopolato ormai da quasi cento anni, con-
duceva a Iglesias. La strada denominata “della
reliquia”, che per centinaia di anni era stata per-
corsa dal corteo processionale, veniva utilizzata
anche prima dello stesso ritrovamento delle sa-
cre spoglie di Antioco, rinnovando così una tra-
dizione rimasta quasi immutata nei secoli. Le
località più piccole lambite dall`itinerario sono
poi presenti nelle descrizioni di quanti hanno
partecipato alla festa e alla processione, perché
durante questo tragitto avvennero numerosi
miracoli attribuiti a S. Antioco.
Preparatisi secondo un ordine stabilito, la ca-
valleria, il Capitolo, i prelati, il cocchio col
simulacro, i nobili, i cavalieri e i pellegrini si
avviavano dal Duomo verso la valle del Cixer-
ri, percorrendo la strada retrostante il palazzo
vescovile, quindi le attuali via Martini e via Azu-
ni, infine uscendo da Iglesias attraverso la porta
Maggiore o di San Sebastiano. Davanti la chiesa
di San Sebastiano fuori le mura, nella quale fu-
rono custodite e traslate le sacre reliquie prove-
nienti da Sulci, a seguito del loro rinvenimento
nel 1615, avveniva la prima delle soste previste
per le preghiere e le invocazioni al Santo, indi
si procedeva lungo l’attuale linea ferroviaria o,
meglio, nella strada che congiungeva Villa di
Chiesa con Cagliari.
Serra Perdosa. Lungo il declivio vi era, e vi è
tuttora, una località denominata Sa Serra Per-
dosa che viene citata nel miracolo riportato nel
“Quaderno, llista y nota...” del 1618, documento
manoscritto e inedito, vero elenco dei miracoli
di Sant’Antioco, pubblicato da P. Filippo Pili;
nel paragrafo delle “Grazie di guarigione impe-
trate con l’invocazione a Sant’Antioco, seguite
spesso da qualche promessa al Santo”3, al n.
64, si racconta il caso di una donna che invoca
il Santo al fine di avere la guarigione da una
paralisi, e promette di seguire la processione.
Sentendo che nel periodo della festa di agosto
la propria salute migliorava, decise di seguire il
simulacro col suo bastone e, ritenendo di stare
Duomo di S.Chiara - Iglesias
151
annali 2014
meglio, abbandonò il sostegno in località Ser-
ra Perdosa, adempiendo così al voto fatto pochi
mesi prima. Lungo la strada si incontrava l’an-
tica chiesa bizantina di San Salvatore nel sito
detto Su Pardu, ove nel 1615 si raccolsero molte
persone in attesa dell’arrivo delle sacre reliquie,
prima del loro trionfale ingresso in città.
Barega. Dal Prato di San Salvatore il percor-
so originario non seguiva l’attuale rettilineo,
che mira a sud perché in certi tratti era diver-
so dall’attuale strada che conduce all’abitato
di Barega. Raggiunta la pianura del Cixerri il
percorso faceva una prima deviazione a ovest,
risalendo verso la montagna di Genna Luas, nei
pressi della chiesa di Santa Barbara, detta de su
Scudetu4, per riscendere nuovamente ai bordi
della pianura. Questa deviazione consentiva di
ricopiare quello che pare il cammino più antico
che usciva direttamente dalla Porta Maggiore
per raggiungere la suddetta piana del Cixerri.
Barega, villa di antica memoria, era in quel pe-
riodo, composto da un boddeu principale e da
molti furriadorgius e lì avveniva la sosta per il
pranzo, proprio nel nucleo abitato più popolo-
so, nei pressi dell’antica chiesa di Santa Maria.
Nel citato Quaderno, al n. 53, nel paragrafo de-
dicato agli “Interventi del Santo per promesse
fatte e rimaste inadempiute”, viene riportato
un fatto avvenuto a Barega, luogo dove, duran-
te il percorso di andata, avveniva la sosta per
il pranzo, al ritorno, invece, si sostava la not-
te, prima di far rientro a Iglesias al mattino. In
quest’occasione la signora Margalida, moglie
di tal Pere Bernat, fu convinta da costui a non
passare la notte a Barega e continuare per Igle-
sias, ma lei, che aveva fatto il voto di andare alla
festa e tornare in città dietro il simulacro, ebbe
un infortunio e decise di rimanere per la notte.
Al mattino seguente, rimessasi in viaggio per
adempiere al voto, si sentì perfettamente guari-
ta e tornò a Iglesias a piedi con la folla5.
Piolanas. Consumato il pranzo, da Barega,
si riprendeva la strada che lambiva la pianu-
ra chiamata Planu Santu Perdu, ma all’altezza
del furriadorgiu Perda Piscua, si deviava repen-
tinamente a destra, verso ovest, per inoltrarsi
nel territorio di Piolanas, di proprietà del Ve-
scovo di Sulci fin dalla donazione di Benedetta
San Salvatore - Iglesias
152
storia e archeologia sulcitana
di Lacon6 (Genna Corriga è una località nomi-
nata nel documento). Questo vecchio sentiero,
oggi leggermente abbozzato, nel tratto iniziale
si confonde sia con la strada ferroviaria Car-
bonia-Villamassargia che con i vari campi col-
tivati. Tuttavia il letto del rio Arienna, che dai
raffronti con le immagini dal satellite7 sembra
abbastanza immutato, ci permette di ricostrui-
re, con moderata precisione, la strada principa-
le che proprio nella carta redatta dal generale
Carlo De Candia viene indicata come “Strada
di S. Antioco detta della Reliquia”8 nel “Salto di
Monsignore o di Piolana”. Il sentiero si lascia a
sud il Rio Arienna e la chiesa di Santa Barba-
ra di Piolanas, detta anche de Vias9, e prosegue
lungo il suddetto rio, attraversandolo due volte,
mentre la denominazione di questo muta in Rio
Pardu Majore. Dopo un tratto quasi rettilineo si
svolta alquanto a sud, per calarsi attraverso una
stretta valle tra due picchi di roccia, di cui il più
scosceso è detto Monte Pertunto. Il percorso si
discosta così dal fiume e discende dirigendosi
verso la fonte di Caput Acquas (de su Suergiu)10
nei pressi del bivio che può portare a Genna
Corriga o a Sa Seddargia, verso Barbusi. In que-
sti luoghi avvennero altri tre episodi miracolosi;
il primo, indicato col codice QLL 50, riguarda
un voto non mantenuto da una donna che pro-
metteva di andare e tornare a piedi alla festa
del Santo, se il marito, gravemente malato, con
“perdita di ragione e conoscenza”, si fosse ri-
preso pian piano dopo la formula della preghie-
ra. Nel 1608, i suddetti coniugi poterono andare
alla festa, ma per il ritorno presero posto su di
un carro e questo si ruppe e cadde a terra pro-
prio mentre passava il cocchio del simulacro,
e ciò avvenne nella località posta al bivio per
Acabudaquas e Ariena11.
Il secondo miracolo, citato col codice QLL 36,
avvenne nel luogo detto Sedda Arja (Seddargia)
e racconta dell’intervento da parte di un uomo,
comparso dal nulla, che salvò un certo Juan
Leu dall’essere strozzato dalle funi di un cavallo
imbizzarrito. I suoi tre compagni di viaggio, un
po’ distanti da lui, non riuscirono dapprima a
sentirlo chiamare aiuto. Raccontato l’accaduto,
concordarono che quest’uomo fosse S. Antioco
Il primo tratto di strada della processione.
153
annali 2014
e tutti poterono partecipare alla festa “con mol-
ta devozione e gratitudine”12.
Il terzo miracolo, citato al n. 8 del Proçess de
Miracles avviene proprio lungo la strada di ri-
torno dalla festa, presso la fonte di Cabudaquas,
quando una donna affetta da scrofolosi, che
aveva pregato il Santo per la guarigione, si lavò
la faccia e le parti affette da quella malattia, e
ne rimase del tutto guarita13.
Barbusi. Superato il Salto di Piolanas e le so-
praddette località attraversate dal rio Arienna
Dopo Barega la processione si dirigeva verso Barbusi lungo il confine nord del salto di Piolanas.
154
storia e archeologia sulcitana
e Pardu Majore, che ormai, ricevute acque da
altri monti, prende la denominazione di rio Flu-
mentepido, (soprattutto dopo la località Acqua
Callentis), si percorreva un tratto di strada in lo-
calità detta Su Strintu de S’Axina e si imboccava
la strada per raggiungere il piccolo abitato di
Barbusi, dove il corteo si radunava, intorno al
santo che veniva collocato sotto un olivo, anco-
ra oggi esistente, per trascorrervi la notte, in un
clima di grande festa, che vale la pena di ricor-
dare con le parole, documentaristiche quanto
pittoriche, dell’Angius14:
“...ed ivi si ferma sino all’aurora in mezzo
all’immensa moltitudine dei peregrini, che di-
stribuiti in innumerevoli compagnie occupano
talvolta un miglio quadrato, e danno i loro con-
viti e si ricreano cantando e ballando al suono
delle launeddas. E’ un bello spettacolo presso le
altrettante brigate; e qui un giovine che sostie-
ne sul fuoco in un ramo formato a spiedo o un
agnello o un capretto; là un altro che stende l’er-
ba per formare un tappeto su cui porre il pane,
il formaggio, le arancie, la ricotta, il salame,
il tagliere, e sopra il porchetto; in questa par-
te un’adorna fanciulla che sparge il formaggio
sfarinato su fumanti maccheroni che la madre
compone sopra un gran piatto; in quella dispo-
sti in arco, e assisi intorno al fuoco, fanciulli
e vecchi, uomini e donne ridenti e scherzanti
che consumano i cibi e fan gorgogliare le fra-
sche riempiendo di vino i corni incisi di rozze
figure dalla mano di un pastore, e maneggiano
i grandi coltelli per trinciare le umorose carni
e porgerle ai denti; in altro canto una famiglia
che riposa sotto la volta d’una gran macchia di
lentisco, e chi sdrajato sulle frondi, chi sul nudo
suolo, chi sopra i sacchi tenendo a guanciale la
sella; in altro sito un cantore che improvvisa
in mezzo ad una gran corona; in un piccol pia-
no erboso un gran numero di uomini e donne
che uniti in gran catena movonsi alla stridula
armonia delle canne e ballano il ballo naziona-
le; mentre dentro la chiesa e nel suo vestibolo
presso al simulacro del santo le persone obbli-
gate a voto genuflesse, a piè nudi e scarmiglia-
Il secolare ulivo di Barbusi.
155
annali 2014
te col cerco promesso nella sinistra e la corona
nella destra veglian pregando sino all’ora della
partenza. Suona finalmente la campana della
chiesa, e a’ suoi rintocchi concorresi da tutte le
parti; nasce un chiarore da mille e mille fiam-
melle, e da mille e mille voci un confuso mor-
morio, come è quello di lontane acque cadenti,
o di un lido quando il vento vi sospinge i flutti.
Ma presto languisce il rumore, e devoti racco-
glionsi tutti in se stessi all’adorazione così come
il sacerdote tra la musica de’ zampognatori im-
prende gli augusti ministerii. Questi compiti, e
proferite le parole della solenne benedizione,
si agita tutta l’adunanza, e la compressa folla
si slarga e dilata come l’ondulazione dell’acqua
percossa: la cavelleria di vanguardia comincia
ad avanzarsi nella oscura via, seguono i buoni
con le loro squille traendo il sacro carro e quin-
di il popolo, e dopo il popolo, la cavalleria di
retroguardia. Uno spettatore posto su qualche
eminenza, donde signoreggi il piano, per cui
procede quella moltitudine, godesi una bellissi-
L’antica chiesa di Barbusi ove si vegliava S.Antioco.
156
storia e archeologia sulcitana
ma scena, vedendo per circa due miglia brillar
innumerevoli cerei in un bel disordine, e alcune
fiamme unirsi, altre disgiungersi, altre nascon-
dersi, e poi comparire nuovamente. Vorrebbesi
più lunga la notte, e dispiace che il barlume del
cielo orientale avvivandosi ognor più faccia lan-
guir quegli splendori, e presto il sole nascente
gli spegna. In quell’ora un’altra comitiva move-
si da Iglesias verso l’Isola sulcitana, e trasporta
l’urna col cranio del Martire, allogata in una ap-
posita cassetta sopra la sella d’un cavallo bian-
co o grigio. I canonici uscendo dalla cattedrale
montano su’ loro cavalli, e seguon il reliquario
cantando l’inno de’ martiri: sussegue il sindaco
di seconda classe, adornate delle insegne conso-
lari, e accompagnato da uno squadrone di mili-
ziani capitanati da un tenente, che va presso al
sindaco come suo ajutante di campo.”
Sirai. La processione riprendeva la mattina se-
guente lungo la strada che portava a Coderra
e quindi a Sant’Antioco, discostandosi dal rio
Flumentepido e dirigendosi verso la località Si-
rai; la strada procedeva verso sud-ovest, lungo
una diagonale oggi non più esistente perché
tagliata in verticale all’altezza della zona indu-
striale di Carbonia dalla strada Iglesias-Porto
Botte, attuale SS. 126. Ancora nel 1844, la car-
ta geografica redatta dal De Candia riportava
le due strade che collegavano Barbusi e la valle
del Cixerri al mare, una si dirigeva in direzio-
ne ovest e, passando per Flumentepido, poco a
nord dell’attuale Monte Sirai, proseguiva verso
il mare diramandosi tra Bruncuteula e Porto-
scuso; la seconda faceva una diagonale da Bar-
busi sino al passo sul rio Gutturu Nieddu, at-
traversando la regione di Sirai, Nuraxeddu e Su
Planu de Coderra.
A Sirai avvenne un miracolo attestato poi nel
Quaderno e indicato col n. 11, raccolto tra quel-
li relativi alla “Liberazione da disgrazie immi-
nenti”: il reverendo Antiogo Cani e la sua com-
pagnia, mentre erano in viaggio per la festa di
S.Antioco, si imbatterono in un pescatore nel-
la località su Strintu de s’axina e ricevettero in
dono del pesce affinché venisse consumato as-
sieme ai suoi compagni. Essi avanzarono anco-
ra per un tratto di percorso sino al luogo detto
Sirai e lì si apprestarono ad accendere il fuoco
per il pranzo. Una scintilla andò a finire nella
fiasca di polvere da sparo del reverendo Cani e
questa scoppiò, volando via in tre parti e ustio-
nandogli il viso e la mano, ma provocando co-
munque un danno piccolissimo, nonostante vi
fossero esplose circa 8 once di polvere da sparo.
La bocca e il fondo di questa fiasca volarono via
con gran furia e potenza tanto che avrebbero
ucciso chiunque ne fosse stato raggiunto15.
Coderra. La regione Coderra, poco a sud del-
la intersezione tra la vecchia strada e la nuova
succitata, veniva interessata dal passaggio della
processione ma solo marginalmente, in quan-
to all’altezza dei vari nuclei abitati che com-
ponevano questa villa, la strada e il guado sul
rio Gutturu Nieddu presso sa Gruxi de Carira,
stavano scostati ad ovest. I vari medaus com-
ponenti questa località, ormai avevano la loro
157
annali 2014
denominazione derivante dai nomi delle fami-
glie che ripopolarono il Sulcis. Il nucleo che
mantenne il nome di Coderra era situato a sud
della piana dell’area industriale di Carbonia,
nei pressi dell’attuale Strada Statale 126, dove
oggi è sita una croce al bordo dell’incrocio di Is
Gannus, e la collina a est che ospita un nuraghe
sul quale è stata costruita una torre quadrata16,
una domus de janas e un piccolo agglomerato di
case denominato Medau Sa Turri.
In questi luoghi è narrato un intervento del
Santo perché alcuni carrettieri non diedero la
precedenza al cocchio che trasportava il simu-
lacro. Giovanni Gamboni e Antonio Pruna, par-
titi per la festa di S. Antioco, ma nel luogo detto
“Coterra”, sentendo la campanella che avvisava
l’arrivo del cocchio, vollero anticiparlo e arriva-
re prima nell’isola di Sulci, ma la fretta fece loro
sbagliare strada e imboccarono il sentiero per
Palmas; i citati Gamboni e Pruna si accorsero
dell’errore quando arrivarono nei pressi del rio
Sassu e dovettero tornare indietro, arrivando
nell’isola per ultimi invece che per primi17.
Is Urigus. La processione passava quindi lungo
l’antica via verso sud-ovest e giungeva al gua-
do sul rio Gutturu Nieddu ove, subito dopo, era
posto un segnale importante che distingueva la
strada maestra da quella secondaria, denomi-
nato Sa Gruxi de Carira. In questo luogo, la stra-
da proseguiva verso sud, biforcandosi nei pressi
delle case Gannau. Da qui, svoltando a sinistra
ci si dirigeva verso sud est, si percorreva “su
mori de sa Santa”, l’itinerario della Madonna
di Tratalias, attraversava il borgo di Funtanona
(da Funtana Ona, cioè, fonte con acqua buona)
da cui si poteva proseguire per il medau Is Pes,
Da Barbusi a Is Urigus attraverso Sirai, Coderra e Sa Gruxi de Carira, l’antica diagonale prima della S.S. n. 126.
158
storia e archeologia sulcitana
e le ville di Arenas e Tratalias; oppure dirigersi
a sud verso San Giovanni Suergiu e il medau
Rio Sassu. Il percorso processionale, invece, di-
ventato in breve tempo secondario, dopo la co-
struzione della strada Reale, passava rasente la
catena montuosa, le cui cime erano dette Mon-
serrato e Perda Asua de Pari, e attraversava i due
abitati chiamati Monserrato e Case Bruncu, oggi
meglio conosciuti come frazione di Is Urigus.
La strada che tutt’oggi attraversa questa borga-
ta ha la denominazione ufficiale di via S. Antio-
co, perché vi passava la processione con il San-
to e questa, dopo aver guadato il rio Monserra-
to, si incrociava con la strada che collegava San
Giovanni Suergiu con Matzaccara. Più a sud,
un ponte permetteva di attraversare il rio Santu
Milanu e la strada, dopo aver accompagnato il
fiume sulla riva destra, passava alla sponda sini-
stra, discostandosi dalla sua foce. Questo “pas-
so” era detto Bau Sa Gruxi, ma oggi non esiste
più in quanto i lavori di bonifica e di costruzione
dei nuovi argini sul rio Santu Milanu ne hanno
cancellato il ponte. Questo fu comunque luo-
go di un miracolo riportato negli “Interventi del
Santo a favore dei suoi devoti”, infatti avvenne
che un uomo, mandato a piedi a Iglesias, affin-
ché provvedesse all’occorrente per addobbare e
decorare la chiesa per la festa, al suo ritorno
non riuscisse più a guadare il torrente chiamato
riu de Santu Gimiliano, per quanti sforzi faces-
se. Poco dopo si presentò un uomo in groppa
a un “cavallo morello” e gli chiese cosa facesse
in quel posto, l’uomo spiegò che non riusciva a
passare perché il torrente si ingrossava a cau-
sa dell’incessante pioggia, ma che era atteso
a Sant’Antioco dai suoi amici. Lo sconosciuto
l’aiutò a passare, portandolo in sella al suo ca-
vallo, e l’accompagnò sino alla chiesa. Arriva-
rono quando era “già mezzanotte e pioveva a
dirotto, nessuno di quei dentro voleva aprirgli,
pensando che a quell’ora e con quel diluvio co-
lui che bussava non poteva essere l’uomo che
essi avevano inviato ad Iglesias...”. Ipotizzaro-
no che fosse qualcuno che sotto minaccia dei
turchi avesse fatto loro da guida per poter cat-
turare qualche schiavo, o che fosse quell’uomo
stesso, che preso schiavo dai turchi, fosse stato
obbligato a guidarli alla chiesa. Ma quelli den-
tro, rassicurati che egli era solo e che non vi era
Il ponte di Santa Caterina nel 1864 al momento del progetto della nuova strada tra Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu.
159
annali 2014
nulla da temere, gli aprirono e gli chiesero del
suo viaggio di ritorno ed egli espose le difficol-
tà avute e l’aiuto dello sconosciuto a cavallo, il
quale, fermatosi nel portico ad attendere l’aper-
tura della porta della chiesa, nel frattempo era
scomparso. Tutti si persuasero che quel cavalie-
re non fosse altro che S. Antioco18.
Il guado sul rio Santu Milanu rappresentava
uno degli ultimi pericoli lungo il tragitto dei
pellegrini; dopo di esso restava da percorrere
qualche miglio in pianura prima dei tre tratti di
strada marittima, interrotta da numerosi pon-
ti, che collegavano la terraferma sarda con gli
isolotti della peschiera e l’isola di Sant’Antioco.
Questi ponti venivano annualmente riassettati
per ordine del vescovo di Sulci e dell’arcivesco-
vo di Cagliari, perché potessero essere sicuri
durante il transito che le migliaia di pellegrini
facevano durante le quattro celebrazioni della
festa.
La strada dei miracoli lasciava sulla propria de-
stra il rio discostandosi sempre di più in quan-
to compiva, come oggi compie, una diagonale
in direzione sud-ovest, verso il ponte di Santa
Caterina. In antichità, questo tragitto, potreb-
be esser stato formato dall’antico letto del rio
Santu Millanu o dallo straripamento di esso;
già nell’80019, infatti, il rio Santu Milanu fu de-
viato verso ovest e la sua foce tenuta più lon-
tana dal ponte suddetto. Può essere suggestivo
immaginare che il ponte romano, con le sue
basse arcate che permettevano il flusso delle ac-
que all’interno dello stagno di Santa Caterina e
della peschiera, fosse stato costruito anche per
attraversare la foce del torrente, oltre che per
il ricambio dell’acqua e del pesce nella ricca pe-
schiera, in modo da creare un equilibrio tra le
acque che all’interno degli isolotti diventavano
troppo salate. In questi due chilometri e mezzo
che separano Bau Sa Gruxi dal primo ponte che
unisce la Sardegna a Sant’Antioco, il percorso
attraversa molti piccoli abitati, medaus e fur-
riadorgius denominati case is Pirroneddus, case
Ghisu, uno dei due medaus is Pizzus, Is Impe-
ras, i borghi Is Collus e Luxia Collu (un tempo
case Ghiso) e, infine, arriva alle casupole di San-
ta Caterina, nei pressi dell’ex centrale elettrica.
I ponti. Il ponte di Santa Caterina, a detta dei
viaggiatori dell’Ottocento studiosi di cose anti-
che, risaliva all’epoca romana e queste nobili
origini vengono citate nelle numerose delibera-
zioni del Consiglio Comunale di Sant’Antioco,
in occasione dei lavori di costruzione della nuo-
va strada che avrebbe collegato il paese con la
nazionale a San Giovanni Suergiu (1866-1868).
Nei pressi di questo antico manufatto, accadde-
ro diversi episodi miracolosi. Uno, citato negli
“Interventi liberatori del santo dalla schiavitù
degli infedeli”, riportato nel QLL col n. 30, ri-
guarda il viaggio fatto da Cagliari nel 1614 da
una donna che voleva chiedere al glorioso San-
to la liberazione del marito, che si trovava in
schiavitù dei Mori da ben 16 anni. Giunta col
suo accompagnatore al ponte di Santa Caterina,
la donna incontrò il marito che finalmente ave-
va ottenuto la libertà ed entrambi si recarono
160
storia e archeologia sulcitana
alla chiesa di S.Antioco per completare la loro
devozione20. Un altro miracolo riportato tra gli
“Interventi del Santo a motivo del mancato ri-
spetto e venerazione...” accadde nell’aprile del
1586 circa, quando il cocchio che portava il sa-
cro simulacro, “passato lo stagno di S. Caterina,
incontrò un altro carro tirato da buoi il cui car-
rettiere non volle scostarsi a un lato dell’unica
strada carrabile per dare la precedenza al Santo
come di solito si usava fare”. Il carrettiere poco
rispettoso, senza accorgersene, andò dritto ver-
so lo stagno, impantanando le ruote, e non vi fu
verso di tirarlo fuori, nonostante l’aiuto di altri
gioghi di buoi. Si decise così di dare strada al
cocchio del Santo per riprendere successiva-
mente i tentativi di tirare fuori il carrettiere, ma
non appena fu passato il simulacro, non vi fu
bisogno di aiuto e il carro uscì dal pantano.21
Valicato il primo ponte, la strada passava co-
modamente sull’isolotto più grande chiamato
Nel 1844 il Comune di Villamassargia lambiva le coste da Bruncu de Teula al Monte di Sarri di Masainas secondo il vecchio possesso del Marchese di Palmas. Nel 1853 nacquero sette nuovi Comuni del Sulcis di cui quattro si scorporarono da Villamassargia.
161
annali 2014
Perda Managus dove, vicino alla sponda dello
stagno di Santa Caterina, vi sono i due menhir
detti Su Para e Sa Mongia di epoca così arcaica
che la loro funzione non veniva riconosciuta se
non in chiave religiosa come pietrificazione di
due peccatori.
Nel 1582, durante la peste di Alghero, il vice-
ré de Moncada vietò di andare alla festa di S.
Antioco per impedire la diffusione del morbo e
per scongiurare che molti fossero fatti schiavi,
data la presenza di vascelli turchi nelle acque
della Isla del Sols. Tuttavia molti iglesienti si
vollero recare comunque alla chiesa di S. An-
tioco e, giunti nel luogo denominato Perda Ma-
nagus videro che “dall’isola di S. Antioco usciva
un uomo a cavallo, vestito alla maniera in cui si
vede nelle pitture raffigurato S. Antioco...” ma
andati incontro a quel cavaliere che ritennero
essere il Santo, non lo trovarono più. Chiesero
notizie ad alcuni carrettieri, ma tutti negarono
di aver visto uomo alcuno, poi si misero a cer-
care le tracce del passaggio del cavallo: capiro-
no così che quell`uomo era davvero S. Antioco
e che la sua apparizione era avvenuta per rassi-
curarli del fatto che l’isola era libera e che pote-
vano compiere il loro pellegrinaggio nel tempio
del Santo nel giorno della festa che per quell’an-
no si celebrò nella cattedrale di Iglesias.
All’estremo lembo dell’isola Perda Managus, co-
minciava una lunga strada marittima interrotta
da alcune arcate, conosciuta come Su Ponti de
Mesu. Questa, in direzione sud, si raccordava
perpendicolarmente con un’altra lingua di terra
tuttora chiamata Corru Longu che si sviluppa
in direzione ovest-est dall’ultimo e più grande
ponte (Ponti Mannu) verso le antiche saline nei
pressi di Palmas. La strada rasenta l’isolotto di
Curzanas, già menzionato nella donazione del-
la Giudicessa Benedetta nel 1216, attraverso il
quale era possibile passare nello stagno di S.
Caterina e raggiungere Tratalias con una scor-
ciatoia. Qui sarebbe avvenuto un altro miraco-
lo, descritto nel QLL col n. 72 tra gli interven-
ti del Santo a favore dei suoi devoti: un fede-
le del Campidano, che non mancava mai alla
festa di S. Antioco, sulla via del ritorno aveva
perso le sue bisacce senza che se ne accorgesse
e, raggiunto il luogo detto Curtjanas22, si sentì
richiamare da un uomo su un cavallo bianco.
Egli pensò che fosse S.Antioco e, toltosi il cap-
pello in segno di rispetto, udì che il cavaliere
gli faceva notare la perdita delle bisacce e che
se fosse tornato indietro le avrebbe senz’altro
ritrovate. “E subito il Santo a cavallo scompar-
ve”23. Ora, giunti al tratto finale degli isolotti,
si entrava nell’isola di Sulci attraverso il terzo
ponte, conosciuto come Ponti Mannu perché il
più grande in quanto sotto le due arcate, sebbe-
ne non altissime, potevano transitare le barche
dal Golfo alla baia di Sant’Antioco e viceversa.
Nel 1607 il reverendo Nicola Curques di Igle-
sias prese parte ai festeggiamenti di S. Antio-
co e, volendosi recare al santuario, nonostante
una grave malattia che gli portava febbri e la
scabbia, tanto da non poter riposare la notte,
chiese che i genitori lo accompagnassero e so-
stenessero nel viaggio per poter chiedere diret-
tamente nel tempio del Santo la grazia per la
162
storia e archeologia sulcitana
guarigione. Giunti nel ponte detto Pontimannu,
venne aiutato a scendere e pregò il Santo per-
ché non finisse lì i suoi giorni e potesse avere la
guarigione che desiderava. Raggiunta la chiesa,
volle pregare davanti la porta maggiore affin-
ché S.Antioco gli concedesse la salute e subito
si sentì meglio tanto da essere condotto nel suo
alloggio e riuscire a riposare bene dopo le fati-
che del viaggio. Compiute poi tutte le devozioni
della festa, poté ripartire per Iglesias in perfetto
stato di salute. Questo miracolo riportato nel
QLL col n. 2324, rimanda al successivo (QLL 24),
dove lo stesso chierico, nel 1611, venne guarito
dopo otto mesi di febbri quartane, a seguito di
un suo pellegrinaggio nell’isola, dove rivolse le
sue preghiere al Santo.
L’arrivo all’isola. Il viaggio giungeva al termine
con l’ingresso nell’isola di Sulci, di proprietà del
Vescovo sin dal 1124 grazie alla donazione del
Giudice di Cagliari Torchitorio Mariano II, fat-
ta probabilmente al termine della contesa tra i
monaci Vittorini, i Cassinesi e il vescovo di Sul-
ci, titolare della cattedra e signore delle terre,
degli isolotti e di porzioni di territorio nella re-
gione del Sulcis e del Sigerro. La strada costeg-
giava la fortezza bizantina e giudicale posta a
difesa dell’ingresso di quell’antico e fastoso abi-
tato che andò man mano riducendosi sino a di-
venire spopolato a causa delle prime incursioni
dei turchi che compivano azioni di pirateria e
saccheggio, spingendosi fin nell’entroterra sar-
do. Molte incursioni avvennero anche durante
la festa, infatti, nonostante l’isola fosse illumi-
nata a giorno dalle numerose fiaccole e fuochi,
spesso capitò di essere invasa dai turchi e altret-
tanto spesso vennero ricacciati perché numero-
si erano anche i miliziani e le persone armate
che la difendevano.
Poco distante dall’ultimo tratto che conduce-
va al sepolcro di Antioco, vi è una biforcazione
ben visibile ai viaggiatori in uscita dall’abitato:
la strada di sinistra consente di lasciare l’isola,
mentre quella di destra consente di inoltrarsi
nel sud dell’isola di Sant’Antioco attraverso le
Sa Gruxi de is reliquias.
163
annali 2014
regioni di Is Pruinis e Canai. Forse fu questo
l’incrocio dove, nel 1628, venne posta una gros-
sa croce di pietra ove venne fatta la conta dei
tantissimi concorrenti alla festa, alla quale par-
tecipò anche il Viceré Don Geronimo Pimentel
Marchese de Vayona. Probabilmente si tratta
della croce, ora in ferro, dove, a seguito del ri-
popolamento del villaggio di Sant’Antioco, ve-
nivano consegnate le reliquie alla nuova comu-
nità per detenerle in chiesa durante il periodo
della festa. In questo luogo, poi denominato Sa
Gruxi de is Reliquias, le stesse venivano restitu-
ite agli iglesienti e al Capitolo per il ritorno alla
cattedrale. Di lì a pochi metri la fontana roma-
na Is Solus annuncia l’antica civiltà che per cen-
tinaia d’anni ha governato e tenuto le sorti del-
la Sardegna, altre vestigia lungo la costa dove
presto si sarebbe espanso il nuovo abitato di
Sant’Antioco e sulla collina della chiesa le case,
le capanne e le “grotte” che, per altri 500 anni,
hanno ospitato migliaia e migliaia di pellegrini
che invocavano e si radunavano attorno al San-
to Patrono della Sardegna, per ottenere quel
conforto che diede quando fu esiliato nell’iso-
la e predicò la fede cristiana. Nel Quaderno, al
n. 9, è descritto un incontro-miracolo avvenuto
nei pressi della fontana romana de Is Solus; qui
il Capitano delle milizie ebbe notizia che erano
stati avvistati 60 vascelli turchi e diede ordine di
evacuare l’isola nonostante fossero appena arri-
vati i pellegrini per la festa di aprile. Il cocchio
col simulacro fece tappa a Is Solus, luogo ove
si radunarono tutti ma, essendo stato deciso di
riprendere il cammino tutti insieme, i buoi si ri-
fiutarono di proseguire e non vi fu alcun modo
per smuoverli. All’improvviso, uno sconosciuto
si presentò e, in modo persuasivo, disse di tor-
nare indietro alla chiesa e di non avere paura,
perché i turchi se n’erano andati via. Tutti quan-
ti rimasero tranquillizzati dalle parole di quello
sconosciuto che subito dopo scomparve e così,
raggiunta la chiesa del Santo, poterono celebra-
re la festa25.
La chiesa. L’antica sede dei vescovi di Sulci,
cattedrale tra le più antiche dell’intera Cristia-
nità, ridotta per secoli a santuario di campagna,
è la tappa finale del viaggio fin qui descritto; i
suoi dintorni sono lo scenario della fede cri-
stiana e nello specifico, della fede in S. Antioco,
protettore di tutti coloro che si invocavano per
una grazia o per una guarigione, per la vendita
di vari prodotti alla ricca fiera o per scambiare
bestiame, per ballare, per il compimento di un
voto e ristorarsi dalle fatiche della vita. Padre
Serafino Esquirro, nella sua cronaca pubblicata
nel 1624, racconta che “Una delle cose più in-
signi, e degne di memoria, non solo nel regno
di Sardegna ma della maggior parte della cri-
stianità, è la festa che ogni anno si usa realiz-
zare quindici giorni dopo la santa pasqua della
resurrezione di Cristo Nostro Signore nell’isola
sulcitana, nella chiesa del beato martire S. An-
tioco...” Poi continua con la descrizione della
festa narrando che “...di sabato si giungeva a
Sulcis e, tra festose scariche a salve di fucileria,
entrarono nella chiesa con un tale fervore che
pareva di essere in mezzo a un ‘giudizio univer-
164
storia e archeologia sulcitana
sal’, tanta era l’affluenza di gente. Lo zelo e la
devozione dell’immensa folla era tale che mol-
tissimi seguivano le sante reliquie andando gi-
nocchioni per la strada accidentata e invocando
il Santo. Alla festa, intervennero moltissimi ari-
stocratici e un numero esorbitante di cavalieri
della nobiltà cagliaritana, abbigliati di stupendi
e ricchissimi costumi. Il lunedì, dopo i vespri,
tra salve di fucileria, ‘mucha musica, muchos
atambores, muchas trompetas’, si formò una
grandiosa processione che, partita dal piazzale
antistante la chiesa, trasportava su
una portantina la statua del Santo,
su un’altra che seguiva erano, inve-
ce, la cassa con il corpo e l’urna con
la testa. La folla era così inconteni-
bile che chi non aveva trovato posto
nella piazza gremiva il tetto della
chiesa; mentre lungo il tragitto del
corteo erano disseminati numerosi
archibugieri che, al passaggio della
statua del Santo, sparavano a salve,
secondo un ordine prestabilito. La
processione si concluse tra la musi-
ca delle trombe e dei tamburi. E con
essa si concluse anche la festa, la più
grande e magnifica di tutti i tempi,
per il numero dei partecipanti e per
l’abbondanza di merci e di alimenti,
messi a disposizione e offerti all’ac-
quisto, nelle rivendite..”26. Il concor-
so della gente fu enorme, e sempre
secondo l’Esquirro, le persone che
presero parte alla festa di Sant’An-
tioco furono in quell’occasione ben 32000.
Alla fine del ’700 il reverendo Pintus, che aveva
piantato una vasta vigna nel piano della chiesa,
la fece estirpare perché la moltitudine di pelle-
grini, carri, buoi e cavalli trovassero posto per
la sosta durante i giorni della festa. Evidente-
mente le grotte e le case dei dintorni, oramai
abitati stabilmente, non potevano più conte-
nere i partecipanti alla festa di S. Antioco.
Anche la chiesa e i suoi dintorni furono scena-
1754 – La chiesa di S.Antioco e i suoi dintorni.
165
annali 2014
rio di numerosi miracoli riportati nel capitolo
delle Grazie di guarigione impetrate da S. An-
tioco nei paragrafi relativi alle “Guarigioni ot-
tenute con la reliquia del Santo” e alle “Guari-
gioni ottenute al sepolcro di S. Antioco o con la
terra del suo sepolcro” e nel capitolo dedicato
agli “Interventi liberatori del santo dalla schia-
vitù degli infedeli”. Spesso accadeva che i fedeli
dormissero in chiesa, dove si sentivano più si-
curi, soprattutto quando rimanevano in pochi o
qualche sacerdote volesse fare delle messe fuori
dalle feste comandate in onore del Santo, ma-
gari trovandosi nei paraggi del tempio. Tra que-
sto genere di interventi del Santo vi erano avvisi
notturni provenienti da voci o uomini che bus-
savano alla porta della chiesa e scomparivano
subito dopo aver avvisato che l’isola si stava ri-
empiendo di turchi sbarcati all’improvviso. Tra
questi episodi vi è quello riportato nel Proçess
de miracles al n. 5 e riguarda la profanazione
della chiesa da parte di numerosi turchi, uno
dei quali, salito sul tetto più alto del sacro tem-
pio si mise a lanciare pietre per demolire i tetti
sottostanti ma, presa una grossa pietra, scivolò
e cadde al suolo morendo all’istante. Il Rais, sa-
puta questa disgrazia e immaginando che que-
sta fosse la giusta punizione di S. Antioco, volle
compiere un atto riparatore facendo pervenire
dentro la chiesa un grande recipiente pieno d’o-
lio per la lampada del Santo27. Un altro episodio,
citato sempre nel Proçess de miracles al n. 13,
avvenne attorno al 1525 e vide coinvolto il no-
bile Ludovico Bellit y Aragall, signore delle ba-
ronie di Gioiosa Guardia, Villamassargia e Ac-
quafredda. Il feudatario, evidentemente devoto
a S. Antioco, si recò nell’isola il martedì dopo
la grande festa, accompagnato dal suo stendar-
do e da un gruppo di trenta militi, a protezione
della sua persona; in contrasto con la Capitania
di Iglesias per motivi di giurisdizione territoria-
le, perché egli vantava diritti sul feudo sino al
ponte di Santa Caterina, preferì non sfilare con
lo stendardo della città di Iglesias e seguire la
messa solamente coi suoi uomini, quando l’iso-
la si svuotava dei pellegrini. Mentre il gruppo
seguiva la celebrazione, sull’isola sbarcarono
circa 400 turchi, allora il nobile, avvisato da un
cristiano, decise di rimanere in chiesa per tutta
la funzione, mantenendo la calma tra i suoi uo-
mini, ordinando di seguire la messa e avere fede
in Dio e in S. Antioco. Quando i turchi si affac-
ciarono alla porta della chiesa, che era rimasta
aperta, rimasero sbigottiti e andarono via nuo-
vamente verso la spiaggia. Terminata la messa,
Ludovico e i suoi uomini ripresero il cammino
di ritorno e, all’altezza del ponte, un turco chie-
se a un milite chi fosse il signore che era con
loro e in quanti fossero in chiesa; egli rispose
che si trattava del loro signore e barone e che in
chiesa erano circa in trenta. Il turco disse che
non era vero, perché la chiesa era parsa gremita
tanto da sembrare che ci fossero circa un mi-
gliaio di persone, per questo i suoi compagni
erano scappati e non avevano osato attaccare
così tanti uomini28.
E, come ogni anno, tutti poterono riprendere la
via del ritorno.
166
storia e archeologia sulcitana
Ma, come tutte, anche questa storia, così datata
e così ricca di episodi, termina; finisce nel 1853,
quando gli abitanti della penisola tentarono
d’impedire il ritorno a Iglesias della statua del
loro Santo con le sue reliquie, riuscendo, dopo
una sommossa che comportò per essi la fama
di turbolenti furasantusu, a trattenere le sole
reliquie, mentre il simulacro del Santo si allon-
tanava in rapida fuga allo schiocco della frusta
del conducente del cocchio29.
La processione, nel corso dei secoli, aveva cer-
tamente cambiato, non solo nella forma, ma
anche per l’itinerario; è verosimile, per esem-
pio, che negli ultimi decenni il percorso preve-
desse il passaggio da Coderra all’attuale Is Gan-
naus, attraverso Su Rei, quindi per arrivare a Is
Urigus non più da nord attraverso la strada di
Sa Cruxi de Carira. Nel 1849, infatti, il Comune
di Villamassargia, titolare della giurisdizione
di Coderra, decise di istituire il posto di gabel-
lotto per la rivendita di generi di monopolio e
concederla al signor Emmanuele Patteri che
possedeva la casa vicina al cammino “Reale”,
nel salto di Coderra30, nei pressi della borgata
detta de Is Patteris, ancora oggi esistente. Dopo
la costruzione della Strada Reale n. 1 o “Carlo
Felice”, il Governo sabaudo, infatti, realizzò il
progetto della strada n. 2 che da Cagliari con-
duceva a Iglesias e terminava a Porto Botte. È,
come si è detto, possibile ipotizzare quindi che,
solo per pochissimi anni, due o tre, parte della
processione avvenisse sulla attuale statale 126,
secondo un itinerario oggi ancora esistente, che
è lo stesso della Madonna di Montserrat, che
raggiungeva Tratalias, discostandosi dal percor-
so di Sant’Antioco all’altezza di Gruxi de Carira.
Perché in quell’anno insorsero gli antiochen-
si? Si può ipotizzare che dopo circa un secolo
dall’inizio della ricostruzione di una comunità
si sentissero sufficientemente maturi da potersi
liberare dalla tutela che Iglesias esercitava, ai
loro occhi, anche nel riportarsi via il simulacro
e soprattutto le reliquie del Santo, una volta fi-
nita la festa.
Avevano ragione a voler trattenere la statua e
le reliquie? A questa seconda domanda si può
rispondere con le osservazioni di Alberto La-
marmora. Il massimo studioso della Sardegna
di allora, il quale, proprio in quell’anno, il 1853,
era, oltretutto, luogotenente generale del Re-
gno, pensava che nella forma, per aver turbato
l’ordine pubblico, gli antiochensi avessero tor-
to, con il Sindaco Luigi Campus che dalla sua
abitazione, nello slargo del Monte Granatico,
cercava di calmare la folla31. Ma, nella sostanza,
avevano ragione: infatti dopo la presa di Tunisi
e di Algeri da parte dei francesi non si sarebbe-
ro più avute incursioni musulmane e, dunque, il
simulacro di S. Antioco non avrebbe avuto più
bisogno delle mura di Iglesias e così, nel breve
volgere di un pomeriggio di primavera, cessò di
esistere la manifestazione popolare più antica,
più partecipata e forse più bella che fino ad al-
lora era esistita in Sardegna.
170
storia e archeologia sulcitana
NOTE
1 Sandro Petrucci, Cagliari nel Trecento. Politica, istitu-
zioni, economia e società. Dalla conquista aragonese
alla guerra tra Arborea ed Aragona (1323-1365) – Tesi
di Dottorato in ‘Antropologia, Storia medievale, Filolo-
gia e Letterature del Mediterraneo Occidentale in rela-
zione alla Sardegna’ (XX ciclo), Università degli Studi
di Sassari anno accademico 2005-2006, p. 1298, nota
4481. Cfr. in questo numero, M. Massa, Di Antiche Sa-
gre (e Chiese, Santi, Vescovi e atti di fede).
2 Maria Mercé Costa, Oficials de la Corona d’Aragó a Sar-
denya (segle XIV), p. 323 e seguenti, saggio contenuto
in Archivio Storico Sardo, vol. XXIX – Padova 1964.
3 Filippo Pili, Le Meraviglie di S.Antioco, p. 82- Ed. San-
tuario S.Antioco, Cagliari 1984.
4 Sergio Bullegas, La scena e il paesaggio, p. 167 – Edi-
zioni dell’Orso, Torino 1997.
5 Filippo Pili, op. cit., pp. 131-132.
6 Ibidem, p. 154.
7 Software: Google Earth.
8 Archivio di Stato di Cagliari, poi A.S.C., Fondo: Reale
Corpo di Stato Maggiore – Serie: Mappe, Unità: Igle-
sias – Tavoletta 19.
9 Sergio Bullegas, op. cit., p. 167.
10 Filippo Pili, op. cit., p. 80.
11 Filippo Pili, op. cit., p. 132.
12 Filippo Pili, op. cit., pp. 158-159.
13 Filippo Pili, op. cit., pp. 79-80.
14 Vittorio Angius, in G. Casalis, Dizionario geografico,
storico, statistico, commerciale degli stati di S. M. il Re
di Sardegna – Vol. VIII, pp. 437-439. – editore G. Maspe-
ro librajo, Torino 1841.
15 Filippo Pili, op. cit., pp. 97-98.
16 Foiso Fois, Castelli della Sardegna medioevale, p. 100 –
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 1992.
17 Filippo Pili, op. cit., pp. 139-140.
18 Filippo Pili, op. cit., pp. 156-157.
19 Carta di R. Marcello indicante il vecchio alveo del
fiume.
20 Filippo Pili, op. cit., pp. 156-157.
21 Filippo Pili, op. cit., pp. 137-138.
22 P. Pili indica Cortoghiana, ma preferiamo ritenere
che fosse Cortinas, Curzacas, Cruccianas o Curzanas
come nei diversi documenti viene riportato il nome di
quest’isolotto (N.d.R.).
23 Filippo Pili, op. cit., pp. 150-151.
24 Filippo Pili, op. cit., pp. 73-74.
25 Filippo Pili, op. cit., pp. 111-112.
26 Serfin Equirro, Santuario de Caller y verdadera histo-
ria de la invencion de los cuerpos santos..., pp. 482;
485-487 – Cagliari, 1624.
27 Filippo Pili, op. cit., p. 117.
28 Filippo Pili, op. cit., pp. 114-115.
29 Luigi Cinesu, a cura di, Fura Santus! - Controversia
sul ritorno delle reliquie di S.Antioco nella penisola Sul-
citana, p. 31 – Edizioni “Santuario S.Antioco”, Iglesias
1987.
30 Archivio Comunale Villamassargia, Serie Amministra-
zione, Fondo Comunità – Reg. 1/5, Risoluzione del 14
Maggio 1849.
31 Da tradizione orale della famiglia Campus-Manno-
Romby-Spignesi di Sant’Antioco.