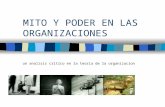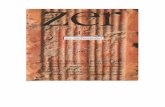Analisi modale, polifonia e teoria musicale tardo-medievale: un approccio storico-critico
Transcript of Analisi modale, polifonia e teoria musicale tardo-medievale: un approccio storico-critico
ANALISI MODALE, POLIFONIA E TEORIA MUSICALE TARDO-MEDIEVALE: UN APPROCCIO STORICO-CRITICO
Nello scritto seguente si farà uso di una terminologia presa a
prestito dalla teoria medievale dei modi così come appare nella
maggior parte dei trattati teorici a partire almeno dall’XI
secolo in poi, teoria che, in realtà, resterà valida, almeno
per alcuni repertorî, fino a buona parte della prima età
barocca. La base sonoro-concettuale su cui si muoveva il musico
medievale si basava su un sistema scalare che contemplava come
unica alterazione o, sarebbe meglio dire, oscillazione
semitonale, il B/B1in due ottave. Il sistema venne
originariamente formulato in un’estensione di due ottave dallo
Pseudo Oddone (fl. 1006-29) nel Dialogus de musica mentre nel
Micrologus (dopo 1026) il monaco Guido d’Arezzo (ca. 991/2 -
dopo 1033) lo estese di un ulteriore tetracordo superiore
(superacutæ) e del Γ grave.2 Nell’Epistola ad Michaelem (conosciuta1 Per evitare confusioni con le sillabe esacordali si preferisce quiindicare le altezze con le lettere dell’alfabeto, secondo la nomenclaturamedievale e seguendo la tavola 1 di cui sotto, differenziandoeventualmente con il corsivo quei casi in cui s’intendano le altezze insenso assoluto e non riferite ad una data posizione all’interno dellagamma.
2 Per un’edizione moderna del Micrologus v. Joseph SMITS VAN WAESBERGHE, inCorpus Scriptorum de Musica, IV, Roma: American Institute of Musicology (1955)e ora anche in Angelo RUSCONI, (cur., trad. e comm.), Guido d’Arezzo, le opere,Firenze: Edizioni del Galluzzo (2005); in maniera più condensata notiziebiografico-teoriche, oltre ad una bibliografia complessiva e aggiornata,su Guido sono rinvenibili altresì nella relativa voce curata da CesarinoRUINI nel Dizionario Biografico degli Italiani, LXI, Roma: Istituto dell’EnciclopediaItaliana (2003), pp. 381-388. Per il trattato di Oddone, che RUSCONI,basandosi sulle numerose e patenti similarità con il Micrologus, non escludepossa trattarsi di un’opera giovanile dello stesso Guido prima del suoesilio aretino dall’abbazia di Pomposa, v. invece Scriptores ecclesiastici de musicasacra potissimum, 3 vols., ed. Martin GERBERT (St. Blasien: Typis San-Blasianis, 1784; reprint ed., Hildesheim: Olms, 1963), 1:265-284 e MichelHUGLO, “Der Prolog des Odo zugeschriebenen ‘Dialogus de Musica’,” in Archivfür Musikwissenschaft 28 (1971): 138-139. Un’edizione critica moderna del
1
anche sotto il nome di Epistola de ignoto cantu) Guido menziona
l’inno giovanneo Ut queant laxis come caratterizzato dal fatto che
ciascuna delle sue frasi inizia su un grado più acuto di quella
precedente.3 Le sillabe corrispondenti (Ut, Re, Mi, Fa, Sol,
La) individuano la successione scalare C, D, E, F, G, a; ora
poiché da codesta scala è assente il b, e di conseguenza il
semitono b-c, fonti già molto vicine cronologicamente a Guido,
come il cassinese 318,4 utilizzano le predette sillabe in guisa
di sottosistema mobile ove Mi-Fa indica sempre il semitono,
anche nel caso in cui esso sia collocato su a-b. Questo
impiego sistematico e trasponibile delle sillabe venne in
seguito denominato ‘solmisazione’ mentre le sillabe stesse, e
la loro relativa successione di due toni interi, un semitono e
ancora due toni interi (T – T – S – T – T) ‘esacordo’. Dunque,
il perno concettuale dell’esacordo era il semitono Mi-Fa che, a
seconda che fosse localizzato su E-F, B-C o A-B, permetteva di
parlare, rispettivamente, di esacordo naturale, duro (perché
conteneva il b durum, quadratum o b) o molle (per la presenza del
b molle, rotundum o b):
Tavola 1
Suoni Duro Natura
le
Moll
e
Duro Natura
le
Moll
e
Duro Denom.
Dialogus è in preparazione a cura di Karl-Werner GÜMPEL.3 La melodia dell’inno, come dimostrato da Jacques CHAILLEY, in ‘Ut queantlaxis et les origines de la gamme’, in Acta musicologica 56/1 (1984), pp. 48-69, venne probabilmente composta o rielaborata dallo stesso Guido, mentreil testo (Ut queant laxis) è da una vecchia tradizione ascritto a PaoloDiacono.
4 Cfr. A. RUSCONI, ‘Il cod. 318 di Montecassino: note sulla struttura e sulcontenuto’, in Michael BERNHARD (cur.), Quellen und Studien zur Musiktheorie desMittelalters III, München: Bayerische Akademie der Wissenschaften (2001):Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, Band 15, pp. 121144.
2
ee
(Mi4)
La eela
dd
(Re4)
La Sol ddlasol
cc
(Do4)
Sol Fa ccsolfa
bb
(Si3)
Mi bbmi
bb
(Si3)
Fa bbfa
aa
(La3)
La Mi Re aalamir
eG
(Sol3)
Sol Re Ut gsolreu
tF (Fa3) Fa Ut ffautE (Mi3) La Mi elamiD (Re3) La Sol Re dlasolr
eC (Do3) Sol Fa Ut csolfau
tb (Si2) Mi bmib
(Si2)
Fa bfa
a (La2) La Mi Re AlamireG
(Sol2)
Sol Re Ut Gsolreu
tF (Fa2) Fa Ut FfautE (Mi2) La Mi ElamiD (Re2) Sol Re Dsolre
3
C (Do2) Fa Ut CfautB (Si1) Mi miA (La1) Re AreΓ
(Sol1)5
Ut Γut
Il sistema venne dal XII secolo spesso rappresentato sul palmo
di una mano, erroneamente attribuita a Guido, ma pure essa
attestata già dal citato cod. 318 di Montecassino6:
Esempio 1
I cosiddetti otto modi autentici e plagali (sussumibili in
quattro maneriæ, una per ogni coppia autentico plagale) erano
ottave ricavate sul sistema scalare anzidetto e, soprattutto a
5 Per maggiore comodità viene fornita, accanto alla nomenclatura medievale,anche quella oggi usata nei paesi di lingua romanza, con l’indicazionedell’ottava di riferimento data in pedice.
6 Cfr. n. 4.4
partire da Bernone di Reichenau (vedi sotto), vennero
sistematizzati come ‘specie’ di quarta e quinta (tetra- e
pentacordi), dove l’identificazione della specie era data dalla
posizione del semitono (sillaba Mi-Fa) al suo interno. La
tavola seguente illustra appunto gli otto modi con le specie
appropriate, la finale (lettera in grassetto), la confinale o
dominante modale (nota perno di ciascun modo: lettera in
grassetto e corsivo), indicando altresì i corrispondenti
segmenti esacordali con le rispettive ‘mutazioni’ o cambiamenti
di sillaba. (La tavola distingue ulteriormente fra esacordo
naturale, duro o molle grazie ad una scrittura in caratteri
rispettivamente normali, sottolineati e corsivi).
Tavola 2:
Protus autentico (Dorico7)
Protus plagale (Ipodorico)
T – S – T – T (5a I specie) + T(S) – S(T) – T (4a I o II specie)D-E E-F F-G G-a a-b(b) (b)/b-c c-dSol-La
Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol Sol-La La
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-Mi
Mi-Fa Fa-Sol
Ut-Re
T – S – T (4a I specie) + T – S – T – T (5a
I specie)A-BB-CC-D D-E E-F F-G G-aRe-Mi Mi-Fa Fa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol
7 I nomi greci vengono qui indicati per praticità e in considerazione delfatto che questa designazione risulta per molti lettori più familiare;tuttavia si rammenta che essa è essenzialmente scorretta (gli otto modimedievali non corrispondendo affatto ai modi greci, anche perché questiultimi non erano entità scalari, bensì modelli schematici di comportamentomelodico-intervallare) e che pertanto non verrà più usata nel corso delleseguenti pagine, preferendole la designazione più neutra secondo lemaneriæ.
5
Sol-La
Ut-Re Re-Mi
Ut-Re
Deuterus autentico (Frigio)
Deuterus plagale (Ipofrigio)
S – T – T – T (5a II specie) + S – T – T(4a II specie)E-F F-G G-a a-b b-c c-d d-eLa
Mi-Fa Fa-Sol Sol-La La
Ut-Re Re-Mi Mi
Re-Mi Mi-Fa
Fa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-Mi
S – T – T (4a II specie) + S – T – T – T (5a II specie)B-C C-D D-E E-F F-G G-a a-bMi-Fa Fa-Sol Sol-La La
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol Sol-La La
Ut-
Re Re-Mi Mi
Re-Mi
Tritus autentico (Lidio)
Tritus plagale (Ipolidio)
T – T – T(S) – S(T) (5a III o IV specie) +T – T – S (4a III specie)F-G G-a a-b/b b/b-c c-d d-e e-fFa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa
Fa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa
T – T – S (4a III specie) + T – T – T(S) – S(T) (5a III o IV specie)C-D D-E E-F F-G G-a a-b/b b/b-cFa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-
Mi Mi-Fa Fa-Sol
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa
Tetrardus autentico(Misolidio)
T – T – S – T (5a IV specie) + T – S – T (4a I specie)G-a a-b b-c c-d d-e e-f f-g
6
Tetrardus plagale (Ipomisolidio)
Sol-La
Re-Mi
Ut-Re Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol Sol-La
Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol
Ut-Re
T – S – T (4a I specie) + T – T – S – T (5a
IV specie)D-E E-F F-G G-a a-b b-c c-dSol-La
Re-Mi Mi-Fa Fa-Sol Sol-La
Ut-Re Re-Mi
Ut-Re Re-Mi
Mi-Fa Fa-Sol
Come si può vedere dalla tavola gli unici casi in cui,
all’interno di una stessa maneria, è possibile una reale
alternanza fra esacordo duro e molle sono nel protus autentico e
nel tritus autentico e plagale: ciò è per evitare il tritono F -
b, intervallo che, altrimenti, occorrerebbe frequentemente nei
modi menzionati, al punto che, soprattutto nel tritus, diviene
assolutamente normale e costitutivo regolarizzare l’uso
dell’esacordo molle ponendo il in chiave, con la conseguenza
di ‘mutare’ la 5a di III specie del tritus regolare in 5a di IV
specie.8
8 Come si è teso a puntualizzare soprattutto negli ultimi anni, il sistemaesacordale, pur a larga, anzi, larghissima divulgazione e diffusioneeuropea, non fu però universalmente accettato e trovò anche illustri,seppur isolati, oppositori, come Johannes Ciconia (ca.1370-1412) in Novamusica (ed. moderna e trad. ingl. a cura di Oliver B. ELLSWORTH, Lincoln:University of Nebraska Press, 1993) o Johannes Gallicus (ca.1415-73) inRitus canendi vetustissimo et novo (ed. moderna a cura di Albert SEAY, ColoradoSprings: Colorado College Music Press, 1981), (v. sotto) autori checoncordavano nel trovarlo un’inutile complicazione rispettoall’apprendimento delle note semplicemente tramite le letteredell’alfabeto o, addirittura, come nel caso di Ciconia, anche conl’ausilio degli antichi nomi greci (proslambanomenos, hypate hypaton, etc.).Per una recente e informata discussione della questione v. Stefano MENGOZZI,‘The Ciconian Hexachord’, in Johannes Ciconia, musicien de la transition, cur. daPhilippe VENDRIX, Turnhout: Brepols (2003), pp. 279-304.
7
Almeno dall’XI secolo, qualunque cantore, anche principiante,
doveva aver interiorizzato, nel processo di apprendimento del
canto piano, queste nozioni fondamentali. Come si tenterà di
dimostrare nelle pagine seguenti, esse costituivano l’orizzonte
strutturale dell’organizzazione melodica e dovevano, in
mancanza di qualunque altro riferimento ‘grammaticale’ di
organizzazione frasale alternativo, avere un qualche riflesso
anche in polifonia che, almeno all’inizio, non è altro che
un’amplificazione timbricostrutturale del canto monodico.
Tuttavia per molti studiosi moderni l’applicabilità della
teoria (o, sarebbe forse meglio dire, teorie) modale alla
polifonia sarebbe altamente problematica, per non dire
impossibile.9 Ciò è in parte dovuto alla scarsità di fonti9 Tra gli studiosi che, sebbene con gradi diversi, più decisamente sioppongono a connettere modalità e composizione polifonica e che in molticasi sarebbero piuttosto orientati ad un’interpretazione tonale-funzionaledell’ultima, Harold POWERS è forse il più noto. I suoi contributi piùsignificativi in merito sono: ‘Mode’, in New Grove Dictionary of Music andMusicians, VI ed., cur. da Stanley SADIE, vol. XII, London: Macmillan(1980), pp. 376-450 (la sua posizione è restata fondamentalmente immutatanella stessa voce della nuova edizione [2001] del New Grove redatta incollaborazione con Frans WIERING [vol. XVI, pp. 775-823]); ID.‘Tonal Typesand Modal Categories in Renaissance Polyphony’, in Journal of the AmericanMusicological Society, 34 (1981), pp. 428-470; e ‘Is Mode Real? Pietro Aaron,the Octenary System and Polyphony’, in Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis,16 (1992), pp. 9-52 (in questi ultimi due scritti lo studioso riprende,mutuandolo da Siegfried HERMELINK, Dispositiones modorum. Die Tonarten in der MusikPalestrinas und seiner Zeitgenossen, in Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 4,Tutzing: Schneider (1960), pp. 11-16, il concetto di tipi tonali [tonaltypes]). La linea di pensiero di POWERS è grosso modo la stessa adottata daSarah FULLER nel suo ‘Modal Discourse and Fourteenth-Century French Song: a“Medieval” Perspective Recovered?’, in Early Music History, 17 (1998), pp. 61-108, uno scritto la cui raison d’être è un feroce attacco al volume, pur permolti aspetti discutibile, di Christian BERGER, Hexachord, Mensur undTextstruktur: Studien zum französischen Lied des 14. Jahrhunderts, in Beihefte zum Archiv fürMusikwissenschaft (1992). Anche Margaret BENT in più punti del suo ‘TheGrammar of Early Music: Preconditions for Analysis’, in Tonal Structures in EarlyMusic, cur. da Cristle COLLINS JUDD, New York & London: Garland (1998), pp.15-59, si esprime in maniera tale da non concedere adito a dubbi circa lasua posizione, perfettamente allineata su quella di POWERS (e del resto ilsuo saggio è così infarcito di citazioni di POWERS da farlo quasi sembrareuna sorta di omaggio allo studioso nordamericano). Tuttavia la BENT rileva
8
teoriche esplicitamente riferentisi ad un legame fra modo e
polifonia; tuttavia la scarsità di queste testimonianze
teoriche è, come cercherò di dimostrare, solo apparente.
È certamente innegabile che i teorici operanti a partire dal
pieno fiorire della polifonia raramente (almeno fino a
Tinctoris) parlano di modalità in un contesto esplicitamente
diverso da quello del canto piano. Ma, di per sé, questo, lungi
dal costituire un elemento a sfavore di qualunque riferimento
dei modi alla polifonia, può semplicemente essere un riflesso
del fatto che la modalità in quanto tale era la scienza
dell’organizzazione orizzontale dei suoni e questo
indipendentemente dal fatto che la melodia risultante fosse da
sola o combinata ad altre, come appunto nel discorso
polifonico.
Uno dei principali problemi con cui ci si deve confrontare
allorquando si tenti di ascrivere un brano polifonico ad un
dato modo è dovuto al fatto che spesso in polifonia si fa uso
di finali diverse da quelle normalmente accettate negli otto
modi tradizionali o quattro maneriæ. Nella maggior parte dei
casi questo si può tuttavia spiegare o con l’uso della
trasposizione diatonica o con la scelta di usare la confinale o
‘dominante’ modale, quale grado conclusivo. Un altro possibile
problema sorge nel momento in cui appaiono conflitti modali fra
le parti. Ma mentre cantus e tenor condividono spesso lo stesso
anche come ‘le regole contrappuntistiche abbiano un valore “locale” e nonci dicano nulla direttamente sulle direzionalità a lungo termine(counterpoint rules are local and tell us nothing directly about long-term goals), lasciandoaperta la questione su come stabilire questi ‘long-term goals’ in un branopolifonico del ‘300/’400. Su queste ed altre questioni di caratterecritico-ermeneutico rimando al mio articolo ‘Modalità e polifonia: unadiscussione critica sui più recenti approcci di ricerca’, in Rivista Italiana diMusicologia XXXIX, 2004/1, pp. 169-198.
9
modo o quantomeno la stessa maneria, con l’uno occupante
rispettivamente l’àmbito autentico, l’altro quello plagale, il
contratenor è in genere la voce che si comporta in maniera più
imprevedibile, spesso anche grazie al suo àmbito
particolarmente esteso e irregolare.
Tuttavia l’applicazione della teoria modale alla polifonia
diviene molto meno problematica se, come metodo di osservazione
dei comportamenti e dell’emersione dei modi, si fa uso delle
specie tetra- e pentacordali. Questo perché il concepire
l’organizzazione della melodia nei termini di tipologie
intervallari pre-definite, discrete e mobili, come sono appunto
di per sé le specie, permette una varietà molto ampia di
combinazioni diverse senza per questo rinunciare al sistema di
riferimento modale di base, sistema che, del resto,
costituisce, come si è accennato, l’unico concreto riferimento
ad una grammatica della melodia per il cantore/compositore
tardo-medievale. Tale tipo di approccio teorico prettamente
intervallare alla modalità, lungi dall’essere un arbitrio dello
studioso moderno, è familiare già a teorici che si occupano
sostanzialmente di monodia. In effetti, la preminenza delle
specie su altre caratteristiche intrinseche emerge nella teoria
dei modi sin dall’XI secolo, probabilmente perché ciò
permetteva un modello di classificazione più facilmente
razionalizzabile e sistematizzabile rispetto, ad esempio, alla
presa in conto della sola finale o delle varie forme di esordio
e di conclusione delle frasi musicali, come potevano essere le
diverse formule d’intonazione dei toni salmodici. Già Hucbald
de St. Amand (ca. 850-930) nel De harmonica institutione, suggerisce
implicitamente l’importanza del pentacordo quando, riferendosi
10
alla possibilità di trasporre le quattro finali tradizionali,
afferma che “[…] quinta semper loca his singulis quattuor superiora, quidam sibi
conexionis unione iunguntur <vel participant>, adeo ut pleraque etiam in eis quasi
regulariter mela inueniantur desinere, nec rationi ob hoc uel sensui quid contrarie, et
sub eodem modo uel tropo perfecte decurrere”.10 L’importanza strutturale
degl’intervalli di quarta e quinta per le attribuzioni modali
emerge abbastanza presto anche in altri importanti trattati,
come l’anonimo Dialogus de musica11 o lo stesso Micrologus di Guido
d’Arezzo12 (l’ultimo noto anche per l’apparentata teoria delle
‘affinità’, grazie alla quale differenti segmenti della gamma
vengono assimilati grazie a una simile costituzione
intervallare). Tuttavia fra i primissimi teorici a trattare in
maniera sistematica dei modi, primariamente e quasi
esclusivamente nei termini delle differenti specie di quarta e
10 “le note poste una quinta sopra ciascuna di queste finali sonorispettivamente unite tra loro in un tale legame di similarità che sitroverà generalmente che le melodie possono concludere su queste note unaquinta sopra senza tema di offendere il proprio giudizio o il proprioorecchio e rimanendo sempre perfettamente nell’àmbito di uno stesso modo otropo”. Per l’opera teorica di Hucbald e, in particolare, per il luogorelativo a questo passo (tratto da De harmonica institutione ), vedasi YvesCHARTIER, L’œuvre musical d’Hucbald de Saint Amand: les compositions et le traité de musique,in Cahiers d’études médiévales. Cahier spécial nº 5, Montréal: Bellarmin (1995), p.203. L’edizione di CHARTIER, corredata anche da una traduzione in francese,sostituisce quella contenuta nell’ormai datato M. GERBERT, Scriptores ecclesiasticide musica sacra potissimum, cit., dove il passo menzionato si trova a p. 119. Perquanto riguarda l’opera di GERBERT essa è stata parzialmente rivista da M.BERNHARD, Clavis Gerberti: Eine Revision von Gerberts Scriptores ecclesiastici de musica sacrapotissimum (St. Blasien, 1784), I, München: Veröffentlichungen dermusikhistorischen Kommission (1989): si citerà qui eventualmente BERNHARDsolo per quei trattati effettivamente rivisti. Esiste altresì unatraduzione inglese dell’opera teorica di Hucbald in Hucbald, Guido and John onMusic: Three Medieval Treatises, cur. e intr. da Claude V. PALISCA, trad. di WarrenBABB e con un indice dei canti citati nei tre trattati a cura di AlejandroE. PLANCHART, New Haven & London: Yale University Press (1978): il passorelativo è a p. 39.
11 In M. GERBERT, Scriptores…, cit., I, pp. 251-264.12 V. sopra, n. 1. Una traduzione inglese è contenuta in Hucbald, Guido and John
on Music…, cit., pp. 57-83. Per la traduzione italiana v. A. RUSCONI, (cur.,trad. e comm.), Guido d’Arezzo, le opere, cit.
11
quinta, vi è il contemporaneo di Guido, Bernone di Reichenau
(m. 1048), che parla altresì dei modi riferendosi alle quattro
maneriæ.13 Quando, nel suo Musica, seu prologus in tonarium cum tonario
Bernone descrive in dettaglio la natura di ogni modo, egli li
classifica chiaramente tenendo presente la divisione
dell’ottava in specie di quarta e quinta.14 Riferendosi al
primo modo, ad esempio egli stabilisce che “protus constat ex prima
specie dyapente & ex prima specie dyatessaron superius”.15 Ma è anche vero
che rispetto a questa ‘visione interna’ dei modi ne prevalse
spesso una ‘esterna’,16 secondo la quale “Tonus vel modus est regula,
quæ de omni cantu in fine diiudicat”.17 Forse, proprio per la sua
semplicità e immediatezza questa formula s’impose e fu
responsabile della proliferazione di dozzine di trattati, dove
la definizione di finale modale ebbe la meglio su “…all other
considerations in melodic classification and orientation in the modal system”.18
Accanto al ruolo fondamentale della finale venne attribuita
un’importanza secondaria ad altri gradi, come certe note
iniziali o mediali o intermedie (la rilevanza dei suoni13 In effetti anche Guido parla (nel XIII capitolo del suo Micrologus) dellequattro maneriæ, senza tuttavia mai fare un riferimento esplicito allasegmentazione dell’ottava in specie tetra- e pentacordali.
14 Edizione moderna in Alexander RAUSCH, Die Musiktraktate des Abtes Bern vonReichenau. Edition und Interpretation, Tutzing: Hans Schneider (1999), pp. 17-70.
15 “Il protus [autentico] consta della prima specie di quinta e della primaspecie di quarta al di sopra”, da A. RAUSCH, Die Musiktraktate…, cit., p. 44.Questa e le seguenti traduzioni, se non altrimenti indicato, sono delloscrivente.
16 L’espressione internal and external view of the modes è presa in prestito da F.WIERING ed appare sia come titolo di un saggio pubblicato su Tonal Structures inEarly music, cit., pp. 87-107 oltreché passim nel volume The Language of the Modes:Studies in the History of Polyphonic Modality, New York & London: Routledge (2001).
17 “un tono o modo è una regola che distingue ogni canto dalla sua finale”.Citato in traduzione inglese da H. POWERS et al., ‘Mode’, cit., p. 784 (a tone ora mode is a rule which distinguishes every chant by its final). L’originale latino è trattodall’anonimo Dialogus de musica e si trova in M. GERBERT, Scriptores, cit., II, p.243.
18 “…ogni altra considerazione rispetto a classificazione melodica eorientamento nel sistema modale”, da H. POWERS, et al., ‘Mode’, cit., p. 784.
12
iniziali e mediani e come essi dovrebbero essere in relazione
alla nota finale e secondo tutti gl’intervalli compresi
all’interno di una quinta giusta è stato rilevato per la prima
volta da Guido nel capitolo XI del Micrologus), ma il teorico
che forse più si discosta dal trattamento bernoniano dei modi
secondo specie intervallari distinte è Johannes Affligemensis
(fl. ca. 1100). Nel suo De musica (probabilmente scritto alla
fine dell’XI secolo, e dunque successivo ai lavori di Guido e
Bernone)19 egli fu tra i primi a legare esplicitamente cadenza
modale ‘secondaria’ sulla confinale e tenore salmodico.20 Così
nell’XI capitolo del suo trattato l’Affligemensis giustifica
l’incorporazione dei tenori salmodici all’interno della teoria
modale in chiave analogica: “Notandum autem, quod sicut fines octo
tonorum in quatuor notis, quæ ob id & finales dicuntur, dispositi sunt, sic octo
tenoribus, videlicet tonorum aptitudinibus notæ quatuor attributæ sunt…”.21
19 Edizione moderna: Johannes Affligemensis: De musica cum tonario, cur. da J. SMITSVAN WAESBERGHE, in Corpus Scriptorum de Musica, I, Roma: American Institute ofMusicology (1950). Per l’identità di Johannes Affligemensis e il(presunto) luogo di composizione del suo trattato, cfr. M. HUGLO, ‘L’auteurdu traité de musique dédié à Fulgence d‘Affligem’, Revue Belge de Musicologie,31 (1977), pp. 519 e la recensione di Christopher HOHLER a Hucbald, Guido andJohn on Music: Three Medieval Treatises, cit., in Journal of the Plainsong and Medieval MusicSociety, 3 (1980), pp. 56-58.
20 Nella liturgia dell’Ufficio i salmi venivano in gran parte recitati suuna nota cardine detta repercussa che, nella maggior parte dei casi, vennefatta coincidere con la dominante modale o confinale anche se, è benericordarlo, il repertorio salmodico dell’Ufficio era originariamentedistinto da quello che poi divenne il principale corpus liturgicogregoriano. Come riferimenti bibliografici essenziali afferenti ilrepertorio gregoriano v. David HILEY, Western Plainchant: A Handbook, Oxford:Clarendon Press (1993) e Kenneth LEVY, Gregorian Chant and the Carolingians,Princeton (NJ): Princeton University Press (1998). Per quel che invececoncerne più specificamente la liturgia dell’Ufficio, basti qui citare lostudio di Robert F. TOFT, The Liturgy of the Hours in East and West: the Origins of theDivine Office and its Meaning for Today, Collegeville (MN): Liturgical Press(1986).
21 “così come le conclusioni degli otto modi sono disposte attorno aquattro note, che sono pertanto denominate «finali», allo stesso modoquattro note sono assegnate ai quattro tenores, cioè le note usate piùfrequentemente nei toni [salmodici]…” (cit. da J. SMITS VAN WAESBERGHE, in
13
Questa linea teorica, fondata in gran parte sui tenori
salmodici per le attribuzioni modali, venne seguita fin ben
addentro il XVI secolo e l’esempio al riguardo più notevole è
forse quello di Pietro Aaron con il suo Trattato della natura et
cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato non da più altri scritto (Venezia:
Bernardino de’ Vitali, 1525), una pubblicazione che tratta
esplicitamente, per di più, di modalità e polifonia, un
argomento su cui torneremo più avanti. Naturalmente trattati
sulla modalità, concentrati particolarmente su una definizione
dell’ottava modale in quanto composta di specie ben precise di
quarta e quinta, continuarono ad essere scritti, in particolar
modo in Italia tra XIV e XV secolo. Probabilmente una delle
prospettive al riguardo più ricche e articolate è quella
offerta da Marchetto da Padova nel suo Lucidarium in arte musicæ
planæ (ca. 1317).22
Marchetto (fl. primo quarto del XIV secolo) tratta
specificamente di modi e modalità nell’XI capitolo del suo
trattato. Tuttavia, come giustamente fa notare Herlinger
nell’introduzione all’edizione moderna,23 il discorso sulla
modalità viene gradualmente introdotto dall’autore tramite
un’accurata descrizione della natura e dell’origine di tutti
gl’intervalli disponibili (capitolo IX). La ragione di ciò è
che per Marchetto il repertorio intervallare, con particolare
Corpus Scriptorum de Musica, I, Roma: American Institute of Musicology, 1950,p. 82); in inglese anche in Hucbald, Guido and John on Music, cit., p. 118. Sinoti che in quasi tutti i passi citati gli autori usano il termine tonus,tropus e modus in maniera completamente sinonimica e interscambiabile e cheper comodità (oltre che per evitare equivoci con il significato tonale-funzionale della parola ‘tono’) si è scelto di tradurre sempre con ilcorrispettivo italiano ‘modo’.
22 Marchetto da Padova, Lucidarium in arte musicæ planæ, cur. e trad. da Jan W.HERLINGER, Chicago: University of Chicago Press (1987).
23 Cfr. Lucidarium in arte musicæ planæ, cit., pp. 3-21: 7-13.14
riferimento a quarte e quinte e alle loro differenti specie,
costituisce il principale determinante modale, relegando così
le note iniziali, mediane (con particolare riferimento alla
confinale o repercussa) e, soprattutto, finale al ruolo di
caratteristiche secondarie. Il teorico espone in maniera
esplicita questo concetto alla fine del IX capitolo dove, dopo
una complessa descrizione sulla formazione delle specie,
aggiunge:
Per has enim species [scilicet dyatessaron et dyapente] sic interruptas
quilibet tropus sive tonus formatur, de quibus et quomodo per ipsas formetur
videre necesse est…
Ogni tropo o modo è formato da queste specie così
interpolate. Dobbiamo ora esaminare i modi e come essi siano
formati a partire da queste specie… (Lucidarium, 9.1.123-
124).24
Più avanti (Lucidarium, 11.3.2) Marchetto afferma che:
Sunt nonnulli qui absque specierum lege cantus diiudicant cuius toni sint solum
propter ascensum et descensum inspecto fine, quorum iudicium pluribus
rationibus nullum est.
Vi sono alcuni che giudicano il modo di una melodia
esclusivamente sulla base della sua ascesa e discesa
rispetto alla finale, senza riguardo per le specie. Il
giudizio di tali persone è nullo, per molte ragioni.
Più avanti nello stesso capitolo Marchetto commenta in maniera
più estesa l’importanza strutturale delle specie. Tuttavia
l’affermazione forse più importante e chiara al riguardo si
trova in Lucidarium, 11.3.7-10. Qui il teorico esprime il suo24 Questa e le seguenti citazioni dal trattato di Marchetto, insieme alsistema di segnatura, sono tratte dall’edizione di HERLINGER. Le traduzioniin italiano sono dello scrivente e a partire dalle traduzioni inglesi delcuratore.
15
totale disaccordo nei confronti di coloro i quali, seguendo
alla lettera la famosa affermazione sopra citata tratta dal
Dialogus de musica (Tonus vel modus est regula, quæ de omni cantu in fine
diiudicat), non riconoscono l’importanza determinante delle
specie di quarta e quinta:
…sophystice poterit formari unus cantus de speciebus tercii toni, et in fine
possemus addere unum tonum eidem infra, scilicet in finali primi, et tamen talis
tonus non erit primus sed tercius; nam si primus diceretur, videretur quod tonus
additus infra plus haberet de potestate formationis tonorum quam principia,
distinctiones et species ipsorum, quod erroneum est et falsum. Hiis rationibus
dicimus quod tales iudicantes cantus de tonis solum propter ascensum et
descensum non musici sed ceci, errorisque cantores potius dici possunt.
…in modo artefatto si potrà formare una melodia tra le
specie del terzo modo, aggiungendo poi, alla fine, un tono
sotto di essa, cioè sulla finale del primo modo, e tuttavia
tale modo non sarà il primo, ma il terzo; infatti, se fosse
considerato primo, sembrerebbe che il tono aggiunto sotto
abbia più importanza nella formazione dei modi di quanta ne
abbiano le note iniziali, i tipi di conclusione e le specie
degli stessi modi, il che è erroneo e falso. Per queste
ragioni affermiamo che coloro che giudicano il modo di una
melodia solo attraverso l’estensione superiore o inferiore
[intorno la finale] non sono musici, ma ciechi, e possono
essere considerati cantori di errori.
In altre parole ciò che qui Marchetto intende è che per
assegnare una data melodia ad un modo specifico si dovrebbe
sempre aver cura di fare attenzione all’organizzazione interna
della melodia stessa (ciò che, naturalmente, include le specie)
e che la finale (che essa sia regolare o trasposta) è di per sé
stessa insufficiente e inaffidabile per stabilire la modalità.
16
Ma quel che veramente conta è che le specie di quarta e quinta
sono i fattori determinanti per la positiva identificazione di
ogni modo trasposto o meno:
…primus tonus et subiugalis eius possunt terminari in quolibet loco manus ubi
species que ipsos formant superius et inferius possunt proprie ordinari, et
idemque dicimus de quolibet alio modo, tam auctentico quam etiam subiugali,
ut de ipsis inferius ostendetur.
…il primo modo e il suo relativo plagale possono concludersi
in qualunque luogo della mano dove le specie che li formano
possono essere ordinate in maniera appropriata sopra e sotto
[la finale]; e diciamo la stessa cosa per ogni altro modo,
autentico o plagale, come si mostrerà più avanti (Lucidarium,
11.4.17-18).
E ancora:
…et hiis rationibus dicimus quod quilibet tonus potest terminare in quolibet loco
manus ubi eius species proprie reperiri.
…per queste ragioni diciamo che ogni modo può terminare in
ogni luogo della mano dove si rinvengano le specie ad esso
appropriate (Lucidarium 11.4.46).
Queste affermazioni qualificano la trasposizione modale come
una pratica non solo del tutto accettabile, ma enfatizzano
anche la relativa irrilevanza della posizione all’interno della
gamma per la determinazione del modo. L’implicazione
inevitabile è, naturalmente, una potenziale, quasi illimitata
proliferazione di alterazioni (definite musica ficta o musica falsa
dato che sono suoni non previsti all’interno della gamma
guidoniana), essendo esse l’unico modo per garantire una
trasponibilità a tutti i livelli. L’unico limite a ciò è
prevalentemente di natura pratica e in effetti Marchetto
17
dichiara altrove (allineandosi con molti altri teorici
medievali) che una trasposizione è tanto più accettabile quanto
più evita l’uso di musica ficta (vedasi la discussione sulle
finali irregolari in Lucidarium, 11.3.30-48).
La teoria modale di Marchetto ebbe un grosso impatto su
parecchi teorici di generazioni anche di molto successive,
sebbene la sua influenza abbia prodotto gli echi più
consistenti soprattutto in Italia. Scritta più di un secolo
dopo il Lucidarium, la Declaratio musicæ disciplinæ (ca. 1425) di
Ugolino da Orvieto (ca.1380-1452) continua a mostrare il suo
debito nel confronti del musico padovano.25 Innanzitutto non si
può mancare di notare come la discussione e l’illustrazione dei
modi occupi più di due terzi del primo libro del trattato di
Ugolino, e questo tenendo conto che la Declaratio ambisce a
coprire esaustivamente tutti gli aspetti della teoria musicale,
incluso il contrappunto e la teoria mensurale.26 Pur partendo
dalla designazione dei modi secondo la nomenclatura pseudo-
greca, Ugolino la sostituisce quasi immediatamente con le
quattro maneriæ. Inoltre nel capitolo XLIX (De tropis sive tonis
autenticis et plagalibus) egli chiarisce in maniera inequivocabile la
sua preferenza per le specie nell’identificazione dei modi
dichiarando:
Ex diapente namque ac diatessaron tropus autenticus construitur, ex quibus
quamquam positione contraria plagalis quisque componatur.
25 Per un’edizione moderna vedi A. SEAY (cur.), Ugolini Urbevetani Declaratio MusicæDisciplinæ, in Corpus Scriptorum de Musica, VII, Roma: American Institute ofMusicology (1959).
26 Marchetto tratta, dal canto suo, di mensuralità nel Pomerium (ca. 1318),probabilmente scritto un anno dopo il Lucidarium. Per un’edizione modernav. Pomerium in arte musice mensurate, cur. da Giuseppe VECCHI, in Corpus Scriptorumde Musica, VI, Roma: American Institute of Musicology (1961).
18
Il modo autentico è costituito da una quinta e da una quarta
dai quali [stessi intervalli], ma invertiti viene [anche]
formato il plagale (Declaratio, p. 87).
Nel capitolo seguente (De tropis sive tonis descriptione) egli
sottolinea ancora una volta l’importanza delle specie:
Tropus, tonus sive modus est quam plurium vocum ex diapente ac diatessaron
ordinatis speciebus […] conveniens dispositio.
Un tropo, tono o modo è un’ordinata disposizione di varie
note secondo determinate specie di quinta e quarta
(Declaratio, p. 89).
Sebbene Ugolino fornisca in seguito al lettore le ‘comuni’
terminazioni o finali e pseudo-finali salmodiche dei varî modi
(capitolo LI), immediatamente dopo (cap. LII) sembra ci tenga a
precisare che la vera ‘formazione’ o ‘forma’ aristotelicamente
intesa di un modo è data dalle differenti combinazioni delle
specie di quarta e quinta:
Differentia enim agentia differentes producunt effectus, quo fit ut tropi sive toni,
qui ex speciebus diapente et diatessaron numero differentibus formam
suscipiunt, sint inter se numero differentes, ita quod esse primi non sit esse
secundi, nec e contra et sic de aliis.
Le azioni di caratteri distinti producono effetti differenti
e come risultato di ciò i tropi o toni, che traggon lor
forma dal numero delle differenti specie di quinta e quarta,
sono differenziati dal numero, cosicché la struttura del
primo non è uguale alla struttura del secondo e viceversa e
così per gli altri (Declaratio, pp. 90-91).
Il trattato di Ugolino prosegue in questa parte illustrando in
dettaglio le peculiarità formali di ciascun modo, ma sempre in
termini di specie (capp. LI-LXIII). Ad esempio, parlando, al
19
capitolo LIII, della formazione del primo modo, il teorico
specifica:
Prothus tropus sive tonus qui in ordine primus est formam suam et esse a
diapente et diatessaron recipit quoniam ex ipsorum primis speciebus formatur,
scilicet, ex re la prima diapente specie et ex re sol prima diatessaron….
Il tropo o tono protus che nella serie [dei modi] è il primo,
riceve la sua forma ed essenza dalla diapente e dalla
diatessaron dal momento che viene formato dalle prime specie
di queste, cioè dalla prima specie di diapente re la e dalla
prima [specie] di diatessaron re sol… (Declaratio, p. 91).
e così via per gli altri modi. È solo dopo queste definizioni
che Ugolino espone altre caratteristiche melodiche dei modi,
come incipit e differentiæ salmodiche (il repertorio schematico di
incipit e conclusioni relative all’intonazione dei salmi
classificati secondo i varî modi), con esempî concreti tratti
dai canti dell’Ufficio (cap. LXIV sino alla fine). Da tutto ciò
si evince che il trattamento dei modi in Ugolino segue da
vicino la teoria marchettiana. Inoltre, come anche appare dai
suoi esempî, per Ugolino, ancor più che per Marchetto, le
specie vengono identificate come elementi costitutivi
liberamente sovrapponibili per la configurazione interna ed
esterna dei modi.
La Practica musicæ (1496) di Franchino Gaffurio (1451-1522)27 è
fedele erede della teoria modale di Marchetto, non apporta
niente di particolarmente nuovo da questo punto di vista (tra
l’altro le note iniziali che fornisce per ciascun modo sono
chiaramente ricalcate da Marchetto) e la sua presentazione
della modalità è molto semplice e schematica. Probabilmente27 Cur. e trad. da Clement A. MILLER, in Musicological Studies and Documents 20,Dallas: American Institute of Musicology (1968).
20
l’unico contributo originale di Gaffurio in questo campo è la
sua classificazione delle quattro maneriæ in due gruppi (protus
con deuterus e tritus con tetrardus, rispettivamente) a seconda che
sia presente una terza minore o maggiore sopra la finale.
L’interesse di questo pur semplice schema risiede naturalmente
nell’anticipazione di tonalità minori/maggiori, ma non bisogna
dimenticare che lo stesso Marchetto identifica come un’unità
distinta e riconoscibile la terza sopra la finale che egli
chiama chorda (Lucidarium, 12.1.21-27). I contributi più
significativi di Gaffurio risiedono piuttosto nel campo della
musica speculativa dove il suo orientamento umanistico lo porta a
citare e a discutere ampiamente gli antichi autori greci dei
quali egli, non conoscendo la lingua, aveva ottenuto traduzioni
in latino ad opera dei grecisti Ermolao Barbaro e Giovanni
Francesco Burana.28
A parte Marchetto e Ugolino, l’altra grande fonte di teoria
musicale per Gaffurio è costituita dall’opera di Giorgio
Anselmi (ante 1386 - ca. 1440-43). In effetti una copia del De
musica: dieta prima de celesti harmonia, dieta secunda de instrumentali harmonia,
dieta tertia de cantabili harmonia di quest’ultimo, trattato scritto
intorno al 1434,29 faceva parte della biblioteca privata del
28 I due maggiori trattati più squisitamente ‘speculativi’ di Gaffurio sonoTheoricum opus musice discipline [Napoli, 1480], cur. da C. RUINI, Lucca:Libreria Italiana Musicale (1996) (l’edizione anastatica Theorica musice,Bologna: Forni, 1969, riprende l’edizione milanese di Filippo Mantegazzadel 1492, della quale esiste una traduzione inglese a cura di Walter K.KREYSZIG, New Haven [CT]: Yale University Press, 1993) e De harmoniamusicorum instrumentorum opus, Milano (1518), ed. anastatica Bologna: Forni(1972) e trad. in inglese a cura di C. A. MILLER, in Musicological Studies andDocuments, 33, s.l.: American Institute of Musicology; Neuhausen-Stuttgart(1977). Per notizie biografiche e quant’altro vedi inoltre Bonnie J.BLACKBURN, art. ‘Gaffurius [Gafurius], Franchinus [Lanfranchinus] [Gafori,Franchino]’, in New Grove Dictionary of Music and Musicians, cit., 9, pp. 410-414.
29 Ed. moderna a cura di Giuseppe MASSERA, in Historiæ musicæ cultores biblioteca,Firenze: Leo S. Olschki (1961).
21
teorico lodigiano, portandone anche i segni delle glosse di suo
pugno; tra l’altro Gaffurio dovette essere uno fra i pochi a
conoscere l’opera dell’Anselmi, che non trovò ampia diffusione
nell’àmbito teorico tardo-medievale e rinascimentale. Tuttavia
l’influenza di Anselmi su Gaffurio si limita in gran parte alla
musica speculativa e di fatto, la teoria modale del primo si
discosta dalla linea marchettiana, non privilegiando in maniera
particolare le specie e limitando in gran parte il discorso
all’osservazione degli àmbiti complessivi. In realtà Anselmi
non sembra molto interessato al trattamento della modalità e,
all’interno del suo trattato, scritto in forma dialogica e
piuttosto esteso, non dedica che poche pagine all’analisi e
alla descrizione dei modi (pp. 161-170 dell’edizione curata da
Massera).
Ora, i trattati summenzionati, e invero gran parte di quelli
scritti nel ‘300/’400, quando parlano di modalità
esemplificandola, traggono i loro esempî quasi sempre dal
repertorio gregoriano. Ma ciò, per le ragioni esposte
all’inizio di questo scritto, non deve di per sé essere
considerato come un’implicita negazione della modalità in
àmbito polifonico. Tra l’altro una considerazione
dell’organizzazione modale in quanto gioco combinatorio di
determinate specie di quarta e quinta poste sopra o sotto l’una
all’altra, faciliterebbe considerevolmente dal punto di vista
concettuale una visione ‘modale’ della polifonia, poiché allora
la progressiva giustapposizione di differenti specie di quarta
e quinta porterebbe a giustificare, ad esempio, l’estensione
dei modi oltre i loro àmbiti comunemente accettati. In merito a
22
quest’ultimo punto Johannes Tinctoris (1435-1511) nel suo Liber
de natura et proprietate tonorum (1476),30 è il primo teorico a far
esplicito riferimento ai ‘modi misti’, cioè ad àmbiti modali
aventi in comune più di una coppia specifica di quarta/quinta.
Sebbene Tinctoris non sia affatto il primo teorico in assoluto
a parlare di modi espressamente applicati alla polifonia,
certamente egli è tra i primi a fornire regole dettagliate per
la composizione polifonica grazie ai modi.
In effetti il suo Liber, redatto per la corte umanista del Re
Ferdinando I (Ferrante) di Napoli intorno al 1476 e concepito
come parte del curriculo musicale della figlia del monarca,
Beatrice, futura Regina d’Ungheria, è il primo trattato sulla
modalità ad essere stato esplicitamente pensato come un’opera
di riferimento per i compositori a lui contemporanei, oltre che
per dare giudizî sulla qualità delle composizioni stesse. Ciò è
evidenziato, nel prologo, dalla stessa dedica:
Præstantissimis ac celeberrimis artis musicæ professoribus Domino Johanni
Okeghem, christianissimi regis Francorum prothocapellano ac Magistro Antonio
Busnois, illustrissimi Burgundorum ducis cantori…
Ai più geniali e celebrati professori di musica, il
Reverendo Johannes Ockeghem, primo cappellano del Re dei
Franchi e il Maestro Antoine Busnois, cantore
dell’illustrissimo Duca dei Borgognoni…31
Più avanti alla fine del prologo e dopo aver sostenuto il suo
discorso con un paio di citazioni classiche, il teorico
30 Edizione moderna a cura di A. SEAY, in Corpus Scriptorum de Musica, XXII,Roma: American Institute of Musicology (1975). Circa le notiziebiografiche sul teorico il contributo fondamentale resta ancora RonaldWOODLEY, ‘Iohannes Tinctoris: A Review of the Documentary BiographicalEvidence’, in Journal of the American Musicological Society, 34 (1981), pp. 217-248.
31 Cf. Liber de natura et proprietate tonorum, cur. da A. SEAY, cit., p. 65.23
chiarisce una volta per tutte di aver concepito il suo trattato
a beneficio dei colleghi di Ockeghem e Busnois:
Unde quom scientia et cognitio tonorum sit compositoribus utilissima,
opusculum hoc de natura et proprietate eorum conscripsi.
Poiché, essendo la scienza e la conoscenza dei modi
utilissima ai compositori, ho redatto quest’operetta sulla
loro [dei modi] natura e proprietà.32
Ora, è ovvio che quando Tinctoris fa riferimento a
‘compositori’ egli allude ai suoi stessi contemporanei, e ciò
implica che egli ha in mente la polifonia. Questo viene in ogni
caso chiarito alla fine del capitolo I dove, dopo aver
brevemente presentato gli otto toni o modi tradizionali per
quel che concerne la loro definizione, numero, fondamento e
designazione, il teorico conclude con la seguente affermazione:
Hii autem sunt octo toni, quibus non tantum in cantu gregoriano qui simplex est
et planus, verum et in omni alio cantu figurato et composito utimur, circa quos
hoc in libello versari nostra fert intentio.
Questi sono gli otto modi, dei quali facciamo uso non solo
nel canto gregoriano, che è semplice e piano, ma anche in
ogni altro canto figurato e composto, che è nostra
intenzione trattare in questo libretto.33
Nei capitoli che seguono Tinctoris illustra le caratteristiche
di ciascuno degli otto modi, partendo significativamente con le
specie di quarta e quinta e continuando con la loro formazione
melodica, mixtio (mescolanza di modi autentici e plagali),
commixtio (commistione di specie di più maneriæ), perfezione
(relativa ai casi in cui il modo occupa l’intero àmbito a sua
32 Ibid., p. 66.33 Ibid., p. 70. L’espressione ‘canto figurato’ indica sempre in quest’epocauna composizione mensurale e polifonica.
24
disposizione), imperfezione (casi in cui al contrario l’ottava
modale non viene occupata per intero) e conclusione. Purtroppo
fra gli esempî da lui forniti solo quattro sono polifonici. Tre
di essi sono forniti allo scopo d’illustrare la necessità per
il quinto e, soprattutto, per il sesto modo (rispettivamente
tritus autentico e plagale) di alternare fra e per permettere
al contrappunto di formare consonanze perfette con il canto
dato (…ratione concordantiarum perfectarum quæ cantui composito incidere
possunt…),34 e ciò anche a costo di far scappare qualche tritono
melodico in una voce, come l’esempio 19 a p. 75 dell’edizione
di Seay chiaramente mostra. D’altra parte, l’ultimo esempio
polifonico (n. 31, p. 81) mostra la commistione fra due
differenti maneriæ (nello specifico i modi II e IV) provocata
dall’introduzione di un nel contrappunto al fine di evitare
una quinta diminuita con il tenor. Sebbene questa sia una
commistione provocata dalla necessità di correggere una
dissonanza, l’autore aggiunge che la presenza simultanea di due
maneriæ può essere concessa, al di là della necessità, dalla
stessa volontà del compositore, tanto nel canto piano quanto
nella composizione polifonica (sive in simplici sive in composito cantu).
Il fatto che la commixtio maneriæ (oltre alla mixtio tonorum) sia
particolarmente rilevante in polifonia viene evidenziato dal
teorico nel capitolo XXIV,35 dov’egli afferma che, sebbene la
modalità generale di un brano debba essere giudicata dal tenor,
ogni voce può essere organizzata secondo uno o più degli otto
modi:
34 Ibid., p. 73.35 Quod commixtio et mixtio tonorum non solum in cantu simplici, sed etiam in composito fiant,pp. 85-86.
25
Denique notandum est quod commixtio et mixtio tonorum non solum fiunt in
simplici cantu, verum etiam in composito, talique modo ut si cantus sit cum
duabus, tribus, quatuor aut pluribus partibus compositus, una pars erit unius
toni, altera alterius, una autentici, altera plagalis, una mixti, altera commixti.
Si noti inoltre che la commixtio e mixtio tonorum esiste non
solo nel canto piano, ma anche in quello polifonico e in
maniera tale che se una composizione è fatta di due, tre,
quattro o più parti, una sarà in un modo, un’altra in un
altro, una in un modo autentico, un’altra in un modo
plagale, una in uno misto, un’altra ancora in uno
commisto.36
A questa significativa affermazione fa seguito la citazione del
rondeau di Du Fay Le serviteur, reso celebre soprattutto per il
fatto di essere un raro esempio di protus trasposto su C, dove
tutt’e tre le parti sono dotate delle segnature in chiave di B
e E, oltreché ad essere l’unico brano polifonico d’autore
effettivamente citato dal teorico. Il fatto che il teorico
menzioni, peraltro brevemente, un solo brano musicale
polifonico a sostegno dell’universalità dei modi (sebbene di un
compositore celebratissimo) non inficia la destinazione
eminentemente ‘polifonica’ del suo trattato, ed anzi,
l’eccezionalità modale dell’esempio stesso (un protus su C) lo
rende ancora più paradigmatico. Del resto la citazione
riportata sopra secondo la quale gli otto modi vengono usati
‘non solo nel canto gregoriano […] ma anche in ogni altro canto
figurato e composto’, è abbastanza chiara da dissipare ogni
possibile dubbio che Tinctoris consideri le regole da lui
fornite nel corso del libro come l’impalcatura di ogni tipo di
discorso musicale da lui conosciuto e da lui riconosciuto come36 Ibid., p. 85.
26
tale, sia che esso sia a una sola come a più parti. Il fatto
che i suoi esempî siano in gran parte monodici non contraddice
affatto la destinazione eminentemente polifonica del liber,
visto che la modalità concerne, come si è avuto modo di
rimarcare più sopra, la struttura della singola linea melodica.
Tra l’altro in polifonia la sovrapposizione di più melodie
rende teoricamente e praticamente possibile la polimodalità,
sebbene l’area modale complessiva di un brano debba essere
giudicata dal tenor, come afferma molto chiaramente il teorico
nel capitolo XXIV del trattato. Non c’è dunque alcun dubbio che
l’illustrazione della modalità fornita dal Liber de natura et
proprietate tonorum sia considerata dall’autore come largamente
sufficiente ad esemplificare il comportamento dei modi nel
‘canto misurato’.37
Sebbene prima di Tinctoris e l’anonimo di Berkeley ben pochi
altri autori abbiano fatto esplicito riferimento al
comportamento dei modi in polifonia, questo silenzio può essere
solo apparente. Il fatto che la teoria dei modi fosse quasi
sempre esposta in connessione con il canto piano non dovrebbe
automaticamente portarci, come fanno invece alcuni studiosi
moderni (v., ad esempio, nota 9) ad implicare che i teorici
considerassero una sua eventuale applicazione alla polifonia
come necessariamente un errore. In effetti gli unici due37 Più di un secolo avanti (1375), l’anonimo autore del manoscrittoBerkeley, una raccolta di alcuni brevi trattati teorici, aveva anch’egliesplicitamente impostato il suo discorso sui modi in senso polifonico(edizione moderna: The Berkeley Manuscript: University of California Music Library, MS 744[olim Phillipps 4450], cur. e trad. da O. B. ELLSWORTH, Lincoln & London:University of Nebraska [1984]), sebbene l’argomento sia affrontato inmaniera talmente elementare (il teorico si limita a definire i limitiesteriori e le finali regolari e irregolari, oltre alle confinali, deimodi), che non val la pena riportarlo qui.
27
teorici che apertamente si dichiarano contrarî all’applicazione
delle regole modali in àmbito polifonico sono Johannes de
Grocheo (fl. ca. 1300) e Johannes Gallicus (ca.1415-73).
Tuttavia, anche in questi casi, i loro pronunciamenti in merito
necessitano di un’interpretazione critica. In effetti, se letta
nel suo contesto, la ben nota affermazione di Grocheo (cantus
autem [sc. mensuratus] per toni regulas forte non vadit nec per eas mensuratur)38
sembra più che altro essere una critica diretta contro coloro
che, trattando di modalità, non vanno oltre la definizione
‘esterna’ dei modi (Describunt autem tonum quidam dicentes eum esse
regulam, quæ de omni cantu in fine iudicat),39 non offrendo in tal senso
alcuna chiave su come affrontare una lettura modale di un brano
polifonico (…si per eas [regulas] mensuratur, non dicunt modum per quem nec
de eo faciunt mentionem).40 Johannes Gallicus nel suo Ritus canendi
vetustissimo et novo (1458-64),41 ancor più del suo predecessore
Grocheo, sembra negare la possibilità per un brano polifonico
di essere giudicato in base ai modi. Tuttavia, quel ch’egli
intende dire con ciò è semplicemente che in polifonia spesso
non vengono rispettate le finali regolari (D, E, F, G), al
contrario di quanto avverrebbe nel canto piano. Per Gallicus,
cioè, una caratteristica essenziale perché un brano possa dirsi
modale è che rispetti il luogo tradizionalmente assegnatogli
sulla gamma. Non che egli non riconosca l’importanza delle
specie di quarta e di quinta; al contrario, egli ritiene che
38 De musica (c. 1300) cur. da Ernst ROHLOFF, Die Quellenhandschriften zum Musiktraktatdes Johannes de Grocheo, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik (1967), p.152.
39 Ibid.40 Ibid. In quest’ottica anche l’anonimo di Berkeley sarebbe stato incluso daGrocheo fra quei teorici.
41 Edizione moderna a cura di A. SEAY, Johannes Gallicus: Ritus canendi, ColoradoSprings: Colorado College Music Press (1981).
28
esse siano fondamentali per giudicare il comportamento melodico
di un brano polifonico, ma per lui a questo punto si esce dai
confini della modalità. Per definire un sistema basato
esclusivamente sul riconoscimento di determinate specie di
quinta, quarta e ottava egli inventa la nozione di constitutio,
essenzialmente due ottave ascendenti grado per grado, la prima
delle quali corrisponde a quella posta da Boezio alla base del
suo sistema scalare (A-aa).42 Tuttavia, a differenza di quel
che fa Boezio, Gallicus estrae le sue ottave diatonicamente,
cioè cambiando ogni volta la struttura intervallare interna e
in pratica facendo rientrare di sottecchi quelle specie modali
già privilegiate da teorici come Bernone e Marchetto,
svincolate però da ogni legame con una finale regolare e una o
più finali extra regulas. In realtà la vera originalità di
Gallicus è stata quella di aver svincolato le specie
intervallari da ogni designazione modale e da ogni associazione
con una finale regolare e di esser quindi stato il primo a
teorizzare implicitamente uno iato fra struttura del canto
piano e struttura della polifonia; di fatto però egli non
introduce alcunché di nuovo perché, per ovvie ragioni
(basandosi cioè sempre sullo stesso sistema fondamentalmente
diatonico) le specie sono in fin dei conti identiche a quelle
dei teorici summenzionati. Il motivo di tanta, apparentemente
inutile, fatica è soprattutto ideologico: da vero uomo di
chiesa Gallicus (un monaco certosino) non tollera l’idea che il42 Per un’edizione moderna del trattato di Boezio, lo scritto musicaletardo-antico più letto per tutto il Medioevo e fin ben addentro ilRinascimento, v. Gottfried FRIEDLEIN, Anicii Manlii Torquati Severini Boetii Deinstitutione aritmetica libri duo. De institutione musica libri quinque. Accedit Geometria quæ ferturBoetii, Biblioteca Scriptorum Græcorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig:Teubner (1867), trad. (ingl.) di Calvin M. BOWER, Fundaments of Music, cur.da Claude V. PALISCA, New Haven (CT): Yale University Press (1989).
29
repertorio gregoriano sia soggetto alle stesse leggi della
musica mensurata e polifonica di cui egli, curiosamente,
colloca l’origine nientedimeno che presso i pagani popoli della
Grecia classica! (v. cap. II:i:11 dell’edizione di Seay).43
Marchetto, dal canto suo, non sembra farsi troppi problemi al
riguardo. In effetti nel suo Lucidarium afferma una sola volta,
ma in maniera tale da non aver bisogno di ripetersi, che …
quilibet cantus, sive perfectus sive imperfectus et cetera, de aliquo modorum existit…
(‘ogni canto, imperfetto, perfetto o qualsivoglia è
attribuibile a qualche modo’, Lucidarium, 10.1.7);44 inoltre il
fatto che una tale apodittica affermazione compaia alla fine di
un capitolo dedicato alla nozione di ‘misura’ nel canto piano e
in polifonia, dovrebbe togliere, se ce ne fosse bisogno, ogni
ulteriore dubbio. Ancora più chiaro risulta Ugolino. Nel
capitolo CLXI della sua Declaratio,45 un capitolo dedicato alla
discussione delle caratteristiche principali dell’area modale
del tritus, egli dà per scontata la pertinenza dei modi in
polifonia. In effetti ad un certo punto egli afferma che il
grado di musica ficta B, sebbene raro nel canto piano (e, in
teoria, non previsto nella gamma guidoniana regolare: v. sopra
tabella 1), occorre frequentemente nella musica mensurata:
Hoc enim in plano cantu raro videtur contingere, licet in mensurato sæpenumero
demonstrari contingat.
Infatti questo [grado di B] appare raramente nel canto
piano, sebbene si possa chiaramente dimostrarne una sua
43 Questo discorso è ampiamente sviluppato da F. WIERING, The Language of theModes: Studies in the History of Polyphonic Modality, New York & London: Routledge(2001), pp. 56-59. (Da notare tuttavia che WIERING fa riferimento aGallicus anche con il nominativo di Legrense).
44 Cf. The Lucidarium of Marchetto of Padua, cit.45 Declaratio musicæ disciplinæ, cit., pp. 226 et seqq.
30
frequente occorrenza in quello mensurato (Declaratio, p.
226).46
Esistono chiaramente altri teorici dei secc. XIV-XV che
suggeriscono una naturale e quasi ovvia applicazione dei modi
alla polifonia.47 Che ciò sia così è assai significativo,
perché ci indica indirettamente che per molti le regole della
modalità in àmbito polifonico non erano altro che una legittima
estensione di uno stesso discorso normativo ritenuto valido in
monodia, come testimoniato, ad esempio, da Guilielmus Monachus
(fl. tardo sec. XV), il quale, nel suo De preceptis artis musicæ
(scritto fra il 1480 e il 1490),48 definisce il modo come …
quædam regula quæ in omni cantu diiudicat et bene dico in omni cantu sive firmo
sive figurato,49 implicando in tal modo che le regole che egli è in
procinto di discutere valgono sia per il canto piano che per la
polifonia.50 A questi teorici potremmo qui aggiungere, per
restare nel ‘400, il parmense Nicolò Burzio (ca.1453-1528) il
quale, nel suo Musices Opusculum (ca. 1487),51 oltre trasmettere
la teoria marchettiana delle specie, sostiene che taluni modi
manifestano in polifonia determinati caratteri ‘affettivi’, un46 Ugolino fa qui riferimento a B come a un grado peculiare alla maniera di
tritus, particolarmente alla sua varietà plagale.47 Per una lista presumibilmente esaustiva, che include anche i secc. XVI-XVII, v. F. WIERING, The Language of the Modes, cit., pp. 205-245.
48 Edizione moderna a cura di A. SEAY, in Corpus Scriptorum de Musica, XI, Roma:American Institute of Musicology (1965). La probabile datazione vieneipotizzata dallo stesso SEAY nell’introduzione.
49 Ibid., p. 54.50 Con la differenza, tuttavia, che in polifonia (ma anche in talunirepertorî liturgici monodici) i modi possono mostrare un àmbito piùesteso, come dichiarato da Guilielmus all’inizio del paragrafo dal titoloOpinio aliquorum de ascensu et descensu tonorum:
Nota quod secundum aliquos toni magistri possunt ascendere usque ad decimam vocem suprafines suos, ita quod descendant quatuor punctos subtus fines suos. Istud enim potest intelligi incantu figurato sive organico vel in cantu prosaico sive prosarum, hoc est sequentiarum, et non incantu firmo Gregoriano… (De preceptis artis musicæ, p. 55).
51 Cur., intr. e trad. da C. A. MILLER, in Musicological Studies and Documents, 37,s.l.: American Institute of Musicology (1983).
31
concetto destinato ad avere una certa fortuna soprattutto
presso gli autori più umanisticamente orientati, operanti però
(con l’eccezione forse di Gaffurio), nel XVI secolo.
Passando nel campo della musica pratica, si può constatare come
l’attenzione a strutture modali, in termini soprattutto di
specie, si fa sempre più sentire a partire soprattutto dal XV
secolo. In effetti, come fa osservare Strohm, nei primi due
decenni del secolo, probabilmente anche a causa dell’influenza
dirompente dell’ars subtilior, la conformità a regole modali non
sembra andare oltre una ‘superficial observation of certain finals and
ranges’,52 mentre più avanti, in particolare nelle opere di Du
Fay e Binchois, possiamo persino osservare evidenti motivi di
apertura modellati su formule modali e articolazioni intorno a
specifiche note perno. Questo si evidenzia anche in brani
profani con finali irregolari, sebbene ogni compositore abbia
il suo proprio modo (quasi uno stile) di trattare determinate
peculiarità modali. Per esemplificare ciò consideriamo due
chansons con finale C per ognuno dei due autori citati.53
52 ‘…superficiale osservanza di determinate finali e àmbiti’, da ReinhardSTROHM, ‘Modal Sounds as a Stylistic Tendency of the Mid-FifteenthCentury: E-, A-, and C-Finals in Polyphonic Song’, in Modality in the Music ofthe Fourteenth and Fifteenth Centuries / Modalität in der Musik des 14. und 15. Jahrhunderts,cur. da Ursula GÜNTHER, Ludwig FINSCHER e Jeffrey DEAN, in Musicological Studiesand Documents, American Institute of Musicology; Neuhausen-Stuttgart:Hänssler Verlag (1996), p. 155.
53 La scelta di quattro brani profani con finale irregolare è un terreno diprova particolarmente efficace della validità intrinseca nella polifonia,per lo meno del ‘400, delle strutture modali illustrate sopra,dimostrando esse, in tal modo, una loro applicabilità, indipendentementedall’utilizzo delle quattro finali regolari e al di là dell’àmbito sacroin cui sono state originariamente concepite.
Gli esempî proposti sono tratti dalle edizioni moderne diriferimento dei brani scelti (per le quali vedi sotto). Tuttavia, perquestioni inerenti la musica ficta lo scrivente espunge alcune dellealterazioni editoriali ivi suggerite in quanto alcune volte si tratta dinormalizzazioni pseudo-tonali, che poco hanno a che vedere con il mondo
32
Per il primo caso si tratta del rondeau Navré je sui d’un dart
penetratif di Du Fay, un’opera del periodo intermedio del
compositore, come è mostrato sia dallo stile che dalla
tradizione manoscritta.54 Il brano (v. es. 3) si presenta con
una segnatura in chiave () al tenor e contratenor, con in più
alcuni E e A nel corso del brano. In quanto rondeau il brano è
diviso in due sezioni, entrambe terminanti con cadenza su C, la
prima in maniera imperfetta, cioè con la terza e al cantus,
mentre la cadenza finale raggiunge per moto contrario e in
maniera regolare l’ottava c-cc con la quinta g al contratenor. Le
due parti inoltre, oltre ad essere pressoché equivalenti come
durata, incominciano con lo stesso motivo imitativo fra le tre
voci, sebbene nella seconda parte esso venga presentato con
gl’intervalli invertiti (g-c-e-g, invece di c-g-e-c).
Se non fosse per le alterazioni di passaggio (B e E più un
A al tenor), oltre che naturalmente per il in chiave per
tenor e contratenor, il rondeau potrebbe tranquillamente essere
ascritto ad un tritus trasposto su C, con il cantus occupante
l’àmbito autentico (piuccheperfetto) del modo (c-cc-ee [ff]) ed
sonoro del Quattrocento. Per gli editorial accidentals si è pertanto scelto diattenersi a quelli essenziali per la condotta delle parti secondo leregole contrappuntistico-modali in vigore all’epoca e, a tale riguardo,ci si è lasciati guidare dall’illuminante scritto di Karol BERGER, MusicaFicta: Theories of Accidental Inflections from Marchetto da Padova to Gioseffo Zarlino,Cambridge: Cambridge University Press (1987).
54 La fonte principe per Navré je sui è Oxford, Bodleian Library, can. misc. 213(Oxford 213), c.172 (con attribuzione a ‘Dufay’) mentre le due fonti piùtarde, e quindi secondarie, sono Paris, Bibliothèque Nationale, nouv. acq.fr. 6771 (PR III: Reina), terza parte, c.197 e München, BayerischeStaatsbibliothek, mus. man. 3232a (St. Emmeram), c.198 (con attribuzione a‘Dufay’). L’edizione moderna di riferimento per la musica profana di DuFay resta Heinrich BESSELER, Guillaume Dufay: Opera Omnia, VI, Cantiones, CorpusMensurabilis Musicæ, Roma: American Institute of Musicology (1964; rev. DavidFALLOWS, Neuhausen-Stuttgart: Hänssler Verlag, 1995), a parte eccezionicome, appunto il presente rondeau per cui invece ci si riferirà al librodi K. BERGER citato sopra.
33
entrambe le voci inferiori l’àmbito plagale (G-g [a]): in
effetti le specie presentate in maniera peraltro cospicua e su
snodi ben in evidenza (es.: nel moto imitativo all’inizio [mm.
1-2]; al tenor, all’inizio della seconda frase musicale [mm. 6-
10]; ancora alle tre voci in imitazione all’inizio della
seconda sezione [mm. 15-17]; al cantus, all’inizio dell’ultima
frase, introducente il melisma finale [mm. 19-21] e infine le
tre parti all’interno del melisma stesso [mm. 24 et seqq.])
sarebbero in prevalenza la quinta di IV specie C-G e la quarta
di III specie G-C, entrambe appunto costitutive della versione
più comune della maneria triti.55 Tuttavia la presenza delle
alterazioni summenzionate ha l’effetto di mutare le quinte di
IV e le quarte di III in I specie, provocando un’oscillazione
del brano fra una sonorità complessiva di tritus e una di protus;
questo senza considerare il fatto che il in chiave nelle due
voci inferiori fa a sua volta risuonare un tetrardus in C. A
tutto questo va naturalmente aggiunto il fatto che l’assenza di
segnature di chiave al cantus, provoca una potenziale permanente
bimodalità rispetto alle voci inferiori; e questo
indipendentemente dal fatto che il cantus presenti occasionali
bemolli di passaggio.56 Dei tre bemolle che il cantus porta
55 Si potrebbe qui obiettare che la quinta di IV specie è piuttosto tipicadel tetrardus (sol-la/re-mi-fa-sol, ovvero, nel suo luogo “regolare”, G-a-b-c-d), ma non la quarta di III specie posta sopra (o sotto, nel casodella varietà plagale) la quinta, la quale invece, unita per l’appuntoalla quinta di IV specie, viene a costituire una trasposizione (del restocomune anche nel repertorio gregoriano) del tritus su C. Se latrasposizione in oggetto veniva di solito praticata al fine di evitarel’uso del come correttivo, all’occorrenza, del tritono F-b, lapresenza, nel rondeau dufayano, del in chiave nelle voci inferiori,sembrerebbe vanificare lo sforzo di rimanere il più possibile diatonici.Ma il compositore utilizza qui, come vedremo ora, l’ambiguitàmaggiore/minore della terza G-b/b come oscillazione fra tritus e protus.
56 Questo senza, naturalmente, prendere in considerazione le ‘correzioni’editoriali dell’edizione Besseler/Fallows, che sono spesso arbitrarie,
34
segnati come alterazioni di passaggio (E), due compaiono nella
seconda sezione (mm. 18 e 25), sezione che, tra l’altro, mostra
molto più della prima, anche grazie alle alterazioni aggiunte
al cantus, un generale sbilanciamento verso un’area modale di
protus con finale C.
Ora, nel discorso fatto sin qui si è volutamente evitato ogni
riferimento (come specificato nella nota 54) ad accidenti di
mano editoriale (dando per scontati solo quelli ‘aggiunti’, per
ragioni eminentemente contrappuntistiche al fine di correggere
intervalli, per lo più verticali, dissonanti) poiché,
soprattutto nel caso specifico, essi testimoniano
un’interpretazione musicale non necessaria del brano. Ciò è
dimostrato anche dal semplice fatto che lo scriba della fonte
principale (Oxford 213) indica molto chiaramente le alterazioni
quando volute, sottintendendo, con la frequente oscillazione
fra E e E, una voluta ambiguità modale fra tritus e protus sulla
comune finale C. Questa è, in un certo senso, quella che
Besseler chiamava Terzfreiheit, con la differenza che lo studioso
tedesco la interpretava con un’oscillazione tonale
maggiore/minore, mentre qui, forse con maggiore ‘proprietà’
storica, si sceglie d’interpretare nel senso di una voluta ed
espressiva ambiguità modale. Che un’oscillazione fra due o più
modi all’interno della stesso brano (e sia pure nel limitato
respiro temporale di un breve rondeau come questo) sottindesse
anche intenti espressivi è quel che tenta di dimostrare Karol
Berger riferendosi proprio a Navré je sui.57 L’interesse per la
non sono necessarie (nel senso che non svolgono la funzione, implicita enon dichiarata in questo genere d’interventi) di correggere intervallidissonanti, tradendo anzi un’implicita tendenza a volervi per forzaimporre una sorta di coerenza ‘tonale’; ma vedi n. 54.
57 Cfr. K. BERGER, Musica Ficta, cit., pp. 177-188.35
discussione di Berger è aumentato dal fatto che egli confronta
le versioni tramandate da tre diverse fonti: Oxford 213, per
l’appunto, Reina e St. Emmeram. Le prime due sono identiche,
eccetto che per la presenza di un e al contratenor, nella m. 3
(alterazione presente come aggiunta editoriale nell’edizione
Besseler/Fallows) e per l’assenza del al tenor, nella m. 25
della versione di Reina. Queste differenze, oltre a modificare
localmente l’attribuzione modale, cambiano come mostra Berger,
la sfumatura retorico-espressiva dei passi relativi. In pratica
gli accidenti aggiunti nella seconda parte di entrambe le
versioni (Oxford 213 e Reina) (e, m. 18, al cantus; e, a e
ancora e, rispettivamente alle mm. 22, 23, 26 del tenor)
avrebbero un preciso riferimento al dolce ‘sguardo’ (regart)
della dama (evocato dal primo verso della seconda sezione: C’est
madame qui par doulx regart , mm. 15-18), mentre la presenza,
peraltro armonicamente non necessaria, del e già dalla prima
parte (nella versione di Reina al contratenor, come si è visto)
anticiperebbe inutilmente, sempre secondo Berger, la marcatura
psicologico-affettiva della seconda parte, rovinando quindi
l’effetto sorpresa. Quanto alla versione tramandata da St.
Emmeram, essa è curiosamente priva di ogni alterazione,
incluso il in chiave al tenor e contratenor. Ma di fatto questa
versione è tramandata senza testo e non è escluso che fosse
concepita per un’esecuzione strumentale, forse per strumenti da
tasto o da corda, come suggerito dalla frequenza delle brevi
divise. L’atmosfera generale di quest’ultima versione è dunque
quella di una maggiore consistenza modale (in favore di tritus su
C) a scapito della varietà coloristico-espressiva: come notato
36
da Berger quest’ultima caratteristica deporrebbe a sfavore di
una sua attribuzione a Du Fay.
Dal canto suo il rondeau Belle, vueillés moy vengier58 (v. es. 4)
presenta una modalità complessiva molto meno ambigua poiché:
1. Le voci inferiori occupano grosso modo l’ottava C-c, con
il cantus posto all’ottava superiore;
2. Tutte le voci fanno perno intorno a un G;
3. Tenor e contratenor sono dotati entrambi di una segnatura
di chiave con B e E, sebbene il cantus condivida stabilmente
solo il B, l’E oscillando costantemente, per correggere
eventuali dissonanze verticali o orizzontali, fra e .
Tutti questi fattori tendono a mantenere gran parte del brano
in un’area di protus con finale C, eccezion fatta, come si è
visto, per il cantus che, a causa dell’oscillazione semitonale
E/ presenta in aggiunta le specie tipiche di un tetrardus con
finale C. Tuttavia la serie delle cadenze (su G, C e D, con il
secondo grado D posto, come spesso avviene nei rondeaux in
protus, particolarmente in Du Fay, a mo’ di cerniera fra le due
sezioni) conferma in maniera precipua la sonorità di protus.
Ritmicamente le due sezioni sono chiaramente distinte: la
prima presenta, all’interno di un tempo imperfetto (binario)
diminuito, una notazione vigorosamente melismatica; la seconda
è notata in tempo sempre diminuito (questa volta perfetto o
ternario) ma con una densità ritmica notevolmente inferiore.59
58 Fonte principe: Firenze, Biblioteca Nazionale, Magl. XIX, 107bis: cc.38v-40 (con attribuzione a ‘Dufay’). Secondaria: Montecassino, Archiviodella Badia, Cod. 871N (Montecassino 871), cc. 4v-5.
59 Per ulteriori notizie su questo rondeau v. in particolare R. STROHM, TheRise of European Music: 1380-1500, Cambridge: Cambridge University Press (1993),pp. 441-442.
37
Passando a Binchois vediamo come il primo caso scelto, il
rondeau Comme femme desconfortée60 (v. es. 5), mostri una marcata
sonorità di tritus con finale su C.61
La struttura cadenzale è piuttosto ricca e variata, potendosi
annoverare snodi che, a parte la finale C, mettono in evidenza
G (mm. 4-5), D (mm. 14-15), su C (mm. 19-20) e su E (mm. 23-
24), il terzo grado sopra la finale, un punto di snodo
intermedio normalmente comune all’interno di brani
classificabili nell’area modale di tritus. Vi sarebbe tuttavia da
aggiungere che le cadenze summenzionate, a parte la prima su
G, sono tutte ‘arricchite’ dalla presenza della terza (quindi
D/F, mm. 14-15; C/E, mm. 19-20; E/G, mm. 23-24) a rigore
consonanza imperfetta in quest’epoca e pertanto teoricamente
proibita in posizione cadenzale, sebbene frequente in Binchois.
60 Fonte principe: Yale University, Beinecke Rare Book and Music Library 91(Chansonnier Mellon), cc.32v-33 (attribuzione a ‘Binchoys’). Secondarie:Wolfenbüttel, Landesbibliothek, Ms. extrav. 287, cc.31v-32; Washington,D.C., Library of Congress, Chansonnier Laborde, cc.17bv-18 (solo tenor econtratenor); Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 517 (olim 295),cc.XXXVIIIv-XXXIX (41v-42); Paris, Bibliothèque Nationale, nouv. acq.fr., Ms. 4379, cc.13v-14; München, Bayerische Staatsbibliothek 9659, c.4(solo cantus e tenor); Uppsala, Universitetsbiblioteket 76a, cc.19v-20;Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magl XIX, 176, cc.123v-125;Escorial, Real Biblioteca del Monasterio, Ms. IV.a.24 (Escorial B), cc.131v-132; Paris, Bibliothèque Nationale, Chansonnier de Jean de Montchenu, Ms.Rothschild 2973 (Chansonnier Cordiforme), cc.38-40 (con contratenoralternativo); Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,Cappella Giulia, Cod. XIII 27, cc.88v-89. In aggiunta a questa riccatradizione manoscritta, sebbene quasi completamente anonima, dellamusica, il testo letterario è tramandato da solo nelle due fontiseguenti: Berlin, Kupferstichkabinett, Ms. 78 17 (Hamilton 674),Chansonnier du Cardinal de Rohan, c.117 e Le Jardin de Plaisance et Fleur de Rhetoricque(Paris: Antoine Vérard [1501]), cc.XCIII e LXII (solo incipit). L’edizionemoderna di riferimento per le chansons di Binchois resta a tutt’oggi ilvolume curato da Wolfgang REHM, Die chansons von Gilles Binchois (1400-1460), Mainz:B. Schott’s Söhne (1957), pp. 53-54 per Comme femme.
61 V. sopra, n. 55, per le considerazioni in merito alla trasposizione deltritus dal suo ‘luogo’ naturale su F a C.
38
Il carattere grandemente eufonico e lo sviluppo del discorso
musicale su linee morbide e dalla sinuosa e rotonda arcata
melodica testimonierebbero della vicinanza del compositore
franco-fiammingo a caratteristiche stilistico-sonore
prettamente inglesi. Senonché, nonostante la ricca tradizione
manoscritta di questo brano, l’ascrizione a Binchois è
testimoniata dal solo Mellon Chansonnier (ca. 1470) fonte postuma
rispetto al compositore, il che lascerebbe supporre una data di
composizione piuttosto tarda.62
Fra i brani in C di Binchois Ay, douloureux63 (v. es. 6) si
distingue come l’unico pezzo dotato di una pressoché esclusiva
sonorità di protus. Tuttavia, come il brano precedente, questo
rondeau, pure piuttosto tardo, mostra un ricco repertorio
cadenzale: C, D, E -sebbene quest’ultimo grado presente solo
nel cantus e, in una cadenza altamente irregolare, in quanto
terza sopra il tenor e terza sotto il contratenor-, G e persino
B. Ciononostante, quarte e quinte impiegate lungo tutto l’arco
del brano sono per la grande maggioranza di I specie e solo in
un caso (mm. 35-36) una quinta di IV specie su g è messa in
evidenza dal cantus. Sebbene questo non sia l’unico passo del
brano dove la voce superiore non abbia necessità di
‘correggere’ b, al fine di evitare dissonanze armoniche o
melodiche, in b, negli altri casi il b è parte o di un moto
cadenzale verso c’ (mm. 13-15, 45-47) oppure è inserito
all’interno di un movimento melodico o frase che non completa o
non evidenzia in maniera particolare la quinta corrispondente
62 Per un’analisi stilistica e una discussione dei problemi di attribuzionev. R. STROHM, ‘Modal Sounds as a Stylistic Tendency…’, cit., pp. 161-162 eID., The Rise of European Music, cit., pp. 442-443.
63 Fonte unica: Oxford 213, c.78v (attribuito a ‘Binchoys’). Edizionemoderna: W. REHM, Die chansons von Gilles Binchois…, cit., pp. 8-9.
39
(mm. 9-11, 23, 28-30, 42-43). Questo ha come conseguenza una
certa preponderanza di quarte e quinte di I specie, nonostante
la risultante modalità di protus, a causa sia dello scarto in
segnature di chiave fra cantus e voci inferiori sia dei moti
cadenzali e melodici in genere, si alterni sino alla fine tra
finali su D, G e C.
Naturalmente queste brevi analisi non pretendono altro che
fornire un assaggio dell’utilità di un approccio modale alla
polifonia tardo-medievale. Va da sé che, per essere completi,
approcci analitici di questo tipo vadano integrati con altri
fattori, in primis con il comportamento contrappuntistico. I due
aspetti si possono in effetti completare a vicenda e sono in un
certo senso complementari; infatti la modalità focalizza
l’attenzione sul profilo melodico e sul colore ‘tonale’
(intendendo ovviamente l’aggettivo nel senso più ampio
possibile), mentre il contrappunto, come del resto già rilevato
dalla Bent (v. sopra n. 9), privilegia un punto di vista più
locale e circoscritto, ma nondimeno utile per stabilire una
grammatica relazionale fra le diverse linee melodiche del
tessuto polifonico.64
64 Per uno sviluppo analitico più approfondito e sempre concentrato su DuFay e Binchois, v. il mio ‘Modal Usage in the Secular Works of Du Fay, inRevue Belge de Musicologie, 59 (2005) (in corso di stampa) e The Emergence ofModality in Late Medieval Song: The Cases of Du Fay and Binchois, testo in preparazione.
40