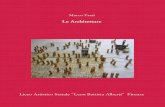La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio. Storia e restauro, a cura di D. Sanguineti, G....
Transcript of La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio. Storia e restauro, a cura di D. Sanguineti, G....
a cura diDaniele Sanguineti e Gianluca Zanelli
testi diDaniele Sanguineti
Antonio Silvestri Gianluca Zanelli
Storia e restauro
DECOLLAZIONEBATTISTA
MARCO ANTONIO POGGIO
DIDEL
LA
Sommario
RedazioneDaniele Sanguineti con la collaborazione di Matteo Moretti
Impaginazione e grafica del volumeSagep Editori, GenovaDirezione editoriale: Alessandro AvanzinoGrafica: Barbara Ottonello
StampaGrafiche G7 Sas, Savignone (Genova)
RestauriLaboratorio di Restauro Antonio Silvestri, GenovaDirettore dei lavori: Gianluca Zanelli
Con il sostegno diCompagnia di San Paolo
Referenze fotograficheAlbenga, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Curia vescovile di AlbengaGenova, Archivio Silvestri RestauriGenova, Archivio fotografico Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della LiguriaGenova, Archivio fotografico laboratorio di restauro Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria (Daria Vinco)Genova, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di GenovaArchivio Valentina FioreArchivio Daniele Sanguineti
RingraziamentiIl primo ringraziamento va alla Compagnia San Paolo che, con immediatezza, ha inteso l’importanza del recupero del gruppo processionale del Poggio e della settecentesca cassa mariana sostenendone generosamente il restauro.Un sentito ringraziamento all’Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici della Curia Arcivescovile di Genova e in particolare a Grazia Di Natale. Un grazie particolare a Ernesto Roncallo, Priore dell’Arciconfraternita Mortis et Orationis di Sestri Ponente, per la costante attenzione dimostrata nei confronti dell’iniziativa. Si ringrazia inoltre a vario titolo: Paolo Arduino, Giacomo Baldaro, Massimo Bartoletti, Rosaria Cigliano, Francesca Contini, Laura Fornara, Fausta Franchini Guelfi, Matteo Moretti, Alma Oleari, Mons. Andrea Parodi, Mariolina Rella, Antonio Silvestri, Daria Vinco, Giovanni Ziglioli.
L’Editore è a disposizione degli eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.
La DecoLLazione DeL Battista
Di Marco antonio Poggio
Storia e restauro
a cura di Daniele Sanguineti e Gianluca Zanelli
© 2013 Sagep Editoriwww.sagep.itISBN 978-88-6373-233-7
In copertinaMarco Antonio Poggio, Decollazione del Battista, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis, particolare.
Presentazioni 04Andrea MuzziGrazia Di NataleErnesto Roncallo
Brevi cenni (e qualche spunto) 08per il patrimonio artistico dell’ArciconfraternitaMortis et Orationis di Sestri Ponente Gianluca Zanelli
La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio: 18il teatro barocco a GenovaDaniele Sanguineti
Il restauro: metodologia e intervento 54Antonio Silvestri
La Madonna del Rosario di Francesco Ravaschio 68Daniele Sanguineti
Bibliografia 74
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria
Ministero per i Beni e le Attività CulturAli
Arcidiocesi di GenovaUfficio Beni Culturali Ecclesiastici
Oratorio ArciconfraternitaMortis et Orationis
4 5
Presentazioni
La pubblicazione del restauro della Decolla-zione del Battista di Marco Antonio Poggio avviene in un periodo in cui sono stati
presentati altri recuperi seguiti dalla Soprinten-denza per i Beni Storici e Artistici ed Etnoan-tropologici della Liguria: alludo al restauro delle opere di Santa Maria della Castagna e a quella del Santuario del Belvedere. La soddisfazione di poter rivedere di nuovo, e in condizioni di rin-novata leggibilità, nelle sedi in cui erano conser-vate queste opere significative dell’arte nella no-stra regione, si aggiunge al fatto positivo che il risultato è stato raggiunto grazie ad un impegno condiviso. Rivolgo il mio pensiero in particola-re a coloro che sono preposti alla cura di questo imponente complesso scultoreo, segnatamente Ernesto Roncallo, Priore dell’Arciconfraternita Mortis et Orationis di Sestri Ponente, Grazia Di Natale dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici della Curia Arcivescovile di Geno-
va, Gianluca Zanelli, lo storico dell’arte della Soprintendenza che, studiando con passione, ha seguito il restauro affidato alla cura del Labo-ratorio di Antonio Silvestri. Ancora una volta la Compagnia di San Paolo è stata di indispen-sabile sostegno alla iniziativa dimostrando una lungimirante sensibilità per la vita delle opere d’arte, sensibilità che deve essere rimarcata con forza in questa fase storica in cui, pur vivendo in un contesto reso unico proprio dalla diffusione delle testimonianze storiche e artistiche, siamo invece costretti a registrare preoccupanti segna-li di segno opposto. Avviciniamoci dunque alla complessa e spettacolare Decollazione del Battista di Sestri Ponente, un’opera che ritorna alla go-dibilità e all’arricchimento spirituale di tutti noi.
Andrea MuzziSoprintendente per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici della Liguria
Le due casse processionali appartenenti all’Arciconfraternita Mortis et Orationis di Sestri Ponente sono state protagoni-
ste, in questi ultimi anni, di un laborioso re-stauro condotto sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria, diretto dal dottor Gianluca Zanelli, ed eseguito dal labo-ratorio di Nino Silvestri. Come ogni bene cu-stodito all’interno degli oratori, le casse proces-sionali sono il segno della profonda devozione dei Confratelli verso i Santi e la Vergine, docu-menti di convergenza spirituale per gli abitanti del luogo, e occasione per gli artisti di esempli-ficare abili ed erudite capacità tecniche.In particolare, San Giovanni Battista, patrono della città di Genova, rappresenta, per i fedeli dell’Arcidiocesi, il Santo che non scese a com-promessi e che perseguì la verità e la rettitudine fino a giungere al martirio. La presenza di in-numerevoli opere d’arte, presenti nel territorio dell’Arcidiocesi, dedicate al Precursore pone in rilievo quanto la devozione fosse sentita e come i fedeli ricercassero la protezione del Santo con l’aiuto di immagini suggestive, particolar-mente evocative della sua vicenda terrena. La cassa lignea di Marco Antonio Poggio, portata in processione dai Confratelli, toccava profon-damente la sensibilità dei fedeli e mostrava con
orgoglio l’importanza delle attività svolte dalla Confraternita, sodalizio di uomini che si oc-cupavano delle pratiche pietose collegate alla dipartita dei meno fortunati. Anche la statua della Madonna del Rosario, attribuita a Francesco Ravaschio, testimonia la necessità di manife-stare, durante le processioni, il legame secolare che i fedeli sestresi avevano verso la Vergine, in-vocata protettrice dall’alto del monte Gazzo su tutto il territorio sottostante. I saggi di Daniele Sanguineti e di Gianluca Zanelli, che seguono in questo contributo, permettono di ripercorre con chiarezza, attraverso le indagini storiche e artistiche, questa sentita devozione dei sestresi, manifestata con opere d’arte di altissimo pregio. Un restauro, dunque, che sottolinea quanto sia fruttuoso oggi lavorare in comunione di intenti tra gli Enti preposti alla tutela e alla valorizza-zione: fondamentale è stato, ancora una volta, l’apporto della Compagnia di San Paolo al fine di salvaguardare la memoria di chi ci ha pre-ceduto, nel desiderio preciso di lasciare a chi seguirà, la testimonianza non solo delle opere d’arte, ma anche e soprattutto i segni di fede che con queste sono intrecciate.
Grazia Di Nataleprodirettore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici
Arcidiocesi di Genova
6 7
Il programma per il restauro delle due casse processionali dell’Arciconfraternita Mortis et Orationis, la Madonna del Rosario e, in
particolare, la Decollazione del Battista, opera in-signe di Marco Antonio Poggio, risale all’inizio del 2000 grazie alla volontà del defunto priore Mario Parodi. Tale programma è stato in segui-to condotto dal nuovo consiglio con l’appoggio e l’incoraggiamento dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Li-guria. Si è provveduto a richiedere vari progetti a ditte altamente specializzate e, infine, il restau-ro è stato affidato dalla Confraternita al labora-torio di Antonio Silvestri di Genova.Queste casse processionali, e in particolare quel-la della Decollazione – per i sestresi “Miodin-a” –, sono molto care alla popolazione e motivo di or-goglio per il loro valore storico e artistico.
Quando, nel 1620, venne aperta al culto la par-rocchia di Santa Maria Assunta, la stessa con-tava già tremila anime, mentre la chiesa ma-trice di San Giovanni Battista ne annoverava solo mille. Con la nuova parrocchia si ritenne di costituire un’associazione confraternale, e nel 1634, a seguito del decreto dell’arcivescovo di Genova, monsignor Domenico De Marini, prese avvio l’edificazione del nostro oratorio, accanto alla parrocchia, ultimato nel 1639. L’Arciconfraternita Mortis et Orationis aveva lo scopo di seppellire i morti dopo aver suffraga-to le anime mediante il funerale e infine pren-dersi cura dei superstiti in difficoltà. Varcando la soglia dell’oratorio si osserva, sulla volta, lo stemma dell’Arciconfraternita; degni di nota sono gli affreschi del presbiterio, realizzati da Giovanni Battista Revello, mentre la tela del coro, tradizionalmente attribuita al sestrese
Antonio Travi, detto il “Sordo di Sestri”, mette in scena l’Imposizione del nome del Battista. Nel 1749 si aggiunsero i due altari laterali dedica-ti alle Anime del Purgatorio e a Santa Maria Maddalena. Le due arche processionali raffigu-ranti la Decollazione e la Madonna del Rosario si ascrivono al periodo d’oro delle scultura sacra del genovesato. Sono inoltre preziosi i due Cro-cifissi: il Nero, realizzato per emulare il Cristo dell’oratorio delle Fucine, il Bianco, opera rife-rita ad Anton Maria Maragliano e che secondo la tradizione giunse a Sestri dalla casaccia ge-novese di Santa Brigida e per ciò chiamato “Il Brigidone di Sestri”. Ma negli studi contenuti in questo volume, a firma di Gianluca Zanelli e Daniele Sanguineti, vengono per la prima vol-ta proposte più pertinenti attribuzioni.Il nostro oratorio, restaurato nel 1967 insieme all’attiguo edificio, è testimonianza dell’attacca-
mento che i sestresi hanno per questa importante realtà, mantenuta aperta tutti i giorni, e dove si espone il Santissimo Sacramento e si celebrano alcune funzioni in forza di bolle papali come quel-la di Paolo V del 1600 e di Clemente X del 1671.Sembra doveroso, dunque, rivolgere un sentito ringraziamento alla Compagnia di San Pao-lo che ha sostenuto il restauro delle due casse processionali, alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria e all’Ufficio Beni Culturali della Curia Arcivescovile di Genova, che hanno seguito i lavori, e a monsignor Andrea Parodi, parroco della Basilica Santa Maria Assunta e nostro as-sistente, nonché a tutti i confratelli e le conso-relle che ci hanno sostenuto in questa impresa.
Ernesto RoncalloPriore dell’Arciconfraternita Mortis et Orationis
8 9
Brevi cenni (e qualche spunto) per il patrimonio artistico
A esclusione della monumentale cassa processionale di Marco Antonio Pog-gio, raffigurante la Decollazione del Bat-
tista, scarso interesse ha suscitato tra gli studiosi il prezioso nucleo di testimonianze figurative ancora conservate all’interno dell’oratorio se-strese dell’Arciconfraternita Mortis et Oratio-nis, la cui fondazione, secondo Paolo Novella, risaliva al 1639 “ad opera del parroco Tomaso Restano”, sebbene la sua costruzione venisse avviata almeno quattro anni prima1. Pure le fonti ottocentesche, come i fratelli Angelo e Marcello Remondini, dedicarono poche righe alla descrizione dell’edificio, ricordando unica-mente che nel 1729 disponeva di un altare di legno, “due altari nel 1749, il maggiore ed un altro dedicato a S. Caterina, ed ora ne ha tre”2. Cenni ulteriori si ritrovano nei manoscritti del Novella, il quale nel 1906 documentò l’im-portante presenza nell’oratorio del “grandioso gruppo in legno colla Decollazione di San Gio-vanni Battista, opera di Marcantonio Poggio”3, per segnalare poi qualche anno dopo anche “un Crocifisso, opera di G.B. Bissoni”4. Rispetto a questi spunti, forniti dalla letteratura locale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del secolo successivo, è possibile aggiungere anche le più recenti note raccolte da Giuseppe Casareto, il quale, oltre a ricordare la cassa del Poggio e il Crocifisso bianco (come opera di Anton Maria Maragliano), segnalò brevemente altri manu-fatti, tra cui la scultura in legno raffigurante la Madonna del Rosario e la pala collocata dietro
l’altare maggiore, riferita, senza ulteriori indi-cazioni, ad Antonio Travi5.Se alcune opere, pur in mancanza di notizie certe, furono verosimilmente realizzate per or-nare l’interno della sede della confraternita, al-tre invece pervennero in un secondo momento da ulteriori siti, in particolare nel corso del XIX secolo, dopo che l’oratorio nel 1798 fu, a pro-pria volta, “spogliato di quanto di valore avea”, con riferimento in particolare alla dotazione di oggetti liturgici in argento6. È il caso della cas-sa del Poggio, in origine conservata nel vicino oratorio dedicato al Battista7, e del bellissimo Crocifisso ligneo (fig. 1), denominato local-mente il “Brigidone”, in quanto la tradizione lo ritiene provenire dal distrutto oratorio di Santa Brigida in San Giovanni di Prè. Un’indicazio-ne che ha portato all’identificazione dell’opera con un analogo manufatto realizzato da Marco Antonio Poggio segnalato dalle fonti in quel-la sede8, ipotesi che, come meglio precisato da Daniele Sanguineti in questo volume, non può essere accolta, sia per motivi iconografici (il Crocifisso del Poggio venne infatti ricordato come “spirante”9), sia sulla base di considera-zioni puramente linguistiche, le quali permet-tono di formulare un più calzante riferimento dell’opera sestrese a Giovanni Battista Bissoni, con una datazione agli anni trenta del XVII se-colo10. Si tratta di una paternità condivisibile a un confronto con altre testimonianze ascritte alla stessa mano, e che può diventare ancor più suggestiva avvalendosi della notizia riportata
Brevi cenni (e qualche spunto)per il patrimonio artistico dell’Arciconfraternita Mortis et Orationis di Sestri PonenteGianluca Zanelli
1. Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
10 11
Gianluca Zanelli Brevi cenni (e qualche spunto) per il patrimonio artistico
da Paolo Novella circa la provenienza di questa prestigiosa scultura dal “distrutto oratorio dei SS. Giacomo e Leonardo di Prè a Genova”11, confraternita alla quale apparteneva effettiva-mente un Crocifisso attribuito da Federigo Ali-zeri al Bissoni12.Nessuna indicazione è per ora emersa riguardo all’interessante nucleo di opere in legno che impreziosiscono gli altari dell’oratorio, per al-cune delle quali è forse ipotizzabile un’esecuzio-ne nell’ambito delle esigenze devozionali della confraternita sestrese, come nel caso del Cristo deposto (fig. 2) collocato nel primo altare a sini-stra13, un’opera che, verosimilmente interessata da ampie riprese in corrispondenza della pelli-cola pittorica, potrebbe rivelare, sia nella resa tagliente del volto sia nella definizione asciutta e incisiva del corpo esanime, una fattura tardo seicentesca da parte di un valido scultore geno-vese profondamente inflluenzato dall’attività di Giovanni Battista Bissoni. Testimonianza della produzione scultorea in legno della fine
del XVII secolo è anche il Crocifisso che svet-ta sull’altare principale14, rivelando caratteri, come la struttura del volto o l’intaglio dei lun-ghi capelli, legati sempre alla tradizione bisso-nesca e non ancora suggestionati dalla lezione maraglianesca. Appartenenti invece a un am-bito parallelo all’attività di Anton Maria Ma-ragliano sono le due sculture con la Madonna Addolorata e San Giovanni Evangelista (figg. 3-4)15, purtroppo sminuite da pesanti moder-ne ridipinture, collocate ai lati di un Crocifisso (fig. 5)16 databile, come le stesse immagini dei dolenti, tra gli anni trenta e quaranta del Set-tecento, complesso riferibile a un artista vicino ai modi di Gerolamo Pittaluga, come dimostra ad esempio l’interessante confronto tra il volto della Vergine e quello dell’analoga figura che compone il gruppo della Madonna del Carmine conservato presso la chiesa di Caminata di Ne (Genova), pagato allo scultore genovese nel 173017.A questo nucleo di immagini lignee, a cui si ag-giunge anche la settecentesca Madonna del Ro-sario – oggetto, come la cassa del Poggio, di uno specifico intervento critico di Daniele Sangui-neti –, nonché una Maddalena penitente inserita nel primo altare a destra – dai tratti che sembrano ormai evidenziare stilemi tipici della produzione genovese di primissimo Ottocento18 –, si affian-ca la bella tela rappresentante l’Imposizione del nome al Battista (fig. 6) inserita nella parete di fondo dell’edificio al di sopra del coro. Da considerare del tutto infondata la tradiziona-le attribuzione al pennello primo seicentesco di Antonio Travi19, l’opera palesa invece con chiarezza l’intervento del pittore settecente-sco Francesco Campora, personalità che in più occasioni ebbe modo di lavorare per commit-tenti sestresi, come documenta non solo la mo-numentale scena con Lo sbarco a Genova delle ceneri di san Giovanni Battista (Genova Sestri Ponente, oratorio del Santo Cristo), datata al terzo decennio del XVIII secolo, ma anche le due belle tele raffiguranti Sant’Erasmo risana un’ossessa e Sant’Erasmo con l’angelo presenti
nella vicina chiesa dell’Assunta (figg. 7-8)20. Si tratta di dipinti che palesano, come la com-posizione dell’oratorio dell’Arciconfraternita Mortis et Orationis, la costante attenzione da parte del pittore ai modelli solimeniani appre-si durante la sua permanenza nella bottega del maestro partenopeo, elementi che nell’opera in esame, databile verosimilmente verso la fine della sua attività – conclusasi con la morte nel 1753 –, sono evidenti soprattutto nell’appari-zione angelica che caratterizza la parte superio-re dell’immagine o in dettagli come il fanciullo che regge il cartiglio posizionato in basso a de-stra o, ancora, nel modo di definire i profondi panneggi che movimentano, con enfasi quasi
scultorea, le vesti dei numerosi partecipanti. Tenuto conto delle notevoli dimensioni, non coerenti con lo spazio architettonico che la ospita, e della sua collocazione, che nasconde alla vista i sottostanti affreschi settecenteschi, appare possibile pensare che anche l’opera di Francesco Campora possa provenire in realtà da una precedente sede. Certo risulta a riguar-do interessante la presenza di un soggetto ana-logo, così particolare, nel vicino oratorio del Santo Cristo (dove sull’altare maggiore svetta la straordinaria composizione di Gregorio de Ferrari), realtà per la quale, come si è già fat-to cenno, Campora ebbe modo di lavorare. Se l’attuale mancanza di notizie rende tale coin-
2. Scultore genovese, Cristo deposto, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis, particolare.
3-4. Scultore genovese, Madonna Addolorata, San Giovanni Evangelista, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
12 13
Gianluca Zanelli Brevi cenni (e qualche spunto) per il patrimonio artistico
cidenza solo un interessante motivo di ricerca, tenuto conto anche della provenienza dall’ora-torio sestrese dedicato al Battista della cassa del Poggio, potrebbe configurarsi comunque come utile spunto per ulteriori indagini l’ipotesi di un’origine dallo stesso edificio pure della tela di Campora. L’opera, che rivela nei confronti della pala del De Ferrari una struttura del te-laio simile sebbene con misure sensibilmente difformi, potrebbe essere stata commissionata dai confratelli del Santo Cristo per sostituire la precedente raffigurazione dipinta da Gregorio, allontanata dall’edificio nel 1746 a seguito del passaggio delle truppe austriache e restituita solo nel 1783 dall’inglese Carlo Haddock21. Durante questo periodo i confratelli potrebbe-ro quindi aver affidato a Campora, prima del
1753, l’incarico di eseguire una nuova pala di identico soggetto con l’intento di non lasciare sguarnito l’altare principale del loro oratorio. Ritornata la tela del De Ferrari nella sua col-locazione originale grazie al munifico gesto del nobile inglese, forse l’analoga composizione realizzata dal pittore genovese settecentesco venne trasferita in seguito, secondo dinamiche simili a quelle individuate per la cassa di Marco Antonio Poggio, presso l’ulteriore realtà con-fraternale sestrese. Si tratta di una ipotetica ri-costruzione dei fatti, ma la particolarità del sog-getto raffigurato e il disomogeneo inserimento del dipinto all’interno dell’apparato decorativo ad affresco che orna la parete di fondo dell’e-dificio, al quale la grande tela è palesemente sovrammessa, appaiono elementi su cui medi-
tare. Sicuramente l’opera non venne eseguita in origine per decorare la zona presbiteriale dell’oratorio, impreziosito da una ricca, conti-nua e articolata superficie affrescata, da riferi-re, come indicato dalle fonti, al quadraturista Giovanni Battista Revello22. Carlo Giuseppe Ratti, nel breve profilo biografico dedicato a questo artista ligure, non mancò infatti di se-gnalare che tra le opere da lui eseguite nella sua carriera si annoveravano anche “i fregi (…) dell’Altar principale nell’Oratorio de Morti” di Sestri Ponente23. Tale cantiere, nel quale l’ar-tista ha dispiegato il suo migliore repertorio, può essere databile nel corso del terzo decennio del Settecento, anche in considerazione della presenza a fianco del Ravello per l’esecuzione delle parti di figura, come confermato anche
da Massimo Bartoletti (comunicazione orale), del bolognese Jacopo Antonio Boni, che in più occasioni ebbe modo di collaborare con il qua-draturista24. L’esecuzione di questo insieme pare forse ascrivibile all’ultimo periodo di attività del Revello, deceduto nel 1732, dopo che Boni nel 1726 si stabilì definitivamente a Genova. L’affidamento dei lavori da parte dei confratelli ai due artisti potrebbe essere derivato dal pre-cedente intervento del quadraturista nella de-corazione della volta della cappella dedicata al Rosario, ubicata nella vicina chiesa dell’Assun-ta25, sacello la cui preziosa facies settecentesca (impreziosita nelle figure degli angeli anche dal pennello del Boni) venne realizzata all’inizio degli anni venti del XVIII secolo, dato che al luglio del 1721 risale l’affidamento allo scul-
5. Scultore genovese, Crocifisso, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
6. Francesco Campora, Imposizione del nome del Battista, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
7. Francesco Campora, Sant’Erasmo risana un’ossessa, Ge-nova Sestri Ponente, chiesa di Nostra Signora Assunta.
8. Francesco Campora, Sant’Erasmo con l’angelo, Genova Sestri Ponente, chiesa di Nostra Signora Assunta.
14 15
Gianluca Zanelli Brevi cenni (e qualche spunto) per il patrimonio artistico
tore Domenico Garibaldo dell’incarico per la realizzazione delle due sculture marmoree raf-figuranti San Domenico e Santa Rosa da Lima, che ancora oggi ornano l’altare26. Un articolato insieme di soggetti scandiscono, secondo un gusto nel contempo armonioso e ridondante, gli spazi del presbiterio dell’oratorio, dominato dalla scena centrale con il Cristo benedicente in gloria (fig. 9), circondata da un complesso insie-me di motivi architettonici che danno forma a un articolato sovrapporsi di piani suggerendo, con sapiente tecnica, una profondità altrimenti inesistente. Esiti che appaiono sempre notevoli nella raffigurazione dei vari personaggi biblici che, alla base della volta, emergono dalle quat-tro aperture collocate ai lati della scena princi-pale, come pure nelle raffigurazioni dell’Angelo
con gli strumenti della Passione e dell’Angelo con il Volto Santo (fig. 10) affrescate sulle pareti del presbiterio, scene dove nella definizione dei volti, delle capigliature, delle membra e dei panneggi appare plausibile la presenza del fare classico di Jacopo Antonio Boni, coadiuvato da alcuni collaboratori, a cui si devono alcuni personaggi meno riusciti. All’artista di origi-ne emiliane possono essere ascritte, tra l’altro, pure due tele raffiguranti la Resurrezione e il Noli me tangere (figg. 11-12), presenti sempre a Sestri Ponente nella chiesa di San Giovanni Battista27, a riprova di un rapporto non occa-sionale con la committenza locale, che espresse scelte in campo artistico aggiornate e consa-pevoli degli esiti raggiunti negli stessi anni in importanti luoghi di culto genovesi.
Descritte le testimonianze figurative più rilevan-ti presenti all’interno dell’oratorio, alle quali si sommano ulteriori manufatti legati alla vita quo-tidiana della confraternita ma per questo non di meno valore, piace concludere segnalando alcuni interventi conservativi realizzati, con cura cer-tosina, da Mariolina Rella della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria e aventi come oggetto alcuni degli elementi che compongono l’importante insie-me di vesti processionali ancora appartenenti al patrimonio della confraternita, questo sì, già da
9. Jacopo Antonio Boni, Cristo benedicente in gloria (con quadrature architettoniche di Giovanni Battista Revello), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
10. Jacopo Antonio Boni, Angelo con il Volto Santo (con quadrature architettoniche di Giovanni Battista Revello), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
11. Jacopo Antonio Boni, Resurrezione di Cristo, Genova Sestri Ponente, chiesa di San Giovanni Battista.
12. Jacopo Antonio Boni, Noli me tangere, Genova Sestri Ponente, chiesa di San Giovanni Battista.
16 17
Gianluca Zanelli Brevi cenni (e qualche spunto) per il patrimonio artistico
alcuni anni, sottoposto a indagine critica da parte di Elena Parma e Fausta Franchini Guelfi28. Beni tra i quali emergono per pregio e raffinatezza ese-cutiva la sontuosa cappa processionale in velluto rosso proveniente in origine dall’oratorio genove-se di San Giacomo della Marina, con tabarrino in velluto arancione (fig. 13), e quella in satin blu, sempre datata alla seconda metà del XVIII seco-lo, acquistata dall’oratorio di San Giacomo alla Fucine; manufatti che per la loro assoluta rilevan-
za storico-artistica hanno ben figurato nel 2010 nell’ambito della mostra dedicata alle confrater-nite in Corsica29. Un prestito che ha reso necessa-rio un intervento conservativo attuato, come già segnalato, da Mariolina Rella, alla quale si deve anche il recentissimo complesso recupero di un gonfalone ottocentesco, di proprietà dell’Arci-confraternita sestrese, che, dopo molti anni di attesa, sta per essere restituito alla proprietà e alla pubblica fruizione30.
1. Novella ms. s.d., c. 195. Cenni sulle vicende dell’oratorio in Casareto 1998, pp. 277-282.2. Remondini 1893, p. 301.3. Novella ms. 1906, c. 336. 4. Novella ms. 1929, c. 476. Nella stessa occasione l’erudito segnalò nuovamente “il grandioso gruppo in legno colla de-collazione di S. Giov. Battista, opera di Marcantonio Poggio”.5. Casareto 1998, pp. 277-282.6. Novella ms. s.d., c. 195; Remondini 1893, p. 301 (con l’indi-cazione del recupero di due lampade d’argento).7. Sulle vicende della cassa si rimanda al contributo di Daniele Sanguineti in questo volume.8. Zanelli 2004, pp. 84-85.9. Sanguineti 2011-2012, p. 462, scheda III.102.10. Sanguineti 2011-2012, p. 462, scheda III.102.11. Novella ms. s.d., c. 195: documenta anche l’arrivo di marmi dalla soppressa chiesa genovese di San Francesco Saverio.12. Per la ricostruzione della vicenda dell’opera: Sanguineti 2011-2012, p. 472, scheda III.130.13. Legno scolpito, intagliato e dipinto, cm 41 x 135 x 43. In questa occasione sono consultate, per ricavare i dati tecnici delle opere, le schede OA del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-rali compilate nel 2001 da Andrea Leonardi e conservate presso l’archivio dell’Ufficio Catalogo della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria. Le datazioni delle opere qui presentate sono frutto di un confronto con Da-niele Sanguineti, che ringrazio per la collaborazione.14. Legno scolpito, intagliato e dipinto, cm 180 x 70.15. Legno scolpito, intagliato e dipinto, cm 130 x 55 (Madonna Addolorata), cm 130 x 63 (San Giovanni Battista).16. Legno scolpito, intagliato e dipinto, cm 95 x 76.17. Avena 2007, pp. 28-35.18. La scultura è inserita all’interno di una grotta che richiama, secondo la narrazione di Jacopo da Varagine, quella di Saint Maxime, nella quale compaioni alcuni putti e vari attributi iconografici legati al personaggio principale.19. Olio su tela, cm 350 x 288. Per l’attribuzione a Travi: Casareto 1998, p. 281. Sulla produzione sacra del pittore seicentesco, con alcuni cenni alla bellissima tela conservata presso l’oratorio di San
Giuseppe a Sestri Ponente e considerazioni riguardo al Matrimonio mistico di santa Caterina della chiesa di Santa Caterina, tradizional-mente riferitogli dalle fonti: Zanelli 2009, pp. 4-13.20. Sul pittore e le opere appena menzionate: Sanguineti 1997, pp. 279-306; D. Sanguineti in Le Storie 2012, pp. 30-33, scheda 3.21. Zanelli 2012, pp. 9-12.22. Ratti ms. 1762 (ed. 1997, p. 116); Ratti 1769, p. 243; Cili-berto 2000, p. 433.23. Ratti 1769, p. 243.24. Botta 2000, pp. 422-423.25. Ratti ms. 1762 (ed. 1997, p. 116); Ratti 1769, p. 243; Cili-berto 2000, p. 433.26. Sanguineti 2011, pp. 30-33.27. Le tele sono state in precedenza ascritte al catalogo di Ro-lando Marchelli: Toncini Cabella 1996, p. 388.28. E. Parma Armani in La Liguria 1982, II, pp. 88-89, schede 76-78, pp. 88-89 (con bibliografia precedente); F. Franchini Guelfi in Les confréries 2010, pp. 480-481, schede 52-53.29. F. Franchini Guelfi in Les confréries 2010, pp. 480-481, schede 52-53. I lavori di restauro sulle vesti processionali e il tabarrino sono stati realizzati da Mariolina Rella negli anni 2010-2011.30. L’intervento è stato eseguito, per la parte tessile, da Mario-lina Rella nel biennio 2012-2013, dopo che per molti anni il manufatto era stato preso in carico dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici a causa di gravi problemi conservativi. La raffigurazione centrale con Angeli che sorreggono un ostensorio è stata restaurata da Giovanni Ziglioli nel corso del 2011.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno facilitato questa ricerca e in particolare: Paolo Arduino, Giacomo Baldaro, Massimo Bartoletti, Grazia Di Natale, Matteo Moretti, Ernesto Roncallo, Daniele Sanguineti, Antonio Silvestri, Daria Vinco. A Mariolina Rella e a Giovanni Ziglioli va la mia particolare gratitudine per la loro fondamentale collaborazione in occa-sione dei restauri sui manufatti dell’oratorio sestrese realizzati negli ultimi anni.
13. Manifattura genovese, seconda metà del XVIII secolo, Tabarrino, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
18 19
La Decollazione del Battista di Marco Antonio PoggioLa DecoLLazione DeL Battistadi Marco Antonio Poggio: il teatro barocco a GenovaDaniele Sanguineti
Il monumentale gruppo raffigurante la De-collazione del Battista, che sfilava per le vie di Sestri Ponente secondo la tipica consuetudi-
ne genovese1, si annovera di fatto tra le più im-portanti testimonianze scultoree superstiti (figg. 14-16)2. Pertinente all’oratorio di San Giovanni Battista e transitato in seguito presso l’Arcicon-fraternita Mortis et Orationis della stessa locali-tà, ove attualmente è custodito3, costituisce un prezioso “incunabolo” della produzione in legno policromo in un momento antecedente all’atti-vità di Anton Maria Maragliano, l’artista più ce-lebre cui si deve il rinnovo dei gruppi itineranti e dei Crocifissi preesistenti4. In realtà il panorama della lavorazione del legno fu, nel primo Seicento, piuttosto viva-ce – come le fonti e i documenti consentono di dedurre – grazie a una nutrita dotazione di opere assicurata, per usi liturgici e processio-nali, dagli eredi di quelle botteghe, in gene-re di origine non autoctona, che si andarono stabilmente a radicare nel corso della seconda metà del secolo precedente5. Il lucchese Ga-spare Forlani, l’urbinate Filippo Santacroce, i lombardi Matteo Castellino e Domenico Bis-soni introdussero progressivamente la scultura di figura, e, con essa, una competenza specifica in parallelo all’attività propria della corpora-zione dei bancalari (ossia falegnami, mobilieri e intagliatori in genere), cui erano obbligati ad afferire per statuto6. Tra le più antiche testimo-nianze pervenute, le casse di Filippo Santacroce per l’oratorio di Sant’Ambrogio a Genova Vol-
tri (1594) e di Domenico Bissoni per l’orato-rio genovese di Santo Stefano (1607)7 danno conto dei risultati raggiunti nella costruzione poderosa dei gruppi processionali, delle storie narrate per mezzo del coinvolgimento di sva-riati personaggi e della progressiva evoluzione di un linguaggio che accoglie, nell’imperante codice della tarda maniera, esigenze sempre più naturalistiche.Disponendo, dunque, di scarsi manufatti, ri-spetto al parterre di opere ricordate dalle fonti in merito all’attività dei protagonisti dell’era pre-maraglianesca, il capolavoro sestrese, pur-troppo ancora privo di circostanziate notizie d’archivio, sembrerebbe nascere dal nulla, in considerazione dell’immensa portata di novità implicite nel modernissimo linguaggio che lo sostanzia.Alla miracolosa disponibilità del gruppo, ora perfettamente leggibile grazie all’impegnativo restauro appena concluso e qui presentato, si contrappone una scarsissima conoscenza del suo autore, Marco Antonio Poggio – secondo l’accezione onomastica tramandata da Sopra-ni8 –, il cui apporto però fu fondamentale per transitare in un nuovo mondo figurativo: dalla maniera attardata condotta nelle botteghe de-gli statuari di origine lombarda, attivi nel pri-mo Seicento, alle vigorose novità irradiate dal-la Roma barocca. Queste ultime, fatte proprie innanzitutto da quegli artisti che le avevano direttamente vedute – si pensi alla sensibilità scultorea di stampo berniniano che il Grechetto
20 21
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
16. Marco Antonio Poggio e collaboratore, Decollazione del Battista, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.14-15. Marco Antonio Poggio e collaboratore, Decollazione del Battista, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis (in questa pagina e nella precedente).
22 23
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
conferì, nel 1645, ai suoi angeli dipinti nella Natività per la chiesa di San Luca9 –, furono introdotte per gradi nella cultura figurativa genovese. Ma una vera e propria accelerazio-ne avvenne in un momento appena successi-vo alla peste del 1656-1657, quando, grazie a una favorevole congiuntura, si definì, in campo pittorico e progettuale, il ruolo di Domenico Piola e si rinnovò profondamente la statuaria
grazie all’apporto del berniniano Pierre Puget e alla formazione romana che nel frattempo, su suggerimento dello stesso Piola, Filippo Parodi stava conducendo10. Ma conviene non indugiare oltre nell’offrire le poche notizie note su Poggio – che nella sua tarda attività si trovò dunque nel bel mezzo di una siffatta congiuntura artistica –, arricchen-dole con qualche traccia archivistica e con va-
rie congetture ricavabili dall’esame del capola-voro disponibile. Il profilo tracciato da Raffaele Soprani, il biografo degli artisti genovesi, collo-cava di diritto lo scultore, per le “molte opere di consideratione”, “fra gli virtuosi”11. Purtroppo però il percorso delineato in quel medaglione biografico, base della rielaborazione settecen-tesca di Carlo Giuseppe Ratti12, non fornisce indizi cronologici né per gli estremi anagrafi-ci né per la datazione delle opere menzionate. Nonostante gli studi “di lettere” desunti da un precettore e i primi rudimenti appresi “con cer-to Scoltore”, il padre, calzolaio, volle che con-ducesse la sua stessa professione13. Convinto in seguito dall’abilità del figlio, decise di affidarlo alla “disciplina” di Domenico Bissoni, tramite l’intercessione di “persona d’autorità”14. Il mae-stro lo impiegò nei “soliti abbozzi che a princi-
pianti si porgono” per giungere, dopo aver veri-ficato la sua spiccata idoneità, non solo a “carte ben historiate e di perfetti maestri”, ma soprat-tutto alla presenza attiva all’interno di quella “profitevole accademia”, tenuta dal figlio Gio-vanni Battista Bissoni, nella quale si disegnava e si modellava dal vero: “destreggiossi costui da principio con la penna & in appresso vi si approfittò valorosamente con modellare”15. Lo stesso Soprani poneva in luce che la prassi di far “spogliar un’huomo”, “fermandolo in alcuna scielta attitudine”, per disegnarlo o modellar-lo nella creta, era, normalmente, costume dei pittori16. Ratti dedicò righe più circostanziate a questa rigorosa formazione avvenuta nel con-testo di quella che egli non potè far altro che appellare Accademia del Nudo: “In essa diede luogo al suo Condiscepolo, il quale col copiare
17. Marco Antonio Poggio, Altare maggiore, Genova Sestri Ponente, chiesa di San Martino di Tour.
18. Marco Antonio Poggio, San Giovanni Battista (partico-lare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
19. Marco Antonio Poggio, Carnefice (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
24 25
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
20. Marco Antonio Poggio, Salomè (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis. 21. Marco Antonio Poggio, Salomè (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
26 27
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
ora in carta col matitatoio, ed ora in creta con le stecche il naturale modello si rendè in breve capace di figurar corpi umani, ed esprimerne i lor varj atteggiamenti”17.Sembrerebbe, dal racconto di Soprani – se-condo il quale Domenico Bissoni portò a com-pimento, in contemporanea, la formazione di Poggio e del figlio –, che Marco Antonio fosse perlopiù coetaneo di Giovanni Battista, il quale, probabilmente, nacque tra il primo e il secondo decennio del secolo18. Domenico iniziò a impiegare il discepolo nelle opere in lavorazione nella propria bottega, facendogli “abbozzar qualche figurina”, fino a utilizzarlo “a finimenti di figure & altri lavori di considera-tione”19. Continuando “per qualche tempo ad operare in tal guisa” nell’officina bissonesca, giunsero a tal punto fama e commissioni che, “con buona licenza del maestro”20, Poggio, nel frattempo divenuto “ben esperto nel disegno, nell’invenzione, nel modellare e nel maneggia-re degli scarpelli”21, aprì uno studio in proprio. Il successo, in un momento posteriore, lo spinse a recarsi in Spagna, “dove dopo due anni grave-mente infermò, e poco stante vi cessò di vivere in età ancor fresca”22. Leggendo tra le righe della biografia e tenendo ben a mente i risultati raggiunti nella Decolla-zione di Sestri Ponente, è utile fornire alcuni indizi cronologici plausibili: un’opera di tale novità e portata, come oltre si dirà, non si può datare a un momento antecedente, quanto-meno, alla metà del secolo. La partenza per la Spagna, dove rimase due anni (unico indizio cronologico fornito dai biografi), potrebbe cer-to essere giustificata da una prestigiosa commis-sione avvenuta, probabilmente, negli anni ses-santa: “sopravenne ordine di portarsi in Spagna chiamato colà per essercitare la sua virtù”23. In ogni caso è certo che Poggio fosse già defunto nel 1674, anno della pubblicazione delle Vite di Soprani. Che la morte fosse avvenuta in “im-matura età”24 sottenderebbe poi l’appartenen-za alla stessa generazione di Giovanni Battista Bissoni, con cui svolse il discepolato presso
Domenico, il quale “ad ambi ugualmente inse-gnava”25. È inoltre necessario sottolineare un elemento, interessante quanto problematico, che potrebbe collocare alla seconda metà de-gli anni venti l’inizio del rapporto con Bissoni: infatti nel giugno 1626 tal Giovanni Antonio Poggi, di quindici anni e figlio di Battista, veni-va “accartato” da Domenico al fine di “discenda arte bancalari et scultore” per un periodo, più limitato del solito, di quattro anni e sei mesi26. Si trattava, mettendo in conto un parziale erro-re onomastico – da parte del notaio o da parte di Soprani –, del nostro scultore? Sembrerebbe del tutto probabile e, in tal caso, Poggio sarebbe nato nel 1611. Ma dando credito alla narrazio-ne del biografo – che così tanto aveva insistito su un lungo rapporto di collaborazione con i Bissoni –, non si spiegherebbe un dato incon-trovertibile, ossia l’assenza del giovane dalla tassazione del 1630 – che funge da censimento sulla presenza degli artisti e degli artigiani co-stretti a metter mano alle loro tasche per l’ere-zione delle mura nuove –, sia nella categoria dei bancalari sia in quella dei “celatores”, ove invece compaiono sia Domenico che Giovanni Battista Bissoni27. Ciò potrebbe significare che, se non fosse esatta l’ipotesi di identificare Mar-co Antonio con l’apprendista Giovanni An-tonio, il nostro dovesse ancora iniziare il suo percorso, fatto improbabile pensando che la cassa di Sestri Ponente, come si argomentava, presuppone un’esecuzione da parte di uno scul-tore maturo; oppure che, ultimato proprio nel 1630 il discepolato – dal 1626 al 1630 i quat-tro anni si erano contrattualmente estinti –, il giovane avesse desiderato, temporaneamente, uscire dalla patria. Si deve, nel caso, ricollocare a Genova in un momento di poco successivo al 1634, quando fu consacrata la chiesa cappuccina di San Martino di Tour, a Sestri Ponente, ed egli pose mano, sempre secondo Soprani – che die-de conto anche delle competenze d’architetto e della sua “pratica d’ornare prospetti, facciate, e cose simili”28 –, all’altare maggiore in legno29, esemplato su un’aggiornata partitura romana, 22. Marco Antonio Poggio, Fantesca (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
28 29
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
come dimostra l’utilizzo delle colonne con timpano spezzato ruotate all’esterno (fig. 17). Nozioni di architettura, ricordate dal biografo attraverso questo impegno, si riflettono anche nella stessa Decollazione, come mostra l’effica-ce rovina architettonica che, nel contempo, suggerisce lo spazio narrativo e offre un perno d’innesto, sotto forma di elegante cornicione modanato e incurvato, per una ruotante e ag-gettante gloria celeste, costituita, tra le nubi, da due arcangeli, tre angioletti e altrettanti cherubini.“A Sestri di Ponente (...) vi è una cassa, ope-ra delle di lui mani, con la Decolatione di San Gio Battista, ricca di più figure e ben intesa”30: grazie, nuovamente, a Soprani è possibile di-sporre di un’opera certa relativa a uno scultore di cui è verificabile, per suo tramite, il ruolo dirompente e rivoluzionario. La piattaforma presenta una gradinata sulla quale sono di-sposte dieci grandi figure e due animali – uno accessorio (il cane) e uno di pertinenza icono-grafica (l’agnello) – in un complesso intreccio di relazioni, gesti e sguardi che culminano nella sospensione dell’attimo tragico: il boia, vigoro-so e con il busto in torsione (trattato realistica-mente con l’addizione di un ciuffo di peluria ad altorilievo al centro del petto), sta per sferrare il colpo mortale al diafano santo, elegantemen-te genuflesso su un primo piano (figg. 18-19). E poi svariati personaggi complementari conferi-scono un andamento nel contempo piramidale e circolare alla grandiosa compagine: un paggio moro, un carcerato (poiché la scena si svolse in una prigione), un soldato alabardiere e uno reggi fiaccola (con la funzione narrativa di illu-minare la cella), Salomè (figg. 20-21) e la vec-chia ancella, pronta, come lascia intuire la po-sizione della mano, a raccogliere il capo in una cesta (fig. 22), e il gruppo d’angeli che, in un intreccio d’ali, sovrasta l’evento, rivelatori per il popolo dei fedeli del mondo celeste (fig. 23). Nonostante la partitura fosse concepita per una fruizione da tutti i lati, la visione del lato breve anteriore (fig. 14) permette, nel contempo, un
calcolato sguardo d’insieme, favorevole a tutti gli attori, cadenzati nello spazio, e ai protagoni-sti, elevati al centro con una direttrice apicale: santo, boia, spada, gloria. Ma non stupisce solo l’ampio respiro scenico, già distante dai pur notevoli progressi in chiave di composizione esaminati nelle opere di Giovanni Battista Bis-soni finora note – per esempio la Madonna del Voto del 1637, ora conservata in una frazione di Genova Voltri31 –, piuttosto la fluidità lin-guistica che, pur fondata sulla riproduzione del dato naturale, crea soluzioni auliche nelle pose dei personaggi seduti o appoggiati alle gradina-te, effetti scenografici nella resa abbondante e contrastata dei panneggi, raffinatezze di scrit-tura nella delineazione dei volti e nel rilievo ondulato, e non più raggrumato, delle chiome e delle barbe. Ratti, sulla scorta di Soprani, la descriveva come “macchina copiosa di figure assai naturali, ben disposte ed atteggiate”32, affiancandola ad altre opere attribuite allo scultore, ossia le cas-se processionali per gli oratori genovesi di San Tommaso e di San Giovanni di Prè, il Crocifisso per l’oratorio di Santa Brigida e una raffigura-zione di “Nostra Signora di Monferrato” per la chiesa di Santa Caterina. Quest’ultima, sortita dagli “industriosi suoi scalpelli” ed esposta alla venerazione nella “maestosa cappella” Spino-la, veicolava il culto spagnolo della Madonna di Montserrat in una delle sedi genovesi dei monaci benedettini, già distrutta alla fine del Settecento33. Dalla cassa eseguita per l’oratorio di San Tommaso, che il biografo inseriva tra le prime opere realizzate in autonomia, si può ricavare un ulteriore spunto cronologico, dal momento che Paolo Novella, nel 1912, ricor-dava la presenza in loco di una lapide nella quale veniva menzionato il contributo di 400 lire per l’esecuzione dell’opera – raffigurante il santo in atto di toccare il costato al Cristo Risorto –, avvenuta nel 164134. Anche dell’altra cassa di-spersa, quella per l’oratorio di San Giovanni di Prè, è possibile dedurre un nuovo dato utile per l’auspicabile riconoscimento futuro (sperando
30 31
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
non sia stata distrutta ma ceduta a qualche ora-torio periferico). Non venne infatti sostituita, come ricordava Ratti, con l’arrivo del gruppo maraglianesco, raffigurante San Giovanni Evan-gelista in Patmos (ora a Ponzone [Alessandria], oratorio del Suffragio)35, poiché in realtà rap-presentava un diverso momento agiografico del santo, ossia il supplizio “nella caldara”, e fu ancora visionata in loco da Accinelli, nel 1774, unitamente a quella di Maragliano36. Infine ri-sulta attualmente disperso anche il Crocifisso eseguito da Poggio, secondo i biografi, per l’o-ratorio di Santa Brigida37, giacché l’ipotesi di riconoscerlo in quello, tradizionalmente appel-lato il Brigidone e ora conservato nello stesso oratorio sestrese di Mortis et Orationis (figg. 1, 24)38, è contraddetta dal linguaggio – del tutto consono al fare di Giovanni Battista Bissoni –, dalla particolarità iconografica ricordata dalle fonti, che lo qualificavano come un Cristo “spi-rante” (mentre quello in oratorio è spirato), e dal fondamentale appunto riportato da Novel-la, che confermava la provenienza originaria del bel simulacro ora a Sestri Ponente dall’ora-torio genovese dei Santi Giacomo e Leonardo di Prè39. Invece, pur in assenza di indizi proban-ti, varrebbe la pena di meditare ulteriormente sul Cristo spirante della chiesa dei Diecimila Crocifissi (fig. 25), costantemente identificato con quello veduto da Soprani nell’oratorio ge-
Nella pagina precedente:23. Marco Antonio Poggio e collaboratore, Angeli in gloria (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
In questa pagina:24. Giovanni Battista Bissoni, Crocifisso, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis, particolare.
25. Gerolamo Del Canto (?), Crocifisso, Genova, chiesa dei Diecimila Crocifissi, particolare.
26. Scultore genovese (Marco Antonio Poggio?), Crocifisso, Ge-nova, oratorio di Sant’Antonio Abate della Marina, particolare.
Nella pagina a fronte:27. Marco Antonio Poggio, San Giovanni Battista (partico-lare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
32 33
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
divaricate, un braccio steso indietro e l’altro alzato a creare un’ampia gestualità culminante in quella spada brandita – vero pezzo metallico di artiglieria – che ne amplifica la risonanza. Questa coppia cruciale, di cui tutti gli altri per-sonaggi sono corteggio, evidenzia, soprattutto per l’impostazione del boia, la conoscenza del
Poggio di conoscere, meditare e riproporre i più aggiornati spunti della statuaria barocca roma-na. Il Battista, in forma di bellissimo giovane genuflesso, presenta un movimento avvitante, sottolineato dall’andamento sinuoso del man-to. In serrata successione prospettica, il boia so-vrasta la scena, cercando stabilità con le gambe
maso Orsolino, costantemente fedele alla sua tarda maniera e impermeabile, fino alla morte, perfino alle innovazioni di Puget43. I termini della questione sono delicati e da affrontare, necessariamente, sul piano della tecnica: come possibile passare da forme abbreviate, tondeg-gianti e scarsamente incise (le statuette quasi monolitiche di Genova Quarto), benché messe in atto in gioventù, a una grafia morbidissima, contrastata, con effetti di elegante naturalismo nella fluida scorrevolezza dei panni e nei rivoli sinuosi conferiti alla barba e alle chiome? Che il vero Crocifisso di Del Canto, veduto da So-prani, fosse andato perduto e che questo invece sia opera di Poggio, magari proprio quello spi-rante di Santa Brigida? Ipotesi per ora fantasio-se, ma necessarie come quesiti da formulare in chiave critica: del resto, similmente, è giunto il momento di includere in questa problematica congiuntura anche il Crocifisso moro, realizza-to in legno di giuggiolo e molto rimaneggiato nel panneggio, che si trova presso l’oratorio di Sant’Antonio Abate alla Marina44: tradizional-mente assegnato a Domenico Bissoni, va inve-ce letto in chiave poggesca, perché quel volto (fig. 26), dal punto di vista costruttivo e di sin-tassi scultorea, non si può che accostare al viso del nostro Battista (fig. 27), allontanandolo da qualsiasi opera nota bissonesca. Proprio il Bat-tista della cassa sestrese offre il pieno senso della portata innovativa che implica uno studio lun-go, profondo e caparbio messo in atto dall’ar-tista al fine di allinearsi a una nuova cultura figurativa, mai vista prima a Genova in cam-po scultoreo e perfino distante dagli esiti, già giudicati con spirito d’avanguardia da Soprani, raggiunti da Giovanni Battista Bissoni. Tale ca-pacità, probabile frutto di una diretta visione dei capolavori della Roma barocca, attecchì su una modalità progettuale basata non solo sulla modellazione dei bozzetti, necessari per lo stu-dio preliminare, ma anche, necessariamente, sul disegno, visto che il biografo ricordava, per lo scultore, la possibilità di “maneggiare i pen-nelli”45. Furono questi i mezzi che permisero a
novese del Santissimo Crocifisso dei Cruciferi e assegnato a Gerolamo Del Canto40: la critica ha sempre dovuto inchinare il capo di fronte a un’attribuzione che continua a porre problemi di non poco rilievo, soprattutto per lo sforzo di conciliare un tale capolavoro, dalla scrittura prossima a quella messa in atto da Poggio, con l’altra cassa assegnata allo scultore, allievo dei Santacroce, ossia il Martirio di san Bartolomeo conservato nell’omonimo oratorio di Genova Quarto e del tutto in linea con l’attività di uno scultore formato presso quella scuola41. Natu-ralmente si ritiene ancora valida l’ipotesi che Del Canto, già attivo in autonomia nel 161742, dovesse aver trovato il modo di adeguare, nel corso di una non breve attività, tecnica e in-venzione alle nuove spore di stampo romano. Nel caso, però, sarebbe l’unico artista a metter in atto un siffatto cambiamento, rifiutato e for-se incompreso da tutti i componenti della fami-glia Santacroce, attivi fino alla metà del secolo, e pure da uno scultore in marmo come Tom-
28. Alessandro Algardi, Decollazione di san Paolo, Bologna, chiesa di San Paolo Maggiore.
30. Alessandro Algardi, Carnefice, San Pietroburgo, State Hermitage Museum, inv. 661.
29. Marco Antonio Poggio, Carnefice (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
34 35
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
ta che diretta, come dimostra l’affinità piutto-sto spiccata del nostro boia soprattutto con il bozzetto in terracotta del carnefice algardiano, ora conservato all’Hermitage (fig. 30), di gran lunga più sottile, scattante e realistico rispetto all’opera finita47. Possibile immaginare Poggio intento a curiosare nelle botteghe dei grandi scultori romani, pronto ad appuntarsi idee? Sembrerebbe confermarlo un aggiornamento praticato in simultanea, giacché la resa del san-to (fig. 32), tortile, parzialmente genuflesso e con le mani alzate, ma nel contempo giunte di lato – ancora del tutto inedito per Genova –, riprende, in controparte, il Daniele scolpito da Bernini entro il 1657 per la cappella Chigi in Santa Maria del Popolo a Roma (fig. 31)48.La possibilità d’espatrio si adatta, in effetti, alle novità dirompenti notate nella cassa sestrese, dove non solo è implicita una conoscenza dei Sacri Monti piemontesi e lombardi e dei loro meccanismi fortemente teatrali49, ma anche una consapevolezza della statuaria barocca di deriva-zione romana. Non è pensabile infatti, in una città come Genova avvezza alla circolazione di opere e artisti, che all’idea innovativa inaugu-rata dai Bissoni di strutturare la bottega con la connotazione di un’Accademia del Nudo, in cui si disegnava, si modellava la creta e si scolpiva con il modello innanzi, non facesse seguito un aggiornamento culturale per mezzo della raccol-ta di stampe, se non del diretto viaggio. Ma al di là della visione delle opere algardiane e berni-niane intorno agli anni finali del decennio cen-trale del secolo, fatto che per ora non è possibile certificare, è innegabile un costante aggiorna-mento messo in atto dallo scultore anche per al-tre vie. Oltre a un attento studio praticato sulle pale d’altare dipinte dai pittori genovesi della realtà, tra cui Andrea Ansaldo, Orazio De Fer-rari e Domenico Fiasella, e una comprensione dello spazio barocco tracciato da Rubens nelle opere lasciate in città – si pensi alle affinità tra gli angeli proiettati nello spazio nella parte supe-riore della Circoncisione sull’altare maggiore del Gesù e quelli che svettano sulla sommità della
gruppo marmoreo realizzato da Alessandro Al-gardi, dal 1635, per l’altare maggiore della chie-sa barnabita di San Paolo Maggiore a Bologna (fig. 28)46. Infatti, per il rapporto d’impagina-zione del santo sovrastato dal proprio carnefice e soprattutto per la scelta di porre l’attenzione sulla violenza imminente – tramite la postura di quest’ultimo con il torso nudo tutto avvitato per sferrare il colpo (fig. 29) –, si direbbe in-dubbia una suggestione derivante dal gruppo marmoreo. Una conoscenza, forse, più media-
31. Gian Lorenzo Bernini, Daniele, Roma, chiesa di Santa Maria del Popolo.
36 37
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
Nella pagina precedente:32. Marco Antonio Poggio, San Giovanni Battista (partico-lare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
In questa pagina:33. Marco Antonio Poggio e collaboratore, Soldato reggi-fiaccola (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
34. Marco Antonio Poggio e collaboratore, Assistente del carnefice (particolare della Decollazione del Battista), Geno-va Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
35. Scultore genovese, Spogliazione di Cristo, Genova, chie-sa della Santissima Annunziata del Vastato, particolare.
Nella pagina a fronte:36. Marco Antonio Poggio e collaboratore, Soldato alabar-diere (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
38 39
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
Nella pagina a fronte:37. Marco Antonio Poggio, Carnefice (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
In questa pagina:38. Marco Antonio Poggio, Carcerato (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
39. Marco Antonio Poggio, Fantesca (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
40 41
La Decollazione del Battista di Marco Antonio PoggioDaniele Sanguineti
que potrebbe condurre davvero tra la fine degli anni cinquanta (ma comunque successivamente al Daniele berniniano) e i primi anni del decen-nio successivo. Anni in cui l’imperversare della peste a Genova (1656-1657) potrebbe aver giu-stificato la necessità di allontanarsi dalla patria.L’opera di Poggio rivela poi una bottega dotata di qualche allievo, dal momento che la grafia di alcuni personaggi, in particolare i volti di al-cuni angioletti, dei due soldati (figg. 33, 36) e dell’assistente del carnefice (fig. 34), pare più dilatata, volumetrica e inespressiva rispetto ai visi, fortemente caratterizzati e vigorosamente o morbidamente incisi, dei due protagonisti (figg. 27, 37), della fantesca e del carcerato (figg. 38-39), figura quest’ultima che nuova-mente indica un modello extra genovese (ro-mano? emiliano?). Il nobile passo con cui in-cede Salomè e che detta, impartendo l’ordine alla realistica serva, una partitura articolata all’andamento dei panni, suggerisce un totale apporto del maestro (fig. 20), come del resto il meraviglioso Battista, proiettato nello spazio grazie a quell’inchino cortese (figg. 32, 40). L’osservazione del gruppo implica, nel contem-po, doti di scenografo e di ingegnere, poiché Poggio non solo subordinò l’esecuzione delle singole figure alla disposizione lungo la peda-na gradinata, ma introdusse la rovina architet-tonica come quinta che cela, all’interno, un robusto palo metallico, imperniato al di sotto della piattaforma di base, a cui è agganciata la gloria angelica (fig. 65). Si pensi dunque quanti stimoli quest’opera – sia per le nuove modalità, fluide e retoriche, di disporre i panneggi, sia per la naturalezza dei movimenti assunti dai personaggi, sia per il complesso impianto strutturale –, dovet-te offrire ai protagonisti del secondo Seicento nel campo della scultura in legno, Giovanni Andrea Torre, Honoré Pellé e il più giovane Anton Maria Maragliano, il quale, negli anni venti del secolo successivo, non poté far altro che ricorrere a questo stesso gruppo, omaggian-dolo, per allestire la propria Decollazione, ora ad Ovada (fig. 41)55.
cassa sestrese (fig. 23)50 –, è ipotizzabile un alli-neamento con quanto andava praticando, negli anni centrali del secolo e soprattutto nel primo lustro degli anni sessanta, il pittore più moder-no, colui che meglio comprese e diffuse le novi-tà derivanti dai maggiori cantieri romani (e non solo): Domenico Piola. Sembrerebbe plausibile, alla luce dell’esegesi tentata, spostare il gruppo sestrese ai primissimi anni sessanta, collocando-lo proprio sotto l’egida di Piola, il quale, nella pala con San Tommaso d’Aquino, realizzata per la chiesa genovese di San Domenico e datata 166051, dimostrava l’avvio di un percorso in cui contava-no l’attenzione verso la cultura bolognese – è evi-dente l’interesse verso l’Algardi per la tipologia del Cristo in croce –, la plasticità delle forme e il possesso di quello spazio barocco appreso, in parte, dalla geniale esperienza di frescante con Valerio Castello e, soprattutto, da una giova-nile esperienza romana. Già Fausta Franchini Guelfi aveva iniziato a percorrere questa strada, formulando l’ipotesi che Poggio fosse venuto a conoscenza, con ogni probabilità, assai prima, se pure per via indiretta, “del nuovo linguaggio figurativo che a Roma era stato inaugurato dal Bernini e da Pietro da Cortona, attraverso i di-pinti e le incisioni del Grechetto”52. È questo il primato sul quale pare necessario insistere, poi-ché l’arca poggesca si pone, a quanto oggi è dato conoscere, all’esordio di una nuova modalità scultorea, forse in contemporanea con la prima attività genovese di Pierre Puget, a Genova dai primi anni sessanta, ma con un decisivo antici-po decennale rispetto alla produzione in marmo, tutta romana, di Filippo Parodi53. Tale ipotesi di cronologia, nell’ostinata assenza di carte d’archi-vio sull’opera, pare favorita anche dai risultati offerti dall’analisi dendrocronologica. Lo scarto temporale, attendibile al 95,4%, prevede che l’essenza lignea utilizzata non sia anteriore al 1460 e successiva al 165054. Una tecnica ese-cutiva sicura – per la quale Poggio si avvalse di tronchi pieni da cui ricavò quasi interamente le figure limitando l’aggiunta di blocchi –, certifica un prolungato tempo di stagionatura, che dun-
42 43
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
Alcune aggiunte al catalogo del Poggio non reggono il confronto con la cassa sestrese, ma offrono, viceversa, un indizio per la progres-siva acquisizione di una tecnica innovativa. Che l’Angelo Custode di Varese Ligure (fig. 42), qui attribuito56, sia collegabile a una puntuale documentazione del 1646, determina davvero una comprova della messa in atto, nella posa dinamica, nella levigata bellezza delle for-me, nella sciolta scorrevolezza dei panneggi, nell’incisività delle chiome, di elementi giun-
ti da un aggiornamento sulle coeve proposte dei pittori – in particolare, di nuovo, un gio-vanissimo Domenico Piola57 –, riscontrabili al sommo grado nella Salomè sestrese. Si ribadi-sce come l’attenzione, più volte sottolineata, all’ambiente dei pittori possa far comprendere la bontà delle informazioni fornite da Soprani a proposito del metodo bissonesco sul quale Poggio basò la propria formazione, giungen-do a riprodurre col mezzo grafico le carte dei “perfetti maestri” e, in seguito, a disegnare e
Nella pagina precedente:40. Marco Antonio Poggio, San Giovanni Battista (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
In questa pagina:41. Anton Maria Maragliano, Decollazione del Battista, Ovada (Alessandria), oratorio di San Giovanni Battista.
42. Marco Antonio Poggio, Angelo Custode, Varese Ligure (La Spezia), chiesa di San Giovanni Battista.
43. Marco Antonio Poggio, Contadina orante, ubicazione sco-nosciuta (già Piancastagnaio [Siena], collezione Bigazzi).
44 45
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
Homo di Genova Prà (fig. 47)63 – rappresenta davvero, per il tono drammatico e la comples-sità dell’insieme, una delle più valide risposte alle sollecitazioni poggesche, da parte di uno scultore dello stesso entourage (o bottega?) e di raffinata grafia. Addirittura il soldato alabardie-re richiama, per postura, lo stesso personaggio nella compagine sestrese (fig. 35). Giudizio ugualmente applicabile al nucleo centrale della complessa Flagellazione di Gavenola64, sia per il bellissimo e morbido protagonista, innega-bilmente imparentato con il Battista poggesco (fig. 48), sia per l’affinità tra il carnefice di sini-stra in quest’ultimo gruppo e la mano ausiliatri-ce che scolpì i soldati nella cassa di Sestri.Infine non si può non dar conto di un aspetto importante dell’arca sestrese, quello che contri-buisce a vitalizzare l’intaglio attraverso un mera-
considerare lavoro di Poggio anche la Madon-na Regina appare a san Bernardo, proveniente dall’antico oratorio di San Bernardo e dei Re Magi e ora nella sacrestia della chiesa di San-ta Maria di Castello a Genova (fig. 45)61: una perentoria attribuzione a Giovanni Battista Bissoni da parte di Alizeri – che citava i re-gistri contabili –, sembra declinabile, per via della scrittura scultorea e delle tangenze con i personaggi della cassa sestrese, a favore di Pog-gio, forse attivo a condurre una commissione bissonesca.Le innovative modalità suggerite dal nostro scultore non dovettero lasciare indifferenti al-cuni artisti attivi nel terzo quarto del secolo: la Spogliazione di Cristo alla Santissima An-nunziata del Vastato (fig. 46)62 – che parrebbe condividere un ambito d’autografia con l’Ecce
a modellare dal vero58. Proprio la resa natu-ralistica dei volti e la capacità di conferire una naturalezza, benché forbita e scenografi-ca, ai panneggi implicano, contrariamente a quanto ancora accadeva per la tradizionale impostazione tardo manieristica condotta dai Santacroce o, nel marmo, da Tommaso Or-solino, uno studio attento della realtà, una conoscenza dei modelli classici e delle grandi novità romane. Le esigenze compositive delle storie articolate nel legno e dipinte con esiti di verosimiglianza potevano accentuare dati di realismo popolaresco, come accadde per la Contadina orante (fig. 43)59 – parte di una più articolata e dispersa compagine – e la Nativi-tà del Battista di Cervo (fig. 44)60, dove Elisa-betta è sorella dell’anziana fantesca recitante nella Decollazione. Non è escluso che si possa
44. Marco Antonio Poggio, Natività del Battista, Cervo (Sa-vona), chiesa di San Giovanni Battista.
45. Marco Antonio Poggio (?), La Madonna Regina appare a san Bernardo, Genova, chiesa di Santa Maria di Castello, sacrestia, particolare.
46. Scultore genovese, Spogliazione di Cristo, Genova, chie-sa della Santissima Annunziata del Vastato, particolare.
47. Scultore genovese, Ecce Homo, Genova Prà, chiesa di Santa Maria Assunta.
48. Scultore genovese, Flagellazione, Borghetto d’Arroscia (Imperia), frazione Gavenola, chiesa di San Colombano Abate, particolare.
46 47
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
che ornano il busto corazzato degli armigeri e i corsetti delle figure femminili. La veste di Salomè (fig. 50), in particolare, presenta un’alternanza di bande, rialzate in stucco, dorate e punzonate, e condotte unicamente a pennello con mazzetti flo-reali su base azzurra, lievi come se fossero i decori di un arredo. Un simile schema, più semplificato nei decori ma ugualmente ricco di raffinatezze, si ritrova sulle vesti del paggetto moro (fig. 52) e del fanciullo che, sostenendo la croce astile, chiude la visione circolare della storia, sul lato breve posteriore (fig. 51).
viglioso effetto, nel contempo, sontuoso e reali-stico: la policromia è infatti originaria, come si è dimostrato nel corso del restauro e gli occhi sono tutti in lamella vitrea (con l’iride azzurra che con-trasta con l’incarnato arrossato per il diabolico boia; fig. 37). Il ricchissimo repertorio di motivi floreali è in effetti databile a un momento ante-riore al pieno barocchetto (cui finora era stata fat-ta risalire), come dimostra l’andamento pausato dei numerosi decori (ad esempio i mazzi floreali cosparsi sul manto del Battista65; fig. 49), dei gal-loni in forte rilievo e dei motivi, a grandi racemi,
49. Marco Antonio Poggio, Decollazione del Battista, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis, particolare della policromia del manto di San Giovanni Battista.
Nella pagina a fronte:50. Marco Antonio Poggio, Decollazione del Battista, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis, particolare della policromia della veste di Salomè.
48 49
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
Nella pagina a fronte:51. Marco Antonio Poggio, Fanciullo reggi croce (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
52. Marco Antonio Poggio, Paggio moro (particolare della Decollazione del Battista), Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis.
50 51
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
per l’aggiornamento di identificazione e attribuzione il saggio di Gianluca Zanelli in questo stesso volume.39. Il modellato anatomico è vigoroso, il fluire del corpo è molto armonico, dettato da intenti di realismo ma, nel con-tempo, sublimato da una dignità classica. Spicca, osservando il volto dai tratti molto marcati, le chiome e la barba incise quasi a sbalzo e i fitti piegami del perizoma, arrotondati sulle creste, un’affinità stringente con le opere di Giovanni Battista Bissoni, in particolare il simulacro della chiesa di San Luca. Paolo Novella, che in un primo tempo aveva annotato, per il “grande Crocifisso, opera del Bissoni, detto degli Scalpellini”, pertinente alla confraternita dei Santi Giacomo e Leonardo di Prè, una collocazione privata (“oggidì si conserva presso una privata famiglia nella nostra città”), in seguito aggiornò le in-formazioni, evidentemente dopo un atto munifico da parte dei privati a favore dell’oratorio sestrese: tra le opere illustrate in quest’ultima sede, infatti, annotò il Crocifisso attribuito a Gio-vanni Battista Bissoni, “dicasi già spettante al distrutto oratorio dei Santi Giacomo e Leonardo di Prè in Genova” (Novella ms. post 1931, c. 195). Alizeri (1875, p. 376) vide l’opera, attribu-ita a Giovanni Battista Bissoni “se ben guardo allo stile”, nella chiesa di San Bartolomeo dell’Olivella, ove la confraternita, dopo la soppressione del 1811, si trasferì dall’originaria sede nell’antica Darsena, fino alla definitiva estinzione (1860). 40. “Nella chiesa delli Incrociati vi fece un Christo in croce as-sai bello”: Raffaele Soprani ricordò la scultura tra le pochissime opere citate per esemplificare il lavoro “virtuoso” di Gerolamo Del Canto (Soprani 1674, p. 198). Ratti, nella rielaborazione delle Vite di Soprani, confermò la citazione, precisando che l’opera “sta locata nell’Oratorio detto degl’Incrociati, a capo del Borgo di esso Bisagno” (Soprani, Ratti 1768, p. 357). Fe-derigo Alizeri la segnalò nella nuova sede, “formata in legno da Gerolamo del Canto soprannominato il Pomo, discepolo del Santacroce, ed unico saggio che ne resti” (Alizeri 1875, p. 612). Giustamente Fausta Franchini Guelfi (in La Liguria 1982, p. 31, scheda 14) osservava che se il Soprani non avesse chiara-mente indicato nel Del Canto l’autore di questo Cristo a pochi anni dalla morte dell’artista, non sarebbe possibile attribuire alla stessa mano la cassa di San Bartolomeo di Quarto.41. Per il Del Canto e la cassa di Genova Quarto: Franchini Guelfi 1973, pp. 51-52; Sanguineti c.d.s.b
42. A quella data risulta attivo a realizzare tabernacoli per le parrocchiali di Fraconalto e di Isola del Cantone: Scandurra 1997-1999, pp. 323-327.43. Per Tommaso Orsolino: Alfonso 1985; Parma Armani 1988, pp. 72-76.44. Genova, oratorio di Sant’Antonio Abate della Marina (provenienza: oratorio di San Giacomo delle Fucine), cm 180 circa: Piaggio 1887, p. 708; Novella ms. 1912 (ed. 2003, p. 47); Cervetto 1903, p. 171; Grosso 1939a, p. 34; Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 291]; Franchini Guelfi 1973, p. 54; F. Franchini Guelfi in La Liguria 1982, pp. 30-31, scheda 13. Risulta segna-lato per la prima volta dall’anonimo del 1818, tra i richiami di spicco della confraternita di San Giacomo delle Fucine (Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 291]). Le fonti più antiche non citarono l’opera, che per la prima volta fu assegnata a Domeni-co Bissoni nei poemetti del Piaggio (1887, p. 708). Poco dopo Paolo Novella lo attribuì a Giovanni Battista Bissoni (Novella ms. 1912 [ed. 2003, p. 47]). La critica moderna si è accostata con sacrale approccio, mantenendo inalterata la tradizionale
il costato a Christo Signor Nostro”, un “componimento invero bellissimo, e ben aggiustato” (1674, p. 193). Segnalata anche nei manoscritti di Viale (ms. 1742, c. 92) e Giscardi (ms. 1754, c. 76), la cassa fu nuovamente inserita nella rielaborazione rat-tiana della biografia dedicata allo scultore da Soprani: “Si vede in essa rappresentato questo Santo innanzi al risorto Cristo, che gli mostra le cicatrici delle Piaghe, in sembiante di ripren-sione, ed insieme di soave benignità” (Soprani, Ratti 1768, p. 362). Ratti sottolineò che tale macchina era “tuttora” conser-vata in oratorio, notizia che sembra conflittuale con il ricordo di una cassa di identico soggetto, nella stessa sede, attribuita a Honoré Pellé (Ratti ms. 1762, c. 201v [ed. 1997, p. 230]; Bello-ni 1988, p. 146; Sanguineti 1996, p. 115; Fabbri 2003, pp. 189, nota 8, 192, nota 40). Non è dato sapere se Ratti si confuse o se in effetti il gruppo poggesco venne sostituito con uno nuovo ordinato al Pellé nel corso, verosimilmente, dell’ultimo quarto del Seicento. Di entrambi i gruppi, eventualmente, si persero le tracce durante le soppressioni del 1811, come confermò Ali-zeri, a proposito della sola cassa del Poggio, ancora nel 1875: “Una Cassa che avean pure a quest’uso scolpita dal Poggio, n’andò a distruzione” (Alizeri 1875, p. 404). 35. Sanguineti 2012a, pp. 231-232, scheda I.4.36. Per la cassa afferente all’oratorio di San Giovanni di Prè: Soprani 1674, p. 193; Soprani, Ratti 1768, p. 362; Accinelli ms. 1774, c. 40; Franchini Guelfi 1973, p. 63; Toncini Cabella 2001, pp. 114, 117. “Un’altra ne fece in San Gio. di Prè di pari stima e valore”: così Soprani (1674, p. 193) ricordava che anche la casaccia di San Giovanni di Prè possedeva una cassa processionale di Poggio. Ratti riportava ugualmente l’informa-zione, pur ricordando che “i confratelli del sopranmentovato Oratorio (...) invece della macchina del Poggio, un’altra ne hanno sostituita egregiamente scolpita dal nostro moderno va-lente Scultore Anton Maria Maragliano” (Soprani, Ratti 1768, p. 362). Dunque il gruppo, secondo Ratti, era già scomparso. Di diverso avviso l’Accinelli (ms. 1774, c. 40) che citò, accanto alla nuova cassa maraglianesca raffigurante la visione mariana in Patmos (Sanguineti 2012a, pp. 331-332, scheda I.4), anche il gruppo “antico” di Poggio “rappresentante S. Giovanni nel-la caldara”, dunque un episodio dissimile da quello illustrato da Maragliano e rivolto a porre in scena il supplizio del santo immerso nell’olio bollente, durante la persecuzione voluta da Domiziano.37. Per l’opera: Soprani 1674, p. 193; Viale ms. 1742, c. 96; Giscardi ms. 1754, c. 76; Soprani, Ratti 1768, p. 362; Novella 1912 (ed. 2003, p. 37); Franchini Guelfi 1973, p. 63; Casareto 1998, p. 281; Toncini Cabella 2001, pp. 111, 117; Zanelli 2004, pp. 84-85. Soprani per primo ricordò l’esecuzione da parte di Marco Antonio Poggio del Crocifisso pertinente all’oratorio di Santa Brigida a Genova, definendolo “molto divoto e di grande maestria” (Soprani 1674, p. 193). Tuttavia il biografo lo qualificava come un Cristo spirante, dato ripreso anche da Ratti (Soprani, Ratti 1768, p. 362) e, poco prima, da Viale (ms. 1742, c. 96) e da Giscardi (ms. 1754, c. 76), che lo descriveva-no entrambi come “Cristo spirante intagliato da Marc’Antonio Poggio”. L’opera, ritenuta dispersa dalla critica (Toncini Ca-bella 2001, pp. 111, 117), fu erroneamente identificata con il Cristo, definito tradizionalmente il “Brigidone”, che si riteneva provenire dall’oratorio genovese (Zanelli 2004, pp. 84-85). Cfr. le due note successive.38. Di questo primo avviso era Zanelli 2004, pp. 84-85. Cfr.
Magnani 1992, pp. 291-302 (con bibliografia precedente); Ga-vazza 1995, pp. 74-81; Pierre Puget 1995; Magnani 2003, pp. 109-123; Sanguineti 2004.11. Soprani 1674, p. 192.12. Soprani, Ratti 1768, pp. 361-363.13. Soprani 1674, p. 192.14. Soprani 1674, p. 192.15. Soprani 1674, p. 193.16. Soprani 1674, p. 193.17. Soprani, Ratti 1768, p. 361.18. Per un aggiornato profilo di Domenico e Giovanni Battista Bissoni: Sanguineti c.d.s.b
19. Soprani 1674, p. 193.20. Soprani 1674, p. 193.21. Soprani, Ratti 1768, p. 362.22. Soprani, Ratti 1768, p. 363.23. Soprani 1674, p. 194. Cfr. Franchini Guelfi 2002, pp. 245-246.24. Soprani 1674, p. 194.25. Soprani 1674, p. 193.26. Genova, Archivio di Stato, Notai Antichi 5211, notaio Giovanni Francesco Cavassa, 17 giugno 1626: Di Raimondo 2003, p. 310.27. Genova, Archivio di Stato, Camera del Governo e Finanze 2605, fascicolo 8, 24 maggio 1630 (bancalari), fascicolo 20, 11 ottobre 1630 (celatores): Sanguineti c.d.s.a; Sanguineti c.d.s.b.28. Soprani, Ratti 1768, p. 362.29. Fichera 1997, pp. 67-68; Fiore 2012, p. 361.30. Soprani 1674, p. 193.31. D. Sanguineti in El Siglo 1999, p. 263, scheda VIII.2.32. Soprani, Ratti 1768, p. 362.33. Soprani (1674, p. 193) segnalò la scultura come “Nostra Si-gnora di Monferrato”. Ratti riprese l’indicazione aggiungendo che Poggio, per la cappella Spinola, “incise” questa immagine (Soprani, Ratti 1768, p. 362). Che si trattasse, tuttavia, di una scultura si deduce dalla testimonianza del Giscardi (ms. 1754, c. 15): “la statua di Nostra Signora di Monsanato [sic!] al suo altare di Marc’Antonio Poggi”. Fu ricordata come opera del Poggio anche nel manoscritto sulle chiese di Genova (Chie-se ms. secc. XVII-XVIII, c. 726), solitamente avaro di segna-lazioni relative alla statuaria. L’opera, di cui si sono perse le tracce, si trovava dunque nella cappella gentilizia degli Spinola all’interno della grande chiesa di Santa Caterina (di Luccoli), una delle sedi genovesi dei monaci benedettini, già distrutta alla fine del Settecento (Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 165]). Il gruppo doveva veicolare dunque il culto spagnolo, irradiato dal celebre santuario presso Barcellona, riproponendo la tradizio-nale iconografia dedotta dalla veneratissima icona romanica.34. Novella ms. 1912 (ed. 2003, p. 71). Per la cassa relativa all’oratorio genovese, raffigurante l’Incredulità di san Tommaso: Soprani 1674, p. 193; Viale ms. 1742, c. 92; Giscardi ms. 1754, c. 76; Soprani, Ratti 1768, p. 362; Alizeri 1875, p. 404; Fran-chini Guelfi 1973, p. 63. Il citato indizio cronologico fornito da Novella, che farebbe risalire l’esecuzione al 1641, potrebbe non distanziarsi troppo dall’informazione riportata dai biografi, secondo i quali il gruppo fu “una delle prime sue opere” (So-prani, Ratti 1768, p. 362). Ratti, con evidenza, interpretava in tal modo la notizia, elargita da Soprani (1674, p. 193), che tale gruppo fosse stato realizzato dall’artista appena “si pose in pro-pria stanza ad operare”. Il biografo seicentesco definì l’opera, che raffigurava “molto leggiadramente” il santo “quando tocca
1. Sulle casse processionali genovesi e sul contesto socio-cultu-rale di appartenenza: Franchini Guelfi 1973; Franchini Guelfi 1986, pp. 110-132; Franchini Guelfi 2004, pp. 401-444 (con bibliografia precedente).2. Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis (prove-nienza: Genova Sestri Ponente, oratorio di San Giovanni Bat-tista e del Santo Cristo): Soprani 1674, p. 193; Orlandi 1719, p. 307; Soprani, Ratti 1768, p. 362; Alizeri 1846, p. LXXV; Re-mondini 1893, p. 250; Revelli 1896, p. 9; Decimonono 1900, p. 31; Novella ms. 1906, c. 336; Parodi 1914, pp. 44, 65-68; No-vella ms. 1929, c. 476; Novella ms. s.d., c. 195; Grosso 1939a, p. 37; Grosso 1939b, pp. 22-23; Grosso 1939c, p. 26; Colmuto 1963, p. 201; Franchini Guelfi 1973, pp. 63-65; F. Franchini Guelfi in Le Casacce 1974, pp. 36-37, scheda 5; F. Franchini Guelfi in La Liguria 1982, II, pp. 22-23, n. 5; Casareto 1998, p. 281; Sanguineti 1998a, p. 23; Cataldo 2003-2004, pp. 23-31; Zanelli 2004, p. 84; Sanguineti 2005a, p. 23; Sánchez Peña 2006, pp. 375-376; Sanguineti 2012a, pp. 37-39. Il gruppo ha preso parte alle seguenti mostre: Le Casacce 1939; Le Casacce 1974 (esposti solo due angeli della gloria); La Liguria 1982.3. Il Revelli nel 1896 (p. 9) segnalò il gruppo già nell’attua-le collocazione e confutò vivacemente i Remondini che, nel 1893, non solo avevano proposto un’episodica attribuzione ad Anton Maria Maragliano, ma l’avevano ancora indicato nell’oratorio originario di San Giovanni Battista. Grazie a Giuseppe Parodi (1914, pp. 66-68) si dispone di notizie più cir-costanziate: secondo la documentazione esaminata e riportata dallo studioso, nel 1744 i confratelli dell’oratorio di San Gio-vanni Battista, cui afferiva la proprietà del gruppo, chiedevano la disponibilità del sito ove sorgeva la casa di Masino Restano per erigere “una piccola cappelletta”, nella piazza di San Giu-seppe, accanto all’omonimo oratorio. A tal proposito chiede-vano inoltre di rimuovere il Pilastro infamante che sorgeva “qui dove fu la casa di Agostino Masino Restano che con due suoi figli fu esiliato per aver osato metter le mani addosso ed ucci-dere il Magnifico Paolo Gentile commissario”. La cappelletta era funzionale al ricovero della cassa che, fino a quel momento (ma non è specificato da quando), si trovava presso la chiesa parrocchiale dell’Assunta. Non è chiaro se questa cappella ve-nisse effettivamente edificata o se il gruppo fosse stato ricove-rato presso l’Arciconfraternita Mortis et Orationis. La rinuncia definitiva del gruppo di Poggio da parte della Fabbriceria di San Giovanni Battista avvenne “in virtù di transazione legale del 24 luglio 1850”. Cfr. inoltre Tubino 1978.4. Sanguineti 2012a (con bibliografia precedente).5. Per l’origine della scuola genovese di scultori in legno, dal secondo Cinquecento: Sanguineti 2009, pp. 37-45; Sanguineti c.d.s.b
6. Sanguineti c.d.s.a
7. Per la cassa di Santacroce: Alizeri 1880, pp. 186-186, nota 1; Sanguineti 2009, pp. 43-44 (con bibliografia precedente). Per la cassa di Bissoni (identificabile con quella ora conservata nell’oratorio di Santo Stefano delle Fosse a Genova Rivarolo) e per l’inedito contratto notarile, del 18 settembre 1607: San-guineti c.d.s.b
8. “Sortì nel battesimo il nome di Marc’Antonio & il cognome Poggio”: Soprani 1674, p. 192.9. L. Magnani in Genova 1992, pp. 147-148, scheda 54.10. Per i protagonisti di questo momento: Rotondi Briasco 1962; Herding 1970; Franchini Guelfi 1975, pp. 318-327;
52 53
Daniele Sanguineti La Decollazione del Battista di Marco Antonio Poggio
p. 139 (con bibliografia precedente); Sanguineti 2012a, pp. 37, 47.63. Genova Prà, chiesa di Santa Maria Assunta, cm 80 x 46.64. Borghetto d’Arroscia (Imperia), frazione Gavenola, chiesa di San Colombano Abate, cm 179 x 165 x 184 (Flagellazione): Bartoletti 1995, pp. 49-59; A. Giacobbe in Lignum 2013, 46-47, scheda 14.65. Le partiture floreali sono in linea con quelle tracciate, ad esempio, da Paul Androuet Du Cerceau nel suo Bouquets pro-pres pour les estofes de Tours (Londra, Victoria & Albert Mu-seum), che ebbe grande diffusione proprio dagli anni sessanta del Seicento.
Desidero ringraziare Gianluca Zanelli che ha voluto avvalersi della mia competenza, onorandomi, per lo studio di questo stra-ordinario gruppo scultoreo.
degli angeli, trovano un puntuale riferimento in vari brani della Decollazione. Dunque l’attribuzione a Bissoni, dedotta dai registri d’archivio, potrebbe essere verosimile nella misura in cui il ma-estro avesse lasciato l’esecuzione interamente al Poggio, il quale, a detta del Soprani, trascorse nella bottega bissonesca un periodo in cui “molti furono coloro che accorsero da suoi esperimentati scalpelli” (Soprani 1674, p. 193). Una possibile datazione po-trebbe essere ricavata dalla stessa iconografia, giacché è probabi-le che l’oratorio dedicato a san Bernardo, ovvero uno dei patroni della città rappresentati nell’iconografia ufficiale fiasellesca della Madonna Regina, si fosse dotata della raffigurazione del santo ti-tolare in un momento non troppo distante dalla proclamazione della Vergine a Regina di Genova, nel 1637.62. Genova, chiesa della Santissima Annunziata del Vastato, cm 210 x 185 x 75: Franchini Guelfi 1973, p. 53; Sanguineti 2005b,
Poggio. La struttura del volto, piuttosto volumetrica e soda, la modalità incisiva di solcare le ciocche delle chiome, la griglia delle pieghe della veste, dagli esiti scenografici e ornamentali nell’accentuazione dinamica della posa elegante, fanno parte di un codice riscontrabile nelle figure della Decollazione, basti osservare la Salomè, caratterizzata dalla stessa bocca schiusa e dal piccolo naso che confluisce nelle arcate sopraccigliari. Con un percorso autonomo anche Donati (2012, pp. 139-140, nota 35), di recente, ha ricondotto, in ipotesi, l’opera a Poggio.57. In particolare si confronti la tela piolesca con l’Angelo Cu-stode (collezione privata), databile entro gli anni quaranta del Seicento: Sanguineti 2008, p. 125.58. Soprani 1674, p. 193.59. Ubicazione sconosciuta, cm 90 circa: Franchini Guelfi 1973, p. 63 (segnalata nella collezione Bigazzi a Piancastagnaio [Siena] ma passata all’incanto negli anni novanta del secolo scorso).60. Cervo (Savona), chiesa di San Giovanni Battista, cm 90 x 120: Colmuto 1963, p. 251, scheda 19; Franchini Guelfi 1973, p. 65. Il gruppo fu reso noto da Graziella Colmuto con l’ipotesi che fosse da annoverare tra le prime opere scolpite da Anton Maria Maragliano e che mostrasse “il suo tirocinio di intagliatore di figurine da presepe”. In realtà, come già osserva-va Fausta Franchini Guelfi, i caratteri linguistici del complesso consentono di inserirlo in un’epoca più arretrata e di notare affinità notevoli con la Decollazione di Sestri Ponente. Rispetto a quest’ultima, sicuramente successiva, Poggio compone una narrazione piuttosto statica e frontale, ma gli appartengono, rispettivamente come sigla e gusto scenico, il volto, estrema-mente realistico, della santa, strutturato similmente a quello dell’ancella che scorta Salomè, e l’ambiente domestico ricreato tramite la culla con i panni in disordine.61. Genova, chiesa di Santa Maria di Castello (provenienza: Ge-nova, oratorio di Santa Maria di Castello, detto di San Bernardo e dei Re Magi), cm 180 x 100 x 70, cm 100 x 70 (santo): Alizeri 1846, p. 338; Alizeri 1875, p. 79; Cervetto 1903, p. 174; Novel-la ms. 1912 (ed. 2003, p. 90); Cappellini 1931, p. 30; Grosso 1939c, p. 26; Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 243]; Franchini 1973, p. 80, nota 36. Il gruppo, composto dalla figura genuflessa di san Bernardo, da un basamento simulante la roccia sul quale un an-gelo trattiene il pastorale e dalla Madonna, pensile, assisa sulle nubi, decorava la prima cappella dell’oratorio di Santa Maria di Castello, dove fu segnalato dal compilatore della Descrizione del 1818: “nel primo a destra son le bellissime statue in legno della B. Vergine col Divin Bambino, sopra gruppo d’angioli, e il santo Abate” (Descrizione 1818 [ed. 1969, p. 243]). Giungeva dall’an-tico oratorio di San Bernardo, confluito in quella sede nel 1723 (Novella 1912 [ed. 2003, p. 88]). Con la definitiva chiusura nel 1885, la compagine fu trasferita nell’attiguo complesso di Santa Maria di Castello, prima in chiesa poi in sacrestia. Alizeri asse-gnò il gruppo, veduto ancora nell’oratorio dei Re Magi, ora a Domenico (Alizeri 1846, p. 338), ora Giovanni Battista Bissoni, precisando che l’informazione fu tratta dai registri dell’oratorio (1875, p. 79). Sebbene la critica successiva, ad eccezione del Cervetto (1903, p. 174), rifiutò l’attribuzione (Grosso 1939c, p. 26; Franchini Guelfi 1973, p. 80, nota 36), giova riconsiderare l’ipotesi “seicentesca”. La lettura stilistica pare davvero affine al capolavoro poggesco: i volumi dei volti – quello mariano con i sopraccigli ad arco che confluiscono nel naso –, l’andamento dei panneggi – mossi ma paludati –, le tipologie fisiognomiche
attribuzione (Franchini Guelfi 1973, p. 54). L’utilizzo del legno scuro, lasciato al naturale e lucidato, si riscontra in effetti nella pratica dei Bissoni. Bisogna tuttavia rilevare che il perizoma è un rifacimento ottocentesco e che l’originario è stato scalpel-lato. La lieve ondulazione del corpo, l’impostazione su moduli nobilmente classicheggianti, le forme anatomiche idealizzate, a partire dal bellissimo volto composto, divergono moltissimo dall’eloquio piuttosto vernacolare delle opere fino ad ora ac-colte nel catalogo di Domenico. Nella resa degli occhi e del naso allungato affiorano le stringenti somiglianze con i risultati raggiunti da Marco Antonio Poggio.45. Soprani, Ratti 1768, p. 363.46. Montagu 1985, II, pp. 369-372, scheda 68.47. Per il bozzetto: S. Androsov, N. Kosareva in From the Sculp-tor’s Hand 1998, pp. 52-53, scheda 5; J. Montagu in Algardi 1999, pp. 138-139, scheda 19.48. Ferrari, Papaldo 1999, pp. 317-318 (con bibliografia pre-cedente).49. I Sacri Monti erano ben noti a Genova, se si pensa che in alcuni manoscritti, relativi alle ipotesi di completamento del grande terreno retrostante la fabbrica dell’Albergo dei Pove-ri, si suggerisce, negli anni successivi alla morte di Emanuele Brignole (1678), di creare un bosco e disseminarlo di cappelle come il Sacro Monte di Varallo (Parma 1978, p. 7).50. A. Orlando in L’Età 2004, pp. 56-57, scheda 1 (con biblio-grafia precedente).51. Sanguineti 2004, II, pp. 385-386, scheda I.31.52. Franchini Guelfi 1973, p. 65.53. Per una aggiornata periodizzazione dei soggiorni romani di Parodi: Magnani 1988, pp. 205-207; Sanguineti 2012b, pp. 67-87 (con bibliografia precedente).54. Le analisi sono state eseguite dal Dipartimento di Inge-gneria dell’Innovazione (Centro di Datazione e Diagnostica) dell’Università del Salento. Cfr. il saggio di Antonio Silvestri in questo volume.55. Sanguineti 2012a, pp. 318-319, scheda I.75. Il gruppo pro-veniva dall’oratorio genovese dei Santi Giovanni Battista e Caterina Martire.56. Varese Ligure (La Spezia), chiesa di San Giovanni Battista (provenienza: Varese Ligure, chiesa di Santa Croce), cm 142 x 47 x 33: Donati 1989, p. 17; Lagomarsini 1989, p. 31; Donati 2000, p. 11; Donati 2012, pp. 126-127, 139-140, nota 35. Nella chiesa agostiniana di Santa Croce era ospitata la compagnia dell’Angelo Custode (Lagomarsini 1989, p. 31). Tale congre-gazione fu istituita nel 1635 all’interno della cappella di San Vincenzo, come informa una relazione datata 2 giugno 1650: dallo stesso testo manoscritto si apprende che “la statua di esso Angelo Custode è dell’anno 1646” (Donati 2000, p. 11). Piero Donati, disponendo di tali notizie, attribuì l’opera a Giovanni Battista Bissoni, utilizzando come riscontro la Madonna della Cintura dell’oratorio genovese dei Cinturati, creduta anco-ra quella eseguita da Bissoni per la chiesa di Sant’Agostino, ma in realtà assegnabile per inequivocabili ragioni di stile ad Anton Maria Maragliano (Sanguineti 2012a, p. 289, scheda I.51). In effetti il linguaggio di Bissoni, pur nell’innovazione naturalistica, fu ancora connesso a modelli orsoliniani, come ben dimostra la Madonna del Voto, del 1637. Se dunque la scul-tura di cui la confraternita di Varese Ligure si dotò nel 1646 si deve ancora considerare quella in esame, allora l’unico ter-mine di confronto appropriato è la Decollazione del Battista di
54 55
Scheda di restauro
La diagnosticaLa complessità del gruppo processionale1, per la quantità di figure e per le dinamiche costrut-tive, e lo stato di degrado già riscontrabile da una prima e superficiale analisi hanno impo-sto una diagnostica utile per tracciare le sin-gole fasi dell’intervento. In particolare è stata condotta un’indagine radiografica al fine di raccogliere informazioni sulla tecnica esecuti-va, sui materiali costitutivi di alcune figure e sull’assemblaggio delle parti: si sono analizzati, a questo proposito, il Battista, il soldato baffuto e l’anziana ancella. A parte l’individuazione di improprie chiodature sulla schiena del prota-gonista (applicate successivamente per reggere l’aureola), le sculture risultano scolpite, dal ba-samento alla testa, in un unico tronco di legno stagionato, comprendente anche parte degli arti, eccetto le porzioni più sporgenti (fig. 53).L’esame di alcuni campioni tramite stereomi-croscopio e microscopio ottico, al fine di indi-viduare le essenze lignee, ha rivelato l’utilizzo di pioppo per alcune figure (il Battista, Salomè, i tre soldati, il carcerato) e per la struttura (l’ar-chitettura e il basamento a finto marmo), men-tre altre figure (il boia, il paggio moro, il paggio bianco, l’anziana ancella, il cane, l’angelo con la veste rosa) sono state scolpite utilizzando legno di tiglio. Un solo campione, relativo al basamento di supporto, ha rivelato l’impiego di conifera (abete bianco)2.L’analisi dendrocronologica, al fine di ottene-re informazioni sulla datazione del legno, ha
fornito come risultato più attendibile (95,4% su 68,2 probability) il seguente scarto tempora-le: 1460AD-1650AD (cfr. il saggio di Daniele Sanguineti)3.Infine le analisi stratigrafiche effettuate su sei campioni della policromia, prelevati dalle fi-gure di Salomè e, soprattutto, dell’anziana an-cella, hanno fornito le seguenti indicazioni: la preparazione pittorica è a base di gesso, previa stesura di un materiale di finitura e protezione tra legno e gessatura, composto da una mescola di bolo e biacca con legante a tempera grassa (probabilmente uovo). Tra i pigmenti utilizzati sono emersi l’azzurrite, la terra verde e il cina-bro mescolati a biacca per le vesti, oltre all’im-pego di lacca non per velature superficiali, ma in forma di granuli con l’aggiunta sempre di biacca, per il conferimento di una brillantezza maggiore alla materia. In superficie la patina di finitura ha rivelato la presenza di olio di lino con tracce di carbonato di calcio e gesso4.Le decorazioni dorate a rilievo delle vesti sono state realizzate con spessi strati di gesso, im-piegando la tecnica a pastiglia e la successi-va incisione (anche a bulino) della superficie gessosa.
Il restauro: metodologia e interventoAntonio Silvestri
Il degradoLa pellicola pittorica di tutte le figure presenta-va ampi sollevamenti “a scodella”, con relative cadute, e, nel contempo, un diffuso ed evidente annerimento dovuto a una tenace stratificazio-ne di nerofumo, particellato atmosferico, alte-razione di patinature non pertinenti e colature di consolidamenti eseguiti in diversi momenti con adesivi anche impropri, come colle vini-liche (fig. 54). La superficie pittorica di alcu-ne sculture, in particolare i protagonisti della gloria angelica, presentava lacune più gravi, riguardanti soprattutto le stesure di colore (e non tanto la preparazione gessosa), causate dalla pioggia e da una prolungata permanenza in ambiente umido con effetti di dilavamento.La struttura lignea sia dei personaggi che dell’architettura era fortemente indebolita da
reiterati attacchi di insetti xilofagi. Inoltre si potevano chiaramente osservare rotture e lacu-ne sparse nel modellato, come, per esempio, le porzioni mancanti di alcuni lembi delle vesti, la rottura scomposta delle zampe posteriori del cane e dello zoccolo della zampa posteriore si-nistra dell’agnello, il maldestro incollaggio, in seguito a un distacco, dell’arto destro del boia, all’altezza della spalla, alcune dita rotte o man-canti e ali sbeccate.
L’intervento conservativo strutturaleNon si poteva dunque rimandare ulteriormente la sospensione del progressivo deterioramento del legno e della pellicola pittorica. Si è pro-ceduto con il consolidamento dei sollevamenti di materia, la disinfestazione, il risanamento strutturale per garantire un nuovo equilibrio
Nella pagina a fronte:53. Radiografia del busto anteriore del Battista che mo-stra l’utilizzo di un tronco pieno intagliato lungo la fibra. I chiodi, non pertinenti, furono applicati sulla schiena per sostenere l’aureola in lamina d’argento.
56 57
Antonio Silvestri Scheda di restauro
con l’uso, ripetuto, di Metiletilchetone, alter-nato, su alcune zone, all’uso di Citrosolv per rimuovere ulteriori strati intermedi cerosi. Al-tri depositi intermedi di sporco organico sono stati rimossi con solvente acquoso TEA 20%. Sulle stesure sottostanti (vernici pigmentate e ritocchi alterati) è stato utilizzato il gel (50% DMSO) rimosso con 50% White Spirit e 50% Etile Acetato. Restavano in molte zone ritoc-chi più antichi e resistenti, sui quali è stato usa-to il gel con Alcol Benzilico, rimosso con 50% White Spirit e 50% Alcol Isopropilico: tuttavia alcune riprese pittoriche dal tono grigio e del-lo sporco raggrumato, in prossimità delle vesti decorate di alcuni personaggi, risultavano in-
statico alle figure. Gli strati pittorici si presen-tavano come un guscio distaccato dal supporto (fig. 55), il quale si era ridotto di volume a se-guito di un’asciugatura repentina preceduta da una lunga esposizione a forte umidità. Per tale motivo è stato necessario assicurare pronta-mente con velinature gran parte delle superfici pericolanti, prima del trasporto del gruppo in laboratorio. Al progressivo smontaggio ha fatto seguito la disinfestazione del legno, sigillando per un periodo di circa cinque settimane le va-rie figure e porzioni in apposite camere stagne, all’interno delle quali sono stati monitorati i valori dell’azoto e quelli dell’umidità relativa (60%-70%) per consentire al legno di recupe-rare il volume originario. Conseguentemente è stato possibile eseguire il consolidamento del colore, fissato al supporto con iniezioni di colla animale e successivamente con l’ausilio del termocauterio. Ultimata questa fase, che ha riguardato circa la metà delle superfici, è stato necessario rimuovere e ripristinare anche le parti consolidate in precedenti interventi di manutenzione, fermate in modo improprio con eccessiva colla vinilica. Inoltre le strutture li-gnee sono state ulteriormente consolidate con iniezioni di Permetrina in essenza di petrolio e ripetute impregnazioni di Regalrez. Le lacune, in particolare alcuni lembi delle vesti, il dito indice della mano destra del giovane con cap-pello, alcune porzioni delle ali dei due arcange-li, sono state risarcite, mentre è stato effettuato lo smontaggio e l’incollaggio corretto dell’arto del boia e delle zampe degli animali.
La pulituraLa pulitura della superficie pittorica è stata ef-fettuata in modo graduale e selettivo mediante test di solubilità. Dopo aver eliminato, con tam-ponature di Citrosolv, gli strati superficiali di cera presenti su tutte le superfici delle sculture, si è proceduto con la rimozione dei più tenaci strati disturbanti. Su molte sculture era inoltre presente una spessa pellicola di vernice di tipo sintetico, disomogenea e pigmentata, asportata 54. Il retro del Battista prima del restauro con la pellicola pittorica annerita, sollevata e lacunosa.
55. Particolare della pellicola pittorica distaccata, lacune con supporto ligneo a vista e fori di sfarfallamento.
58 59
Antonio Silvestri Scheda di restauro
parazione (cfr. La diagnostica), interrompevano l’integrità di lettura – più di quanto fosse visi-bile, ovviamente, nella fase iniziale alla rimo-zione dell’annerimento –, si è deciso, con il di-rettore dei lavori, Gianluca Zanelli, di risarcire tutte le lacune, anche quelle più estese, con la stuccatura e, successivamente, la reintegrazio-ne pittorica. La prima operazione è stata ese-guita con gesso di Bologna e colla di coniglio, con livellamento alla superficie piana, anche in prossimità di lacune coincidenti con decori a pastiglia o in rilievo (fig. 58).
L’integrazioneLe cattive condizioni delle superfici, pittori-che o dorate, hanno reso la reintegrazione par-ticolarmente difficoltosa. Il cospicuo danno generato dalle cadute di colore è stato risarci-to ad acquerello sulle zone dorate e sulle vesti
globate nel colore, quindi non è stato possibile rimuoverle totalmente, ma solo alleggerirle. La superficie pittorica originaria, in tal modo recuperata, risulta caratterizzata da pennellate di colore a tempera piuttosto corpose, sebbe-ne giunte a noi ampiamente compromesse da incauti e precedenti interventi di pulitura, che hanno provocato l’impoverimento tonale della materia pittorica e il tentativo di risarcirla con ridipinture dalla tonalità grigiastra. A conclu-sione della pulitura è stato steso a pennello uno strato protettivo di vernice (figg. 56-57).
La stuccaturaIn seguito al sorprendente risultato ottenuto con la pulitura e dopo aver constatato che gran parte delle lacune, caratterizzate da un tono scuro a causa dell’impregnante steso sul legno prima della stesura degli strati originali di pre-
57. Fase della pulitura della pellicola pittorica (tassello a risparmio sulla schiena dell’agnello che mostra lo stato precedente all’intervento).
56. Fase della pulitura della pellicola pittorica (tassello a risparmio sulla porzione di destra della schiena del Battista che mostra lo stato precedente all’intervento).
60 61
Antonio Silvestri Scheda di restauro
Le basi: degrado e interventoLe basi del gruppo processionale erano ricoper-te da grossolane ridipinture ed erano struttu-ralmente degradate: la pedana a scalini su cui è fissata la scultura del Battista, in particolare, presentava la sconnessione e il parziale distac-co del tavolato, con chiodi allentati o divelti nel punto del suo ancoraggio lungo i bordi, anch’essi molto degradati dai tarli con profon-de spaccature e dissesti e con mancanze di por-zioni di legno. La piattaforma di supporto, seb-bene ben costruita e con legni più pregiati, mo-strava un degrado causato da una tenace rosura degli insetti xilofagi: la fascia laterale mostrava
policrome, mentre le zone degli incarnati e quelle delle vesti – dove insistevano, sebbene alleggerite, le vecchie ridipinture –, sono state rifinite con velature di colore a vernice, per conferire trasparenza. L’integrazione eseguita risulta facilmente riconoscibile, soprattutto sulle parti con i decori in oro, dove l’effetto della foglia d’oro e del rilievo è stato restitui-to per mezzo dell’acquerello, riproducendo in piano il decoro e ottenendo un buon risultato di continuità con le parti originali (fig. 59). La verniciatura finale protettiva Mastice stesa in più mani per nebulizzazione ha concluso il restauro.
Nella pagina a fronte:58. Stuccatura estesa delle lacune di pellicola pittorica per fornire un supporto alla fase dell’integrazione pittorica (Soldato alabardiere).
59. Integrazione, chiaramente individuabile, di un decoro a rilievo dorato sul gallone della manica (Fantesca).
62 63
Antonio Silvestri Scheda di restauro
colla forte. La base è stata ulteriormente rinfor-zata agli angoli, al centro e lungo il perimetro con traverse di legno, incollate e inchiodate sotto la pedana, per garantire la buona tenu-ta delle sculture sopra fissate e la loro stabilità durante la movimentazione del gruppo. La pu-litura della spessa stratificazione disomogenea di materiale scuro, molto resistente, presente su tutta la superficie della pedana, è risultata mol-to difficoltosa, ed è stata effettuata ammorbi-dendola con ripetute applicazioni di gel (100% DMSO), a seconda delle zone, e asportandola strato dopo strato con l’ausilio del bisturi. Il ri-sultato finale è stato soddisfacente, perché in tal modo è stato possibile recuperare la cromia originale a finto marmo, pur se in molte zone abrasa e lacunosa. La reintegrazione pittorica, eseguita con basi a tempera e rifiniture con co-lori a vernice, ha ricucito tutte le lacune.
numerosi fori di sfarfallamento e fitte gallerie di scavo. Il tavolato di superficie era più in ordi-ne e ben solido, fatta eccezione per un innesto di raccordo delle tavole centrali che aveva un dissesto. Gli angoli modanati, più esterni e sog-getti a incidenti durante le movimentazioni, risultavano i più danneggiati, con sconnessio-ni, lacune dei profili di rifinitura, e scollamenti nell’impiallacciatura in noce ebanizzato.Inizialmente si è praticato lo smontaggio del ta-volato alla base, cui ha fatto seguito il consoli-damento del legno con ripetute impregnazioni di Regalez sulle porzioni più degradate. Le parti mancanti sulla fascia del perimetro sono state risarcite con innesti lignei sagomati e con la-stronatura di noce, poi ebanizzata. Il tavolato di base ha richiesto l’inserimento di listelli linea-ri per colmare gli spazi tra una tavola e l’altra, quindi il loro ancoraggio al bordo utilizzando
61. Carnefice: esploso simulato con l’individuazione del bloc-co addizionato per l’avambraccio steso.
62. Carcerato: esploso simulato con l’individuazione del bloc-co addizionato per il fianco sinistro, dalla spalla alla gamba.
60. San Giovanni Battista: esploso simulato con l’individuazione di blocchi addizionati (gamba piegata in esterno, avambracci, dita).
64 65
Antonio Silvestri Scheda di restauro
re intonate; le mancanze più estese sono state ricostruite con Araldite e rifinite sempre con gessature intonate; le gallerie e tutti i fori di sfarfallamento procurate dagli insetti sono stati prima chiusi con una pasta a base di legno in polvere e colla, quindi con gessature intonate. La reintegrazione pittorica delle lacune è sta-ta eseguita con aniline ad alcol. La superficie è stata infine lucidata e protetta con strati di cere miste.
Il montaggioLa fase del montaggio delle varie parti scolpi-te ha richiesto un ulteriore lavoro di revisione degli ancoraggi in metallo, ripristinando le mo-dalità, volute dallo scultore, con cui le figure sono assicurate all’architettura, per garantire loro maggiore elasticità e resistenza durante le movimentazioni. Ogni figura, infatti, è im-
La verniciatura Mastice stesa in più mani per nebulizzazione ha protetto la pellicola pittorica.La superficie lignea della grande piattaforma era ricoperta da strati di vernici nere, dall’a-spetto catramoso, così spesse da essere refratta-rie ai normali saggi di pulitura: è stato pertanto necessario ammorbidire la superficie con una fonte di calore e asportare in modo meccanico con lame gli strati sovrapposti. Ultimata questa fase, la superficie aveva recuperato il livello ne-cessario per constatare la sua sua essenza (noce ebanizzato) e l’entità del degrado del legno (reiterata rosura da xilofagi). Il consolidamen-to è stato effettuato con ripetute infiltrazioni di Regalrez. Il risanamento della struttura lignea ha previsto l’inserimento di listelli di legno sa-gomati per compensare le parti mancanti delle cornici lungo i bordi. Le lacune di piccola e media entità sono state risarcite con stuccatu-63. Soldato reggifiaccola: esploso simulato con l’individuazione dei blocchi addizionati per gli avambracci.
64. San Giovanni Battista: particolare del volto con le palpebre modellate in stucco per trattenere gli occhi vitrei.
66 67
Antonio Silvestri Scheda di restauro
riscontrano nelle seguenti figure: 1) Battista (gamba piegata in esterno, avam-bracci, dita; fig. 60) 2) carnefice (avambraccio steso, intero braccio che impugna la spada; fig. 61)3) carcerato (fianco sinistro dalla spalla alla gamba alzata e piegata; fig. 62). 4) aiutante del carnefice con cappello rosso (avambraccio destro)5) Salomè (avambraccio destro)6) soldato reggifiaccola (avambracci; fig. 63)Per gli occhi in vetro si è osservata una tec-nica consueta, ossia la collocazione, nell’orbita scavata, di calotte sferiche in vetro soffiato, di-pinte nel verso e assicurate dalle palpebre mo-dellate in stucco (fig. 64)6.La quinta architettonica, che suggerisce l’am-bientazione delle carceri e nel contempo reg-ge la gloria angelica, contiene al suo interno una struttura di ferro, sostenuta, all’altezza del primo gradino della pedana, da due mensole, per poi attraversare entrambe le basi ed uscire dal tavolato di fondo, dove è bloccata con un cuneo metallico. Verso l’alto si biforca e, ripie-gandosi leggermente, confluisce nelle nuvole, per sostenerle ed offrire un’“anima” interna agli angeli (fig. 65).
1. Legno scolpito e dipinto. Basamento: cm 290 x 200 (piatta-forma), cm 213 x 110 (base gradinata). Altezze: cm 273 (quinta architettonica e gloria), cm 90 (Battista), cm 135 (carnefice), cm 79 (carcerato), cm 92 (paggio moro), cm 102 (secondo car-nefice seduto), cm 135 (soldato alabardiere), cm 102 (soldato seduto reggifiaccola), cm 138 (Salomè), cm 130 (fantesca), cm 64 (fanciullo con croce astile). 2. Le analisi sono state effettuate da Raffaella Bruzzone presso il Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica del Polo Bota-nico del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università degli Studi di Genova.3. Le analisi sono state eseguite dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (Centro di Datazione e Diagnostica) dell’U-niversità del Salento.4. Le analisi sono state condotte da Angelita Mairani di Arte-materia. Indagini diagnostiche e servizi per l’arte.5. Silvestri 2012, pp. 458-461. In generale per le tecniche di assemblaggio dei blocchi: Fidanza 2011, pp. 199-210 (con bi-bliografia precedente).6. Mazzoni 2011a, pp. 211-220; Mazzoni 2011b, pp. 77-88.
perniata in modo tale da creare uno spazio di ondeggiamento atto a non danneggiarla, sug-gerito e consentito dai piedi lievemente distan-ziati dalla pedana. Il rimontaggio di tutte le parti scolpite sulla piattaforma di base ha preso avvio dalla pedana a doppio gradino su cui è innestata, nella parte posteriore, l’alzata archi-tettonica (fig. 65). Questa parte, come tutte le figure, sono state riposizionate calandole con un argano, procedendo dalla gloria angelica per proseguire con tutti i restanti personaggi fino al lato breve anteriore, ossia terminando con la collocazione del Battista. Sono stati riposizio-nati gli accessori: l’aureola, in lamina d’argento (priva di punzone), e la spada in ferro del car-nefice, la cui impugnatura si apre per consen-tire l’inserimento nella mano, chiusa a pugno, del personaggio.Dopo il rimontaggio è stato effettuato il rileva-mento del peso dalla cassa: 288 chilogrammi.
La tecnica esecutivaIl restauro ha consentito, grazie alla diagnostica e all’osservazione diretta nel corso dello smon-taggio, la costatazione di una prassi scultorea di altissimo livello. Intanto l’utilizzo di essenze lignee caratterizzate da una lunga stagionatura ha conferito, già negli intenti dell’artefice, sta-bilità e garanzia nei confronti di fessurazioni e drastici movimenti della materia. Si constata poi una modalità di ricavare la singola figura da un unico tronco pieno, intagliandolo per leva-re la materia e far emergere il personaggio, con modalità simili alla scultura in marmo. Tutto ciò in relazione a una prassi esecutiva piuttosto coerente (come si suppone, giacché lo studio dei sistemi costruttivi non è molto avanzato per la produzione in legno genovese) con le botteghe di primo Seicento attive a Genova, contrariamente a quanto accadrà più tardi, per esempio, con Anton Maria Maragliano, per il quale le addizioni di più blocchi, per gli agget-ti o per gli incastri tra le figure, divenne una modalità esecutiva assai più praticata5. Poggio limitò al massimo l’addizione di blocchi che si 65. Ricostruzione virtuale della struttura portante in ferro inglobata nella quinta architettonica.
68 69
La Madonna del Rosario di Francesco Ravaschio
fu responsabile del rinnovo in chiave neoclassi-ca della grande produzione in marmo a Genova4. Si devono ricordare, in particolare, gli impegni profusi in Palazzo Ducale, nei quali la critica ha rilevato, accanto a un controllo compositivo di matrice neoclassica, un’attenzione nostalgica verso la tradizione tardo barocca e primo sette-centesca5. Ma fu proprio quella la realtà culturale respirata dal giovane al momento della formazio-ne, avviata nel corso del decennio centrale del se-colo, magari proprio presso la bottega di qualche valido maraglianesco, come ad esempio Pietro Galleano. Finora, dunque, si ignorava che Rava-schio avesse scolpito anche il legno e, viceversa, la critica non si era avveduta che il “Ravasco di Genova”6, autore delle statue citate, fosse in real-tà il ben noto scultore. Simile al suo fu il percorso, per ora meglio tracciato, di Pasquale Navone, che alternò una produzione di scultura in legno poli-cromo, caratterizzata da un dettato maraglianesco gradito alla committenza confraternale, a una in marmo, più aggiornata e in linea con i dettami ir-radiati dall’Accademia7. L’ambivalenza operativa e interpretativa che caratterizza questi scultori è alla base di un momento culturale, avviato con l’istituzione della Ligustica (1751), in cui non ci fu affatto una cesura, ma un lento assestamento, lungo fin quasi la parte restante del secolo, nei confronti dei nuovi canoni8. Per quanto riguarda Ravaschio, come per Navone, non devono allora stupire da un lato la formazione tradizionale svol-ta presso qualche bottega tardo barocca, dall’altra l’iscrizione, nel 1757, alla scuola del disegno pres-
La MaDonna DeL rosario di Francesco RavaschioDaniele Sanguineti
Si ignora, per il secondo gruppo conservato nell’oratorio Mortis et Orationis di Sestri Ponente, la circostanziata provenienza e
l’originaria funzione cultuale (figg. 66-67). Non si può escludere, in mancanza di una specifica traccia bibliografica1, una connessione al culto del Rosario praticato nell’attigua parrocchiale dell’Assunta, dove, nella cappella alla sinistra del vano presbiteriale, è ospitata una scultura riferi-bile a Giovanni Battista Santacroce e databile al secondo quarto del Seicento2. Probabilmente, trasformando l’antico simulacro – non a caso molto ridipinto – in un’immagine di culto stan-ziale, si decise, nel terzo quarto del Settecento, la commissione di un nuovo e aggiornato gruppo processionale, ricoverato – forse per la particolare conformazione dell’Assunta dotata di un’unica aula con cappelle a parete – in oratorio. La col-locazione cronologica ora formulata emerge dalla lettura stilistica dell’opera, la sola che si possa per ora applicare in assenza di una specifica docu-mentazione. I caratteri del gruppo, che presenta la Madonna assisa su un alto trono di nubi e so-stenuta da tre angioletti in volo, sono a tal punto peculiari da consentire il diretto inserimento nel catalogo di Francesco Ravaschio. Questo sculto-re, a cui alcune carte d’archivio hanno consen-tito, in un primo tempo, di assegnare la Pietà di Diano San Pietro (fig. 68) e il Santo Stefano di Casella (fig. 69), realizzati nel 17693, non è altri che il celebre statuario (1743-1820), il quale, dopo un viaggio di studi a Roma svolto con il collega Nicolò Traverso negli anni 1775-1780,
70 71
Daniele Sanguineti La Madonna del Rosario di Francesco Ravaschio
vernici dal tono molto giallo, alterate ed essicca-te, che creavano un disturbo per la fruizione ed esercitavano un’azione di strappo nei confronti della pellicola pittorica originaria. Erano presenti ampi e diffusi sollevamenti di materia, pronti alla caduta, molti dei quali interessavano anche parti risarcite in passato (soprattutto i lembi anteriori della veste della Madonna), dove erano presenti grossolane ridipinture poco intonate e imprecise nell’imitare i motivi dei decori. La quantità dei rifacimenti eseguiti negli anni indicava la preca-rietà degli strati pittorici, dovuta in gran parte a un microclima non idoneo, che aveva causato bruschi movimenti del legno con conseguenti e importanti cadute di materia. Inoltre, l’azio-ne prolungata degli insetti xilofagi, attestata dai numerosi e ampi fori di sfarfallamento, aveva in-debolito la struttura lignea rendendola in alcune
gruppi maraglianeschi)14 – è il maestro virtuale, mediato, ovviamente tramite quegli allievi ca-ratterizzati da un dettato di livello più corretto e meno manierato (per intenderci, piuttosto Pietro Galleano e Carlo Aschero che Giovanni Maragliano o Agostino Storace)15.Probabilmente Alizeri, se fosse stato a conoscenza di questa giovanile produzione, avrebbe contenu-to gli entusiastici giudizi sullo scultore, come del resto fece per Pasquale Navone, l’altro artista che frequentò, creando sulla tradizione maraglianesca una propria scuola di allievi, la statuaria in legno, conducendola fino alla fine del secolo.
Scheda di restauro Lo stato conservativo precedente al restauro era mediocre (fig. 70). Le superfici scultoree erano ricoperte da strati di particellato organico e da
e Ravaschio – che invece lo praticò ben oltre quell’impegno menzionato da Alizeri – avessero continuato la produzione lignea dal 1780 in poi, ossia dal rientro in patria. Tuttavia accanto alle notizie dei gruppi scultorei in legno, realizzati dal ventiseienne Ravaschio, nel 1769, in un’epoca precedente all’incontro con il collega, e al simu-lacro mariano realizzato nel 1774 per la comunità di Onzo11, alla vigilia del viaggio romano, sussiste la possibilità che sia suo – e ben più tardo – anche il Cristo risorto12, sempre conservato in quest’ulti-ma località e sostanziato da una matrice culturale più compassata, corretta e accademica.Il gruppo di Sestri Ponente rivela una perizia esecutiva d’alto livello, impostata sulla regia vo-lumetrica e corretta delle anatomie e sulla resa virtuosistica dei panneggi, davvero scenografici, cartacei e forbiti, pur nella retorica conduzione dei viluppi. Una magnifica policromia, caratte-rizzata da un eccezionale impiego di foglia d’oro nella gallonatura e nei fiorami del manto e nel più minuto decoro “a sgraffito” della veste, po-trebbe rivelare la miglior bottega del momento, quella dei Campostano (fig. 71)13. Una sigla pe-culiare si individua agevolmente soprattutto nei modi di conformare i volti, dalla testa mariana, squadrata e classicheggiante, ai visi di Gesù e degli angeli, dalle forme paffute e dalla capiglia-tura scomposta: tali brani si ritrovano, oltre che nel Santo Stefano di Casella (fig. 69), soprattutto nella Pietà di Diano (fig. 68), il cui volto della Vergine e lo squadernarsi enfatico e rigoroso dei panneggi sono sovrapponibili alla nostra imma-gine. Questo è il momento cronologico a cui converrebbe ascrivere il gruppo sestrese, poiché la Madonna di Onzo, il cui saldo allo scultore viene registrato il 4 giugno 1774, pare, a un anno di distanza dal viaggio romano, indugiare, al di là dell’impostazione facciale (sempre accomunata da ricorrenti caratteristiche), verso forme baroc-chette, come dichiara il ritmo danzante dei pan-neggi e la stilizzazione delle forme. Anton Maria Maragliano – osservato nei dettagli di impagina-zione (giacché l’angioletto che sostiene le nubi nella cassa sestrese, si ritrova in alcuni celebri
so l’Accademia9. Alizeri fornì un utilissimo indi-zio, taciuto dalla critica moderna, circa l’acerba dedizione di Traverso e di Ravaschio alla scultu-ra in legno, dal momento che ricordò l’intaglio, per il palazzo della famiglia dogale dei Cambiaso, di “certi gruppi di figure (...) da servire dorati ad ornamento delle costoro stanze negli angoli del-le pareti” e che di tale impegno lui stesso aveva particolarmente gradito “la venustà, la pulitezza e l’eleganza”10. Dalla sola descrizione si comprende dunque l’aggiornamento dei canoni di una produ-zione tradizionale – quella delle statue cantonali da parata –, tipica espressione barocca frequenta-ta da Filippo Parodi. Si dovrebbe dubitare, allo stato attuale degli studi, che Traverso – per il quale finora non è noto alcun lavoro in legno –
66-67. Francesco Ravaschio, Madonna del Rosario, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis, dopo il restauro, fronte (pagina precedente) e retro.
68. Francesco Ravaschio, Pietà, Diano San Pietro (Impe-ria), chiesa di San Pietro.
69. Francesco Ravaschio, Santo Stefano, Casella (Genova), chiesa di Santo Stefano.
72 73
Daniele Sanguineti La Madonna del Rosario di Francesco Ravaschio
1. Legno scolpito e dipinto, cm 190 x 100 x 85, cm 45 x 45 (basamento). Solo Casareto (1998, p. 281) accenna alla statua mariana, che “va ascritta al periodo d’oro della scultura sacra genovese del XVII secolo [sic!] e costituisce un patrimonio re-ligioso di massimo interesse”.2. Sanguineti 2011, p. 31. Per l’erezione della cappella: Ravec-ca 1998, p. 67.3. Diano San Pietro (Imperia), chiesa di San Pietro, cm 113 x 83: Abbo 1983, p. 68; Abbo 1985, pp. 42-43, 54, nota 5; G. Abbo in Lignum 2013, pp. 56-59. Casella (Genova), chiesa di San-to Stefano, cm 183: Santamaria 1999, pp. 88-90. Nella chiesa parrocchiale di Diano San Pietro la documentazione d’archivio rivelava anche la fornitura, insieme alla Pietà, di una Madonna del Rosario da parte dello scultore: l’attuale simulacro mariano, che veicola il culto del Carmine (G. Abbo in Lignum 2013, p. 58), mostrerebbe un linguaggio distante dal fare di Ravaschio.4. Sborgi 1988a, pp. 308-309; Sborgi 1988b, pp. 310-317. 5. C. Olcese Spingardi in El Siglo 1999, p. 425, scheda XV.13-16 (con bibliografia precedente). 6. Appellato in tal modo nelle registrazioni d’archivio per il gruppo fornito alla parrocchiale di Casella: Santamaria 1999, pp. 89-90.7. Franchini Guelfi 1996, pp. 537-552; Sanguineti 2013.8. Per l’ambiente della Ligustica: Sborgi 1974; Pesenti 1987, pp. 349-375; Sborgi 1990 pp. 25-58; Baccheschi 2000, pp. 349-360.9. Genova, Archivio dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Libro degli Accademici e Studenti 1751.10. Alizeri 1865, pp. 174-175.11. Onzo (Savona), chiesa di San Martino: A. Rolandi Ricci in Lignum 2013, p. 74. Il 4 giugno 1774 viene registrato il saldo a favore di Francesco Ravaschio per il simulacro mariano raffi-gurante la Madonna con Gesù Bambino, dipinta contemporane-amente da Giovanni Battista Campostano.12. Onzo (Savona), chiesa di San Martino, cm 175 x 70: A. Rolandi Ricci in Lignum 2013, pp. 74-75, scheda 25.13. Per Lorenzo (notizie dal 1750, † ante 1773) e il figlio Gio-vanni Battista Campostano (Genova 1749, notizie dal 1764 al 1774), nomi connessi alla policromia delle stesse opere di Ravaschio finora note (G. Abbo in Lignum 2013, p. 58; A. Ro-landi Ricci in Lignum 2013, p. 74), cfr. Sanguineti c.d.s.b
14. Cfr. in particolare la Madonna del Carmine ora nella chiesa di Santa Fede a Genova e l’Assunta di Pieve di Teco (Sangui-neti 2012a, pp. 250, 284, schede I.16, I.46).15. Per queste personalità: Sanguineti 1998b, pp. 141-152; Sanguineti 1998c, pp. 531-533; Sanguineti 1998d, pp. 52-67; Sanguineti 2012a, pp. 99-105.
ne è avvenuta tramite la stesura di gesso di Bo-logna e colla di coniglio. Queste parti sono state reintegrate con la tecnica dello spuntinato e con velature di colore, mentre le zone interessate da ridipinture, alleggerite dall’intervento di pulitura, sono state intonate ed è stato ripreso il decoro sul-la veste della Madonna, accordandolo in modo più idoneo con la parte originale. La verniciatura protettiva Mastice ha concluso il restauro.
Antonio Silvestri
legno presente sulla veste della Madonna è stata saldata con colla animale. La pulitura delle super-fici è stata condotta per gradi: il primo livello ha previsto l’utilizzo di LA4, che ha consentito di asportare gli strati superficiali di particellato or-ganico e di assottigliare gli spessi strati di vernice alterata; un secondo livello è stato effettuato con LA7, che ha rimosso gran parte degli strati di ver-nice, rispettando le ridipinture, eseguite in modo molto esteso in precedenti restauri, che avevano ridisegnato i decori della veste mariana. L’aggan-cio dell’angelo posto sulla nuvola, sul retro del gruppo, è risultato precario a causa del degrado della struttura lignea, pertanto questa parte è stata ulteriormente consolidata con Paraloid ed è sta-to inserito e incollato un innesto ligneo, che ha consentito di fissare in modo sicuro l’aggancio. La stuccatura dei fori di sfarfallamento e delle lacu-
zone spugnosa e privando in tal modo gli strati pittorici di un sostegno stabile. Sulla veste, in bas-so a destra, si apriva una fenditura verticale dei masselli che costituiscono una piega del panneg-gio, dovuta probabilmente a un fatto accidentale durante un’incauta movimentazione. Le parti pericolanti della superficie pittorica sono state velinate prima del trasporto in laboratorio, dove è stata eseguita la disinfestazione del legno mediante anossia (chiusura, per circa un mese, del gruppo scultoreo in una sacca sigillata all’interno della quale è stato sottratto l’ossigeno e immesso azoto). Sono seguiti numerosi e ripetuti consoli-damenti della pellicola pittorica pericolante con iniezioni e infiltrazioni di colletta e in alcuni casi con Primal. Il consolidamento del legno è stato effettuato con iniezione di Relarez e in alcune zone più degradate con Paraloid. La fenditura del
70. Francesco Ravaschio, Madonna del Rosario, Genova Sestri Ponente, oratorio Mortis et Orationis, particolare prima del restauro.71. Francesco Ravaschio, Madonna del Rosario, Genova Sestri Po-nente, oratorio Mortis et Orationis, particolare della policromia.
74 75
Bibliografia
Abbo 1983G. Abbo, La chiesa parrocchiale di Diano San Pietro, in “Communitas Diani”, 1983, pp. 61-73.
Abbo 1985G. Abbo, Parrocchia di San Pietro Apostolo. Comune di Dia-no San Pietro, in “Communitas Diani”, 1985, pp. 42-54.
Accinelli ms. 1774F.M. Accinelli, Delle Casacce ossia oratori de Disciplinanti, ms. 1774, Genova, Biblioteca Berio (ms. VI.5.21).
Alizeri 1846F. Alizeri, Guida artistica per la città di Genova, I, Genova 1846.
Alizeri 1865F. Alizeri, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalla fon-dazione dell’Accademia, II, Genova 1865.
Alizeri 1875F. Alizeri, Guida illustrativa del cittadino e del forestiero per la città di Genova e sue adiacenze, Genova 1875.
Alizeri 1880F. Alizeri, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle ori-gini al secolo XVI, VI, Genova 1880.
Alfonso 1985L. Alfonso, Tomaso Orsolino e altri artisti di ‘Natione Lom-barda’ a Genova e in Liguria dal sec. XIV al sec. XIX, Genova 1985.
Algardi 1999Algardi. L’altra faccia del barocco, catalogo della mostra a cura di J. Montagu, Roma 1999.
Avena 2007A. Avena, A Caminata di Ne, un’inedita Madonna dello scultore Gerolamo Pittaluga, in “La Casana”, 2007, 4, pp. 28-35.
Baccheschi 2000E. Baccheschi, L’Accademia Ligustica di Belle Arti, in E. Ga-vazza, L. Magnani, Pittura e decorazione a Genova e in Ligu-ria nel Settecento, Genova 2000, pp. 349-360.
Bartoletti 1995M. Bartoletti, Il gruppo ligneo della Flagellazione, in Gavenola e il Signor Vannenes. Un episodio del ’700 in valle Arroscia, a cura di F. Boggero, Bordighera 1995, pp. 49-59.
Belloni 1988V. Belloni, La grande scultura in marmo a Genova (secoli XVII e XVIII), Genova 1988.
Botta 2000M. Botta, Giacomo Antonio Boni, in E. Gavazza, L. Magna-ni, Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Genova 2000, pp. 422-423.
Cappellini 1931A. Cappellini, Genova. Tesori d’arte patria, Genova 1931.
Casareto 1998G. Casareto, L’oratorio e la confraternita, in P.R. Ravecca, Basilica di N.S. Assunta Sestri Ponente. Il territorio, la storia, l’arte, l’attività pastorale, Genova 1998, pp. 277-282.
Cataldo 2003-2004G. Cataldo, Francisco Salzillo y Poggio Marc’Antonio, in “Imafronte”, 2003-2004, 17, pp. 23-31.
Cervetto 1903L.A. Cervetto, I Gaggini da Bissone. Loro opere in Genova ed altrove, Milano 1903.
Chiese ms. secc. XVII-XVIIIChiese di Genova, ms. secc. XVII-XVIII, Genova, Archivio Storico del Comune (ms. 50).
Ciliberto 2000P. Ciliberto, Giovan Battista Revello detto il Mustacchi, in E.
Gavazza, L. Magnani, Pittura e decorazione a Genova e in Liguria nel Settecento, Genova 2000, p. 433.
Colmuto 1963G. Colmuto, L’arte del legno in Liguria: A.M. Maragliano (1664-1739), Genova 1963 (“Fonti e Studi di Storia Eccle-siastica”, III, pp. 193-309).
Decimonono 1900Decimonono centenario della Natività di S. Giovanni Battista, Genova 1900.
Descrizione 1818 (ed. 1969)Descrizione della città di Genova da un anonimo del 1818, ed. a cura di E. Poleggi - F. Poleggi, Genova 1969.
Di Raimondo 2003A. Di Raimondo, Nuovi documenti sullo scultore Domenico da Bissone, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, 2003, XLIII, pp. 305-318 (Studi in memoria di Giorgio Co-stamagna).
Donati 1989P. Donati, Brevi note sulle arti figurative nell’Alta Val di Vara, in Arte e devozione in Val di Vara, catalogo della mostra a cura di M. Ratti, Genova 1989, pp. 9-20.
Donati 2000P. Donati, Il patrimonio artistico delle Confraternite nell’Alta Val di Vara: alcune riflessioni, in Restauri a San Pietro Vara e dintorni, catalogo della mostra a cura di P. Donati (San Pietro Vara), La Spezia 2000, pp. 7-11.
Donati 2012P. Donati, Tra Genova e il Magra. Pittori e scultori nella Ligu-ria di Levante, Cinisello Balsamo 2012.
El Siglo 1999El Siglo de los Genoveses e una lunga storia di arte e splendori nel palazzo dei Dogi, catalogo della mostra a cura di P. Boc-cardo, C. Di Fabio (Genova), Milano 1999.
Fabbri 2003F. Fabbri, Monsieur Onorato/Honoré Pellé. Uno scultore fran-cese a Genova fra XVII e XVIII secolo, in “Studi di Storia dell’Arte”, 2003, 14, pp. 183-196.
Ferrari, Papaldo 1999O. Ferrari, S. Papaldo, Le sculture del Seicento a Roma, Roma 1999.
Fichera 1997C. Fichera, Il bel San Giovanni di Sestri Ponente, Genova 1997.
Fidanza 2011G.B. Fidanza, Sistemi di assemblaggio e risultati formali: al-cuni casi seicenteschi, in “Bollettino d’Arte”, 2011, volume speciale (Scultura lignea. Per una storia dei sistemi costruttivi e decorativi dal Medioevo al XIX secolo, atti del convegno [Serra San Quirico e Pergola, 2007] a cura di G.B. Fidanza, L. Speranza, M. Valenzuela), pp. 199-210.
Fiore 2012V. Fiore, ‘Perché la povertà fu diletta sposa di Christo’. Altari cappuccini in Liguria, in I Francescani in Liguria. Insediamen-ti, Committenze, Iconografie, atti del convegno (Genova 2009) a cura di L. Magnani, L. Stagno, Roma 2012, pp. 359-367.
Franchini Guelfi 1973F. Franchini Guelfi, Le Casacce. Arte e tradizione, Genova 1973.
Franchini Guelfi 1975F. Franchini Guelfi, Appunti su alcuni problemi della cultu-ra figurativa a Genova alla fine del Seicento, in “Pantheon”, 1975, 4, pp. 318-327.
Franchini Guelfi 1986F. Franchini Guelfi, Le casse processionali delle confraternite liguri: immagine devozionale e sacra rappresentazione, in Musi-ca popolare sacra e patrimonio storico artistico etnografico delle
Bibliografia
76 77
Bibliografia
confraternite nel Ponente Ligure, atti del convegno (Imperia 1982) a cura di G. De Moro, Imperia 1986, pp. 110-132.
Franchini Guelfi 1996F. Franchini Guelfi, Pasquale Navone dal theatrum sacrum tardobarocco all’Accademia, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», 1996, XXXVI, pp. 537-552.
Franchini Guelfi 2002F. Franchini Guelfi, La scultura del Seicento e del Settecento. Marmi e legni policromi per la decorazione dei palazzi e per le immagini della devozione, in Genova e la Spagna. Opere, arti-sti, committenti, collezionisti, a cura di P. Boccardo, J.L. Co-lomer, C. Di Fabio, Cinisello Balsamo 2002, pp. 241-259.
Franchini Guelfi 2004F. Franchini Guelfi, La diversità culturale delle confraternite fra devozione popolare, autonomia laicale e autorità ecclesia-stica, in “Atti della Società ligure di Storia Patria”, 2004, XLIV, pp. 401-444 (Storia della cultura ligure, a cura di D. Puncuh).
From the Sculptor’s Hand 1998From the Sculptor’s Hand. Italian Baroque Terracottas from the State Hermitage Museum, catalogo della mostra (Chi-cago, Philadelphia) a cura di I. Wardropper, Chicago 1998.
Gavazza 1995E. Gavazza, Puget e gli artisti genovesi: l’incontro tra due cultu-re, in Pierre Puget (Marsiglia 1620-1694). Un artista francese e la cultura barocca a Genova, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza, L. Magnani, G. Rotondi Terminiello (Geno-va), Milano 1995, pp. 74-81.
Genova 1992Genova nell’Età Barocca, catalogo della mostra (Genova) a cura di E. Gavazza, G. Rotondi Terminiello, Bologna 1992.
Giscardi ms. 1754G. Giscardi, Notizia di Pitture, Statue, et altro in diverse Chie-se, e palazzi della Città e contorni di Genova con la relazione dell’origine delle medesime Chiese, ms. 1754, Genova, Biblio-teca Franzoniana (ms. C54).
Grosso 1939a
O. Grosso, Catalogo della mostra delle Casacce genovesi, in Le Casacce e la scultura lignea sacra genovese del Seicento e del Settecento, catalogo della mostra a cura di O. Grosso, Genova 1939, pp. 29-47.
Grosso 1939b
O. Grosso, Le Casacce genovesi e la scultura lignea sacra genovese del Seicento e del Settecento, in Le Casacce e la scultura lignea sacra genovese del Seicento e del Settecento, catalogo della mostra a cura di O. Grosso, Genova 1939, pp. 11-27.
Grosso 1939c
O. Grosso, Scultura e costumanze popolaresche nelle casacce genovesi, in “Genova”, 1939, giugno, pp. 17-37.
Herding 1970.K. Herding, Pierre Puget. Dasbildnerische Werk, Berlino 1970.
Lagomarsini 1989S. Lagomarsini, Arte religiosa e iconografia in Val di Vara, in Arte e devozione in Val di Vara, catalogo della mostra (Varese Ligure) a cura di M. Ratti, Genova 1989, pp. 21-32.
La Liguria 1982La Liguria delle Casacce. Devozione, arte, storia delle confra-ternite liguri, catalogo della mostra a cura di F. Franchini Guelfi, Genova 1982.
Le Casacce 1939Le Casacce e la scultura lignea sacra genovese del Seicento e del Settecento, catalogo della mostra a cura di O. Grosso, Genova 1939.
Le Casacce 1974Le Casacce nell’arte e nella storia ligure, catalogo della mo-stra, Genova 1974.
Les confréries 2010Les confréries de Corse. Une société idéale en Méditerranée, catalogo della mostra a cura di J.M. Olivesi, Corte 2010.
Le Storie 2012Le Storie di San Giovanni Battista dell’oratorio del Santo Cri-sto, a cura di G. Zanelli, Genova 2012.
L’Età 2004L’Età di Rubens. Dimore, committenti e collezionisti genove-si, catalogo della mostra (Genova) a cura di P. Boccardo, Milano 2004.
Lignum 2013Lignum Crucis. Crocifissi e arredi della Passione del Signore nella Diocesi di Albenga-Imperia, catalogo della mostra, Al-benga 2013.
Magnani 1988L. Magnani, Documenti per l’attività di Filippo Parodi a Ge-nova e in Veneto, in La scultura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento, Genova 1988, pp. 205-207.
Magnani 1992L. Magnani, La scultura dalle forme della tradizione alla liber-tà dello spazio barocco, in Genova nell’Età Barocca, catalogo della mostra a cura di E. Gavazza, G. Rotondi Terminiello (Genova), Bologna 1992, pp. 291-302.
Magnani 2003L. Magnani, Pierre Puget, uno scultore barocco fra Genova e la corte di Francia, in Genova e la Francia. Opere, artisti, committenti, collezionisti, a cura di P. Boccardo, C. Di Fabio, P. Sénéchal, Genova 2003, pp. 109-123.
Mazzoni 2011a
M.D. Mazzoni, Considerazioni di tecnica costruttiva e deco-rativa di alcune sculture lignee napoletane tra Sei e Settecento. La tecnica degli occhi di vetro, in “Bollettino d’Arte”, 2011, volume speciale (Scultura lignea. Per una storia dei sistemi costruttivi e decorativi dal Medioevo al XIX secolo, atti del convegno [Serra San Quirico e Pergola 2007] a cura di G.B. Fidanza, L. Speranza, M. Valenzuela), pp. 211-220.
Mazzoni 2011b
M.D. Mazzoni, Le tecniche di realizzazione degli occhi di vetro nel XVII secolo con particolare riferimento ad Andrea Brusto-lon, in Andrea Brustolon: opere restaurate. La scultura lignea in età barocca, atti del convegno a cura di A.M. Spiazzi, M. Mazza (Belluno 2009), Padova 2011, pp. 77-88.
Montagu 1985J. Montagu, Alessandro Algardi, Londra 1985, 2 volumi.
Novella ms. 1906P. Novella, Genova. Guida storica artistica descrittiva, ms. 1906, Biblioteca del Centro di Documentazione per la Sto-ria, l’Arte e l’Immagine di Genova.
Novella ms. 1912 (ed. 2003)P. Novella, Gli oratori di Genova. Note storiche e descrittive compilate da Paolo Novella, ms. 1912 (ed. a cura di G. Bia-vati, Genova 2003).
Novella ms. 1929P. Novella, Genova. Guida storica-artistica, ms. 1929, Bi-blioteca del Centro di Documentazione per la Storia, l’Ar-te e l’Immagine di Genova.
Novella ms. post 1931P. Novella, Parrocchie della Grande Genova. Memorie sto-riche descrittive, ms. post 1931, Biblioteca del Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova.
Orlandi 1719P.A. Orlandi, L’Abecedario Pittorico dall’autore ristampato, corretto ed accresciuto di molti professori, Bologna 1719.
Parodi 1914G. Parodi, Tradizione, arte e storia intorno al taumaturgo Cro-cifisso di San Giovanni Battista (Sestri Ponente), Genova 1914.
Parma 1978E. Parma, Albergo dei Poveri, Genova 1978.
Parma Armani 1988E. Parma Armani, Gli Orsolino, in La scultura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento, Genova 1988, pp. 71-76.
Pesenti 1987F.R. Pesenti, L’Illuminismo e l’età neoclassica, in La pittura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento, Genova 1987, pp. 349-375.
Piaggio 1887M. Piaggio, Poesie, Genova 1887.
Pierre Puget 1995Pierre Puget (Marsiglia 1620-1694). Un artista francese e la cultura barocca a Genova, catalogo della mostra (Genova) a cura di E. Gavazza, L. Magnani, G. Rotondi Terminiello, Milano 1995.
Ratti ms. 1762 (ed. 1997)C.G. Ratti, Storia de’ pittori scultori et architetti liguri e de’ forestieri che in Genova operarono, ms. 1762, Genova, Ar-chivio Storico del Comune (ed. a cura di M. Migliorini, Genova 1997).
Ratti 1769C.G. Ratti, Delle vite de’ pittori, scultori ed architetti geno-vesi e dei forestieri che in Genova hanno operato, Genova 1769.
Ravecca 1998P.R. Ravecca, Basilica di N.S. Assunta Sestri Ponente. Il terri-torio, la storia, l’arte, l’attività pastorale, Genova 1998.
Remondini 1893A.-M. Remondini, Parrocchie dell’Archidiocesi di Genova, Notizie storico-ecclesiastiche. Riviera di Ponente, regione XIV (parte seconda), Genova 1893.
Revelli 1896G.B. Revelli, Il Crocifisso di S. Giovanni Battista (Genova-Sestri), Genova 1896.
Rotondi Briasco 1962P. Rotondi Briasco, Filippo Parodi, Genova 1962.
Sánchez Peña 2006J.M. Sánchez Peña, Escultura Genovesa. Artífices del Sete-cientos en Cádiz, Cadice 2006.
Sanguineti 1996D. Sanguineti, Arredo marmoreo e scultura da processione: ricerca di un patrimonio smembrato, in San Giacomo della Marina. Un oratorio di casaccia a Genova nel cammino ver-so Compostella, a cura di G. Rotondi Terminiello, Genova 1996, pp. 93-116.
78 79
Bibliografia
ospitale genovese del Medieovo, catalogo della mostra a cura di G. Rossini, Genova 2001, pp. 109-117.
Tubino 1978G. Tubino, Tre secoli fa a Ssestri. Come fu rubata la ‘Miondi-na’, in “Il Secolo XIX”, 1978, marzo.
Viale ms. 1742G.B. Viale, Notizia di pitture, statue et altro in diverse chie-se e palazzi della città e contorni di Genova colla relazione dell’origine delle medesime chiese, ms. 1742, Genova, Biblio-teca Universitaria (ms. B.III.35).
Zanelli 2004G. Zanelli, Il patrimonio artistico degli oratori del Ponente genovese: ritrovamenti e restauri, in Confraternite genovesi all’alba del terzo millennio, atti del convegno a cura di L. Venzano, Genova 2004, pp. 70-87.
Zanelli 2009G. Zanelli, Considerazioni intorno alla produzione sacra di Antonio Travi, in “Bollettino delle Civiche Istituzioni Cul-turali. Udine”, 2009, 11, pp. 4-13.
Zanelli 2012G. Zanelli, Vicende e riscoperta delle Storie di San Giovan-ni Battista dell’oratorio del Santo Cristo, in Le Storie di San Giovanni Battista dell’oratorio del Santo Cristo, a cura di G. Zanelli, Genova 2012, pp. 8-21.
Sanguineti 1997D. Sanguineti, Contributo a Francesco Campora (1693-1753): opere e documenti, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, 1997, XXXVII, pp. 279-306.
Sanguineti 1998a
D. Sanguineti, Anton Maria Maragliano, Genova 1998.
Sanguineti 1998b
D. Sanguineti, Appunti su Agostino Storace: opere documenta-te e ipotesi attributive per un discepolo di A.M. Maragliano, in «Rivista Ingauna e Intemelia», 1994-1995 (ma 1998), pp. 141-152.
Sanguineti 1998c
D. Sanguineti, Galleano Francesco, Galleano Pietro, in Dizio-nario Biografico degli Italiani, Roma 1998, 51, pp. 531-533.
Sanguineti 1998d
D. Sanguineti, Scultura lignea genovese: i fratelli Galleano, Giovanni Maragliano e gli altri, in «Antologia di Belle Arti» (Studi sul Settecento), 1998, 55-58, pp. 52-67.
Sanguineti 2004D. Sanguineti, Domenico Piola e i pittori della sua casa, Son-cino 2004, 2 volumi.
Sanguineti 2005a
D. Sanguineti, Il Paradiso secondo Maragliano in cinque mac-chine processionali, in Han tutta l’aria di Paradiso. Gruppi processionali di Anton Maria Maragliano tra Genova e Ovada, catalogo della mostra (Ovada) a cura di F. Cervini, D. San-guineti, Torino 2005, pp. 11-32.
Sanguineti 2005b
D. Sanguineti, La scultura lignea, in L’Annunziata del Vasta-to a Genova. Arte e restauro, a cura di G. Rossini, Venezia 2005, pp. 139-145.
Sanguineti 2008D. Sanguineti, “Ebbe il nostro Valerio quattro Discepoli, tutti di buona riuscita”. Biscaino, Cervetto, Magnasco, Merano e la cerchia di Valerio Castello, in Valerio Castello 1624-1659. Genio Moderno, catalogo della mostra a cura di M. Cataldi Gallo, L. Leoncini, C. Manzitti, D. Sanguineti (Genova), Milano 2008, pp. 106-129.
Sanguineti 2009D. Sanguineti, Note sulla scultura lignea genovese al tempo dei Calvi, in Lazzaro Calvi. San Martino e il povero. Il restauro, catalogo della mostra (Genova) a cura di M.T. Orengo, G. Zanelli, Cinisello Balsamo 2009, pp. 37-45.
Sanguineti 2011D. Sanguineti, Domenico Garibaldo e le statue di Sestri Po-nente, in “La Casana”, 2011, 1, pp. 30-33.
Sanguineti 2011-2012D. Sanguineti, Scultura genovese in legno. Materiale per un repertorio dalla seconda metà del Cinquecento al Settecento, tesi di dottorato, Università degli Studi di Udine, anno accademico 2011-2012.
Sanguineti 2012a
D. Sanguineti, Anton Maria Maragliano 1664-1730. ‘Insi-gnis sculptor Genue’, Genova 2012.
Sanguineti 2012b
D. Sanguineti, Filippo Parodi e il decoro della nave ‘Paradiso’: precisazioni cronologiche e spunti di riflessione, in “Paragone”, 2012, 106, pp. 67-87.
Sanguineti 2013D. Sanguineti, Navone, Pasquale, in Dizionario Biografico degli Italiani, 78, Roma 2013, ad vocem.
Sanguineti c.d.s.a
D. Sanguineti, Assetti corporativi tra obblighi e rivendicazioni: gli scultori in legno e i bancalari nella Repubblica di Genova, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, c.d.s.
Sanguineti c.d.s.b
D. Sanguineti, Scultura genovese in legno dal secondo Cinque-cento al Settecento, Torino c.d.s.
Santamaria 1999R. Santamaria, Le statue lignee della chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Casella e due sculture di Agostino Storace in Santa Maria Assunta di Vaccarezza, in Miscellanea di Studi del Centro Culturale del Comune di Casella, Casella 1999, pp. 85-101.
Sborgi 1974F. Sborgi, Pittura e cultura artistica nell’Accademia Ligustica 1751-1920, Genova 1974.
Sborgi 1988a
F. Sborgi, Alcune considerazioni preliminari sulle vicende della scultura nell’ultimo quarto del XVIII secolo, in La scultura a Ge-nova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento, Genova 1988, pp. 301-309.
Sborgi 1988b
F. Sborgi, Nicolò Traverso e Francesco Ravaschio e la scultura fra fine Settecento e inizi Ottocento, in La scultura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo Novecento, Genova 1988 pp. 310-317.
Sborgi 1990F. Sborgi, Alcune note sulla cultura artistica in Liguria nella se-conda metà del Settecento, in Gerolamo Grimaldi e la Società Patria. Aspetti della cultura figurativa ligure nell’età dell’Illumi-nismo, catalogo della mostra a cura di L. Pessa, Genova 1990, pp. 25-58.
Scandurra 1997-1999C.V. Scandurra, Documenti per lo scultore Gerolamo del Canto, in “Studi di Storia delle Arti”, 1997-1999, 9, pp. 323-327.
Silvestri 2012A. Silvestri, Annotazioni sulla tecnica, in D. Sanguineti, An-ton Maria Maragliano 1664-1739. ‘Insignis sculptor Genue’, Genova 2012, pp. 458-461.
Soprani 1674R. Soprani, Le vite de’ Pittori, Scoltori et Architetti Genovesi, e de’ Forastieri, che in Genova operarono, Genova 1674.
Soprani, Ratti 1768R. Soprani, C.G. Ratti, Vite de’ Pittori, Scultori, ed Architet-ti Genovesi di Raffaello Soprani Patrizio Genovese. In questa seconda Edizione rivedute, accresciute, ed arricchite di note da Carlo Giuseppe Ratti Pittore, e Socio delle Accademie Ligusti-che, e Parmense, Genova 1768.
Toncini Cabella 1996A. Toncini Cabella, Rolando Marchelli: nuove testimonianze pittoriche e documentarie, in “Atti dela Società Ligure di Storia Patria”, 1996, XXXVI, pp. 377-407 (Studi e Documenti di Storia Ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco).
Toncini Cabella 2001A. Toncini Cabella, Le opere d’arte delle chiese e degli oratori, in La Commenda dell’Ordine di Malta. Arte e restauri di un