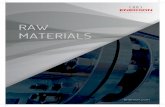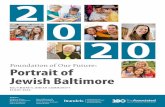entrepreneurial-portrait-of-family-business-succession-in ...
THE PORTRAIT OF ANTONIO NAVAGÈRO BY GIOVAN BATTISTA MORONI:
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of THE PORTRAIT OF ANTONIO NAVAGÈRO BY GIOVAN BATTISTA MORONI:
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
IL RITRATTO DI ANTONIO NAVAGÈRO DI GIOVAN BATTISTA MORONI: STORIA, INDAGINI DIAGNOSTICHE E RESTAURO*THE PORTRAIT OF ANTONIO NAVAGÈRO BY GIOVAN BATTISTA MORRONI:HISTORY, SCIENTIFIC ANALYSIS AND RESTORATIONdi Mariolina Olivari1, Roberta Grazioli2, Fabio Frezzato3, Paolo Cornale4
1 Soprintendenza per i Beni storici, artistici e demoetnoantropologici per le Province di Milano, Como, Lecco, Lodi,
Monza, Pavia, Sondrio e Varese2 Studio di Restauro, Roberta Grazioli3 Centro Ricerche sul Dipinto, CSG Palladio, Vicenza4 CSG Palladio, Vicenza
The aim of the valorization of such an important document of portrait painting as the Portrait of Antonio Navagèro in the Pi-nacoteca di Brera (Milan), has been achieved combining historical research with a careful restoration work including a scien-tific research which has provided important results for the restoration work and chiefly for a better pinpointing of the Moroni’stechnical evolution. The historical work on documents has clarified how the painting entered the collections of Brera in 1813,along with a better definition of the figure of Navagèro.The scientific analysis have pointed out the peculiarities of Moroni’s
(*) I singoli capitoli del testo sono stati scritti rispettivamente da Mariolina Olivari (Il ritratto di Antonio Navagèro di Giovan Battista Moroni aBrera), Roberta Grazioli (Il restauro), Fabio Frezzato e Paolo Cornale (Il ritratto di Antonio Navagero: materiali e tecnica esecutiva alla luce delleindagini scientifiche). Il restauro e la diagnostica sono stati finanziati dal Rotary Club, sezione Milano Nord.
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 324
Il ritratto di Antonio Navagèro di Giovan Battista Moroni a Brera
Il ritratto1 di Antonio Navagèro (fig. 2), pur non es-
sendo figlio delle soppressioni, entrò prestissimo a
Brera, grazie agli scambi promossi dall’allora se-
gretario Zanoja e dalla Commissione dei professori tra
l’Accademia e alcuni antiquari o conoscitori. L’11 no-
vembre del 1813 fu fatto un cambio con Pasquale Can-
na, che per la tela di Moroni riceveva quattro dipinti2.
Presumo di essere nel vero identificando qui Pasquale
Canna con lo scenografo che in quegli stessi anni fu at-
tivo in molti teatri italiani, la Scala in primis, dove mise
in scena varie opere. Nel 1812 Canna era a Venezia per
allestire la scenografia de L’Inganno felice di Rossini e
non è improbabile che proprio in quell’occasione ac-
quisisse il dipinto di Moroni e lo portasse con sé a Mila-
no nel 1813. Se poi si considera che lo scenografo era
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
il Ritratto di Antonio Navagèro di Giovan Battista Moroni: storia, indagini diagnostiche e restauro 325
Fig. 2 - A sinistra il dipinto prima del restauro (in blu i punti dei microprelievi, in giallo i punti di misura XRF); a destra il dipinto dopo il restauro (foto di R. Grazioli).
Nella pagina accanto, Fig. 1 - Radiografia della zona del volto (foto CSG Palladio, Vicenza).
painting technique, including the use of pyrolusite in the priming layers, that he certainly learnt when he had worked in Mo-retto’s workshop. A comparison with other scientific reports on Moroni’s paintings shows that the portrait of Brera belongs toa moment when the painter was changing his method of preparation of canvas with the gradual transition from white tobrown grounds. The restoration of the painting has been based on the applying of a methodology that could restore the chroma-tic and material features trying to make a ‘dialectical’ comparison with the restoration carried out by Luigi Cavenaghi in theXIX century. Wet cleaning techniques have been used, including conductimetric and chemical affinities essays, to avoid dama-ges to the original layers and even to some of those relevant to the past restoration. Varnishes and coatings that altered the pic-torial features have been carefully removed or selectively thinned out.
Parole chiave: Test di solubilità, pulitura differenziata, pulitura per via umida, ESEM, XRF, micro FTIR, pirolusite.
1 Olio su tela, cm. 115 x 90, Inv. Nap. 876; Inv. Gen. 83; Reg. Cron. 334.2 Dal Registro Napoleonico risulta che i dipinti erano una Madonna col Bambino e san Giuseppe di Francesco Francia, giunta dalla chiesa disanta Lucia di Faenza (Inv. Nap. n. 623), una Madonna col Bambino e san Giovannino di Elisabetta Sirani (correggo quanto avevo io stessaindicato nel 1990 in Pinacoteca di Brera, Scuola veneta (Zeri 1990, pp. 426 - 428, n. 216), quando per un errore di allineamento nella letturadell’Inventario Napoleonico avevo indicato il Gessi quale autore del dipinto), che proveniva dalla Madonna di Gagliani o Gaglioni (?), La Caritàdi Bonifacio Veronese (Inv. Nap. 636) e una tela con Puttini con strumenti musicali attribuita a Paolo Veronese (inv. Nap. 112).
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 325
stato un allievo di Brera3, diventa più che lecito chie-
dersi se lo scambio, più che una iniziativa personale,
non sia stato un’idea pilotata da Brera stessa, per assi-
curarsi un tassello che veniva a rimpolpare il settore
dei ritratti, uno dei più scarsi della Galleria.
Nel ritratto, il basamento marmoreo su cui si appoggia
con la mano sinistra il personaggio, riporta l’iscrizione
“CUM BERGOMI / PRAETURAM / SUSTINERET /
M.D.LXV” (fig. 3), grazie alla quale si era potuto da tem-
po (v. catalogo di Brera del 1875) riconoscere nel ritrat-
tato il nobile veneto Antonio Navagèro, figlio di France-
sco e di Dandola Michiel4. Benchè nel dipinto i fili bian-
chi che già gli ingrigiscono la barba e i capelli ne invec-
chino l’aspetto, aveva solo trentatre anni quando Moro-
ni lo ritrasse, vista la data di nascita ricordata dal Barba-
ro5, il 1532. Sappiamo che morì poi a cinquantacinque
anni nel 1587. Nel ritratto indossa la veste propria della
carica ricoperta, rossa con robone nero foderato di “lu-
po cerviero”, cioè di lince.
Francesco Rossi segnala una ulteriore effige del preto-
re in una medaglia firmata in caratteri greci APCEN,
conservata nel Medagliere del Castello Sforzesco di Mi-
lano6. Al verso della medaglia è presente il motto: INI-
QUOR. MORSUS. NON. PREVALEBUNT. Al recto, oltre
al profilo del Navagèro, la medaglia reca l’iscrizione:
AN. NAVGIERI. PA. VE. AET. ANN. L (Antonius Nauge-
rius Patricius Venetus Aetatis Annorum L)7. Se il 1532
fosse la data di nascita esatta, la medaglia sarebbe dun-
que posteriore al dipinto di Moroni, perché risalirebbe
al 1582 e ciò spiegherebbe perché il ritrattato appaia
più appesantito e segnato rispetto alla tela. Il 17 dicem-
bre del 1565 il Navagèro inviava a Venezia, come già al-
tri suoi predecessori avevano fatto, un rapporto sulla
situazione bergamasca, funestata da una crisi interna
notevole per le accuse di eresia lanciate da fra Girola-
mo Finucci nientemeno che al vescovo, Vittore Soran-
zo, e per la sanguinosa lotta che opponeva due delle fa-
miglie più cospicue, i Brembati e gli Albani8.
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
Mariolina Olivari, Roberta Grazioli, Fabio Frezzato, Paolo Cornale326
3 Tra il 1779 e il 1785 Canna aveva frequentato a Brera i corsi di Ornato, Figura e Architettura (Ringrazio Francesca Valli per lacomunicazione). 4 OLIVARI M., in AA.VV. 1990, scheda 219, pp. 432-436.5 BARBARO, cc. 294v., 295.6 ROSSI 1979, p. 336, n. 50.7 Gabinetto Numismatico e Medagliere delle Raccolte Artistiche del Comune di Milano.8 Nel 1562 Giovan Battista Brembati era stato condannato da Venezia al bando perpetuo, mentre l’anno dopo la famiglia Albani era statadispersa e il capofamiglia Gian Gerolamo con uno dei figli era stato mandato al confino nell’isola di Lesina, a seguito del clamoroso omicidio delrivale Achille Brembati durante la messa in Santa Maria Maggiore (BELOTTI 1937). I figli di Albani furono mandati anch’essi al confino, i sicaritorturati, decapitati e squartati.
Fig. 3 - Immagine a luce radente, in cui sono visibili l’impronta del supporto originale a saia a seguito dello schiacciamento indotto dalla foderatura e alcune micro-lacune del film pittorico (foto di R. Grazioli).
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 326
Il Navagèro aveva ricevuto quindi in dote una città dif-
ficile, gravemente squassata dall’odio e dalla violenza,
inquieta anche sul versante religioso. La Repubblica
doveva quindi tenere altissima l’attenzione e la scelta
di Navagèro non era casuale, poiché la famiglia cui ap-
parteneva aveva una rilevante tradizione diplomatica
e aveva fornito alla Serenissima ambasciatori, podestà
e uomini politici9.
Sembra che il ritratto si accordi perfettamente con
quanto Francesco Maria Tassi riporta nella vita del Mo-
roni: “...unico riuscì ne’ ritratti, de’ quali tanta era la sti-
ma, che ne faceva Tiziano, che dir soleva a’ Rettori, che
da Venezia partivano per i governi di Bergamo, che se
bramavano il loro vero, e naturale ritratto si facessero
dipingere dal Moroni”10.
Forse anche Antonio Navagero aveva seguito il consi-
glio del grande maestro e si era perciò rivolto all’artista
bergamasco.
Il risultato è davvero un “vero, e naturale ritratto”, cer-
to meno “grande” di quanto Tiziano avrebbe saputo fa-
re e forse il magistrato avrebbe voluto, e tanto più lom-
bardo nella sua concretezza. Dalla tela ci guarda un vi-
so bonario, con un accenno lontanissimo e segreto di
sorriso: un personaggio assai poco tizianesco già nella
psicologia, nel suo porsi davanti alla memoria futura.
Nessun gioiello, nessun accessorio, nessun richiamo
ad altre passioni. Tanta semplicità e un così netto rigo-
re è certo da mettere in relazione anche con l’impegno
controriformistico della famiglia, concretizzato dal
ruolo rilevante avuto da Bernardo nel movimento pro-
mosso da Trento, dove si distinse come uno dei prota-
gonisti.
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
il Ritratto di Antonio Navagèro di Giovan Battista Moroni: storia, indagini diagnostiche e restauro 327
9 Il cugino Bernardo, che moriva proprio nel 1565, fine diplomatico, era stato nominato cardinale nel 1561 ed era stato legato pontificio alConcilio di Trento.10 TASSI 1970, p. 166. L’autore continua raccontando il celebre aneddoto, già raccontato dal Ridolfi, del gentiluomo Albani a Venezia, cuiTiziano rifiutò con gran garbo il ritratto, consigliandogli, con sottilissima ironia, di tornare a Bergamo da Moroni, che avrebbe fatto certamenteun’opera “più pregevole..., e più singolare della mia”.
Fig. 4 - Particolari durante la pulitura: si evidenziano la spessa vernice oleoresinosa (a sinistra) e l’effetto di maculatura del fondo per alterazione cromatica delle campiturechiare (a destra) (foto di R. Grazioli).
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 327
Alla fine del mandato il magistrato si portò il ritratto a
Venezia, dove quasi un secolo dopo, nel 1648, venne
registrato dal Ridolfi ancora “in casa Navagiera alla Pie-
tà”11. Anche il Tassi riprende la notizia, pur ammetten-
do di non avere mai visto alcuno dei ritratti di Moroni
elencati da Ridolfi nelle case dei privati veneziani. Non
vi è dunque la certezza che a fine Settecento il quadro
fosse ancora a Venezia, né sappiamo come sia finito po-
co dopo sul mercato antiquario.
Sulla storia conservativa antecedente al restauro odier-
no gli archivi di Brera restituiscono una sola notizia
certa, l’intervento di Cavenaghi nel 1883 – 84, quindi
nel momento immediatamente successivo alla separa-
zione tra Accademia e Pinacoteca (1882), quando ci fu
una sorta di riordino generale e il restauratore mise
mano a parecchie cose12. L’intervento costò allora 100
lire. Le osservazioni fatte da Roberta Grazioli sugli stuc-
chi preesistenti emersi dalla pulitura e sulle lacune
confermano puntualmente le osservazioni effettuate
da Cavenaghi, anche il sospetto che il dipinto non po-
tesse essere arrivato a quel tempo, a più di trecento an-
ni d’età, senza altri interventi più antichi purtroppo
non rintracciabili.
Secondo un procedimento usato frequentemente, Ca-
venaghi applicò, alla fine dell’intervento, una generale
stesura oleoresinosa su tutta la superficie del dipinto,
quale ravvivante e patinante. Questa però era ora così
fortemente ossidata da avvolgere tutto in una omoge-
nea e punitiva cortina giallastra. Tolto questo velo or-
mai controproducente il Ritratto di Antonio Navagero ci
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
Mariolina Olivari, Roberta Grazioli, Fabio Frezzato, Paolo Cornale328
Fig. 5 - Stuccature ottocentesche del bordo inferiore nel particolare durante la pulitura (a sinistra); ridipinture ottocentesche a legante oleoso nel particolare durante la pu-litura (a destra) (foto di R. Grazioli).
11 RIDOLFI 1648, I, p. 131.12 Sopr. BSAE Milano, Archivio Antico, II, cass.57. All’interno del documento troviamo anche alcune considerazioni di Cavenaghi chesottolineava la necessità “di assicurare il colore in alcune parti, di piccoli restauri e passarvi la vernice levati i ristauri precedenti e riparato nei gua-sti”.
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 328
viene restituito veramente come un limpido capolavo-
ro della maturità dell’artista. Predominano i grigi, mo-
dulati freddissimi, di una luminosità adamantina e
ghiacciata sui frammenti architettonici dello sfondo,
ripresi appena più sbiancati o sporchi nel pelo di lince,
di nuovo affioranti nella pietra fredda che fa da base di
appoggio alla mano del gentiluomo.
Rompe questa tavolozza che sembra ricchissima e che
è invece fatta solo di grande mestiere, l’avaro angolo di
terso cielo turchese in alto a sinistra, così simile a quel-
lo delle migliori pale, come la straordinaria Assunzionedella Vergine già nella chiesa bergamasca di san Bene-
detto e ora a Brera. Ma è soprattutto il rosso aranciato
della veste, che attraversa come una lama inaspettata e
fulgente questo sobrio quadro d’insieme che lo trasfor-
ma in una immagine indimenticabile.
Il restauro Stato di conservazione - L’esame diretto dell’opera ha
confermato i dati d’archivio che registrano due restauri
precedenti, di cui il primo ad opera di Luigi Cavenaghi
nel 1883-8413. L’intervento successivo, che precedette
la mostra del 1979 curata da Mina Gregori14, e fu esegui-
to dal Consorzio di restauratori bergamaschi facenti ca-
po all’Accademia Carrara, fu limitato al risarcimento di
alcune lacune e alla verniciatura superficiale: il raffron-
to con le fotografie dell’epoca mostrava una situazione
pressoché invariata ad oggi15. Il supporto originale, rico-
noscibile dall’esame in luce radente della superficie, è
costituito da una pezza di lino ad armatura a saia a tessi-
tura regolare. L’assenza di importanti deformazioni pla-
stiche del supporto e di fenomeni gravi di deadesione,
testimoniava una buona situazione fisico-meccanica
dei supporti e del telaio, confermandone il ruolo strut-
turale. L’osservazione diretta conferma i dati diagnosti-
ci relativi all’attenta tecnica di preparazione che confe-
risce grande elasticità grazie alla stesura preliminare
con funzione apprettante ed isolante, e all’impiego di
legante oleoso nell’imprimitura pigmentata. La strati-
grafia semplice del film pittorico, privo di velature di fi-
nitura, reso con una delicata modulazione dei toni me-
diante impasti omogenei e un ductus uniforme, contri-
buisce alla realizzazione di una pittura semplificata nel-
la sua composizione ed estremamente elastica nel com-
portamento meccanico, trovando riscontro nella cretta-
tura da invecchiamento che interessa gli strati pittorici
in modo uniforme, senza distinzioni significative tra
preparazione e film pittorico, con la formazione di un
cretto principale profondo ad andamento preferenziale
obliquo, determinato dall’intreccio diagonale delle tra-
me del supporto con gli orditi, in cui si inserisce un cret-
to secondario più sottile e regolare, indotto dalle stesure
più superficiali: conferma ne è la buona interazione col
supporto, ad eccezione di alcuni distacchi nei punti di
sforzo. Le indagini preliminari avevano evidenziato
stuccature e ritocchi lungo il perimetro, l’impressione
della tela sul fronte dovuto alla stiratura e la presenza
diffusa di microlacune corrispondenti ai punti emer-
genti del filato (fig. 3). Le pennellate chiare e scure, ese-
guite sullo sfondo con effetti di vibrazione cromatica,
avevano assunto l’aspetto di una deturpante maculatu-
ra per alterazione delle parti chiare ed evidenziazione
di quelle scure. Il film protettivo, costituito da più ste-
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
il Ritratto di Antonio Navagèro di Giovan Battista Moroni: storia, indagini diagnostiche e restauro 329
Fig. 6 - Test di solubilità conduttimetrici, con resin soap e chelanti, test di Teas sul-le campiture grigie; in basso: particolare dei test con resin soap sulle campiture az-zurre (foto di R. Grazioli).
13 L’intervento di Luigi Cavenaghi prevedeva la foderatura del supporto a colla-pasta e doppia tela pattina, stirando il dipinto a faccia in giù; lasostituzione del telaio, la pulitura delle stesure pittoriche, la stuccatura e una diffusa integrazione pittorica. La presenza di numerose ridipintureche denunciavano lacune pregresse degli strati pittorici lungo il perimetro, imputabili alle condizioni conservative ambientali o a problemi deltelaio originale, avrebbe giustificato la foderatura ottocentesca nonostante l’assenza di lacerazioni o discontinuità del supporto.14 GREGORI 1979, pp. 166-167.15 GREGORI 1979, p. 45.
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 329
sure spesse e disomogenee di vernici, presentava una
vistosa alterazione per ossidazione fotocromatica, ac-
cumuli giallastri e un aspetto opalescente, con conse-
guenti ingiallimento ed omogeneizzazione generali
dell’aspetto superficiale (fig. 4). La natura in buona
parte oleo-resinosa delle vernici di restauro ottocen-
tesche era denunciata da accumuli bruni di consi-
stenza gommosa, identificabili nelle mucillagini resi-
duali caratteristiche della frazione oleosa: nel caso in
oggetto poteva essere individuata come ‘miscela rav-
vivante’, tra i prodotti consigliati nel manuale del Sec-
co Suardo, impiegata nel restauro ottocentesco in fase
pre-integrazione per saturare il colore o in fase inter-
media per occultare aree interessate da alterazioni o
ridipinture, applicata per impregnazione a caldo16.
La differente leggibilità delle ridipinture rivelava la
presenza di due interventi di restauro susseguenti, dei
quali il più antico, più esteso, è quasi illeggibile sotto
lo strato di vernice alterata, mentre il secondo, so-
vrammesso e più evidente, riguarda lacune puntuali. I
risultati dei test di pulitura hanno definito un quadro
stratigraficamente complesso, maggiormente com-
promesso lungo il perimetro17 (fig. 5). Non si riscontra-
vano danni da abrasione meccanica o corrosione per
effetto di puliture aggressive. Intervento- L’attuale in-
tervento si è basato su tre considerazioni: perfetta effi-
cienza delle caratteristiche fisico-meccaniche di sup-
porto e telaio; stabilizzazione dei fenomeni di degrado
in corrispondenza delle aree di criticità; presenza di
stesure di vernice, patinature e ridipinture che pregiu-
dicavano la corretta leggibilità. La fase preliminare ha
previsto la verifica della stabilità del sistema struttura-
le e degli strati pittorici: le deadesioni localizzate sono
state consolidate con resina acrilica Plexisol P550 in
solvente alifatico, attivata con termocautere. La disin-
festazione delle parti lignee è stata effettuata a scopo
preventivo per garantirne una miglior diffusione e
provvedere l’opera di adeguata protezione da attacchi
xilofagi18. La ricerca di metodiche di pulitura che pre-
sentassero il minimo grado di invasività possibile, valu-
tando anche la coerenza degli interventi pregressi, di
evidente valore documentale, ha assunto un ruolo cen-
trale nel recupero delle qualità materiche e cromatiche
dell’opera. Le peculiarità conservative e tecniche han-
no imposto l’individuazione di metodi differenziati in
funzione delle singole campiture, flessibili, in grado di
restituire un corretto equilibrio fra tutte le parti nel ri-
spetto della storia conservativa dell’opera. Una prima
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
Mariolina Olivari, Roberta Grazioli, Fabio Frezzato, Paolo Cornale330
Fig. 7 - Tassello di pulitura stratigrafico (a sinistra) e prova di pulitura avanzata (adestra) (foto di R. Grazioli).
16 CECCHINI, GIORDANO, MILANI 1995, pp. 60, 100.17 All’intervento novecentesco erano attribuibili in sequenza stratigrafica: film di vernice terpenica applicata con stesure differenziate infunzione delle diverse campiture. I test di solubilità hanno fornito un parametro di solubilità minima già a Fd 82 con miscela di ligroina eacetone o con miscele di tipo acquoso (soluzione tampone ph 9,7); - ritocchi mimetici a vernice, alterati e puntuali su stuccature bianche omarroni; - seconda stesura di vernice terpenica, di maggiore consistenza, leggermente pigmentata per attenuare le alterazioni lungo il lato destro,rimovibile a Fd77 o resin soap. La sequenza ottocentesca sottostante presentava: - patinatura oleoresinosa bruna, con aggiunta di bitume,localizzata sullo sfondo a sinistra e sulla parte superiore occultando svelature, lacune di modesta entità e microlacune diffuse; - velature puntualia vernice di rifinitura a ridipinture sottostanti; - stesura oleoresinosa estesa con differente grado di assorbimento, presumibilmente composta damiscela di olio siccativo, resina terpenica e bitume, fortemente rigonfiante ed affiorante con tempi di applicazione del solvente prolungati.Particolarmente spessa, celava la maggior parte delle ridipinture; - ritocchi a legante oleoso, estremamente tenaci ed alterati; - stuccature grigio-marrone, saturate a gommalacca, tenaci e debordanti.18 Emulsione grassa di permetrina applicata ad impacco per consentire una maggiore diffusione del prodotto e provvedere l’opera di unadeguata protezione per un lasso di tempo prolungato (ca.6 mesi-1 anno).
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 330
serie di test puntuali ha permesso di stabilire i parame-
tri di solubilità delle sovrammissioni mediante una me-
todica di riferimento standardizzata, i cui risultati sono
stati riformulati per ottenere metodologie adeguate ai
livelli di pulitura individuati, in relazione alle singole
campiture e al risultato complessivo19 (fig. 6).
Sondaggi stratigrafici per aree cromatiche hanno con-
sentito l’identificazione dell’esatta sequenza delle so-
vrammissioni stabilendone il corretto grado di rimo-
zione, in accordo con le indicazioni della Direzione La-
vori (fig. 7). Una prima fase per via umida con metodi
basati sull’affinità chimica dei materiali20, per non in-
terferire con le componenti sottostanti, ha rimosso la
vernice terpenica superficiale; è seguito l’alleggeri-
mento selettivo delle patinature a legante oleoso, che
presentavano un elevato grado di ossidazione ed una
forte interazione con la stesura pittorica, e delle ridi-
pinture con miscele di solventi organici a range di pola-
rità medio-bassa predeterminata, applicati in suppor-
tanti differenziati per calibrare l’interazione superfi-
ciale21 (fig. 7).
L’intervento pittorico, previo adeguamento delle stuc-
cature, è stato pure condotto in modo differenziato, mi-
rando al risarcimento delle lacune puntuali con meto-
do mimetico, alla revisione delle numerose alterazioni
cromatiche originali, otticamente più invasive, me-
diante leggera velatura, all’integrazione delle lacune di
maggior entità e ricalibratura delle ridipinture conser-
vate a selezione cromatica22. La superficie è stata pro-
tetta con vernice mastice nebulizzata ad aerografo, per
equilibrare le caratteristiche ottiche superficiali.
Il ritratto di Antonio Navagèro:materiali e tecnica esecutiva alla lucedelle indagini scientifiche Negli ultimi quindici anni sono state eseguite numero-
se indagini su vari dipinti del pittore di Albino, fra i
quali almeno sette sono stati sottoposti a microprelievi
esaminati in sezione microstratigrafica23. Ciò ha per-
messo di ricostruire i metodi, all’epoca piuttosto inno-
vativi, impiegati da Moroni per preparare i supporti,
ma soprattutto, nella maggioranza dei casi, ha fornito
l’evidenza della presenza di un vero e proprio marker,la pirolusite, un ossido di manganese nero (MnO2) che
in campo pittorico è stato riconosciuto solo in pochi ca-
si e prevalentemente in opere di Moretto da Brescia e
del suo allievo Moroni24. Claudio Seccaroni ha eviden-
ziato per primo, in base ad analisi in fluorescenza X
(XRF) eseguite insieme a Pietro Moioli su opere di Cor-
reggio e di Perugino, la possibilità che un’area indagata
contenga pirolusite25, anziché, come talvolta si ipotizza
semplicisticamente, solo terra d’ombra, classe di terre
brune ricche di manganese e ferro26. La conferma della
tesi è venuta pochi anni dopo dalle analisi stratigrafi-
che eseguite alla National Gallery di Londra su dipinti
di Moroni, che hanno permesso di localizzare i granuli
di pirolusite perlopiù negli strati preparatori dei dipinti
esaminati27. Gli stessi Moioli e Seccaroni hanno pubbli-
cato nel 2005 i risultati di analisi XRF condotte su sei di-
pinti di Moroni, da cui è stato nuovamente dedotto
l’impiego dello stesso minerale solo negli strati prepa-
ratori28. Ciò è in accordo con l’ipotesi che la pirolusite
sia stata usata principalmente per la sua capacità di ac-
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
il Ritratto di Antonio Navagèro di Giovan Battista Moroni: storia, indagini diagnostiche e restauro 331
19 Sono stati condotti test di solubilità con solventi organici secondo i parametri del triangolo delle solubilità con test di Teas e test di solubilitàmediante miscele acquose standardizzate basati su metodi conduttimetrici e di variazione del Ph: 1- miscele di tensioattivi ionici e non ionici; 2-miscele chelanti a Ph variabile; 3- soluzioni tampone a ph differenziato; 4- resin soap.20 Resin soap di acido abietico, successivo lavaggio con oxy-bile per l’asportazione dei residui.21 Resin soap di acido abietico o miscela di solventi organici (0,2% alcool benzilico, 0,2% Tea, 2% oxy-bile) in gel di carbopol o in emulsionestearica. L’operazione è stata approfondita dove la consistenza della stesura interferiva pesantemente con un recupero adeguato delle qualitàcromatiche e con la rimozione delle ridipinture alterate. L’asportazione dei ritocchi alterati è stata eseguita a tampone con Dowanol Pm1:laddove le ridipinture si presentavano più tenaci si è provveduto all’applicazione di soluzione di Dowanol PM1-citrato di ammonio all’1% inacqua deionizzata in emulsione stearica seguita da lavaggio con miscela di ligroina ed acetone a bassa polarità (Fd 87).22 L’integrazione delle lacune di maggior entità e la ricalibratura della vistosa alterazione lungo il lato destro sono state eseguite mediantetecnica riconoscibile, selezione cromatica condotta a puntini o sottili trattini in funzione delle aree di intervento.23 Oltre ai due campioni prelevati dal Ritratto di Antonio Navagero e analizzati da CSG Palladio (Vicenza), di cui si parla nel testo, fra le indaginistratigrafiche pubblicate si veda DUNKERTON, SPRING, 1998, p. 129; SPRING, GROUT, WHITE 2003, pp. 100-101; GALEOTTI, LALLI, LANTERNA,RIZZI, TOSINI 2005, pp. 131-132; VOLPIN 2008, pp. 28-31.24 La presenza di pirolusite in dipinti del XVI secolo conservati alla National Gallery di Londra è stata riscontrata in sezioni stratigrafichericavate da campioni prelevati da tre opere del Moretto eseguite tra il 1538 e il 1554, e da quattro di Moroni collocabili fra il 1555 e il 1565(SPRING, GROUT, WHITE 2003, p. 113). Ciò assegnerebbe al Moretto il ruolo di innovatore e a Moroni quello di continuatore di una tradizionelegata molto probabilmente alla disponibilità del minerale in area bergamasco-bresciana, attestata anche da Vannoccio Biringuccio (Seccaroni1999, p. 45). Nell’articolo di Spring, Grout e White si citano anche due dipinti di Tiziano contenenti pirolusite (pp. 101 e 113; inoltre, sullarecente riattribuzione a Tiziano di uno dei due dipinti si veda JOANNIDES, DUNKERTON 2007.25 SECCARONI 1999, p. 44; SECCARONI, MOIOLI 2002, p. 94.26 Ibid.27 Pirolusite è stata anche trovata mescolata a biacca e terra verde, nello strato grigio-verde dello sfondo di un ritratto maschile alla NationalGallery di Londra (SPRING, GROUT, WHITE 2003, p. 101).28 “L’ampia variabilità del rapporto ferro / manganese e la presenza sistematica di quest’ultimo elemento in tutti i dipinti esaminati,indipendentemente dal colore delle campiture, escludono la possibilità di interpretare il dato come dovuto all’impiego di terra d’ombra. Quantodetto, e il fatto che i conteggi di manganese tendono comunque a salire in corrispondenza delle campiture in cui gli strati pittorici risultanomeno schermanti... indicano che la pirolusite non è invece stata impiegata negli strati cromatici” (MOIOLI, SECCARONI 2005, p. 132). Altreindagini XRF eseguite da Gianluca Poldi su dipinti di Moroni al Museo dell’Accademia Carrara di Bergamo confermano la presenza di pirolusite(comunicazione personale).
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 331
celerare l’essiccamento dei leganti oleosi e solo secon-
dariamente per le sue qualità cromatiche.
Le indagini svolte su ritratto del Navagèro hanno com-
preso la riflettografia dell’intero dipinto, radiografie
parziali (zona del volto e della mano destra)29, analisi
composizionali su otto punti tramite fluorescenza X
(XRF) portatile e due analisi di microcampioni ridotti
in sezione microstratigrafica lucida30.
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
Mariolina Olivari, Roberta Grazioli, Fabio Frezzato, Paolo Cornale332
29 Sia la riflettografia, eseguita con fotocamera al silicio nella banda fra 0,85 e 1,2 μm, sia la radiografia di una sola zona, vanno intese comepassi preliminari ad eventuali ulteriori approfondimenti.30 La ricerca analitica è stata eseguita da CSG Palladio s.r.l. (Vicenza). Per le analisi in fluorescenza X (XRF) è stato impiegato uno strumentoportatile Bruker Tracer III-V. Per le analisi microstratigrafiche in sezione lucida è stata utilizzata la seguente strumentazione: microscopio otticoNikon Alphaphot-2 POL N-57; ESEM mod. Quanta 200 (FEI Company, USA), spettrofotometro FTIR iS10 accoppiato a un microscopioFTIR Continµum con dispositivo micro ATR a cristallo di silicio, accessorio Smart Orbit a cristallo di diamante e Spectra-Tech MicroCompression Diamond Cell (Thermo Scientific, USA).
Fig. 8 - Polsino rosso - Sezione stratigrafica al microscopio ottico (in alto) e all’ESEM (in basso): strato A) fibre di tela impregnate di colla e pochissimo gesso (riconoscibilenegli aggregati di maggior luminosità all’ESEM); B) colla C) imprimitura giallo-bruna con ocre, carbonato di calcio e granuli neri di pirolusite; D) stesura pittorica conte-nente vermiglione e lacca rossa; E) vernici di restauro (foto CSG Palladio, Vicenza).
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 332
Dall’immagine riflettografica non emerge con eviden-
za un disegno preparatorio (underdrawing) nettamente
delineato e distinto dai contorni degli elementi figura-
tivi, sia a causa della preparazione scura, sia forse per
l’uso di materiali poco rilevabili, diversi ad esempio dal
carboncino. Quasi assenti e di minima entità anche i
pentimenti31.
Analogamente, le zone sottoposte a radiografia non
hanno rivelato caratteri sostanzialmente difformi da
quanto appare in superficie, né tracce di versioni pre-
cedenti. Si nota solo, sulla parete adiacente al volto,
l’incrocio di svelte pennellate (fig. 1). Quanto detto si
accorda con l’ipotesi di un’esecuzione condotta senza
incertezze.
Importanti aspetti della tecnica pittorica sono stati ri-
velati dalle analisi stratigrafiche: le immagini acquisite
all’ESEM dimostrano che la tela è stata trattata con una
minima quantità di gesso disperso in medium proteico
- presumibilmente colla animale32 - che funge da sottile
preparazione per proteggere il supporto tessile dal-
l’azione deleteria degli oli negli strati soprastanti (fig.8). Al di sopra è stata stesa un’imprimitura giallo-bruna
piuttosto spessa (50-110 µm), composta da ocra gialla,
ocra giallo-aranciata e carbonato di calcio, accompa-
gnati da pirolusite, da minime aggiunte di ocra rossa,
orpimento e/o realgar. Il legante è di tipo oleoso33.
La scarsa quantità di gesso nel sottile strato di colla, e
allo stesso tempo lo spessore decisamente maggiore
dell’imprimitura giallo-bruna dimostra il progressivo
slittamento della funzione di quest’ultima da fondo
cromatico e isolante delle stesure pittoriche a prepara-
zione vera e propria del supporto34.
È interessante notare che in una delle opere più tarde,
La Vergine incoronata dalla Trinità in Sant’Alessandro
della Croce a Bergamo, da poco restaurata, le analisi mi-
crostratigrafiche hanno rivelato che sopra la tela, pro-
babilmente trattata con colla animale, la mestica bruna
è diventata la vera preparazione ed appare ricoperta da
un ulteriore strato di imprimitura bianca o bianco-gri-
giastra che precede ovunque le stesure pittoriche35.
Imprimiture brune su tele appena sfiorate da minime
quantità di gesso sono state trovate in più dipinti del
Moretto, il quale con Correggio, Dosso, Parmigianino e
in rari casi Tiziano, si colloca nel ristretto gruppo di pit-
tori ‘sperimentali’, a tutt’oggi considerati fra i primi
fautori dell’evoluzione che nella seconda metà del se-
colo porta sempre più frequentemente gli artisti italia-
ni ad adottare preparazioni colorate in sostituzione di
quelle tradizionali bianche36.
Nel ritratto del Navagèro le stesure pittoriche sono co-
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
il Ritratto di Antonio Navagèro di Giovan Battista Moroni: storia, indagini diagnostiche e restauro 333
Fig. 9 - Incarnato del collo. Sezione stratigrafica: sopra l’imprimitura giallo-bruna è visibile lo strato rosato di biacca e vermiglione, con rari granuli di ocra gialla, ocra rossae pirolusite (foto CSG Palladio, Vicenza).
31 Caratteristiche simili presentano sia i dipinti di Moroni conservati al Museo dell’Accademia Carrara di Bergamo, sia la grande tela con LaVergine incoronata dalla Trinità (POLDI, VILLA 2008, pp. 23-24).32 L’analisi mediante micro FTIR ha evidenziato assorbimenti di legami peptidici.33 Imprimiture di questo genere sono state riscontrate in tutte le indagini stratigrafiche segnalate alla nota 24.34 Una situazione simile è stata rilevata da chi scrive nel corso di recenti analisi eseguite su un dipinto sacro di Moroni, fino ad oggi assegnatoal quinto decennio del Cinquecento (in attesa di pubblicazione).35 VOLPIN 2008, pp. 29-30.36 “With one possible exception, all Moroni’s primings are over a thin layer of gesso, but the priming is the more substantial layer. It can beassumed that Moroni developed his practice from his master … As early as 1526 … Moretto was employing brown preparations, possibly witha small amount of gesso scraped into the canvas interstices; but on the late altarpieces there is no evidence for any gesso” (DUNKERTON, SPRING2008, pp. 123).
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 333
stituite in entrambi i campioni da un unico strato, con
spessori non elevati (fra 30 a 45 µm)37.
Lo strato rosso del polsino, che ricalca la situazione di
tutto il farsetto, è costituito da vermiglione, lacca rossa
di probabile origine animale (come suggerisce la non
trascurabile percentuale di fosforo riscontrata all’EDS)
e minime aggiunte di biacca e nero carbone, il tutto le-
gato in olio. Nell’incarnato del collo (fig. 9) la miscela di
pigmenti che lo caratterizza contiene in prevalenza
biacca e vermiglione, insieme a poche ocre, pochissi-
ma lacca rossa e pirolusite; il medium è oleoso, parzial-
mente trasformato in saponi di piombo e ossalati.
L’indagine microstratigrafica è stata accompagnata da
misurazioni mediante analisi XRF portatile su otto
punti del dipinto (fig. 2).
Quasi ovunque i rapporti manganese/ferro richiama-
no la presenza di pirolusite e non solo di terra d’ombra,
ipotizzabile peraltro nei punti 3, 7 e 8. Per il cielo (pun-
to 1) è stato usato un pigmento rameico (probabilmen-
te azzurrite) e biacca. Anche nel ciuffo erboso (punto
6) sopra la porzione di colonna in alto a sinistra sono
stati rilevati pigmenti rameici, che potrebbero corri-
spondere a verdigris alterato da verde a bruno per
l’azione del legante.
Le zone chiare del collo di pelo (punto 5) sono a base di
biacca; l’abito nero sulla destra (punto 3) è probabil-
mente realizzato con un nero carbonioso e forse terre,
considerando che il modesto numero di conteggi del
manganese impedisce di ipotizzare pirolusite nella mi-
scela pittorica; nello stesso punto prevale il piombo, ri-
feribile a biacca usata per la rovina retrostante.
In corrispondenza dell’incarnato e del farsetto gli ele-
menti riscontrati confermano quanto osservato in se-
zione. In quattro punti, infine, sono state rilevate im-
purezze di zinco, riferibili come in altri casi, alle terre
impiegate38.
Bibliografia
AA.VV. 1990
AA.VV., Pinacoteca di Brera. Scuola veneta, Mondadori
Electa, Milano 1990.
BARBARO
Barbaro M., Genealogie nobili venete, Venezia, Bibliote-
ca del Museo Correr, Ms. Cicogna 513, cons. XI, 2/4.
BELOTTI 1937
Belotti B., Una sacrilega faida bergamasca del Cinquecen-to, Istituto italiano d’arti grafiche, Bergamo 1937.
CECCHINI, GIORDANO, MILANI 1995
Cecchini G., Giordano G., Milani D. (a cura di), Mate-riali tradizionali per il restauro dei dipinti. Preparazione eapplicazione secondo il manuale di Giovanni Secco Suar-do, (Associazione Giovanni Secco Suardo), Studio Gra-
fico Pubblicitario s.r.l., Dalmine 1995.
CREMONESI 2004 a
Cremonesi P., L’uso di tensioattivi e chelanti nella pulitu-ra di opere policrome, Il Prato, Padova 2004.
CREMONESI 2004 b
Cremonesi P., L’uso dei solventi organici nella pulitura diopere policrome, Il Prato, Padova 2004.
DUNKERTON, SPRING 1998
Dunkerton J., Spring M., “The development of pain-
ting on coloured surfaces in sixteenth-century Italy”,
in Painting techniques. History, materials and studiopractice, Pre-prints of the 17th International Congress
of the IIC (Dublin, 7-11 September 1998), ed. by A.
Roy, P. Smith, International Institute for Conserva-
tion of Historic and Artistic Works, London 1998, pp.
120-130.
EASTAUGH, WALSH, CHAPLIN, SIDDALL 2004
Eastaugh N., Walsh V., Chaplin T., Siddall R. (ed. by),
Pigment Compendium. A Dictionary of Historical Pig-ments, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
FELLER, STOLOW, JONES 1985
Feller R. L., Stolow N., Jones E.H., On Picture Varnishesand Their Solvents, National Gallery of Art, Washington
D.C 1985.
GALEOTTI M., LALLI C.G., LANTERNA G., RIZZI A., TOSINI I.,
“Le indagini conoscitive: indagini diagnostiche e mor-
fologiche”, in Giovan Battista Moroni. Il Cavaliere in ne-ro. L'immagine del gentiluomo nel Cinquecento, Skira, Gi-
nevra-Milano, 2005, pp. 131-132.
GREGORI 1979
Gregori M. (a cura di), Giovan Battista Moroni, Catalogo
della mostra, Azienda autonoma di turismo, Bergamo
1979.
JOANNIDES, DUNKERTON 2007
Joannides P., Dunkerton J., “A Boy with a Bird in the
National Gallery: Two Responses to a Titian Question”,
National Gallery Technical Bulletin, vol. 28 (2007), pp.
36-57.
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
Mariolina Olivari, Roberta Grazioli, Fabio Frezzato, Paolo Cornale334
37 Cfr. VOLPIN 2008, p. 31.38 MOIOLI, SECCARONI, op. cit., p. 132.
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 334
MOIOLI P., SECCARONI 2005
Moioli P., Seccaroni C., “Pigmenti identificati mediante
analisi XRF non distruttiva in sei dipinti di Giovan Bat-
tista Moroni”, in Giovan Battista Moroni. Il Cavaliere innero. L’immagine del gentiluomo nel Cinquecento, Skira,
Ginevra-Milano, 2005, pp. 132-133.
POLDI, VILLA 2008
Poldi G., Villa G.C.F., “Analisi non invasive sull’Incoro-
nazione della Vergine di Moroni”, in Giovan BattistaMoroni “La Trinità che incorona la Vergine”, a cura di E.
Daffra, Fondazione Credito Bergamasco, Bergamo
2008, pp. 22-26.
RIDOLFI 1648
Ridolfi C., Le meraviglie dell’arte. Ovvero le vite degli illu-stri pittori veneti e dello Stato, I, Venezia 1648.
ROSSI 1979
ROSSI F., “Mostra storico-documentaria”, in Giovan Bat-tista Moroni, catalogo della mostra, Azienda autonoma
del turismo, Bergamo 1979, p. 317-345.
SECCARONI, MOIOLI 2002
Seccaroni C., Moioli P., Fluorescenza a raggi X. Prontua-rio per l’analisi XRF portatile applicata a superfici policro-me, Nardini Editore, Firenze 2002.
SECCARONI 1999
Seccaroni C., “Alcuni pigmenti scarsamente documen-
tati. Ipotesi e osservazioni in margine ad analisi con-
dotte su tre tempere di Correggio”, Kermes, 34 (1999),
pp. 41-59.
SECCO-SUARDO 1983
Secco-Suardo G., Il Restauratore dei dipinti, Reprint An-
tichi Manuali (ed. anastatica dell’edizione 1927), Hoe-
pli, Milano 1983.
SIGNORINI , CREMONESI 2004
Signorini E., Cremonesi P., “L’uso dei solventi organici
neutri nella pulitura dei dipinti: un nuovo test di solu-
bilità”, in Progetto Restauro, 31, Il Prato, Padova 2004,
pp. 2-15.
SPRING, GROUT, WHITE 2003
Spring M., Grout R., White R., “Black Earths: A Study of
Unusual and Dark Grey Pigments used by Artists in
the Sixteenth Century”, National Gallery Technical Bul-letin, 24 (2003), pp. 97-114.
TASSI 1970
Tassi F.M., Vite de’ Pittori Scultori e Architetti Bergama-schi, ms. 1793, a cura di F. Mazzini, I, Labor, Mila-
no1970.
VOLPIN 2008
Volpin S., “I materiali e la tecnica pittorica alla luce del-
le indagini chimico-stratigrafiche”, in Giovan BattistaMoroni “La Trinità che incorona la Vergine”, a cura di E.
Daffra, Fondazione Credito Bergamasco, Bergamo
2008, pp. 2-31.
I t a l i a n H e r i t a g e A w a r d 2 0 1 3
il Ritratto di Antonio Navagèro di Giovan Battista Moroni: storia, indagini diagnostiche e restauro 335
324-335 IHA_Layout 1 27/10/13 02.16 Pagina 335