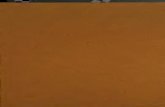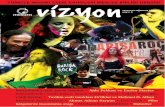ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ENRICO FERMI " SAN GIOVANNI LA PUNTA MATTIA ASCANIO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " ENRICO FERMI " SAN GIOVANNI LA PUNTA MATTIA ASCANIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ENRICOFERMI”
SAN GIOVANNI LA PUNTA
MATTIA ASCANIO
NOVECENTO: MOSAICO DI CULTURA, ARTE E
TECNOLOGIA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
INDICE
IL SECOLO SCORSO: LA CULTURA E LE SCOPERTE
Storia: L’Italia Giolittianapag. 2
Letteratura Italiana: Il Decadentismo in Italia pag. 5
Storia dell’arte: Gustav Klimtpag. 13
Ed. musicale: La musica nei primi anni del secolo scorsopag.19
Scienze e Geografia: Il sistema solare e suoi scienziati pag.23
Tecnologia: L’energia solarepag.27
Inglese: The various sources of Energy pag.30
Francese: L'énergie éolienne pag.33
Ed. fisica: La pallavolopag.34
1
Italia Giolittiana
Giovanni Giolitti (1842-1928)
Il Novecento in Italia inizia con il periodo detto“giolittiano” dal nome dell’uomo che dominerà lascena politica per oltre un decennio, dal 1903 al1914. Nascono i partiti di massa. Giolitti, sia comeministro degli Interni, sia come presidente delConsiglio, rifiuta di intervenire nelle lotte traoperai e imprenditori, cerca il dialogo con isocialisti e introduce il diritto di voto pertutti gli uomini adulti.
3
La sua politica industriale però penalizza il Sud.Lui fu chiamato al ministro degli Interni, daVittorio Emanuele III, figlio del re Umberto Iucciso a Monza, per poi diventare presidente delConsiglio. La sua visione della politica era moltopratica e concreta, infatti cercava di volta involta i rimedi vantaggiosi. Agli occhi di chi lo amava meno risultava unfreddo ragioniere, mentre i sostenitori loapprezzavano per il suo grande fiuto da statista,la capacità di intuire e mettere in pratica lescelte giuste al momento giusto. Anche l’Italiaconobbe il decollo industriale. Il sistemabancario finanziava lo sviluppo: i settoritrainanti sono il tessile (NAUMANN), il meccanico(FIAT) e quello dell’energia elettrica (SEI). Giolitti dovette affrontare molti scioperi. Perlui lo sciopero non era un reato, ma una forma dilotta. Lo Stato doveva essere neutrale, garantirel’ordine pubblico e intervenire solo di frontealle violenze. Egli inoltre varò alcune leggi a favore deilavoratori: fu innalzata da 9 a 12 l’età in cui siandava a lavorare, l’orario massimo di lavoro era12 ore al giorno per le donne e 11 per gliadolescenti sotto i 15 anni. Alle donnelavoratrici fu riconosciuto un mese pagato digravidanza. Con la riforma elettorale del 1912Giolitti introduce il diritto di voto per tuttigli uomini adulti.
4
Nasce l’epoca dei grandi partiti di massa efinisce la maggioranza parlamentare dei liberali.Oltre a migliorare e a regolare le condizioni dilavoro, con le riforme, Giolitti giunse a farapprovare nel 1912, l’allargamento del suffragioelettorale. Si dimostrò anche generoso nelconcedere favori ai fedeli sostenitori.L’estensione di voto a tutti i maschi adultiobbligò i partiti a diventare più moderni e amigliorare le loro organizzazioni. I cattolici avevano negato la collaborazione alloStato italiano, colpevole dell’ aggressione alloStato Pontificio del 1870. Il patto tra liberali eCattolici prese una forma ancora più concreta inoccasione dei voti nel 1913. Venne siglato ilPatto Gentiloni e ottenuto l’appoggio dellaChiesa. In cambio i liberali si impegnavano asostenere la scuola cattolica e a non approvareleggi contro alla morale cattolica, come ildivorzio. Tra il 1900 e il 1914 emigrano ben 8 milioni emezzo di Italiani. Nella scelta delle mete doveemigrare, gli Italiani seguirono soprattutto trelinee direttrici: verso i Paesi europei, verso leAmeriche e verso l’Australia. Giolitti riprendel’attività coloniale italiana e riesce ariprendere la Libia all’Impero Ottomano. Sonofavorevoli all’iniziativa i nazionalisti, gliindustriali e alcuni socialisti. Il risultato sulpiano economico però è deludente. Le elezioni nel 1913 registrano un rafforzamentodei socialisti. Giolitti si dimette e il nuovo
5
presidente del consiglio, Antonio Salandra, adottauna politica repressiva contro ogni manifestazionein piazza.
6
Il decadentismo in ItaliaVerso la fine del Novecento, sorsero nuoviindirizzi di pensiero, si affermò un nuovo gusto eun nuovo concetto dell’arte. Il termine decadentismo viene dal francesedècadent, che veniva usato per definire dei “poetimaledetti” nella seconda metà dell’Ottocento,chiamati così per la loro vita disordinata eribelle. Essi non si sentirono offesi, maaddirittura accettarono questo appellativo comeuna giusta definizione del proprio stato d’animo:stanco, annoiato, sazio di una società che a lorosembrava avesse compiuto il suo ciclo storico efosse ormai alla fine.Questo movimento ebbe origine in Francia epresentava gravi segni di pessimismo e angoscia.Si ritorceva principalmente contro le durerepressioni delle proteste dei lavoratori, controle dure leggi del mercato, i complessi conflittinazionali e internazionali che sfociarono inun’aggressiva politica di espansione coloniale ein due guerre mondiali e che distrussero ilmomento dell’ottimismo positivistico.Al di sopra di ogni principio morale, alcuniartisti decadenti posero il valore della purabellezza, che viene definito estetismo, che sitraduce nella ricerca della forma pura. Gli esponenti più significativi della correnteletteraria italiana del Decadentismo sono i poetiGiovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. Pascoliper la sofferenza interiore che esprimono le sue
7
poesie, rendendo la vita difficile da vivere;D’Annunzio soprattutto per la concezione dellaricerca estrema della bellezza e la concezione delsuperuomo e per il nazionalismo. Alla base del Decadentismo c’è la teoria delsuperuomo, dove il personaggio è maggiore a tuttoe a tutti. Questa particolare esasperazionedell’individualismo costituì la base ideologicadelle future dittature in Europa: il fascismo, ilnazismo, e lo stalinismo.
8
Giovanni Pascoli
Giovanni Pascoli (1855-1912)
Giovanni Pascoli nacque a San Mauro(Forlì) nel1855. La sua fanciullezza trascorsa nelle campagneromagnole, fu presto segnata da vari luttifamiliari. Fu soprattutto la morte del padre aimprontare l’indole del futuro poeta di unsentimento sfiduciato e pessimistico verso lavita. Divenne presto famoso per l’eccezionale qualitàdella sua opera poetica e per le sue opere latine
9
premiate ad Amsterdam. Il poeta morì a Bologna nel1912. Pascoli all’inizio della sua carriera raccontavaesperienze personali. Accanto ai lutti familiari,nelle sue opere compare anche l’ambiente romagnoloe contadino. La poesia pascoliana fu per tutti una novità permolti aspetti, e in primo luogo per la sceltadegli argomenti, che erano semplici e quotidiani.Sarebbe però sbagliato considerarla di facilecomprensione. Non è facile, perché è allusiva:quasi sempre la realtà, per il poeta, ha unsignificato che va al di là di ciò che tuttivedono e sentono. Ad esempio Pascoli in una suapoesia parla di un aquilone, che è un gioco di unbambino, ma alludono anche alle illusioni dellafanciullezza; l’aratro nella nebbia rappresentauno strumento agricolo ma anche un desolatoabbandono. Anche il suo linguaggio hacaratteristiche particolari, perche possiedelinguaggi quotidiani, parole dotte o dialettali,termini insoliti o molto specifici e perciò poconoti. Tra le sue poesie ricordiamo: La cavalla storna,Il temporale, Lavandare, La mia sera, Novembre etante altre … La prima particolarmente toccanteperché in essa il poeta esprime il dolore per latragica e prematura morte del padre e checontrassegnerà la qualità delle sue opere.
10
La cavalla stornaNella Torre il silenzio era già alto. Sussurravano i pioppi del Rio Salto.I cavalli normanni alle lor poste frangean la biada con rumor di croste.Là in fondo la cavalla era, selvaggia, nata tra i pini su la salsa spiaggia;che nelle froge avea del mar gli spruzziancora, e gli urli negli orecchi aguzzi.Con su la greppia un gomito, da essaera mia madre; e le dicea sommessa:« O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna;tu capivi il suo cenno ed il suo detto! Egli ha lasciato un figlio giovinetto;il primo d'otto tra miei figli e figlie; e la sua mano non tocco' mai briglie.Tu che ti senti ai fianchi l'uragano,tu dai retta alla sua piccola mano.Tu c'hai nel cuore la marina brulla,tu dai retta alla sua voce fanciulla». La cavalla volgea la scarna testa verso mia madre, che dicea più mesta:« O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna;lo so, lo so, che tu l'amavi forte! Con lui c'eri tu sola e la sua morteO nata in selve tra l'ondate e il vento,tu tenesti nel cuore il tuo spavento;sentendo lasso nella bocca il morso,nel cuor veloce tu premesti il corso:
11
adagio seguitasti la tua via, perché facesse in pace l'agonia . . . »La scarna lunga testa era daccanto al dolce viso di mia madre in pianto.«O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna;oh! due parole egli dove' pur dire!E tu capisci, ma non sai ridire.Tu con le briglie sciolte tra le zampe,con dentro gli occhi il fuoco delle vampe, con negli orecchi l'eco degli scoppi, seguitasti la via tra gli alti pioppi:lo riportavi tra il morir del sole, perché udissimo noi le sue parole».Stava attenta la lunga testa fiera. Mia madre l'abbraccio' su la criniera.« O cavallina, cavallina storna,portavi a casa sua chi non ritorna!a me, chi non ritornerà più mai!Tu fosti buona . . . Ma parlar non sai!Tu non sai, poverina; altri non osa. Oh! ma tu devi dirmi una una cosa! Tu l'hai veduto l'uomo che l'uccise: esso t'è qui nelle pupille fise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome.E tu fa cenno. Dio t'insegni, come».Ora, i cavalli non frangean la biada:dormian sognando il bianco della strada.La paglia non battean con l'unghie vuote:dormian sognando il rullo delle ruote.Mia madre alzò nel gran silenzio un dito: disse un nome . . . Sonò alto un nitrito.
12
ParafrasiNella Torre era già calata la notte. Simuovevano(per il vento) i Pioppi e il Rio Salto. Icavalli normanni stavano ai loro posti,masticavano la biada facendo rumore. Là in fondoc’era la cavalla, selvaggia, nata fra i pini sullasalata spiaggia; che nella criniera aveva ancoragli spruzzi dell’acqua e le urla nelle orecchie(irumori del mare).Sulla sua schiena mia madre avevaappoggiato il gomito e gli diceva a bassa voce:”Ocavallina, cavallina storna che portavi colui chenon c’è più(il marito ucciso), tu obbedivi ai suoigesti e alle sue parole. Egli ha lasciato unfiglio piccolo, il primo di otto, e non è maiandato a cavallo. Tu che corri veloce, tuobbedisci alla sua piccola mano. Tu hai nel cuorela vegetazione marina, dai retta alla sua vocebambina. La cavalla volse la sua testa magra versomia madre che diceva sempre più a bassa voce:Ocavallina, cavallina storna, che portavi colui chenon c’è più, lo so che lo amavi veramente! Con luiin quell’istante c’eri solo tu e la morte. Tu chesei nata tra i boschi, le onde, il vento, nel tuocuore spaventato, sentendo il laccio nella boccache tiene il morso, corresti via. Con calmaseguitasti per il tuo percorso perché morisse inpace. La magra lunga testa era accanto al dolceviso di mia madre che piangeva. “O cavallina,cavallina storna, che portavi colui che non c’èpiù..Oh! due cose egli avrà detto! E tu le hai
13
capite, ma non le puoi dire. Tu con le brigliesciolte tra le zampe e negli occhi lo sparo, connegli orecchi l’eco del colpo, proseguivi la tuavia tra i pioppi: lo riportavi a casa per iltramonto perché noi sentissimo quello che aveva dadire. Stava ferma con la testa alzata. Mia madregli abbracciò il collo:”O cavallina, cavallinastorna, riporta colui che non c’è più! A me, coluiche mai più tornerà! Tu sei stata buona..ma nonsai parlare! Tu non lo sai fare, poverina; altriche potrebbero non osano parlare. Oh! Ma tu devidirmi una cosa! Tu l’ hai visto l’uomo che l’ haucciso, lui è ancora nei tuoi occhi. Chi è stato!Ti dico un nome. E tu fammi un cenno. DioT’insegni a farlo. Ora i cavalli non mangiavano:dormivano sognando la strada (il tragitto percorsoin giornata), non calpestavano la paglia:dormivano sognando il rumore delle ruote. Miamadre alzò nella notte un dito e disse unnome..Risuonò un forte nitrito.
CommentoLa morte misteriosa del padre ha segnato molto la vita del Pascoli ed è infatti uno dei temi che ricorre sempre nelle sue poesie. Tutta la sua famiglia è rimasta sconvolta dalla tragedia, soprattutto la madre, che non avendo nessuno con cui confidarsi, si rivolge alla cavalla perché sa che è l’unica di cui potersi fidare e che sa la verità. Il poeta paragona la fedeltà della cavalla
14
alla vigliaccheria dell’uomo. Gli uomini che sanno, infatti, non parlano mentre la cavalla che vorrebbe parlare non può, non ha la parola. Un altro tema che ricorre spesso nelle sue opere è ladescrizione e l’uso della natura come un simbolo per trasmettere qualcosa di profondo al lettore.
15
Il temporaleUn bubbolìo lontano. . .
Rosseggia l’orizzonte,
come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un’ala di gabbiano.
ParafrasiIl brontolio di un tuono lontano … L’orizzonte siaccende di rosso, come se fosse di fuoco, verso ilmare; sui monti il cielo è nero come la pece, inmezzo vi sono nubi bianchi: tra le nuvole nere c’èun casolare: un’ala di gabbiano.
CommentoPascoli attraverso il linguaggio delle sensazionipresenta un paesaggio al tramonto: da un parte ilmare, infuocato dal brillare dei raggi del soleche cala, e dall'altra le montagne, su cui sistanno addensando le nere nubi di un temporale. Inmezzo alla campagna un casolare bianco sidistingue grazie alla luce di un lampo improvviso.Il poeta descrive la scena attraverso lesensazioni, che si susseguono una dopo l'altranella poesia: il rumore del tuono; il colore rosso
16
dell'orizzonte; il nero delle nuvole minacciosedel temporale, in mezzo al quale si stagliaqualche nuvola sfilacciata più chiara; il colorebianco del casolare che appare all'improvviso eche è reso dall'analogia.
17
Gustav Klimt
Gustav Klimt (1862-1918)
Gustav Klimt nasce nel 1862 a Baumgarten,quartiere di Vienna, secondo di sette fratelli. Ilpadre Ernst, immigrato boemo, è orafo, la madre,Anna Finster, appassionata di musica lirica. Le condizioni economiche della famiglia, giàcompromesse, diventano precarie dopo la crisieconomica del 1873 causata dal fallimentodell'Esposizione Universale di Vienna. Gustav Klimt è il pittore più rappresentativodell'art nouveau. Partito da una formazioneartistica ancora tradizionale, diviene uno deimassimi esponenti della secessione viennese. Inlui prevalgono il simbolo, l'evocazione della
18
realtà, piuttosto che la sua rappresentazione; lalinea elegante, morbida e sinuosa, labidimensionalità delle forme, l'accostamentosapiente dei colori, il preziosismo, in unafusione e in un assorbimento delle più svariatecomponenti, che vanno dalla conoscenza dei mosaicidi Ravenna fino alle più recenti acquisizioniartistiche (simbolismo, decadentismo) epsicoanalitiche. Ma l'arte di Klimt non è tutta o soltantoespressione di un mondo interiore morbosamenteangosciato, come appare in molte sue opere: egli ècapace di rendere anche l'ultima magica poesia diun bel paesaggio o la forza interiore che emanadai visi di alcuni ritratti femminili. Nel 1876 il quattordicenne Gustav viene ammesso afrequentare la scuola d'arte e mestieri del MuseoAustriaco per l'arte e l'industria, dove studieràfino al 1883, confrontandosi con svariate tecnicheartistiche, dal mosaico alla ceramica e cosi via. Tre anni dopo, con il fratello minore Ernst ed unamico, grazie all'interessamento del professorLaufberger, ottiene la commissione per ladecorazione di un cortile, su progetto dellostesso Laufberger. Tra il 1886 e il 1888 sidedica, con il fratello e l'amico, alladecorazione del Burgtheater di Vienna, in unaserie di pannelli raffiguranti teatridell'antichità o del mondo contemporaneo. I tre guadagnano ben presto la stima e lanotorietà tra i cittadini viennesi, e lecommissioni dei primi ritratti garantiranno loro
19
un discreto successo e una tranquillità economica.I ritratti vengono eseguiti a partire dafotografie, e una delle prime qualità che vienericonosciuta a Gustav è proprio la precisionefotografica nella resa dei volti. Nel 1888 Klimt riceve un riconoscimento ufficialedall'imperatore Francesco Giuseppe e le universitàdi Monaco e Vienna lo nominano membro onorario.Nel 1892, a pochi mesi dalla morte del padre,anche il fratello Ernst muore improvvisamente:Gustav deve farsi carico di entrambe le famiglie,e questo lutto lascia un segno anche nella suaproduzione artistica. Nello stesso periodo avvienel'incontro con Emilie Flöge che, pur essendo aconoscenza delle relazioni che il pittoreintrattiene con altre donne (negli anni '90infatti Klimt sarà il padre riconosciuto di almeno14 figli), sarà la sua compagna fino alla mortedel pittore. Nel 1898 si inaugura la prima mostra dellaSecessione viennese, movimento artisticocostituitosi l'anno prima con Klimt presidente.Questa rivista si chiamava Ver Sacrum (primaverasacra) di cui sono stati pubblicati 96 numeri,fino al 1903. Nel 1894 l'università di Viennaaveva commissionato all'artista la decorazione delsoffitto dell'aula magna sul tema illuminista deltrionfo della Luce sulle Tenebre, da sviluppare sutre facoltà: Filosofia, Medicina e Giurisprudenza.I lavori vengono rimandati per anni e, quando ipannelli verranno presentati, rispecchiano ilmutamento stilistico del giovane pittore,
20
influenzato dalla Secessione che egli stesso avevafondato. Tutti e tre i pannelli, della dimensione430x300cm, vennero distrutti da un incendio delCastello di Immerdorf nel 1945, e ne rimangonosolo foto in bianco e nero e una foto a colori delbozzetto di Medicina. Il primo pannello fu presentato da Klimt solo nel1900, in occasione della settima mostra dellaSecessione. Si tratta della Filosofia. Già inquesta occasione si capisce come lo stile delpittore sia radicalmente cambiato e difficilmentepotrà rispondere alle attese della committenzapubblica. Ottantasette professori dell'università'protestarono contro questa opera, la quale,tuttavia, vinse anche il primo premioall’Esposizione Universale di Parigi del 1900. Nonsi tratta più del limpido stile storicista tantoamato dai viennesi, ma un fluire di corpisimbolici e metafisici; non una parata dei grandipensatori del passato ma un turbinio di forzeoscure e non rassicuranti. A sinistra una massa dicorpi in diversi atteggiamenti, giovani e anziani,disperati o sereni; a destra uno sfondopunteggiato di stelle su cui aleggia un voltomisterioso (l'enigma del mondo) mentre in bassospunta un volto femminile radioso: La Filosofia.
21
Il bacio (1908);
L’albero della vita (1905-1909) realizzato per il palazzo Stoclet con L’attesa e L’abbraccio.
25
La musica nei primi anni del secolo scorsoNon è possibile ritrovare nelle vicende delNovecento poche linee conduttrici dominanti, lacaratteristica del secolo è proprio quella dellediverse correnti. Molti musicisti nella loro vitaaderiscono a più correnti. Si possono ritrovarealcuni elementi che consentono di mettere un certoordine nella musica del Novecento.1. La prima fase abbraccia il periodo che vadalla fine dell’ Ottocento alla prima guerramondiale e comprende diverse correnti.-Impressionismo: il cui maggiore esponente èClaude Debussy, dalla musica incerta e sfumata
Claude Debussy (1862-1918)
Politonalità: utilizza accordi derivatidall’accostamento di più tonalità e da ritmi
27
irregolari. Il suo autore più importante èStravinskij.
Igor Stravinskij (1882-1971)
Espressionismo: un sistema dove i dodici suonidella scala cromatica sono usati in modolibero. Il massimo compositore è Schonberg.
Arnold Schonberg (1879-1951)28
Futurismo: Balilla Pratella utilizza i rumoriper creare composizioni musicali, anticipandola musica concreta ed elettronica.
Balilla Pratella (1880-1955)
2. Il periodo del primo dopoguerra comprende le seguenti correnti.- Neoclassicismo:i compositori si ispiranoall’epoca classica.
Dodecafonia: utilizza i dodici suoni dellascala cromatica, seguendo un ordine preciso.Tra i seguaci più importanti ci sono Berg eWebern.
29
Alban Berg (1885-1935)Anton Webern (1833-1945)
Neonazionalismo: ricollegandosi alle scuolenazionali dell’Ottocento cerca di rinnovare illinguaggio musicale.
30
3. La terza tendenza riunisce tutti i musicistiche ricercano una frattura con la tradizione edabbraccia il periodo del secondo dopoguerra.- Nuova avanguardia: tende a realizzare lapolifonia con qualsiasi altro mezzo eapparecchiatura.
- Serialità: applica il principio dellaserialità come il tempo e il timbro.
- La musica aleatoria: vuol dire “musicalasciata a caso” cioè che si basasull’assoluta libertà e improvvisazione.
- Musica concreta: introduce suoni e rumorimanipolati in vario modo. Il più importantecompositore è Schaeffer.
Pierre Schaeffer(1910-1995)
4. La quarta tendenza è eseguita da musicisti cheutilizzano tecnologie nuove.- Musica elettronica: i nuovi timbri sonoricavati da sintetizzatori.
31
- Binomio musica e informatica: sfrutta lepotenzialità del computer per otteneretimbri, estensioni e modi musicali.
5. Negli ultimi anni del secolo si conclude ilperiodo delle avanguardie e si afferma ildiritto di ogni musicista di scegliereliberamente i modelli da seguire. Altri elementicaratteristici sono l’integrazione di musicheprovenienti da aree geografiche tra loro moltodistanti e la fusione di musica colta,leggera,jazz, popolare ed etnica.
32
Il Sistema solare e i suoi scienziati
Il Sistema solare nacque circa 4 miliardi di annifa quando una nube enorme di polvere e gas iniziòa scontrarsi. Le zone di maggiore condensazione di materialeformarono un nucleo che divenne sempre più caldo eesteso e che formò il Sole. Il Sole costituisce il centro del sistema solare eil 99% della massa dell’intero sistema. Il sistemasolare è l’insieme dei corpi celesti che ruotanoin modo ellittico attorno alla stella Sole. I pianeti finora conosciuti del Sistema solaresono otto, e vengono divisi in due gruppi: ipianeti terrestri (simili alla terra) e i pianetigioviani (simili a Giove).
33
I pianeti terrestri sono: Mercurio, Venere, Terrae Marte; essi sono caratterizzati da unasuperficie rocciosa e solida e hanno una densitàabbastanza elevata. Giove, Saturno, Urano eNettuno sono invece i pianeti gioviani. Hannodensità minori rispetto a quelli della terra, sonoper la maggior parte composti da elementi allostato liquido e gassoso. Questi otto pianeti simuovono intorno al Sole e percorrono orbite aforma di ellisse. Questo movimento viene chiamatomoto di rivoluzione. I pianeti inoltre girano sulproprio asse, compiendo un moto di rotazione. Isatelliti sono corpi celesti di minori dimensionie che ruotano intorno ai pianeti: la Terra ne hauno (la Luna), Marte due, Giove sedici, Saturnodiciassette, Urano quindici e Nettuno otto.
Niccolò Copernico
34
Niccolò Copernico (1473-1543) Studio del Sist. Solare sec. Copernico
Niccolò Copernico fu un prete e astronomo polaccofamoso per aver portato all'affermazione la teoriaeliocentrica. La sua teoria che propone il Sole al centro delsistema di orbite dei pianeti componenti ilsistema solare e riprende quella greca diAristarco di Samo dell'eliocentrismo, la teoriaopposta al geocentrismo, che voleva invece laTerra al centro del sistema. Merito suo non èdunque l'idea, già espressa dai greci, ma la sua
35
rigorosa dimostrazione tramite procedimenti dicarattere matematico. La teoria di Copernico non era però senza difetti,o almeno senza punti che in seguito si sarebberorivelati sbagliati, come per esempio l'indicazionedi orbite circolari, anziché ellittiche come oggisappiamo dei pianeti. La teoria impressionò grandiscienziati come Galileo e Keplero, che sul suomodello svilupparono correzioni ed estensionidella teoria. Fu l'osservazione galileiana dellefasi di Venere a fornire il primo riscontroscientifico delle intuizioni copernicane.
Galileo Galilei
Galileo Galilei (Pisa 1564- Arcetri 1642)
Galileo Galilei è stato un fisico, filosofo,astronomo e matematico italiano, padre dellascienza moderna. Il suo nome è associato adimportanti contributi in dinamica e in astronomia,
36
fra cui il perfezionamento del telescopio, che glipermise importanti osservazioni astronomiche, eall'introduzione del metodo scientifico (dettospesso metodo galileiano o metodo scientificosperimentale). Di primaria importanza furono ilsuo ruolo nella rivoluzione astronomica e il suosostegno al sistema eliocentrico e alle teoriecopernicane. Sospettato di eresia e accusato divoler sovvertire la filosofia naturalearistotelica e le Sacre Scritture, Galileo fuprocessato e condannato dal Sant'Uffizio.
37
Keplero e le sue leggi
Johannes Keplero (1571-1630)Il moto dei pianeti attorno al Sole è statodescritto da tre leggi formulate nel Seicentodall’astronomo tedesco Keplero.
La prima legge di Keplero dice che: ipianeti percorrono orbite a forma di ellissee il Sole occupa uno dei due fuochi.
La seconda legge di Keplero dice che:durante il moto, i segmenti che uniscono ilcentro del pianeta al centro del Soledescrivono aree uguali in tempi uguali. Unpianeta non percorre la sua orbita con lastessa velocità, ma rallenta quando è piùlontano dal Sole e accelera quando è piùvicino.
La terza legge di Keplero dice che: ilquadrato del tempo necessario a un pianeta
38
per compiere un intero giro attorno al Soleè proporzionale al cubo della sua distanzamedia dal Sole.
39
L’energia solare
L' energia solare è l'energia associata allaradiazione solare e rappresenta la fonte primariadi energia sulla Terra che rende possibile lavita. Da essa derivano più o meno direttamente quasitutte le altre fonti energetiche disponibiliall'uomo quali i combustibili fossili, l'energiaeolica, l'energia idroelettrica, l'energia dabiomassa con le sole eccezioni dell'energianucleare, dell'energia geotermica e dell'energiadelle maree. Può essere utilizzata direttamente ascopi energetici per produrre calore o energiaelettrica con varie tipologie di impianto,
40
soprattutto perché è pulita quindi non inquina, èinesauribile, non contamina, ed è distribuitaanche se in modo non uniforme, su tutto il globo. L’energia solare purtroppo presenta degliinconvenienti: è una fonte variabile, infatti èlegata all’alternarsi del giorno e della notte,alle stagioni e alle condizioni climatiche e anchese diffusa ovunque alcune zone della Terra sonopiù favorite perché maggiormente colpite
dall’irraggiamento solare. Irraggiamento solare nelle diverse aree geografiche d’Italia
Le principali tecnologie che utilizzano l’energiasolare riguardano i seguenti campi diapplicazione:
Produzione di calore a bassa temperatura Produzione di calore ad alta temperatura Conversione fotovoltaica
Produzione di calore a bassa temperaturaE’ il settore più collaudato che offre buonirisultati. I settori di applicazione riguardano:
41
La produzione di acqua calda nelle abitazioni per usi sanitari;
Il riscaldamento di case, uffici, scuole; La produzione di aria calda per usi agricoli eindustriali.
42
Produzione di calore ad alta temperaturaLa tecnologia più matura per la produzione dienergia elettrica dal Sole è quella che utilizzai collettori parabolici lineari, ma vengonoattuati anche i sistemi a torre e il progettoinventato da Archimede.
Conversione fotovoltaicaLe celle fotovoltaiche, trasformano direttamentel’energia luminosa dei raggi solari in energiaelettrica. Gli impianti fotovoltaici sono ingrado di risolvere i problemi relativiall’alimentazione elettrica di utenzeparticolari, come quelle in località distantidalla rete di distribuzione e quelledifficilmente raggiungibili. Inoltre ci sonoanche degli impianti collegati alla reteelettrica. Nelle ore in cui il generatore non èin grado di produrre l’energia necessaria acoprire la domanda di elettricità, la retefornisce l’energia richiesta.
43
The various sources of energy
Le diverse fonti di energia
Renewable Energy Renewable energy is energy which comes fromnatural resources such as sunlight, wind, tides,rain and geothermal heat, which are renewable.
Hydroelectric
Hydroelectric is an energy power from water. Aproven technology for the production ofelectricity. This type of power is also entirelyrenewable and has no CO2 emissions. Disadvantagesis hydroelectric plants and the dams they requirecause some damage to the landscape.
45
Eolic
Eolic is an energy power from the wind. Entirelyrenewable with no CO2 emissions. Disadvantages isthe cost is still quite high. High-capacity solarplants require a large surface area.
Biomass
46
Biomass is an energy power from the wasteproducts. There are plentiful sources of this typeof power in the waste products from agriculture,forestry and food processing and is not dependedon fossil fuels. Disadvantages is the burningthese substances creates polluting gases andliquid waste. Collecting, transporting and storingwaste is expensive.
Tidal power
Tidal power is an energy created by the sea. It isrenewable with no CO2 emissions. Disadvantages isthey damage the marine environment and spoil thelandscape.
Hydrogen
47
Hydrogen is an energy created by any power plant.Plentiful sources can be generated by any existingpower plants. Extremely clean no CO2 just wateremissions. It has lots of applications.Disadvantages is the cost of producing hydrogen isstill quite high.
48
Energie éolienne
L’energia eolica
Si vous traversez une campagne française, si vousregardez autour, vous pouvez rencontrer certainspales d'éoliennes. Mais quelle est leur fonction?Une éolienne est utilisée pour produire del'électricité. Ils sont fabriqués à partir denombreux matériaux: la tour, moteur,transformateur. La tour d'une éolienne est de 60 à100 mètres de haut. Voici comment une éolienne: Levent fait tourner le moteur plus un moulin àvent;-Le moteur tourne un générateur et produit del'électricité. L'électricité générée par le
49
générateur passe à travers les conduits dechauffage et à l'intérieur de la tour. Le systèmede commande est constitué par un ordinateur surlequel se produire si les fonctions de lame devent correctement.
50
La Pallavolo
La pallavolo venne inventata da un insegnante dieducazione fisica che aveva modificato un’attivitàludica praticata in Germania, che senza volerlodette vita al gioco più praticato a livelloscolastico. La pallavolo è un gioco sicuro poichémanca il contatto fisico e offre la possibilità diformare squadre miste, senza che la parte maschileabbia il sopravvento. È un gioco aggregante, incui la squadra partecipa coralmente ed ognicomponente ha le proprie responsabilità. È ungioco in cui la palla deve stare sempre in aria eogni volta che tocca terra si assegna un punto. Loscopo del gioco infatti è quello di fare piùpunti, facendo cadere la palla dentro ilrettangolo di gioco degli avversari e passandolaal di sopra della rete che divide il terreno digioco. La pallavolo è un gioco che si pratica inun terreno di m 18 x 9. Nelle palestre lasuperficie di gioco deve essere di colore chiaro ele linee di un colore diverso dal terreno di gioco
51
e larghe 5 cm. La rete è posta sopra la lineacentrale ad un’altezza di 2,43 m per gli uomini e2,24 m per le donne. La palla deve avere unacirconferenza di 66 e pesare 270 grammi circa. Lesquadre possono disporre di 12 giocatori ciascuna:6 in campo, 3 in attacco e 3 in difesa, e 6 inpanchina. Ogni giocatore non può fare più di untocco, la squadra intera non ne può fare più ditre. La partita inizia dopo che l’arbitro, duranteun sorteggio, decide chi incomincia a battere. Siperde il punto, durante la battuta quando ilpallone non va nel campo avversario. La squadrache conquista il punto ha diritto anche allabattuta successiva. Il set si vince a 25 punti.Ogni partita si divide in set che possono essere otre o cinque.
52