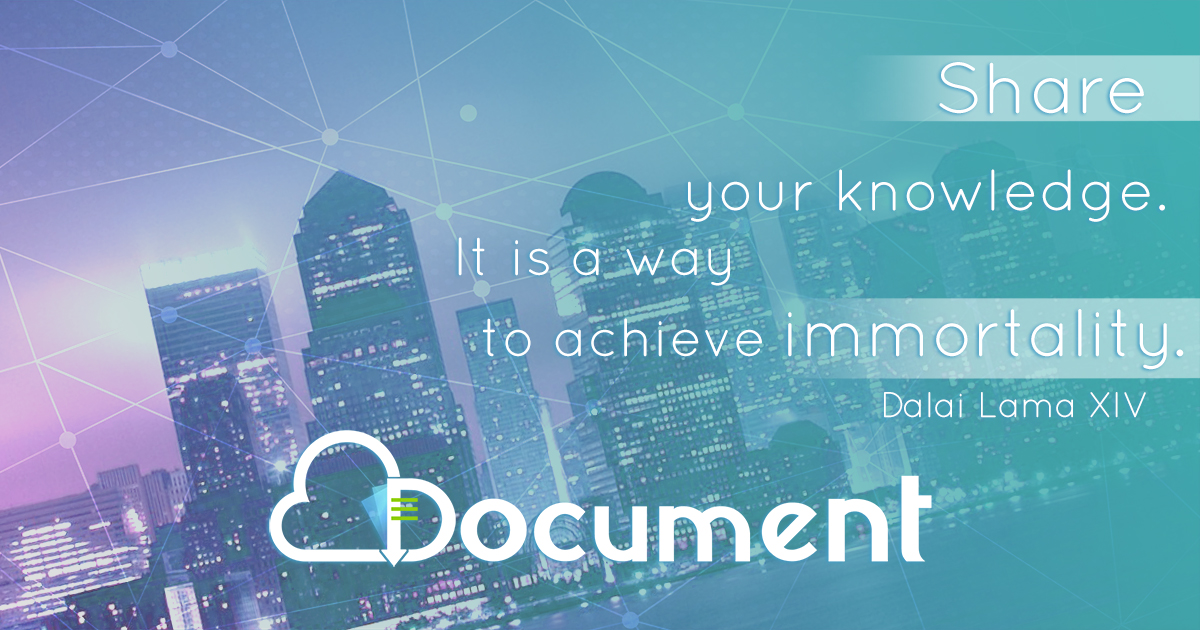Il bello dell'etica. Per una rilettura del rapporto tra essere e dover essere.
Transcript of Il bello dell'etica. Per una rilettura del rapporto tra essere e dover essere.
Questa ricerca e la sua pubblicazione sono state finanziate in parte dall'Univer-sità Cattolica nell'ambito dei suoi programmi di promozione e diffusione dellaricerca scientifica (esercizio 2005) e in parte dal Dipartimento di Filosofia dellamedesima Università
Copyright © 2005 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, ltaly
Ristampa Annoo I 2 3 456 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata a qualsiasi titolo, eccetto quella ad uso personale.Quest'ultima è consentita nel limite massimo del 15% delle pagine dell'opera, anche se effettuatain più volte, e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti dall'art. 2 della legge vigente.
Ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è illecita ed è severamente punita.Chiunque fotocopia un libro, cm mette a disposizione i mezzi per farlo, cm comunque favorisce
questa pratica commette un reato e opera ai danni della cultura.Stampa: Tipomonza, via Merano 18. Milano.
Indice
Ringraziamenti
Introduzionedi Michele Lenoci
Filosofia e razionalità: quale futuro?di John R. Searle
Fallibilità del fallibilismo?di Lorenzo Fossati
Due approcci al problema della razionalitàdi Stefano Gattei
È possibile una teoria della razionalità? Il contribu-to di Hilary Putnamdi Roberta Corvi
Il sorriso della ragione. La rivoluzione di A.R.Damasiodi Lucia Urbani Ulivi
Esiste una condizione necessaria per la razionalità?di Pieranna Garavaso
Il bello dell'etica. Per una rilettura del rapportotra essere e dover esseredi Adriano Pessina
5
Pago
»
»
»
»
»
»
»
9
17
41
60
78
107
127
144
Ragione e storiadi Massimo Marassi pago 158
«Esperienza estetica» e razionalitàdi Roberto Diodato » 191
Autori
6
_. --------------------------
Il bello dell 'eticaPer una rilettura del rapporto tra essere edover essere
di Adriano Pessina
1. La dinamica esistenziale
In un passo di Enten-Ellerl, Kierkegaard scrive: «Tu dici che la vita perde su-
bito la sua bellezza non appena l'etica si fa valere. "Invece della gioia dellaspensieratezza, della bellezza della vita considerata esteticamente, ci date ladoverosa attività, i lodevoli sforzi, l'infaticabile ed indefesso zelo,,»2. Questacontrapposizione tra etica ed estetica, tra la vita pesante, impegnata e, cometale, segnata dalla fatica dell'obbedienza al dovere, ai principi, alle regole, e lavita leggera, capace di librarsi nell'insieme delle possibilità e del godimento,sembra rappresentare bene un luogo comune presente anche nella cultura con-temporanea. L'attuale curvatura soggettivistica della moralità, di cui diremotra poco, sembra, infatti, essere una risposta pratica alla duplice esigenza dimantenere, nella vita, alcuni valori di riferimento (i propri valori che gli altrisarebbero chiamati a rispettare e a riconoscere anche laddove non siano con-
l Le riflessioni che qui proponiamo fanno riferimento ad alcune pagine di Kierkegaard, manon intendono proporsi come un'interpretazione o una presentazione del suo contributo in ordi-ne alle ternatiche etiche. Per questo motivo le citazioni di Enten-Elfer. Et Livs-Fragment, Rei-tzel, Kjobenhavn 1843, fanno riferimento all'edizione italiana curata da Remo Cantoni per i tipidella Mondadori (S. Kierkegaard, aut-aut, Mondadori, Milano 1975, la prima edizione è del1956). che risultano essere molto efficaci dal punto di vista letterario. Poiché, come è noto, nonsono mancate le. giustificate, critiche a quella edizione, oggi di fatto sostituita dall'edizioneitaliana curata da Alessandro Cortese, che ha ripresentato l'intero disegno di Enten-Eller, ab-biamo indicato tra parentesi le pagine corrispondenti, verificando che, almeno per quanto ri-guarda i passi citati, non esistessero reali differenze di significato. (S. Kierkegaard, Enten-Elfer,L'equilibrio tra l'estetico e / 'etico nelf 'elaborazione de//a personalità, Tomo Quinto. Adclphi,Milano 1999). In un caso abbiamo, peraltro, indicato la differente traduzione fatta nelle dueedizioni, senza poter dirimere la questione. Del resto, come abbiamo detto, non è nostra inten-zione analizzare il contributo di Kierkegaard (e non a caso sono state tralasciate molte e signifi-cative tesi del pcnsatore danese), ma tentare di svolgere autonome considerazioni in ordine alleproblematichc etiche.
2 S. Kierkcgaard. aut-aut, cit., p. 151, (Enten-r:l/er, cit., p, 169),
/44
divisi) e, nello stesso tempo, di superare il fardello di una eteronomia dellalegge che la cultura contemporanea collega all'immagine della cosiddetta og-gettività dell'etica cosiddetta tradizionale. Ovviamente il riferimento alla tra-dizione è spesso difficilmente decifrabile: alcuni vedono nella tradizione il re-taggio del pensiero classico e cristiano, altri la presenza dell'imperativo cate-gorico di origine kantiana, più o meno trasformato. Si tratta, insomma, di unasituazione analoga a quella descritta da Kierkegaard con queste parole:
In contrasto con una concezione di vita estetica che vuoi godere la vita, si sente spes-so parlare di un'altra concezione che pone il significato della vita nel vivere per sod-disfare al proprio dovere. Con questo si vuole indicare una concezione di vita etica.Pertanto l'espressione è assai imperfetta, e si potrebbe quasi credere che sia stata in-ventata per gettare del discredito sull'etica3
.
Non è difficile notare, infatti, come un'immagine dell'etica che vedel'uomo dipendere da principi e da norme e che indichi come scopo del viverela soddisfazione di un dover essere che è tanto più oggettivo quanto più è im-personale, possa indurre all'idea di un'eteronomia della volontà e della libertàumane. Ora, come è noto, e si tratta di un risultato storico sul quale il filosofoche osserva l'esperienza storica tanto quanto legge i libri di filosofia, deve ri-flettere, il pensiero moderno, specie con Kant, aveva proprio cercato di libera-re la morale da ogni eteronomia e di promuove quella morale autonoma, cosìcelebrata nel pensiero contemporaneo, proprio facendo riferimento a quel fat-to della ragione che è l'imperativo categorico. Ora, al di là della valutazioneteoretica della prospettiva kantiana e della sua attualizzazione, va detto che leragioni del cosiddetto soggettivismo etico (cioè di quella posizione pratico-teorica che fa dipendere il valore dall'atto della scelta stessa, che ne diventacondizione di possibilità, e non soltanto di attuazione), sorgono, in larga misu-ra, anche da quello che lo stesso Kierkegaard denuncia come errore, e cioè dalfatto che
l'individuo vien posto in un rapporto esteriore col dovere. L'etica viene determinatacome dovere, e il dovere come una somma di singoli postulati; individuo e doverestanno l'uno fuori dell'altro come degli estranei. Una vita per il dovere come questa èbrutta e assai noiosa, e se l'etica non avesse un rapporto molto più profondo colla per-sonalità, sarebbe sempre assai difficile sostenerla di fronte all'estetica. Non voglio
) {bidelli. p. 132, (p.145).
/45
negare che vi siano molte persone che non giungono oltre, ma non è colpa del dovere,è colpa loro4
La verità del soggettivismo, se così si può dire, sta nella rivendicazione diun nesso vitale tra essere e dover essere, tra scelta e valore, cioè risiede neltentativo, mal formulato, di operare una riconciliazione tra la concreta condi-zione dell 'uomo e il desiderio di autorealizzazione. Il primato della scelta, cheil soggettivista rivendica come segno della libertà e dell'autenticità, in fondonon è altro che il primato dell'etica, perché la vita etica è la vita nella quale sisceglie: ciò che resta aperta, come questione, nel soggettivismo, è, in fondo, ilriferimento al criterio in base al quale la scelta debba essere formulata.
Kierkegaard, che, come è noto, ci ha fornito delle riflessioni insuperabili aproposito del rapporto tra etica ed estetica, specialmente laddove esse si pon-gono come enten-eller, come aut-aut, ha posto in luce, però, anche ciò che quici preme evidenziare, e cioè ciò che costituisce il bello dell 'etica, quanto lariscatta da quell' immagine di vita brutta e noiosa di cui si diceva prima. Percomprendere in che cosa consista la bellezza dell'etica occorre però prima de-finire la bellezza. Scrive Kierkegaard:
Ma rimaniamo fermi alla categoria che l'esteta rivendica sempre per sé - alla bellez-za. Tu dici che la vita perde subito la sua bellezza non appena l'etica si fa valere. «In-vece della gioia, della felicità, della spensieratezza, della bellezza della vita considera-ta esteticamente, ci date la doverosa attività, i lodevoli sforzi, l'infaticabile ed indefes-so zelo». Se tu fossi qui presente ti pregherei di darmi una definizione della bellezza,per poter cominciare. Ma siccome non è possibile mi permetto di adoperare la defini-zione che sei solito dare: «Il bello è ciò che ha la sua teleologia in Sé»5.
Questa definizione della bellezza è particolarmente importante per la no-stra riflessione. Se è bello ciò che ha in sé la propria finalità", ciò che non habisogno di altro per manifestare la sua perfezione, allora possiamo compren-dere perché sia proprio la vita etica a possedere questo requisito di bellezza.La vita etica, infatti, trova in sé la propria determinazione e questo è possibileladdove si pensi all'uomo stesso, alla persona umana, come a una realtà che
4 lbidem, p. 133, (p. 146).5 Ibidem, p. 151 (p. 169).6 A nessuno sfugge il fatto che la definizione dell 'uomo come fine in sé sia la stessa, cele-
bre, definizione kantiana. Ma questa riconciliazione tra finalità, bellezza e veridicità della con-dizione umana, accennata nel testo kierkegaardiano assume una prospettiva nuova 0, almeno.pone a tema una prospettiva trascurata nell'ambito della riflessione filosofica modernasull 'esperienza morale.
/46
non solo è determinata in sé, è, ma è determinata alla maniera di dover essereciò che è. Questo rapporto tra essere e dover essere ha un nome specifico: per-sonalità morale. L'uomo concreto, nella sua determinazione, non può essereche quello che è, ma nel suo sviluppo e nella serietà del suo scegliere egli di-venta ciò che deve essere, cioè porta a compimento la bellezza della finalitàche gli appartiene. Il rapporto tra scelta e finalità manifesta come la dinamicaesistenziale dell'uomo rappresenti il luogo dove la relazione tra essere e doveressere fornisce un nuovo senso alla determinazione stessa.
L'essere concreto che diviene non può che essere un essere che in qualchemodo deve essere: l'essere dell'uomo che sceglie è l'essere il cui dover esseregli appartiene, sia nell'atto della scelta, sia nella finalità a cui deve rispondere.La personalità umana che ognuno di noi può e deve costruire nel suo agire è,in fondo, l'opera creativa che l'etica consegna al singolo. Ora, dicendo chel'etica consegna qualcosa al singolo, si intende dire - spezzando, per ora soloin modo assertorio, il circolo del soggettivismo - che la scelta del singolo sitrova a un duplice crocevia, per certi versi problematico, per altri meno: dauna parte, il riferimento al contesto nel quale egli si trova a vivere (l'ethos);dall'altra, l'io personale che si trova a dover scoprire. Ci sono passi, in Kier-kegaard, che sembrerebbero avallare la posizione soggettivistica, del valoredella scelta come tale, della sua pura autoreferenzialità, ma sono passi chevanno letti all'interno di un quadro più vasto. Così, da una parte, egli scrive:
Se mi vuoi comprendere bene, posso dire che nello scegliere non importa tanto loscegliere giusto, quanto l'energia, la serietà e il pathos con il quale si sceglie. Con ciòla personalità si manifesta nella sua infinità interiore e si consolida nuovamente.'.
Ma questa tesi, senza voler qui fornire un'esegesi del testo di Kierkegaard,che esula dal nostro intendimento, è subito corretta con questa affermazione:«proprio per questo, benché l'uomo possa scegliere il falso, ciononostante,proprio a causa dell'energia colla quale ha scelto, scoprirà d'aver scelto il fal-so» 8
.
Questo riferimento al falso e, quindi, al vero, pone di nuovo in luce altrielementi della questione etica: la bellezza della vita etica è corre lata alla suaverità. Del resto va anche detto che la possibilità di trovare la verità dellacondizione umana passa attraverso il confronto con l 'ethos a cui si appartiene.C'è un diventare se stessi che non è visto attraverso la negazione dei legami
7 lbidem, p. 43 (p. 32).8 lbidem (p. 33; Cortese traduce «aver scelto il torto»).
147
con gli altri, con il contesto nel quale si vive. Ma resta, certamente, decisiva,la scelta intesa come progressiva maturazione della propria identità:
Come un erede, anche se fosse erede di tutte le ricchezze di questo mondo, non lepossiede prima di diventare maggiorenne, così la più ricca personalità non è nullaprima di aver scelto se stessa. La grandezza, infatti, non consiste nell'essere questo oquello, ma nell'essere se stesso, e questo ciascuno lo può se lo vuole '.
Il riferimento all'etica come ambiente culturale, e alla personalità umanacome ambito della costruzione della moralità, aprono lo spazio proprio dellafilosofia morale, cioè di quell'esercizio critico della ragione che dovrebbepermettere la definizione dei criteri capaci di dirimere le forme della soggetti-vità dalle forme del soggettivismo, riportando il riferimento al tema della veri-tà nell'alveo che le è proprio, cioè nel contesto di una verità vissuta che deveanche diventare verità saputa e argomentata, a fronte di possibili sue negazio-ni. Con ciò intendiamo dire che il nesso essere e dover essere, che si mostragià nella dinamica ontologica dell'uomo e si complica per la mediazione dellalibertà, ha bisogno di ulteriori approfondimenti, non può assestarsi sul pianofenomeno logico.
Ma ciò che conta, per ora, è l'idea di un riscatto dell'etica rispettoall'estetica. Non si tratta, infatti, di procedere a una sorta di travestimento e-stetico dell'etica, quanto piuttosto di cogliere, nelle profondità personali dellaquestione etica, il fascino di una creatività che non è arbitraria e dissolutoria,come è, invece, la pura determinazione dell'estetica. La bellezza della vita eti-ca è strettamente connessa con un'altra idea, che la contemporaneità sembraaver stravolto, quella del godimento. Ma che cosa significa godere della vita eche cosa permette questo godimento? Non è difficile collegare la nozione delgodimento con la nozione del piacere, e ricordarne il carattere eminentementesoggettivo. Ma possiamo anche, ed è questa la linea che si dovrebbe percorre-re, pensare alla nozione di gaudio, cioè all'idea che l'etica è il luogo, l'ambitoculturale ed esistenziale nel quale si dovrebbe gioire del vivere. Ma che cosapuò assicurarci questa gioia della vita, qual è la sua condizione di possibilità oil suo fondamento? Ora, è sempre Kierkegaard a fornirei degli spunti che cipermettono di comprendere alcune forme della contemporaneità quando scri-ve:
La personalità immediatamente determinata non è spirituale, ma fisica. Qui abbiamouna concezione di vita che insegna che la salute è il bene più prezioso, quello intorno
9 lbidem, p. 53 (p. 45).
/48
al quale ruota tutto il resto. Questa concezione ha un'espressione più poetica se si di-ce: la bellezza è il valore più alto l0.
La salute e la bellezza: la vita fisica e la vita estetica. Queste due conce-zioni della vita sembrano, anche oggi, costituire la più potente sfida alla vitamorale, che non sembra in grado di rispondere a questo appello al «godimen-to» della vita. La questione ha una sua serietà e pone in gioco il problema del-la scelta: ma di che scelta si tratta? Occorre, per principio, rinunciare al godi-mento, magari sacrificare la vita estetica e la propria salute al fine di servire icomandamenti dell'etica? Non è escluso che possa accadere anche ciò, ma ciòche è fuorviante è l'idea che lo specifico della vita moralmente buona consistain questo sacrificio, quasi, appunto, che qui si giocasse l'idea dell'aul-aut. Lavita estetica e la vita fisica sono in larga parte determinati dalla figura del de-siderio (che oggi alcuni tendono a interpretare come desiderio infinito e persi-no come desiderio dell'Infinito), e il desiderio, per la sua stessa dinamica, èteleologico. Ma si tratta di una teleologia che pone fuori dalla persona stessala sua consistenza e propone una stabilità che è sempre decentrata. Ora, secontinuiamo a percorrere il testo di Kierkegaard, troviamo un riferimento checi permette di comprendere meglio qual è la reale alternativa tra vita estetica,vita morale e vita fisica. Ed è, ancora una volta, in una concezione dell'eticacome realizzazione della personalità umana, come teleologia non più decen-trata. Sarebbe facile obiettare che una simile impostazione finisce soltanto conl'avallare un'autoreferenzialità del soggetto che può essere facilmente indicatasia come soggettivismo, sia come egoismo. Ma questa tesi varrebbe soltanto auna condizione, e cioè che il senso (significato e direzione) di questa dinamicaantropologica fosse posto dalla stessa volontà umana e non, invece, ricono-sciuto dall'intelligenza e pensato come attuabile grazie alla volontà. Scrive,con grande efficacia, Kierkegaard: «incontriamo una concezione di vita che ciinsegna che dobbiamo godere la vita, ma la condizione di questo godimento latroviamo nell'individuo stesso, però in modo da non essere posta da lui»I'.
Non si tratta, a ben vedere, di una tesi nuova, benché espressa in modo fa-scinoso nel cuore stesso della modernità, perché la troviamo, con altre parole,in un classico pensatore del medioevo come Tommaso d'Aquino, quando e-sprime la sua teoria sulle inclinazioni naturali. Nel pensiero di Tommaso, in-fatti, le inclinazioni non esprimono un'eteronomia del soggetto, ma permetto-no di dare voce (cioè debbono diventare giudizio) alla sua dinamica ontologi-ca. Il bene morale, perciò, non appare come una qualità naturale, o come
IO lbidem, p. 57 (p. 50).Il lbidem, p. 59 (p. 52).
149
qualcosa che possa essere intuito, ma come ciò che, nell'atto del giudizio,viene riconosciuto in grado di garantire il gaudio della vita umana, cioèl'uomo vivente. Non possiamo qui svolgere compiutamente questa riflessione,che ci permetterebbe di ribadire un approccio non soggettivistico all'indivi-duazione dei beni morali, ma possiamo però segnalare una linea di approfon-dimento. I beni dell'uomo sono molteplici ed è un fatto che l'uomo, per co-struire la propria personalità umana, debba, scegliendo, rinunciare a qualcosa:ma la logica della rinuncia è sempre secondaria e non sorge con l'idea chequanto appartiene all'ordine dell'utile, del piacevole, del fisico, non apparten-ga all'ordine dei beni morali (cioè dei beni per l'uomo), bensì dentro il con-vincimento che la teleologia comporta sempre una subordinazione, una gerar-chia, una logica di mezzi e fini: insomma, la logica della vita morale si artico-la lungo un imperativo ipotetico che ha in sé, se volessimo esprimerei con unossimoro, soltanto un imperativo categorico, quello di realizzare compiuta-mente l'uomo. 11 bello dell'etica sta in questa teleologia. Sulla classicità diqueste tesi (cioè, a parere dello scrivente, sulla capacità di questi tesi di mo-strare ciò che permane nella condizione antropologica dell'uomo) ci riporta,per esempio, la riflessione di Hanna Arendt quando sceglie Aristotele per ri-dare voce al tema della bellezza della vita etica:
G li altri tre modi di vita [sciI. secondo Aristotele] avevano la caratteristica comune diconcernere il «bello», cioè le cose né necessarie, né meramente utili: la vita dei piace-ri corporei in cui il bello, come si offre, viene consumato; la vita dedicata alla polis, incui l'eccellere produce belle imprese; e la vita del filosofo dedita all'indagine e allacontemplazione delle cose eterne, la cui immortale bellezza non può essere prodottadall'intervento produttivo dell'uomo, né mutata dal fatto che egli le consumi 12
Ed è comunque interessante notare che in questa originaria struttura inten-zionale del volere, che spezza l'illusione dell'autoreferenzialità dell'uomo, sicolloca la stessa teleologia umana: non si diventa soggetti morali se non si co-glie il nesso che esiste tra il volere altro da sé e il volere se stesso: così come ilcorpo non si sviluppa senza nutrimento, la personalità morale non si sviluppasenza che l'uomo acquisisca quelle conoscenze che gli permettono di ordinareun'aspirazione alla perfezione che può restare, appunto disordinata, laddovenon sia guidata dalla ragione e dalle ragioni delle scelte. Non si tratta, pertan-to, per parafrasare per esempio Tommaso, di seguire soltanto le proprie dina-
12 H. Arendt, The Human Condition, University of Chicago Prcss, Chicago 1958; tr. it di S.Finzi, Vi/a activa, Bompiani, Milano, p. Il.
150
miche esistenziali, ma di valutarie al fine di determinarne la pertinenza nellacostruzione della propria esistenza, nella concreta esistenza storica.
In ogni caso, non si tratta di tornare ad Aristotele o a Tommaso, o di se-guire le suggestioni di Kierkegaard o della Arendt, quanto piuttosto di chie-dersi se la progressiva incapacità della filosofia morale contemporanea di ren-der ragione della specificità dell'esperienza morale (e di interloquire con leforme concrete della vita etica), non dipenda dalla progressiva eliminazione diuna serie di categorie, come quella del vero e del bello, dal proprio ambito. Ilbene morale può essere pensato fuori dal riferimento al vero e al bello? Forsel'avvento della nozione di valore ha impedito di cogliere la ricchezza dellastessa nozione di dovere morale, costretto, per così dire, tra i due estremi delformalismo impersonale di una legge morale in me e dell'utilitarismo indivi-duale di un appetibile cosa buona fuori di me. Questo giudizio può sembraresommario e, in un certo senso, non rende ragione della complessità della ri-flessione filosofica che si è articolata intorno all'etica, ma permette, per cosìdire, di comprendere l'orizzonte delle critiche espresse nel contesto della co-siddetta etica materiale dei valori e in quello della denuncia di Moore dellaricorrente fallacia naturalistica. Ma, una volta assunte queste critiche, resta in-soddisfacente ogni filosofia morale che pretenda di oltrepassare il livello ori-ginario e originante del giudizio morale ricorrendo alle forme dell'intuizione(intellettiva o emozionale) del valore. In realtà, ed è questa la linea che biso-gnerebbe percorrere, il bene morale sorge come consapevolezza che, di frontealle molteplicità delle cose che possono essere volute e conosciute, soltantoalcune sono veramente in grado di fornire bellezza ali 'esistenza, cioè di darleuna stabilità nella relazionalità.
I costumi buoni e belli di un popolo sono il luogo dove ognuno trova i vin-coli necessari per costruire la propria vita e goderne il senso. E tra questi vin-coli perché non citare quello dell'amicizia, dove si gode della gratuità dellebuone relazioni e si impara a conoscere anche noi stessi? Certo, sono affer-mazioni che vanno chiarite, pensate, giustificate e discusse: sono però le af-fermazioni dalle quali dovrebbe muovere una filosofia morale capace di unesercizio della razionalità che fa i conti con le dinamiche costitutivedell'esistenza umana. Infatti sarà compito della filosofia chiedersi se sono ve-ramente buoni e belli questi costumi e a questa domanda non potrà risponderese non ritornando a pensare l'identità umana. In questo modo l'alternativa po-sta da Kierkegaard tra la vita estetica e la bellezza della vita etica potrà trovareun criterio di demarcazione:
Da questo capisci cosa significa l'evoluzione estetica; essa assomiglia allo sviluppodelle piante, e benché l'individuo divenga, diviene solo quello che è spontaneamente.
151
Chi considera la personalità eticamente, pone subito una differenza assoluta, quellacioè tra bene e male; e se in sé trova più male che bene, ciò non significa che il male èquello che deve avere il sopravvento, ma significa che il male è quello che deve esse-re soffocato, e il bene deve avere il sopravvento 13.
Si tratta, in altri termini, di comprendere che seguire le inclinazioni o, co-me sarebbe meglio dire, le dinamiche ontologiche dell'uomo, non significapromuovere lo spontaneismo, ma giudicare per scegliere.
2. Nuove forme di esperienze: possibilità e compiti
La tecnologia trasforma radicalmente la nostra esperienza. La trasforma inmodo reale e la trasforma in modo simbolico. In modo reale, purché muta lerelazioni spazio-temporali con il nostro ambiente, con i nostri simili, conl'eredità delle nostre conoscenze (basti pensare alla cosiddetta rivoluzione in-formatica), con il nostro corpo (si pensi alla cosiddetta rivoluzione biotecno-logica, alla possibilità di suddividere le funzioni della generazione umana, direndere funzionali in noi organi altrui, di integrare l'artificiale con il biologi-co), con la natura che ci circonda (con la possibilità di modificare le strutturedei viventi e di permettere di programmare animali e vegetali come macchinebiologiche per produrre farmaci). I mutamenti sono fatti. E l'uso consueto deltermine rivoluzione per descriverli indica la percezione della loro portata inriferimento sia ali 'esperienza concreta, sia alle modalità con le quali tendiamoa comprenderli. Ciò che accompagna questi fatti è il simbolo della possibilità,che esalta la scelta, potenzia la libertà, accresce l'idea della potenza umana ela percezione che i limiti siano vincoli destinati a cadere.
La tecnologia, nel suo versante simbolico, rappresenta, per usare categoriekierkegaardiane, la dimensione estetica. È proprio dell'esteta, infatti, vederepossibilità laddove, invece, la personalità etica vede compiti. La vita estetica,in fondo, non è realmente bella proprio perché non ha una teleologia in sé, macontinuamente fuori di sé. E in questo senso occorre dire che la tecnologiacontribuisce a dissolvere l'ethos di un popolo non perché sia malvagia in sé,non perché non porti ottimi frutti per la qualità della vita delle persone, maperché sprigiona la potenza simbolica del possibile come negazione del valoredi ogni vincolo e di ogni limite. Il senso del limite, che è il senso dell'ordine edella stessa teleologia (se il fine non è anche un limite, un termine, non hasenso parlare di teleologia), non può avere ascolto nella logica del possibile.
13 S. Kierkegaard, aut-aut, cit., p. 103, iEnten-Eiler, cit., pp. 108-109).
/52
Ora, l'ethos contemporaneo si trova a dover fare i conti con la potenza reale esimbolica della tecnologia e, per questo motivo, esperimenta e rappresenta(nel senso del mostrare) le nuove insicurezze della vita. Un'insicurezza chesembra far propria la celebre espressione sartriana che vorrebbe l'uomo artefi-ce della sua stessa essenza, cioè della sua identità. Un 'identitàjìitura e con unfuturo che, non essendo frutto di un passato o di una storia, non può nemmenoessere certa di essere un' identità.
Un dover essere come pura possibilità (come esperimento antropologico) enon più un dover essere dell'essere che si radica nella consapevolezza di ciòche è proprio dell'essere dell'uomo". La risposta alla sfida estetica della tec-nologia non può essere data che dal bello dell'etica, cioè da quel suo connota-to teleologico che non respinge i possibili e non li demonizza, ma li pensa e livaluta nella serietà dello scegliere, che è determinato dall'idea che l'uomo ab-bia un compito da attuare e che questo compito è criterio di demarcazione cheripristina le categorie del bene e del male morale, cioè di ciò che è bene o noche l'uomo attui.
Il possibile e il fascino estetico della tecnologia sono all'origine diquell'insicurezza del vivere che trasforma i modi concreti del vivere e rendefragili e precari quei vincoli che, come prima dicevamo, sono il terreno con-creto da cui partire per cercare la verità della condizione umana. Un nuovoethos si affaccia, fatto di molte solitudini, spesso esaltate come possibilità.
In un saggio, datato, per certi versi, perché la prima edizione è del 1986,ma ancora pieno di valide suggestioni, il sociologo U. Beck scriveva:
Nelle idealizzazioni dell'amore moderno si riflette ancora una volta la traiettoria della
modernità. L'esaltazione è il contrappunto della perdita che la modernità si lascia die-tro. Niente Dio, niente preti, niente classi, niente vicini, ma almeno Tu - E la gran-dezza del Tu è proporzionale al vuoto che predomina in tutti gli altri ambiti. Questo
14 Mi permetto di rimandare a quanto scrivevo nell'introduzione del mio libro Bioetica.L'uomo sperimentale, Bruno Mondadori, Milano 1999: «Quanto al sottotitolo, L'uomo speri-mentale, esso intende riferirsi non soltanto all'uomo come soggetto ed oggetto della sperimen-razione. ma a quel modello antropologico che si profila all'interno di una cultura largamentedebitrice dell'interpretazione scientifica, fisiologica e biologica, dell'uomo: modello o immagi-ne che si proietta nella ridefinizione delle prassi riproduttive, che presiede al progetto mentale ereale della clonazione e della predeterminazione dei caratteri genetici, che condiziona le prassidi prolungamento o di interruzione dell'esistenza (dalla trapiantologia all'eutanasia). Modello,infine, che condiziona i rapporti sempre più articolati e sofisticati con l'ambiente vitale, con glianimali e i vegetali, per estendersi a quelle zone più o meno esplorate della materia non viven-te, ma che pure ci permette di esistere. Riflettere su questi modelli che condizionano la nostraesistenza e segnano la nostra condizione storica. valutandone le ragioni, è impresa umana nondelegabile a nessuno» (p. XVI).
/53
significa anche che a tenere assieme il matrimonio e la famiglia non sono tanto il lorofondamento materiale e l'amore, quanto la paura di rimanere soli. Ciò che minaccia oviene temuto, al di là del matrimonio e della famiglia, è forse il fondamento più stabi-le del matrimonio, a dispetto di tutte le crisi e di tutti i conflitti: la solitudinel5
.
Ci sarebbe da riflettere su questa diagnosi: Kierkegaard aveva pensato dirappresentare nella figura del matrimonio il luogo dell'etica, mentre, da ciòche scrive Beck, esso sembra essere, nelle società occidentali, il rifugio dallasolitudine dell'esteta che nelle sue indeterminate possibilità ha scopertol'insicurezza del vivere. Si può però osservare che una somma di solitudinispezza l'isolamento, non la solitudine stessa. La solitudine esistenziale, delresto, ha molti aspetti e molte cause: quella che sembra emergere dalle analisidi Beck rasenta la dimensione di ciò che Kierkegaard definirebbe disperazio-ne. Ma se i vincoli affettivi, sociali, parentali, sono soltanto una risposta alladimensione destabilizzante delle possibilità, allora essi cessano di diventareun compito e perciò un bene di cui godere: bisognerebbe riflettere sulle tra-sformazioni simboliche, e non soltanto fisiche, delle relazioni interpersonalimediate da quella che potremmo, sebbene impropriamente, definire la culturadella tecnologia.
Il compito di diventare se stessi resta, comunque, un compila anche perl'uomo che esperimenta le forme culturali della contemporaneità, nelle qualisembra confermarsi l'immagine di un'etica come forma censoria del fascinoliberatorio dell'estetica.
Resta, comunque, aperta la domanda che costituisce il filo conduttore diqueste pagine: chi deve essere l'uomo perché si realizzi il bello dell'etica?Perché sappia godere della sua vita? La risposta, ovviamente, richiederebbealtre riflessioni, però a nessuno sfugge che il nodo della questione è ora postosul chi è colui che deve essere. Come scrive la Arendt:
Il problema della natura umana (quaestio mihi factus sum [io stesso sono divenutodomanda], come dice Sant' Agostino) pare insolubile sia nel suo senso psicologico in-dividuale, sia nel suo senso filosofico generale. È molto improbabile che noi, che pos-siamo conoscere, determinare e definire l'essenza naturale di tutte le cose che ci cir-condano, di tutto ciò che siamo, possiamo mai essere in grado di fare lo stesso pernoi: sarebbe come scavalcare la nostra ombra. Per di più nulla ci autorizza a ritenereche l'uomo abbia una natura o un'essenza affini a quella delle altre cose. In altre paro-
15 U. Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurta.M. 1986: tr. il. di W. Privitera e C. Sandrelli. La società del rischio. l'erso una seconda mo-dernità. Carocci, Roma 2000, p. 169.
154
le, se abbiamo una natura o un'essenza, allora certamente soltanto un dio potrebbeconoscerla, e definirla e il primo requisito sarebbe che egli fosse in grado di parlare diun «chi» come se fosse un «che cosa». La difficoltà sta nel fatto che le modalità dellaconoscenza umana riferibili alle cose dotate di qualità «naturali», compresi noi stessinella misura limitata in cui rappresentiamo la specie più altamente sviluppata dellavita organica, si rivelano inadeguate quando ci chiediamo: «E chi siamo noi?», Questaè la ragione per cui tutti i tentativi di definire la natura umana quasi inevitabilmentefiniscono con l'introduzione di una divinità, cioè con il dio dei filosofi, che, da Plato-ne in poi, si rivela a un esame rigoroso come una specie di idea platonica dell'uomo.Naturalmente, smascherare tali concetti filosofici del divino come concettualizzazionidi potenzialità e qualità umane non costituisce una dimostrazione, e neppure un argo-mento, della non-esistenza di Dio; ma il fatto che i tentativi di definire la naturadell'uomo conducano così facilmente a un'idea che ci si impone direttamente come«super umana» e che viene perciò identificata con il divino, può destare dei dubbi sul-la possibilità di un adeguato concetto di «natura umanac '".
La Arendt fa bene a porre questi interrogativi, ma resta il fatto che a essipuò rispondere soltanto la filosofia e che le difficoltà che segnala non dipen-dono soltanto dall'argomento in sé, difficile, ma anche dall'atteggiamento del-la cultura contemporanea che sembra diffidare dall'idea che Dio sia una rispo-sta e non soltanto un problema per l'esistenza umana.
Di fronte alle possibilità che la tecnologia offre, e in particolare di frontealla rivoluzione biotecnologica che permette di modificare le strutture geneti-che dei viventi e, quindi, anche, di ipotizzare una nuova razza umana, il bari-centro del problema resta questo: esiste un senso, c'è un'intelligibilità del rea-le che può essere assunto come criterio per le attività trasformatrici dell'uomo,oppure l'unico criterio è la scelta, la volontà di scommettere che l'uomo è unessere più razionale di quella cieca natura, ora madre, ora matrigna, che gli hapermesso di vivere nei secoli su questa terra? E, inoltre, ciò che l'uomo trovadi fronte a sé, e in sé, è puramente natura? C'è una verità dell'essere delle co-se o la verità sta nella progettualità dell'uomo, e, quindi, sarà vero ciò chesarà realizzato? La filosofia, oggi, si trova sul crinale di due sollecitazioniche non le sono affatto estranee, perché usano categorie che le sono familiari,quella promossa da una cultura che cerca il proprio fondamento nel saperedelle tecnoscienze e quella che lo esprime a partire dalla fede biblica, dovel'uomo si pensa come creatura. Come scrive Guardini:
16 H. Arendt, Vita activa, cit. p. IO.
/55
Il credente deve compiere una fondamentale distinzione: il mondo non è «natura», macreazione; creazione nel senso puro, vale a dire: un 'opera chiamata ali 'essere permezzo d'una libera azione. Il mondo non è qualcosa di «naturale», d'intelligibile persé, di giustificabile da sé, ma ha invece bisogno d'essere fondato; ed è fondato daquella stessa istanza che I'ha prodotto nella sua essenza e nella sua realtà. Il suo esse-re-prodotto poi non si fonda sull'operare d'una causa costruita secondo lo schema del-la natura-energia, ma su un atto che ha - inteso il termine in un senso più ampio - ilcarattere della «grazia». [ ... ] È stato detto che al fondo di questa raffigurazione di uncreatore personale sta la mentalità semitica, per la quale Dio non avrebbe col mondoun rapporto vitale, ma Egli sarebbe come l'architetto o il dominatore che gli si accostadal di fuori. Lasciamo in sospeso la questione fino a che punto sia pensabile un esseredivino collocato di fronte al mondo, costruttore e dominatore non partecipe. È un'ideacomunque che non ha nulla in comune con la Genesi. Una divinità puramente tra-scendente non sarebbe che la controparte di un 'altra puramente immanente, la qualenon andasse oltre il mondo, ma ne rappresentasse soltanto l'aspetto interiore. Le dueconcezioni si condizionerebbero a vicenda, ma sarebbero ugualmente estranee a quel-la della Rivelazione. Il concetto dell'autentico Creatore è diametralmente opposto atutti quelli delle varie religioni naturali. La creazione non è «trascendente», né «irn-rnanente». Non si può afferrare per mezzo di simili concetti, ma è semplicemente laforma dell 'attività a Dio solo riservata: a quel Dio che è davvero Dio e non soltantouna divinità17
.
Che cosa ha da dire oggi la filosofia su questa alternativa tra creatura e na-tura? La domanda ha una duplice attualità: da una parte riguarda, per così di-re, il presente di ogni uomo impegnato a costruire la propria personalità, per-ché non è indifferente sapersi opera della natura o opera di Dio; dall'altraperché l'orizzonte delle possibilità offerte all'opera dell'uomo grazie alle tec-noscienze (cioè, grazie alle sue doti dispiegate e potenziate tramite il sapere ela meccanica) riporta nella scelta umana il fondamento del limite (non certodell' esito, che resta sempre aperto a successo o fallimento), e quindi interpellail compito dell'uomo al di là delle sue mere possibilità, cioè lo riconduce allasua responsabilità. Le tecnoscienza, nel suo versante simbolico, rappresentabene le esigenze della vita estetica di cui parla Kierkegaard, perché l'esteta èchi cerca nel futuro e nelle esplorazioni dei possibili quella stabilità che nonpuò (o non vuole) riconoscere in sé. C'è, in effetti, un fascino del possibileche è la sfida più sottile alla bellezza della personalità morale.
17 R. Guardini, Welt und Person. Versuche zur christlichen l.ehre vom Menschen, Wcrk-bund, Wurzburg 1939; tr. it. di G. Colombi, Mondo e persona. Saggio di antropologia cristia-na. a cura di S. Zucal. Morcelliana, Brescia 2000. pp. 40-41.
156
L'aut-aut non può essere posto tra la tecnoscienza e la sua negazione, matra i criteri estetici e i criteri etici dello sviluppo della tecnoscienza, tra chi ve-de possibili e chi vede compiti. Tra una bellezza che esprime la teleologiapropria dell'uomo e una bellezza che esprime il possibile. Che cosa differen-zia l'una dall'altra, visto che entrambe le prospettive fanno riferimento allecategorie delfuturo, la prima nel dover essere, la seconda nel possibile? Nellascommessa sul futuro l' aut-aut è tra chi ritiene che l'identità dell' uomo stiasoltanto nel suofuturo e chi la pone nel suo essere. Ma per sapere chi ha tortoo ragione non possiamo aspettare l'esito di questa sorta di scommessa pasca-liana: anzi, non dobbiamo scommettere finché manteniamo desta la speranzache la ragione filosofica sappia dirimere il vero dal falso, il giustodall'ingiusto, il buono dal cattivo. La personalità etica, in fondo, ha la pretesa,che andrà svolta fino in fondo sul piano giustificativo, di poter motivare intermini di veridicità le proprie scelte riconoscendo l'essere dell'uomo comeun bene che deve essere e che, quindi, trova nella sua identità la direzione del-la sua storicità. I possibili, perciò, non sono affatto indeterminati, perché esi-stono possibilità che non vanno esplorate perché dissolvono la teleonomicitàdell' esistenza umana. Sebbene non sia sufficiente fare questa affermazioneper stabilire nel concreto quali vie l'uomo dovrà esplorare nella sua concretaattività, resta però importante chiarire quale sia il senso dell'alternativa che sipone, anche oggi, all'uomo. Le strutture permanenti dell'uomo, infatti, si ma-nifestano nelle diverse condizioni storiche e ciò che, nelle trasformazionidell'esperienza, richiede un nuovo sforzo di riflessione non riguarda soltantoil dispiegarsi della potenza e del dominio sulla vita, ma il senso che ha e deveavere per la comprensione della finalità umana.
Queste annotazioni, per quanto frammentarie, rispondono a un 'esigenza difondo: rinnovare la riflessione filosofica sulla vita morale senza rinunciare adalcun aspetto implicato dal dover essere dell'uomo. Una filosofia morale cheemargina il riferimento alle categorie del vero e del bello, e spezza il nesso traetica e teologia razionale, potrà forse servire a costruire un insieme di principie precetti che magari sono in grado di favore un controllo sociale e culturale,ma difficilmente saprà affrontare le cosiddette sfide della tecnologia e trovaredi nuovo le vie per indicare in che modo si possa avere quel gaudio esistenzia-le che è, in fondo, lo scopo e il bello dell'etica.
157