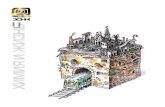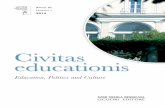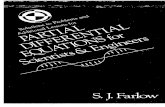Quando è la storia a dover Resistere.
Transcript of Quando è la storia a dover Resistere.
Quando è la Storia a dover
Resistere
Università degli Studi di Torino
Corso di insegnamento: Storia Contemporanea H Docenti: Daniela Adorni e Davide Tabor
Relazione di:
Virginia Giustetto (matr. 773346) Corso di Laurea in: Letteratura,
Filologia e Linguistica Italiana
“Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico,
conferisce a ogni storia il carattere di “storia contemporanea”, perché,
per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano,
essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente,
nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni”
Benedetto Croce, La storia come pensiero e come azione
Introduzione
Conseguito il diploma liceale a Torino, a seguito di un percorso scolastico che più
volte aveva toccato il tema della Resistenza italiana, mi ritrovai a studiare in una
piazza italiana del nord Italia ricca di studenti fuori sede, qual è oggi Bologna, e a
conversare con coetanei che avevano maturato un’idea molto diversa dalla mia
riguardo agli sviluppi della guerra partigiana e al biennio 1943-1945. All’inizio ne fui
sorpresa, per certi versi annichilita, pur trovandomi, per così dire, di fronte alla prova
dell’assunto fondamentale secondo cui, fatto salvo il dovere di ogni storico di
rispettare i fatti, “la storia è, essenzialmente, interpretazione”1 filtrata con gli occhi di
del presente. Di seguito ho provato a spiegarmi questa mancata “memoria condivisa”
domandandomi che cosa, del nostro modo di guardare – e di chi l’ha fatto negli anni
’50, negli anni ’60, negli anni ’70 e così via – abbia influito sulla conoscenza che oggi
abbiamo della Resistenza.
Nel mentre sono trascorsi ormai quasi tre anni e sono tornata a studiare a Torino.
Non avendo trovato una risposta allora, ho provato a rinnovare la ricerca, e così è
nato il seguente lavoro. Seppur in forma breve (uno studio del genere, ne sono
consapevole, richiede più materiale e maggior dedizione), ho provato a scoprire in
che modo la storia della Resistenza sia stata raccontata a ragazzi di Torino di età
compresa tra i 14 e i 19 anni; cosa abbia resistito al tempo e cosa, invece, sia scivolato
via, seguendo meccanismi talvolta più evidenti e talvolta meno, spesso indotti da
cause esterne, di cui non sempre siamo consapevoli.
1 Edward H. Carr, Sei lezioni sulla storia (1961), Einaudi, Torino 2000, p. 29.
Metodologia
I dati e le analisi avanzate di seguito nascono a partire da un questionario sottoposto
a 117 studenti (51 ragazze e 66 ragazzi), iscritti nell’anno in corso al Liceo Scientifico
Piero Gobetti di Torino. Ho scelto di non limitare la ricerca ai ragazzi del quinto
anno che avessero già affrontato il tema della Resistenza a lezione, nel corso del
semestre accademico, bensì di estendere lo studio anche ai ragazzi delle classi
inferiori, interessata a valutare le conoscenze generali riguardo al tema. Pertanto, il
questionario è stato rivolto a:
29 studenti della classe prima, di cui 15 femmine e 14 maschi;
19 studenti della classe seconda, di cui 11 femmine e 8 maschi;
17 studenti della classe terza, di cui 8 femmine e 9 maschi;
23 studenti della classe quarta, di cui 9 femmine e 14 maschi;
29 studenti della classe quinta, di cui 8 femmine e 21 maschi.
All’interno del questionario sono state inserite 4 domande chiuse e 7 domande
aperte. L’alternanza mi ha consentito in un secondo momento un duplice lavoro: da
un lato, avendo a che fare con numeri, ho ricavato dati statistici e percentuali (seppur
parziali, trattandosi pur sempre di un campione limitato); dall’altro, raccogliendo e
elaborando le risposte aperte, ho approfondito aspetti più specifici e ho strutturato il
discorso per temi.
Scopo del lavoro, come riportato sopra, è il tentativo di muoversi lungo l’asse
diacronico della storia, al fine di valutare in che modo il racconto della Resistenza si
sia tramandato fino a oggi, analizzando gli aspetti e i fatti tuttora conosciuti e quelli
che, al contrario, sono stati dimenticati, e provando, in tal caso, a coglierne le ragioni.
La ricerca è stata suddivisa in cinque capitoli, così intitolati:
1. Regioni di provenienza ed esperienze dirette della Resistenza;
2. Educazione scolastica alla Resistenza;
3. Il 25 aprile settanta anni dopo;
4. Il ruolo delle donne;
5. Perché parlare di Resistenza oggi?
1. Regioni di provenienza ed esperienze dirette della Resistenza
Al fine di verificare il modo in cui la Resistenza è sentita e riconosciuta nei diversi
territori italiani, è stato domandato ai ragazzi di indicare la regione di provenienza dei
loro nonni. Questo ha consentito, in un secondo momento, di suddividere i risultati
su un’ipotetica griglia ripartita in sei sezioni, stabilendo, convenzionalmente, che i
territori da Roma in giù fossero considerati appartenenti al Sud Italia e i territori da
Roma in su al Nord Italia2. Al termine del conteggio, ho avuto modo di constatare
che:
42 studenti hanno il 100% dei nonni provenienti dal Nord Italia;
26 studenti hanno almeno il 75 % dei nonni provenienti dal Nord Italia;
17 studenti hanno il 50% dei nonni provenienti dal Nord Italia e il restante 50% dal
Sud Italia;
15 studenti hanno almeno il 75% dei nonni provenienti dal Sud Italia;
11 studenti hanno il 100% dei nonni provenienti dal Sud Italia
6 studenti hanno il 100% dei nonni provenienti dall’estero.
La ripartizione, ben distribuita – seppur con una maggioranza di studenti originari del
Nord Italia – si spiega con i flussi migratori che a partire dai primi anni Cinquanta
portarono a Torino centinaia di migliaia di persone provenienti dal sud della penisola,
trasformando il capoluogo piemontese nella “città più meridionale d’Italia” e dando
vita a un insieme di storie e di ‘passati’ molto diversi tra loro.
Nel questionario, successivamente, si domanda se in famiglia siano mai stati
raccontati episodi riguardanti la Resistenza e se vi siano stati parenti che ne abbiano
avuto un’esperienza diretta. Poco più della metà risponde che talvolta, in famiglia, è
stato toccato l’argomento, mentre il 41% (48 ragazzi) dichiara di avere avuto parenti
con esperienze dirette, indicando, in alcuni casi, la presenza di uomini che
2 Nel fare ciò, mi sono parzialmente rifatta alla linea Gustav disposta da Hitler a partire dal 4 ottobre 1943, pur ritenendo la città di Roma territorio meridionale, mentre la linea passava da Cassino, paese a 130 km a sud dalla capitale.
Aree 100% Nord 75% Nord 50% Nord 50% Sud
75% Sud 100% Sud 100% estero
n° studenti 42 26 17 15 11 6
combatterono tra le file dei partigiani e, in molti altri, episodi in cui piccoli gruppi di
partigiani furono accolti e nascosti in casa, soprattutto da donne. Di questo 41% ho
calcolato che il 73 % (cioè 35 studenti su 48) sono ragazzi che hanno almeno 3/4 dei
nonni settentrionali.
48 ragazzi hanno parenti che ne hanno avuto esperienza diretta, di cui:
Inoltre, rispetto ai 48 ragazzi totali, 27 dichiarano che le esperienze vissute dai nonni
siano state compiute in Piemonte.
I due grafici sono indicativi poiché si inizia a
evidenziare la differente coscienza storica –
quanto meno a livello di racconti famigliari
– che si ha sella Resistenza, a seconda del
proprie origini territoriali. Nell’ottica di
creazione di una storia nazionale, non si può
prescindere dal fatto che soltanto per alcuni
ragazzi la storia della Resistenza sia stata la storia della propria famiglia.
Tuttavia, a sopperire a tale ‘squilibrio’, se così lo si può chiamare, entra in gioco – o
quanto meno dovrebbe entrare in gioco – la scuola di secondo grado, e in tale senso i
dati rilevati ne offrono una conferma. Infatti, nonostante il 41% dei ragazzi abbia
avuto famigliari coinvolti direttamente nella Resistenza, soltanto il 15% del campione
totale dichiara che la famiglia sia il luogo in cui il tema della Resistenza è stato
35
7
6
Fig.1 > 75% nonniprovenienti dal NordItalia
50% dei nonniprovenienti dal Nord e50% dei nonniprovenienti da Sud > 75% dei nonniprovenienti dal SudItalia
56%44%
Fig. 2 EsperienzeinPiemonte
Esperienzefuori dalPiemonte
maggiormente approfondito, mentre la maggioranza assegna tale primato proprio alla
scuola.
Si consideri che, dei 18
ragazzi3 che individuano
nella famiglia il luogo di
maggior approfondimento,
14 hanno almeno 3/4 dei
nonni originari del Nord
Italia e 9, cioè il 50%, sono
al 100% piemontesi. Il
dato, ancora una volta,
sottolinea come il riverbero
della storia passata nel
presente – e in particolar modo nell’ambiente famigliare – sia direttamente
proporzionale al fatto di aver vissuto sulla propria pelle l’esperienza della Resistenza.
2. Educazione scolastica alla Resistenza
A partire dalle analisi precedenti risulta evidente l’importanza che la scuola assume
nell’educazione dei ragazzi alla storia del biennio 1943-1945. In tale senso, come
mostrato nel grafico in fig. 3, il 79,2% dei ragazzi ritiene di aver appreso a scuola la
maggioranza delle conoscenze attorno al tema. Tuttavia, alcuni quesiti posti
successivamente mettono in luce diverse lacune in termini di conoscenze generali.
Viene richiesto ai ragazzi cosa rievochi in loro una serie di date e luoghi storici. In
particolare:
- la data 8 settembre 1943;
- la data 25 aprile 1945;
- il luogo Marzabotto;
- il luogo Piazzale Loreto.
3 Sommando i dati del grafico a torta risulta che le risposte siano 120, tre in più rispetto al numero totale dei ragazzi. Questo si spiega col fatto che tre di loro abbiano contemporaneamente selezionato, come risposta, sia la scuola sia la famiglia.
18
95
5 2
In quale di questi luoghi hai maggiormente approfondito il tema della Resistenza? (Fig.3)
Famiglia
Scuola
Altro
Astensioni
Riporto di seguito i risultati:
Eccezione fatta per la seconda domanda, si denota un sostanziale astensionismo per
tutte le altre risposte, fatto che mette in luce una diffusa ignoranza circa eventi di
portata storica significativa. Nel primo caso, inoltre, è interessante sottolineare come
il dato delle astensioni salga al 75% se si escludono le risposte dei ragazzi di quinta, i
quali, ‘freschi di studi’, abbassano la percentuale.4
Nel secondo caso i dati rilevati risultano differenti. Il 68% dei candidati
risponde correttamente, pur mantenendosi alto il divario tra le riposte fornite dai
ragazzi di quinta e quelle dei ragazzi iscritti a classi inferiori. Ad esempio, dei 29
ragazzi di prima superiore, 17 rispondono correttamente, contro i 27 (sempre su un
totale di 29) rilevati all’ultimo anno – ovvero il 93% dei candidati. Segnalo inoltre che
sono state date per valide risposte non del tutto esatte come “fine della guerra in
Italia”, o “liberazione” e che soltanto una percentuale molto bassa di ragazzi ha
legato la data alla presa di potere del CLNAI o al proclama diffuso via radio che
favorì, in pochi giorni, la resa di tutti i presidi tedeschi e fascisti ancora attivi sul
territorio.
4 Nello specifico, le risposte dei ragazzi di quinta sono così ripartite: su 29 studenti totali, 17 rispondono correttamente (59%), 7 in maniera errata (24%) e 5 non si espongono (17%).
68%
19%
13%
25 aprile 1945
Rispostecorrette
Risposteerrate
Astensioni
13%
8%
79%
Piazzale Loreto
Rispostecorrette
Risposteerrate
Astensioni
22%
17%61%
8 settembre 1943
Rispostecorrette
Risposteerrate
Astensioni
19%5%
76%
Marzabotto
Rispostecorrette
Risposteerrate
Astensioni
Nel terzo e nel quarto caso si presenta una situazione ancora singolare. Per
quanto riguarda la strage di Marzabotto, il dato di astensioni raggiunge il 76% e
quello delle risposte corrette appena il 19% – tra le risposte corrette sono per altro
state accettate indicazioni generiche come “strage”, che non certifica l’effettiva
conoscenza attorno all’evento. In questo caso, inoltre, scompare il divario di
‘conoscenza’ tra gli studenti di quinta e tutti gli altri: ad esempio, su 29 studenti totali,
in prima si rilevano 22 astensioni, in quinta 21 – pressoché il medesimo numero. Se si
considera che in Europa, durante la Seconda guerra mondiale, l’eccidio di Monte Sole
fu uno dei più gravi crimini di guerra perpetuato contro civili, la quasi totale
ignoranza attorno al fatto assume contorni quantomeno scoraggianti, per quanto sia
doveroso ricordare che l’entità del massacro ha cominciato a delinearsi ben dopo la
Liberazione e, soprattutto, che il processo contro 17 ufficiali e sottoufficiali tedeschi
coinvolti nella strage ha avuto inizio soltanto nel 2006, poiché “l’armadio della
vergogna”5 è stato aperto nel 1994, a distanza di cinquanta anni esatti dall’accaduto.
Nel quarto caso, il dato delle astensioni cresce ulteriormente. Il 79% dei ragazzi
non ha idea del significato storico di Piazzale Loreto durante il biennio 1943-1945 e
tra le 15 risposte corrette (su un totale di 117 ) non si conta neanche una risposta che
metta in collegamento la strage dei 15 partigiani avvenuta il 10 agosto 1944 con la
scelta di appendere nel medesimo luogo i corpi del duce, di Claretta Petacci e dei 18
gerarchi della Repubblica di Salò. Anche in quinta liceo la maggioranza degli studenti
ignora il significato storico del luogo.
In definitiva, i dati rilevati mettono in evidenza un fatto: dopo settant’anni, non
si conosce il significato di alcuni dei principali avvenimenti che hanno favorito la
nascita della nostra Repubblica. Non credo che tali ‘lacune culturali’ siano da
imputare ai ragazzi: esse rispecchiano meglio di qualsiasi analisi storiografica il modo
in cui, nei decenni successivi al conflitto, si è scelto di raccontare la nostra storia. In
molti casi, si è identificato nell’oblio o nell’amnistia la matrice da cui far scaturire la
cosiddetta pace sociale e questo approccio ha mostrato inevitabilmente i suoi frutti:
per un ragazzo di oggi la data chiave dell’8 settembre 1943 ha perduto gran parte del
5 L’espressione sta a indicare l’armadio ritrovato in un locale di palazzo Cesi-Gaddi a Roma – sede di diversi organi giudiziari militari – nel 1994. All’interno furono rinvenuti 695 fascicoli d’inchiesta e un registro generale che riportava 2274 notizie di reato, relative a crimini di guerra compiuti in Italia durante gli anni dell’occupazione nazi-fascista. Si tratta a tutti gli effetti di un caso di occultamento volontario di documenti storici.
suo significato e impiccagioni ed eccidi sono sfumati in lontananza, addossati gli uni
agli altri, avvolti tutti dalla medesima, pericolosa, confusione.
3. Il 25 aprile settanta anni dopo
Dedico un paragrafo al tema che ho ribattezzato “questione 25 aprile”, data storica in
cui, via radio, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò
l’insurrezione in tutti i territori controllati ancora dai nazifascisti per imporre loro la
resa, e che sancisce, convenzionalmente, la fine del conflitto e la vittoria delle forze
partigiane. Nel paragrafo secondo è stata mostrata, a livello di numeri, la percentuale
di studenti che ne riconoscono tuttora il significato storico e politico, ma risulta a
mio avviso interessante elaborare anche un altro tipo di dati, per certi versi più
significativo. Al’interno del questionario si domanda ai ragazzi se ritengano giusto
che il 25 aprile sia stato decretato giorno festivo istituzionale. Il 94% di loro
risponde affermativamente, il 2,6% negativamente e il restante 3,4% si astiene
(curioso che gli studenti stranieri coinvolti abbiano risposto tutti affermativamente).
Questo primo risultato sembra dare risalto al valore che ancora oggi attribuiamo
all’evento, anche considerando che le risposte sono perlopiù univoche, in quanto non
si rilevano differenze a seconda della classe di appartenenza degli studenti e dunque
del loro ‘livello di competenza’.
Al quesito successivo, tuttavia, le percentuali cambiano notevolmente. Si
chiede al candidato se si opporrebbe alla scelta di rendere il 25 aprile una ricorrenza
commemorativa (alla pari, ad esempio, della Giornata della Memoria delle vittime
dell’Olocausto, fissata il 27 gennaio), senza che ciò presupponga un’ufficiale festività.
Una sorta di giornata del ricordo – in occasione della quale poter organizzare lezioni
di approfondimento, per dire – senza tuttavia che tutto si fermi come in un qualsiasi
altro giorno festivo. Il 62% degli studenti risponde che non si opporrebbe a una
scelta del genere, contrastato da un solo 30% (il restante 8% non si espone a
riguardo). È significativo soprattutto un aspetto: è vero che, considerando soltanto i
dati della quinta la percentuale di risposte affermativa scenderebbe notevolmente –
mentre in quarta, ad esempio, la percentuale di favorevoli supera addirittura il 73% –
ma comunque, anche dopo aver affrontato a lezione determinati argomenti, più della
metà dei ragazzi di quinta (il 52%) non avrebbe problemi a ‘riscrivere’ (e per molti
versi condannare all’oblio) la storia italiana. Ancora una volta, dunque, l’esito della
ricerca sembra condurre alla medesima conclusione.
4. Il ruolo delle donne
Due delle domande presenti nel questionario hanno come tema le donne. Nel primo
quesito, si domanda ai ragazzi se, a loro avviso, le donne abbiano preso parte alla
Resistenza. L’88% risponde affermativamente, contro un 8% di risposte negative e
un 4% di astensioni. Nello specificare che ruolo abbiano assunto, la maggioranza dei
ragazzi identifica nella donna colei che, durante la guerra partigiana, nascondeva i
combattenti o si preoccupava di offrire loro cibo e cure mediche, anche nelle vesti di
staffetta. Venti studenti, cioè il 19% di coloro che hanno risposto in modo
affermativo, riconosce nelle donne anche delle combattenti, alla pari degli uomini,
sottolineando come, talvolta, esse si occupassero anche delle pianificazioni
organizzative e logistiche delle azioni di guerra. Per lo più, tuttavia, si rimarca la
differenza tra il ruolo maschile e quello femminile: agli uomini spettano le armi,
scrivono in molti, alle donne il compito di prendersi cura della famiglia o di offrire
rifugio e ristoro agli uomini.
Si domanda poi agli studenti di indicare il ruolo assunto dalle staffette durante la
Resistenza. Il 38% dei ragazzi risponde correttamente; il restante 62% afferma di non
conoscere la risposta (e di questo 62% poco meno di un terzo sono ragazzi di
quinta). Il dato è rilevante, soprattutto se messo in rapporto con gli esiti
88%
8%4%
Pensi che le donne abbiano preso parte alla Resistenza? (Fig.4)
Sì
No
Non so
38%
62%
Sai indicare che ruolo assunto dalle staffette? (Fig.5)
Sì
No
precedentemente esposti (fig. 4). Sembrerebbe che la conoscenza del tema – le donne
nella Resistenza – sia perlopiù superficiale, e che laddove si richieda una competenza
più specifica vengano alla luce diverse lacune.
D’altronde, allontanandosi da questo ambito e domandando ai ragazzi di indicare
alcuni degli orientamenti politici presenti all’interno del fronte resistenziale, i risultati
sono, se possibile, ancora più netti. Il 55% si astiene dal rispondere – percentuale che
corrisponde a 65 studenti su 117. Tra le risposte rinvenute – molte delle quali
scorrette – diverse risentono del filtro del presente, o quantomeno dell’idea che è
andata diffondendosi negli ultimi decenni a proposito della Resistenza: saltano le
sfumature e ci si affida a macrocategorie in molti casi imprecise. In tale ottica il
fronte resistenziale assume le vesti di un unico gruppo compatto, riconoscibile sotto
l’etichetta di “comunisti” – e viene difficile non pensare ai reiterati slogan del
ventennio berlusconiano durante la Seconda Repubblica…
5. Perché parlare di Resistenza oggi?
In ultima istanza, si domanda ai ragazzi a cosa sia servita la Resistenza, e che senso
abbia parlarne ancora oggi. Soltanto 5 di loro, ovvero sia il 4% del campione totale,
dichiara che sia di scarso interesse trattare a distanza di 70 anni un argomento del
genere. Prevale, su tutte, con il 65% delle preferenze, l’idea che sia invece necessario
parlarne, onde evitare che vadano perduti i valori etici e sociali acquisiti in quegli
anni.
4%
65%
24%
7%
Ritieni che oggi:
Sia di scarso interesse parlareancora di Resistenza
Sia necessario continuare aparlarne, per non dimenticarei valori etici e sociali acquisiti
Non ho un'idea a riguardo
Astensioni
Circa un quarto dei ragazzi, infine, ammette di non avere un’idea a tal riguardo, forse
poiché poco informato sui fatti. È curioso, a tal proposito, che di questo quarto quasi
il 40% siano studenti di quinta liceo, ovvero sia coloro da cui, a rigor di logica, ci si
aspetterebbe più che dagli altri una presa di posizione.
Alla domanda “In definitiva, a cosa credi sia servita la Resistenza?” ancora una
volta si rilevano diverse risposte fortemente filtrate dal tempo presente. Alcune, quali
“La Resistenza è servita a far capire che l’Italia è un Paese forte anche senza aiuti
esterni”, o “Ha dimostrato che sappiamo cavarcela da soli”, sembrano, a mio modo
di vedere, subire l’influenza dei dibattiti contemporanei circa il ruolo dell’Unione
Europea e la presunta sottomissione dell’Italia a paesi come la Germania. E ancora,
la riposta “Ha evidenziato la cesura tra chi sta al potere e chi dev’essere
rappresentato” fa facilmente pensare alla distanza odierna tra cittadini e istituzioni.
La maggioranza dei ragazzi parla tuttavia di “acquisizione di diritti e di libertà”, per
mezzo della “cacciata di Mussolini e del fascismo”. Tre studenti evocano la
promulgazione della Costituzione e una ragazza mette in luce l’acquisizione di diritti
da parte delle donne. Per molti, la Resistenza ha consentito di “riappropriarsi di
valori perduti durante il Ventennio”. Ventiquattro studenti (il 21%) sceglie infine di
non rispondere.
Conclusioni
L’obiettivo principale di questa ricerca era cogliere il “senso comune” sulla
Resistenza tra ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Al termine del lavoro mi
sembra di poter dire che, a un primo livello di analisi, l’argomento sia ancora vivo e
genericamente conosciuto. Scendendo più nello specifico, però, mi pare di rilevare
una certa inerzia, quasi che quegli anni appaiano ormai lontani, accostabili a qualcosa
di definitivamente “passato”, che poco riverbera, oggi, sul nostro presente. A chi o a
cosa attribuire tale distanza? Non si può, a mio avviso, non ricondurla almeno in
parte al modo in cui, a partire dai primissimi anni della neonata repubblica, si scelse la
via della “rimozione”, dando vita, da un lato, a uno Stato che manteneva al suo
interno il germe fascista – pensiamo alla sua burocrazia e a molti apparati sociali – e,
dall’altro, promuovendo un’idea di Resistenza che presentava molte contraddizioni.
Inoltre, essa si configurò meramente come lotta armata, escludendo del tutto la
cosiddetta “resistenza civile” – l’insieme, cioè, di quelle pratiche di lotta contro il
dominio e lo sfruttamento nazista in cui fu il coraggio morale a scombinare le carte e
che soltanto a partire dal 1989 riacquisirono il meritato credito.
Al contempo, credo che l’inerzia possa spiegarsi anche come conseguenza di
un altro “rimosso storico”: gli anni Settanta così intensamente intrisi di politica e
terminati, forse, nel peggior modo possibile.6 Anni Settanta che si legarono senza
dubbio agli anni della Resistenza e durante i quali, non a caso, furono avviate nuove
ricerche sulla lotta partigiana, riscoprendo interi ambiti che la storiografia tradizionale
aveva da sempre lasciato ai margini.
Tuttavia, con la fine di un’epoca, quella dei movimenti e della politica condotta
dal basso7, si è conclusa una certa attitudine al “fare politica” e si è avviata, a mio
modo vedere, una fase di profondo distacco, per molti versi anche ideologico. Le
generazioni nate a partire dagli anni ’80 risentono di tutto questo, private di una vera
e propria identità sociale e culturale. Le generazioni nate a cavallo tra gli anni ’90 e i
primi anni 2000 – a cui appartengono i 117 ragazzi in questione e di buon grado
anche la sottoscritta – sono cresciute e si sono formate durante il ventennio della
Seconda Repubblica, che ha conosciuto una vera e propria inversione di tendenza in
termini di “militanza” e di “militanza collettiva” e un reiterato abuso di espressioni
quali “il comunismo” o “le sinistre”. Di fronte a tutto questo si chiede alla storia di
non cedere. Oggi, domani e dopodomani, ergersi nel tentativo forse vano e
certamente beffardo di resistere.
6 Ne Le ragioni di un decennio, Giovanni De Luna, proprio a proposito del modo in cui si conclusero gli anni ’70, scrive: “Con la sconfitta tutto fu schiacciato dal peso esorbitante del terrorismo e delle sue vittime. Un intero decennio fu riassunto nella definizione spettrale di “anni di piombo”. 7 E guarda a caso, a proposito di analogie storiche, Guido Quazza definì la vita di banda “un microcosmo di democrazia dal basso”.
Bibliografia
Calvino, Italo, Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 1964.
Carr, Edward H. Sei lezioni sulla storia (1961), Einaudi, Torino 2000
De Luna, Giovanni, Le ragioni di un decennio, Feltrinelli, Milano 2011.
Paracchini, Andrea, Rappresentazioni sociali della Resistenza, dal sito
www.storia900bivc.it/pagine/editoria/paracchini207.html.
Revelli, Nuto, Le due guerre. Guerra fascista e guerra partigiana, Torino, Einaudi 2003.
Sémelin, Jacques, Senz'armi di fronte a Hitler. La resistenza Civile in Europa 1939-1943,
Sonda, Torino 1993.