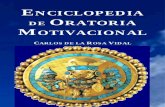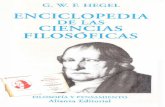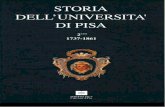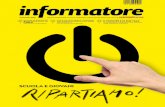Enciclopedia è termine di scuola
Transcript of Enciclopedia è termine di scuola
Anno III
Numero 1
2014
Civitas educationis
SUOR ORSOLA BENINCASA
LIGUORI EDITORE
Education, Politics and Culture
Civitas Educationis. Education, Politics and Culture
Ambiti di interesse e finalità
Civitas educationis. Education, Politics and Culture è una rivista internazionale peer-reviewed che promuove la riflessione e la discussione sul legame fra educazione e politica (intesa come dimensione fondamentale dell’esistenza umana).Tale legame ha caratterizzato il pensiero e le pratiche educative occidentali sin dai tempi degli antichi greci, così come testimonia il nesso paideia-polis.La rivista vuole essere un’agorà in cui sia possibile indagare questo nesso da diverse prospettive e attraverso contributi teorici e ricerche empiriche che focalizzino l’attenzione sulle seguenti aree tematiche:
Sistemi formativi e sistemi politici;Educazione e diritti umani;Educazione alla pace;Educazione alla cittadinanza democratica;Educazione e differenze;Educazione e dialogo interreligioso;Educazione e inclusione sociale;Educazione, globalizzazione e democrazia;Educazione e cultura digitale;Educazione ed ecologia.
Aims and scope
Civitas educationis. Education, Politics and Culture is an international peer-reviewed journal and aims at pro-moting reflection and discussion on the link between education and politics (as a fundamental dimension of human existence).
That link has been characterizing western educational thinking and practices since the time of the ancient Greeks with the bond between paideia and polis.
The journal intends to be an agora where it is possible to investigate this topic from different perspecti-ves, with both theoretical contributions and empirical research, including within its scope topics such as:Educational systems and political systems;Education and human rights;Peace education;Education and citizenship;Education and differences;Education and interfaith dialogue;Education and social inclusion;Education, globalization and democracy;Education and digital culture;Education and ecology.
Gli articoli pubblicati in questo periodico sono sottoposti preventivamente ad una doppia procedure di peer review.
Editor-in-chiefElisa Frauenfelder
Advisory EditorEnricomaria Corbi
Editorial BoardFabrizio Chello, Daniela Manno, Stefano Oliverio, Pascal Perillo
National Scientific CommitteeMassimo Baldacci (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”), Franco Cambi (Università degli Studi di Firenze), Enricomaria Corbi (Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli), Michele Corsi (Università degli Studi di Macerata), Lucio d’Alessandro (Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli), Luigi D’Alonzo (Università Cattolica del Sacro Cuore), Ornella De Sanctis (Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli), Franco Frabboni (Università di Bologna), Elisa Frauenfelder (Università degli Studî Suor Orsola Be-nincasa – Napoli), Cosimo Laneve (Università di Bari), Umberto Margiotta (Università Ca’ Foscari Venezia), Giuliano Minichiello (Università degli Studi di Salerno), Margherita Musello (Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli), Vincenzo Sarracino (Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli), Fabrizio Manuel Sirignano (Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli), Giancarla Sola (Università degli Studi di Genova), Maura Striano (Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Natascia Villani (Università degli Studî Suor Orsola Benincasa – Napoli), Carla Xodo (Università degli Studi di Padova).
International Scientific CommitteeGert Biesta (University of Exeter), Janette Friedrich (Université de Genève), Jen Glaser (Hebrew University of Jerusalem), Larry Hickman (Southern Illinois University Carbondale), David Kennedy (Mont Claire University), Walter Omar Kohan (Universidade de Estado de Rio de Janeiro), Marco Eduardo Murueta (Universidad Nacional Autónoma de México), Marie-Noëlle Schurmans (Université de Genève), Rupert Wegerif (University of Exeter).
Web site http://www.civitaseducationis.eu e-mail: [email protected]
Civitas educationisEDUCATION, POLITICS AND CULTURE
Anno III
Numero 1
2014
SUOR ORSOLA BENINCASA
LIGUORI EDITORE
Dipartimento di Scienze Formative, Psicologiche e della Comunicazione
Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione R.O.C. n. 10757
Gli articoli pubblicati in questo periodico sono sottoposti preventivamente ad una doppia procedura di peer review.
Anno III, numero 1 – 2014
ISSN 2280 - 6865 (edizione a stampa) ESSN 2281 - 9568 (edizione digitale)
Pubblicazione semestrale: abbonamento annuale (due numeri): € 36,00
Gli Articoli pubblicati in questo Periodico sono protetti dalla Legge sul Diritto d’Autore (http://www.liguori.it/areadownload/LeggeDirittoAutore.pdf).Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla citazione, alla riproduzione in qualsiasi forma, all’uso delle illustrazioni, delle tabelle e del materiale software a corredo, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla registrazione analogica o digitale, alla pubblicazione e diffusione attraverso la rete Internet sono riservati. La riproduzione degli Articoli di questo Periodico, anche se parziale o in copia digitale, fatte salve le eccezioni di legge, è vietata senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.Il regolamento per l’uso dei contenuti e dei servizi presenti sul sito della Casa editrice Liguori è disponibile all’indirizzo http://www.liguori.it/politiche_contatti/default.asp?c=contatta#Politiche
Direttore Responsabile: Arturo Lando
Amministrazione e diffusioneLiguori Editore - via Posillipo 394 - I 80123 Napolihttp://www.liguori.it/Informazioni per la sottoscrizione di abbonamenti [email protected]
© 2014 by Liguori Editore, S.r.l.Tutti i diritti sono riservatiPrima edizione italiana Dicembre 2014Stampato in Italia da Liguori Editore, Napoli
ISBN 978 - 88 - 207 - 6558 - 3 (a stampa) eISBN 978 - 88 - 207 - 6559 - 0 (eBook)
1. Educational-Political Practices 2. Pedagogy I. Titolo II. Collana III. Serie
La carta utilizzata per la stampa di questo volume è inalterabile, priva di acidi, a ph neutro, conforme alle norme UNI EN Iso 9706 ∞, realizzata con materie prime fibrose vergini provenienti da piantagioni rinnov-abili e prodotti ausiliari assolutamente naturali, non inquinanti e totalmente biodegradabili (FSC, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS)
Table of contents - Indice
EDITORIAL 1Elisa Frauenfelder
SYMPOSIUM Education as inclusion Edited by Maura Striano
Maura StrianoIntroduction 11
Sergio TrammaUna lettura pedagogico-sociale dell’inclusione: prospettive e criticità 19
Stefano MalteseIncludere educando o educare includendo? Questioni pedagogico-sociali e spunti di riflessione sulle pratiche di intervento 35
José MedinaTowards An Ethics and Pedagogy of Discomfort: Insensitivity, Perplexity, and Education as Inclusion 51
Maura StrianoInclusione e sviluppo sociale ed educazi-one 69
Andrea CanevaroEducazione come inclusione 81
Hans Schuman, Nicolina Montesano MontessoriInternational Developments on Inclu-sive Education and the Presentation of a Participative and Reflective Approach to Research 99
ESSAYS – SAGGI
Marinella Attinà, Paola MartinoInclusive Pedagogy, Well-Being, Care and Responsibility for the Humanisation of Mankind 121
Vasco d’AgneseOtherness and Responsibility: Education as Uncertainty-Based Practice 131
Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio“Enciclopedia è termine di scuola” 143
Marcello OstinelliRousseau e l’educazione del cittadino 165
BOOK REVIEWS – RECENSIONI
Raffaella BiagioliM. Contini & S. Ulivieri (a cura di), Donne, famiglia, famiglie, Milano: Guerini Scientifica, 2010 187
Stefano LentiniM.T. Trisciuzzi, Hayao Miyazaki. Sguardi oltre la nebbia, Roma: Carocci, 2013 191
ESSAYS – SAGGI
“Enciclopedia è termine di scuola”*
Egle Becchi**, Adolfo Scotto di Luzio***
* Il saggio è stato impostato e discusso da entrambi gli autori. I paragrafi1,2, 3 sono stati composti da Adolfo Scotto di Luzio, quelli 4 e 5 da Egle Becchi. Il paragrafo 6 è opera comune.
** Università degli Studi di Pavia.*** Università degli Studi di Bergamo.
Abstract: This paper analyzes some articles about teaching and education in the Enciclopedia Einaudi and discusses their ideological and epistemological approach, their methodology, and their unsatisfactory connection to the political and cultural events of Europe during the last 30 years of the 20th century. The authors use the results of this analysis to explain the present crisis of the Italian educational system.Key-words: Enciclopedia Einaudi, crisi della scuola, educazione.
Riassunto: Il saggio analizza alcune voci, su insegnamento e educazione, dell’Enciclopedia Einaudi, di cui discute la prospettiva ideologica ed epistemologica, l’impianto metodologico e il legame non criticamente elaborato con le vicende politiche e culturali dell’Europa dell’ultimo trentennio del Novecento. Tale disamina serve a proporre una spiegazione della crisi attuale della pedagogia della nostra scuola.Parole-chiave: Enciclopedia Einaudi, crisis of the school, education.
Questo articolo rappresenta la proposta di una riflessione, in vista di un lavoro più ampio, sul posto che la scuola occupa nel sistema della cultura italiana degli ultimi decenni del Novecento, tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta per intenderci. È allora, infatti, che i nodi della storia dell’Italia repubblicana e della sua scuola vengono al pettine. Con questi nodi abbiamo ancora oggi a che fare. Il tracciato che abbiamo seguito è, a grandi linee, il seguente: alla fine di un lungo ciclo espansivo delle democrazie occidentali, durato grosso modo trent’anni, dal 1945 al 1975, e che ha visto, sullo sfondo di una imponente trasformazione sociale, una straordinaria espansione della scolarità postelementare, la scuola italiana si trova messa di fronte ad una crisi di legittimità del sistema politico-istituzionale destinata ad aggravarsi nei decenni a venire e che il sistema nazionale di istruzione riflette in un crescente diso-rientamento. Un’intera enciclopedia del sapere, erosa progressiva-
144 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
mente ai margini, si sfalda senza che si sappia come sostituirla. La scuola diventa una sorta di deposito alluvionale in cui i detriti della vecchia cultura delle élite si sovrappongo agli elementi più recenti dei saperi tecnico-professionali. È un movimento che equivale a una perdita progressiva di centro e che spinge la scuola sulla china di una accentuata burocratizzazione, enfatizzando, in assenza di simboli unificanti, le soluzioni meramente gestionali dei problemi di legittimità che essa è costretta a fronteggiare. Il punto saliente di questo passaggio è l’interruzione del rapporto fra scuola e luoghi della produzione culturale, la separazione tra mondo magistrale e universo della ricerca accademica, che si manifesta, tra l’altro, nel venir meno di tutto un complesso di strumenti bibliografici per la formazione e la riproduzione culturale degli insegnanti. È l’inari-dirsi di queste fonti dell’autonomia intellettuale del corpo docente a segnare del proprio tratto il paesaggio di questi anni scolastici. La biblioteca magistrale viene svuotata e riempita di nuovi strumenti, segnati in prevalenza dall’urgenza delle pratiche, da un didattici-smo di corto respiro, infine dalla richiesta di un nuovo conformismo ideologico. Quanto, insomma, appare con progressiva chiarezza è il venir meno della rappresentazione di un capitale culturale da assimilarsi e da far assimilare nelle istituzioni del nostro sistema formativo; il riferimento alla tradizione e all’attualità di un sapere organizzato che si viene sistemando in forme innovative.
Enciclopedia è termine di scuola e il modo migliore per guardare alle vicissitudini culturali della nostra scuola è capire cosa succede proprio a questo genere di strumenti intellettuali, le enciclopedie appunto. A partire dal Novecento ogni progetto che si colloca sul terreno dell’organizzazione della cultura è un progetto che prova a mettere in forma il campo dell’istruzione. È, sempre, al tempo stesso, una proposta rivolta alla scuola e in modo particolare agli insegnanti. L’Enciclopedia italiana nata all’interno del laboratorio del-la cultura idealistica è solo il punto culminante di questo lavoro di potenziamento degli strumenti intellettuali del sistema della tra-smissione formale del sapere. Il sapere che si impartisce ai giovani rimanda infatti a una sua organizzazione, e la scuola novecentesca è messa nelle condizioni di potersi giovare di strumenti bibliografi-ci, di repertori, di enciclopedie. Ora, la domanda che ci poniamo è la seguente: che cosa accade a questo genere editoriale negli anni che ci interessano e in che modo le sue vicende illuminano il percorso tardo novecentesco del nostro sistema di istruzione?
Le enciclopedie rappresentano un luogo particolarmente sensi-bile. Costituiscono il laboratorio in cui una cultura mette in mostra i propri criteri operativi, di sistemazione e di selezione della sua immagine. Sono esplicitamente uno strumento di orientamento e
La crisi della scuola come crisi dell’egemonia›
“Enciclopedia è termine di scuola” 145
ESSAYS – SAGGI
di formazione del pubblico e, nel contesto italiano, rappresentano al tempo stesso il terreno di un vero e proprio regolamento di conti tra passato e presente, tra innovazione culturale e tradizione. Negli anni da noi considerati nuovi progetti sorgono, l’Enciclopedia Einaudi, ad esempio, ma anche su un piano diverso l’Europea Gar-zanti, e vecchie istituzioni, è il caso della Treccani, per più versi significativo, rimettono a nuovo il proprio modello. Noi ci occupe-remo dell’Enciclopedia Einaudi. I motivi si lasciano riassumere con la dichiarata ambizione del progetto e con il riferimento all’area politico culturale della sua provenienza, la cultura torinese, il suo delicato rapporto con il Pci, la difficoltà crescente a tenerlo insieme all’insegna della coppia Gramsci e Gobetti, fortemente sollecitata dall’assalto ideologico della nuova sinistra nei dieci anni immedia-tamente precedenti (il libro di Paolo Spriano Gramsci e Gobetti appare nel 1977 e raccoglie una serie di studi pubblicati a partire dalla metà degli anni Sessanta. Il titolo gli deriva da un saggio apparso in Studi storici nel 1976. Spriano aveva accolto l’invito di Roberto Cerati e si proponeva di giustificare la portata di un binomio al di là del “richiamo un po’ rituale alla comune battaglia antifascista”).
Attraverso l’Enciclopedia Einaudi ci proponiamo di mettere a fuoco le conseguenze che sulla scuola in idea produce l’internazio-nalizzazione della cultura italiana a partire dalla metà degli anni Sessanta. Il progetto della casa editrice torinese è situato infatti allo sbocco di un faticoso attraversamento, quello appunto che Italo Calvino individuò come il tema cruciale del rinnovamento della cultura italiana alla fine degli anni Cinquanta1. Questo passaggio e la crisi che esso determina negli atteggiamenti di fondo degli intellettuali, nella tenuta di tradizioni accademiche e dei loro rag-gruppamenti, nel linguaggio della pedagogia e nelle sue categorie, nel repertorio dei problemi, non avviene, come è ovvio, in un vuoto di storia. Esso si produce nell’attrito con due fattori rilevanti. Il salto scientifico e tecnologico della società italiana del dopoguerra, da un lato; la configurazione politico-ideologica dell’identità degli intellettuali e del sistema delle appartenenze accademiche, dall’al-tro. L’effetto principale di questa particolare conformazione storica della cultura nazionale dopo la seconda guerra mondiale consiste nella tendenza a scambiare crisi dell’ideologia e crisi della cultura e a proiettare sulla società e sul sistema delle idee, come complessità, quello che più appropriatamente andrebbe considerato il senso di
1 I testi di questa riflessione di Calvino sono noti e rimandano al dibattito politico culturale promosso dalla rivista Il menabò di letteratura tra la fine degli anni Cinquanta e la seconda metà degli anni Sessanta, in particolare mi rife-risco a “Il mare dell’oggettività”, scritto nel 1959 ma pubblicato sul numero 2 della rivista nel 1960, e a “La sfida al labirinto”, uscito nel 1962, oggi in Calvino (2002). Per una lettura di questo attraversamento, cfr. Zancan (1996).
146 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
insoddisfazione per l’inadeguatezza di un apparato interpretativo di tipo ideologico.
Affidata alla direzione di Ruggiero Romano, l’Enciclopedia esce in sedici volumi tra il 1977 e il 1982. Vale la pena di notare che la scelta di Romano assume, ai fini del nostro discorso, un duplice significato. Trasferitosi a Parigi nel 1947, quando aveva appena ventiquattro anni, Romano è lo studioso italiano più prossimo al modello, allora dominante, della versione braudeliana delle Annales e alle sollecitazioni epistemologiche implicate dal nesso lì istituito tra storia e scienze sociali, con un orientamento deciso in direzio-ne della nuova ricerca teorica sui fondamenti della conoscenza scientifica2.
A questa prima serie di considerazioni va poi aggiunta l’os-servazione che Romano rappresenta l’autore biograficamente più distante dal quadro dei problemi derivanti alla cultura italiana dall’elaborazione dell’eredità neoidealistica e dal complicatissi-mo rapporto che questa elaborazione intreccia con le questioni politiche e ideologiche della transizione fascismo/post fascismo. È del tutto evidente allora che la direzione ‘extra-territoriale’ di Romano rappresenta una esibita presa di distanza dalla tra-dizione culturale italiana e, al tempo stesso, l’indicazione che fosse possibile semplicemente aggirarne il groviglio di problemi collegandosi direttamente a una ricerca europea orientata a sua volta in senso scientifico-epistemologico. Secondo una direzione in senso più generale culturale della casa editrice, sul quale aveva esercitato una influenza notevole il ripensamento, in chiave tutta scientifica e tecnologica, del transito degli anni Sessanta operato da Italo Calvino3. È, per dirla in maniera un po’ spiccia, l’indi-viduazione dell’Europa, di una Europa francese e strutturalista, come via d’uscita alla crisi dell’egemonia. Con un movimento tipico della cultura italiana di quegli anni, che segnerà ideologi-camente i decenni a venire: l’Europa come soluzione all’impasse
2 Per un primo orientamento, cfr. Braudel (1989). L’edizione francese, per Flammarion, risaliva al 1969.
3 Ai testi cui si è già rimandato nella precedente nota 1 si possono aggiun-gere due interviste datate 1968 su scienza e letteratura, ora in Calvino (1995), in cui la vocazione profonda della letteratura italiana, nel segno di Galilei, è individuata da Calvino nel tentativo della nostra tradizione di costruire attra-verso la parola letteraria un’immagine dell’universo: «L’opera letteraria come mappa del mondo e dello scibile, lo scrivere mosso da una spinta conoscitiva che è ora teologica ora speculativa ora stregonesca ora enciclopedica ora di filosofia naturale ora di osservazione trasfigurata e visionaria […] Questa vena negli ultimi secoli è diventata più sporadica, e da allora certo la letteratura italiana ha visto diminuire la sua importanza: oggi forse è venuto il momento di riprenderla […] in certi momenti ho la sensazione che la via che sto seguendo mi riporti nel vero alveo dimenticato della tradizione italiana» (Ibid.: 233).
“Enciclopedia è termine di scuola” 147
ESSAYS – SAGGI
culturale del progressivo esaurirsi della tradizione intellettuale del comunismo italiano.
I volumi sui quali concentreremo la nostra attenzione in que-sto paragrafo sono il terzo, il quarto e il settimo, dove si leggono le voci, nell’ordine, Conoscenza, Coppie filosofiche, Disciplina/discipline, Insegnamento. Appaiono tra il 1978 e il 1979. Siamo dunque, nel giro molto compatto di un breve numero di anni, pienamente dentro la transizione politico-culturale degli anni Settanta, tra crisi della democrazia keynesiana e frantumazione incipiente del quadro geo-politico del dopoguerra. Questo comporta, da un lato, l’indebolirsi, fino al pieno sfilacciamento, del nesso tra costruzione culturale dello Stato sociale e coscienza storica, che si era venuto saldando tra le due sponde dell’Atlantico fin dagli anni Venti e Trenta del Novecento; dall’altro, l’emergere di una nuova tensione, che diven-terà ossessiva nei decenni successivi, tra ubiquità e memoria, tra delocalizzazione e radicamento. Particolarmente sensibile proprio sul terreno dell’impresa scientifica, sul quale si colloca il progetto dell’Enciclopedia e dove insistono in modo particolare i testi che prenderemo in esame. Ne emerge il quadro, molto complesso, della crisi della razionalità classica, del nuovo rapporto che essa istituisce tra ragione e cultura e più in generale dei conflitti tra cognitivo e non cognitivo.
Le voci rimandano a un unico autore, Fernando Gil, porto-ghese, filosofo della conoscenza a Lisbona e a Parigi, dove aveva studiato logica negli anni Sessanta e dove sarebbe diventato diret-tore di ricerca all’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Legato a Mario Soares, quando questi diventerà presidente della Repubblica nel 1986 sarà il suo consigliere culturale. Dell’Enciclopedia Einaudi, Gil era consulente del progetto, insieme, tra gli altri, a Jean Petitot e Giulio Giorello. Nel quadro di queste coordinate cronologiche e culturali appena abbozzate, il rilievo che le voci dell’Enciclopedia assumono in rapporto al nostro soggetto deriva dalla netta disloca-zione che il testo opera delle questioni relative al problema dell’i-struzione su un terreno culturale segnato dalla duplice impasse, pri-mo, della crisi del paradigma comeniano della democratizzazione del buon senso e, per dirla con Gil, della sua contropartita, il venir meno cioè della “credenza” nella infallibilità dell’educazione (crisi che proprio in quel giro di anni manifesta tutta la sua portata nel contesto più generale dell’esaurimento del lungo ciclo espansivo del secondo dopoguerra e della grande spinta che questo aveva comportato alla scolarizzazione di massa nel mondo occidentale). Insieme a tutto questo, ed è qui che si apre l’altro lato dell’impasse di cui prima si diceva, c’è poi la difficoltà specifica di trovare una via d’uscita allo smottamento dei quadri ideologico-culturali del post Seconda guerra mondiale lungo la linea del mito dell’Euro-
148 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
pa Universitas, nella versione dell’“Impresa scientifica europea”, di cui scriverà all’inizio degli anni Novanta quel Giulio Giorello che abbiamo già visto impegnato nell’impresa einaudiana, in un libro per Feltrinelli a tre voci, con Tullio Regge e Salvatore Veca, sul quale dovremo ritornare, intitolato proprio a quel mito (Giorello, Regge & Veca, 1993).
Sul terreno che più da vicino è nostro, quello della scuola, l’Enciclopedia Einaudi si colloca così allo sbocco di una duplice crisi, di cui non riesce a venire a capo: del modello classico, ‘moderno’, dell’istruzione per tutti; dell’impossibilità poi di fare della scienza come “forma spirituale” della nuova Europa la piattaforma ideo-logica di una rifondazione delle istituzioni educative democratico-nazionali.
Sulla soglia di questo passaggio d’epoca, Gil individua alcuni processi in atto della scuola che verrà. In particolare, coglie come la crisi del paradigma moderno dell’istruzione riabiliti l’intera tematica aristotelica dell’habitus e della portata conoscitiva delle pratiche. È la diagnosi, non senza preoccupazione, di una rin-novata subordinazione dell’istruzione all’educazione, di un inse-gnamento espulso dalla scuola vera e propria, affidato alla vita professionale e conseguito attraverso “pratiche conoscitive” e non più attraverso “studi” nel vero senso della parola. Partendo da qui, scrive Gil,
occorrerebbe riconoscere che il presupposto di un’autonomia della sfera conoscitiva e dell’indipendenza di una realtà curricolare, che presiederebbe al sistema scolastico (che si è ratificato senza discussio-ne, essendo questo il fondamento della pratica e il senso della teoria dell’insegnamento, dal XVI secolo in poi), si troverebbe ad essere in certa misura compromesso. Da un punto di vista sociale il curricu-lum sarebbe fondamentalmente un’occasione per acquisire l’habitus, e non il motivo della vita scolastica; e la distinzione fra educazione e insegnamento presenterebbe in questa prospettiva un valore piuttosto euristico» (Gil, 1979: 738-739).
Per la verità, proprio sul terreno di questa constatazione si pone una difficoltà che ha una portata più vasta della tenuta del quadro tracciato da Gil e mette in gioco una intera strategia argomentativa e con essa la soluzione ‘politica’ che verrà prospettata nel decennio successivo in questo ambito dell’argomentazione culturale. L’intro-duzione di un punto di vista sociale, di fatto la considerazione di un’evoluzione storica nei rapporti tra istruzione e potere sociale nella società, pone non solo la questione se il problema scolastico si lasci risolvere in termini astrattamente categoriali e di modelli teorici, come pretende Gil, ma più in generale se la filosofia della scienza sia realmente in grado, come pure pretende, di indicare una
“Enciclopedia è termine di scuola” 149
ESSAYS – SAGGI
via d’uscita alla crisi culturale degli anni Settanta e con essa una prospettiva agibile per le politiche della ricerca e della formazione. Come di fatto è accaduto negli anni che stanno immediatamente alle nostre spalle.
La necessità di tenere conto del contesto, questo di fatto si-gnifica l’introduzione del “punto di vista sociale”, rende visibile e costringe l’osservatore a prendere atto dello scarto tra selezione sociale delle competenze e selezione conoscitiva. Una tecnocra-zia, nota Gil, non esiste in nessun luogo. Di fronte a questa con-statazione, la centralità della formazione scientifica nella scelta delle élite e dunque nella costruzione di un sistema scolastico effi-cace è poco più di un mito sociale. «Resta tutto da dimostrare», scrive infatti il nostro autore, seppure attenuando la portata della sua affermazione in un inciso rafforzato dal segno grafico della parentesi, la tesi dell’effetto della mentalità scientifica nell’attri-buzione degli incarichi socialmente importanti (Ibid.: 738). Ma allora, se “modelli di intelligibilità” ed “entità relativa” degli studi sono due cose diverse, su quali basi reali poggia la pretesa di fare del modello scientifico della storia europea una soluzione politica, un’indicazione per orientarsi nella pratica? La scuola si riprende qui i suoi privilegi sulla pretesa di ridurne la portata di istituzione politica e sociale alle esigenze cognitive di una teoria dell’insegnamento. Pone soprattutto una domanda circa i saperi che sono realmente in grado di interpretarne politicamente la funzione. Perché se è vero come scrive Gil che modelli di intel-ligibilità e organizzazione degli studi sono due cose diverse, è pur vero che non tutti i modelli di intelligibilità si equivalgono e alcuni dimostrano una maggiore capacità di altri di orientare gli studi in relazione alle esigenze politiche di governo della società. La difficoltà della proposta dell’Enciclopedia Einaudi appare se pos-sibile ancora maggiore tenuto conto del modo in cui il modello viene costruito nell’argomentazione di Gil, sulla base cioè di una radicale escissione degli esiti del processo di formazione della concezione moderna della conoscenza dalle basi reali, storiche, della loro elaborazione. Le necessità della sistematizzazione, an-nota Gil, collidono con la storicità del processo (Gil, 1977: 779).
Vale la pena allora guardare più da vicino i termini della pro-posta ‘politica’ di questa filosofia della scienza colta tra anni Set-tanta e Ottanta nell’elaborazione di una via d’uscita al problema dell’impresa europea nel quadro della crisi degli assetti geopolitici e ideologici imposti dalla conclusione della seconda guerra mondiale. Il problema della scuola si colloca nello spazio di questa cornice più ampia e la sua storia nella transizione novecentesca non può non tenerne conto.
150 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
Per fare questo dobbiamo abbandonare i testi dell’Enciclopedia ei-naudiana e rivolgerci a un libro pubblicato da Jaca Book nel 1990, Prove. Attraverso la nozione di prova/dimostrazione, in particolare al sag-gio conclusivo, Kant e la controversia, e all’appendice, La supposizione di Samuel Clarke, dove Gil affronta le questioni implicate dal conflitto tra Leibniz e Clarke sulla natura dello spazio newtoniano e sul principio dell’indifferenza degli indiscernibili (Gil, 1990).
Entrambi questi scritti sono accomunati da un’idea che lo stes-so Giorello, intervenendo nel 1986 in un dibattito sulla filosofia italiana, aveva formulato in questi termini: la scienza matura non esclude la metafisica (Giorello, 1986). Anzi, questa e le dispute che sprigiona sono alla base di quello “stato eccitato” dell’impresa scientifica in cui consiste al tempo stesso il suo processo creativo. La controversia è un modo di esistenza politico dell’impresa scientifica e pretende di fare della scienza il contenuto della “forma spirituale” di una democrazia sovranazionale dopo la fine dei “dogmatismi dispotici”. Il riferimento è ovviamente al Kant della Critica della ra-gion pura e ai problemi dell’Antinomia. Come il politico deve essere in grado di simulare le intenzioni dell’avversario tanto da saperlo saggiamente anticipare così, aggiunge Giorello, «qualunque pro-gramma scientifico di una certa portata deve essere in grado di ri-produrre entro il proprio armamentario intellettuale almeno i pezzi riusciti del programma avversario» (Ibid.: 85). Per questo, continua, riprendendo esplicitamente un tema che Gil aveva trattato nel suo saggio einaudiano sulle coppie filosofiche, «questo tipo di simulazione è una componente strutturale della crescita della scienza, poiché l’unità di valutazione del cosiddetto progresso scientifico non è un singolo quadro concettuale […] ma una coppia di programmi rivali: come per Eraclito di Efeso, il principe greco che è stato l’inventore della democrazia intellettuale, “il conflitto è il signore di tutte le cose”» (Ibidem).
In questo continuo andirivieni tra l’Erkenntnisproblem della filo-sofia moderna e l’allusione alle questioni di una democrazia pos-sibile dopo la fine della guerra fredda, tra democrazia intellettuale e democrazia politica, tra Repubblica delle Lettere e Repubblica transnazionale dei Cittadini, il riferimento alla controversia filosofi-ca nella codificazione kantiana rimanda alla costruzione di un vero e proprio modello storico-scientifico di interpretazione dell’identità europea. Il diciassettesimo secolo, il secolo di Keplero, Galileo, De-scartes, Pascal, Newton e Leibniz, è non solo il secolo della scienza e dell’ideale moderno della conoscenza ma, nella formulazione kantiana della soluzione delle Antinomie della ragione, il teatro di quella “grande lite” tra empirismo e razionalismo cui Kant stesso credé di poter ricondurre tutti i conflitti filosofici:
Un modello scientifico della storia della democrazia›
“Enciclopedia è termine di scuola” 151
ESSAYS – SAGGI
L’argomentazione – osserva Gil nel saggio dedicato a Kant e la con-troversia – si vede ridotta all’essenziale e si sviluppa seguendo l’unico schema della prova apagogica, nei quattro casi e per quanto riguarda sia la Tesi che l’Antitesi […] Aspetto non meno essenziale, le Tesi sono dichiarate solidali tra di loro (la loro ispirazione è razionalistica) e così pure le Antitesi (la cui ispirazione è empiristica: lo stesso empi-rismo è divenuto dogmatico! […]). Questo significa che tutti i conflitti filosofici possibili si lascerebbero esprimere dalla grande lite del sec. XVII, che ha visto la contrapposizione del razionalismo e dell’em-pirismo. Effettivamente […] si suppone che le controversie storiche salienti siano riconducibili ai quattro conflitti kantiani, in particolare: “Queste affermazioni raziocinanti corrispondono ad altrettanti ten-tativi di risolvere quattro problemi della ragione naturali e inevitabili. Il numero di questi problemi non può essere né maggiore né minore” (Gil, 1990: 159).
È questo allora il senso della “lezione del Seicento” che Gio-rello richiamava nel 1986 e che Gil codificava in forma più ‘sa-vante’ nello stesso periodo (un Seicento sistematizzato da Kant): un relativismo scientifico, che si traduceva nelle forme esterne di un relativismo istituzionale in grado di consentire la proliferazio-ne delle alternative, trova la sua espressione compiuta solo in un esperimento democratico maturo, di cui l’Europa sarebbe il duplice depositario, in quanto memoria del moderno e in quanto luogo in cui finalmente quell’antico progetto ritorna.
Ma è proprio questo rapporto tra luogo e memoria ad essere pro-blematico alla fine degli anni Ottanta. Salvatore Veca, nel libro del 1993 già richiamato, Europa Universitas, si sarebbe incaricato di rilevare la frattura difficilmente ricomponibile tra evocazione del passato e effettività delle condizioni presenti. La controversia, il pro-liferare delle alternative, semplicemente non hanno più un luogo. O meglio, l’impresa scientifica europea, di cui la controversia è al tempo stesso il motore e la regola è tale, cioè europea, solo perché in Europa ha preso forma nel Seicento, ma certo in Europa non abita più o non vi abita più in modo privilegiato. Il punto era una considerazione realistica della riconfigurazione dei rapporti di po-tere internazionale dopo la seconda guerra mondiale e nel quadro della guerra fredda. Veca non lo diceva esplicitamente, ma certo nel riferimento al progetto europeo era difficile non tenere conto che l’Europa si era potuta pensare tale, unita, con l’illusione di giocare un ruolo autonomo sulla scena internazionale solo a patto di occultare la sua natura “protetta”, di entità politica sotto tutela:
Il venir meno della disunità europea – scrive Veca nel 1993 – di quella Europa [della guerra fredda], sembra rendere più ardua (o quanto meno scompaginare le carte per) la costruzione di una Europa che
Una soluzione evasiva: l’Europa›
152 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
potremmo o vorremmo, ancora una volta e in termini inediti, ricono-scere come “nostra”. Il guazzabuglio seguito al collasso della grande disunità centrale, cui è associata nel tempo l’impresa della costruzione europea, sembra a sua volta generare un singolare effetto di disunità nella parte o nell’area geopolitica della Comunità […] In ogni caso, l’impressione è che la metamorfosi dei confini nel versante esterno della Comunità e, in particolare, le trasformazioni, le tensioni e i con-flitti dell’Est non più imperiale si convertano in una varietà di sfide globali per un’Europa che tende a dividersi e vede prevalere la logica, la strategia o la tattica dei suoi stati nazionali territoriali. Così lo stato-nazione, una delle eredità e delle glorie del lessico politico, giuridico e istituzionale europeo, ritrova una propria singolare funzione nell’e-poca dell’erosione e del declino, quanto meno, delle sue capacità e delle sue competenze ormai classiche nell’esercizio della sovranità, dell’influenza e della forza legittima» (Veca, 1993: 133-134).
La soluzione a questa constatazione era deludentemente elu-siva: l’Europa è a pezzi. La fine della guerra fredda, cioè il venir meno dei due fattori di unità di un’Europa militarmente sconfitta nel 1945, per dissoluzione interna nel caso dell’Unione Sovietica e per progressivo disimpegno geostrategico come nel caso degli Americani, produce disunità e frantumazione, che a loro volta trovano espressione, ai margini, nella forma belluina della guerra e del massacro, al centro, nella figura di profonde diseguaglianze sociali. Come se ne viene fuori? La comunità educante ha il com-pito di generare quello che oggi non c’è. Come? Con uno sforzo volontaristico di chi ci crede. In questa visione, non c’è spazio per nessun tentativo di comprendere che cosa, ai tempi della guerra fredda, aveva assicurato l’unità di una parte dell’Europa e dunque il rapporto tra l’europeismo del secondo dopoguerra e la tutela americana. «È difficile sfuggire alla sensazione», scrive Veca, «che l’impresa politica dell’integrazione e dell’unità sovranazionale o federale europea sia largamente o, forse, integralmente debitrice nei confronti della geopolitica e dell’equilibrio stabile della “guerra fredda”» (Ibid.: 132). Dove la cosa notevole è l’uso pudico di quel richiamo alla sensazione, una forma attenuata dell’interdizione a un pensiero vero e proprio.
Il sogno dell’Europa è di fatto un sogno sognato all’ombra dell’ordine geopolitico garantito dall’equilibrio delle potenze.
Quello che però preme mettere in evidenza è altro. La pro-posta sorta sul terreno di una filosofia della scienza italo-francese tra anni Settanta e Ottanta, di una codificazione della controversia kantiana e delle sue implicazioni politico-epistemologiche, e con esse la ridefinizione del problema dell’insegnamento, non trova la politica cui affidarsi e resta una discussione molto aleatoria, non priva, e questo va rimarcato, di effetti concreti nell’ispira-re a cascata una vulgata pedagogica che si sarebbe imposta tra
“Enciclopedia è termine di scuola” 153
ESSAYS – SAGGI
fine Novecento e nuovo secolo nel ciclo delle riforme scolastiche e soprattutto nel ripensamento dei contenuti dell’insegnamento e dell’organizzazione scolastica delle discipline. Nell’Enciclopedia Gil aveva scritto, a proposito della scienza come storia dei passaggi graduali da produzioni personali a un’opera collettiva, che «ten-dente già di per se stessa alla semplificazione, la teoria si trova in seguito all’origine di un’altra sequenza di testi, sempre semplificati, che sfocia nel plagio organizzato dei manuali scolastici» (Gil, 1977: 802). Lo stesso discorso vale per il modo in cui si costruisce e opera la cosiddetta “scienza dell’educazione”.
Il venir meno di un solido terreno politico spiega anche il naufragio del progetto editoriale dell’Enciclopedia Einaudi. Un’opera senza referente si potrebbe dire. Non c’è un terreno politico su cui poggiare in modo saldo il piede nel tentativo di venire fuori dalla crisi dell’egemonia. L’Europa introvabile è la grande chimera della cultura italiana rimasta senza patria dopo la crisi del comunismo. Anche il discorso sulla scuola ne avrebbe inevitabilmente risentito gli effetti nei vent’anni successivi.
Se questo è il contesto politico e culturale entro il quale si colloca l’Enciclopedia Einaudi, va dato anche uno sguardo sommario al suo impianto teorico e metodologico. Pertanto si sono consultate altre voci, oltre a quelle giù ricordate: “Enciclopedia” (vol. I), “Educa-zione” (vol. V), “Istituzioni” (vol. VII). Il punto di vista che informa l’opera, come si legge nella “Premessa dell’Editore” non è quello di «accumulare cognizioni e notizie», bensì di esprimere «l’intreccio delle strade che la ricerca contemporanea sta seguendo, le strutture organizzative e – soprattutto – le possibilità del domani» (vol. I, 1977: XIII), nella convinzione che «la totalità del sapere non è il mero frutto di una serie di addizioni, bensì di una complessità di articolazioni» (Ibidem). Non basta: sempre nella “Premessa” si dichiara che non si sono rispettati dei «vincoli disciplinari» (Ibid.: XIV). Tale convinzione viene ribadita in molte voci, e l’espressio-ne più chiara ed energica è quella di Giuseppe Papagno, che in “Istituzioni” afferma esserci oggi una «coscienza emergente che i fondamenti della stessa scienza […] possono non essere risolti fa-cendo ricorso solo alla sua area specifica interna. Sembra cioè che certi interrogativi possano essere affrontati solo uscendo dal campo prescelto, cercando altrove basi, principi, certezze o semplicemente criteri di scelte» (Papagno, 1979: 1092). Non esclusività propria di specialismi disciplinari, quindi, ma accanto alla competenza in un particolare campo del sapere, sguardo attento e indagatore verso altri territori tradizionalmente cintati, di fatto aperti a nuove do-mande, nuovi meticciamenti, nuove analisi. È questa una linea che informa la grande opera, desta meraviglia, inquieta, non poche
Insegnare›
154 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
volte ha una funzione di stimolo al ripensamento di definizioni e problemi.
Nei 14 volumi le voci sono 556, trattate da studiosi diversi. I lemmi sono distinti in parole portanti, dotate di «coefficiente di migrabilità», vale a dire capaci di «assumere sensi e funzioni in campi diversi»; importanti, «abitualmente ricorrenti nel discorso del sapere attuale», e complementari, utili per «una certa storicizzazio-ne (ossia concretizzazione) della trattazione teorica» (Vol. I: XIV, n. 1). Non si dice com’è avvenuta la scelta delle 556 parole, né come si è deciso per la distinzione in portanti, importanti, complemen-tari. L’organizzazione problematica delle 556 voci nei 14 volumi preannuncia i problemi di scarsa perspicuità metodologica, che si accentuano nei due testi che contengono il XV, la Sistematica, con una “Premessa” di Ruggiero Romano, e il XVI, gli Indici, preceduti da un’“Introduzione” di Renato Betti. Nel XV volume le 556 voci vengono riassunte in 73 pacchetti di parole, i quali sono, insieme, anche snodi verso «la formazione di altri pacchetti da costruire a seconda dell’angolazione d’interessi del lettore» (Romano, 1982: XX-XXI)4. Qui si presenta, e in termini dichiarati, la difficoltà della sussunzione delle 556 parole nei pacchetti. Tale operazione è stata fatta grazie a un’analisi tematica, che Romano dichiara «fine», vale al dire «capace di vedere il modo di trattamento del tema (che può essere fenomenologico, deterministico, riduzionistico)» (Ibid.: XXI). Se però consideriamo i 73 pacchetti ci accorgiamo che non sempre questa consegna è stata rispettata, soprattutto perché non pochi di essi sono stati scritti da un autore diverso dall’estensore del lemma corrispondente, con cui questi non ha nessuna affinità di impianto culturale.
Allora, più che di sussunzione si potrebbe parlare di integra-zione o, perfino, di aggiornamento. Il che fa scattare un altro in-terrogativo di non poca importanza: come è stata operata, a tutti i livelli e in particolare in questa parte finale, che intende dare gli strumenti per una lettura dell’opera, l’analisi tematica, indicata a più riprese come modus di selezione? Come ci si è avvalsi di que-sta metodologia sfaccettata, circa la quale semiologi e narratologi hanno pubblicato non poche pagine? Una correzione sarebbe data grazie a una rielaborazione informatica che si avvale di grafi, con cui si costruiscono i rimandi fra pacchetti e parole, e, non ultimo, si definiscono delle Zone di lettura, aree contrassegnate in grigio, nelle quali un pacchetto risulta portante (Ibidem). Ma anche la gestione informatica dei problemi del compattamento, seppure nuova e ori-ginale a quel tempo, risulta, a mio avviso, questionabile, ancora una
4 In calce, Romano ringrazia Renato Betti, Fernando Gil, Giulio Giorello «per l’attento aiuto prestatomi» (Ibid.: XXI).
“Enciclopedia è termine di scuola” 155
ESSAYS – SAGGI
volta per le modalità di scelta delle informazioni su cui lavorare, vale a dire i termini che sono stati rilevati nelle loro occorrenze e di cui è stato calcolato il valore. Essi sono stati selezionati e apprezzati, infatti, sia sulla base della traduzione italiana, quindi attraverso un filtro non controllabile, sia – e soprattutto – da «let-tori» non specialmente «esperti del settore» (Betti, 1984: XXVII), che li hanno evidenziati e hanno attribuito un valore numerico non solo in base al loro presentarsi in ogni pagina e in ogni articolo, ma anche in relazione all’importanza che hanno nell’ambito dei discorso dell’autore stesso. Con tale criterio si è costruita la rete dei rimandi costitutivi dei pacchetti. Renato Betti (Ibidem), cui compete la parte informatica dell’opera, afferma esplicitamente che «introdur-re delle regolarità in un ammasso di dati, riuscendo a controllare l’inevitabile perdita di contenuto e rendendoli disponibili a metodi formali, è un problema che continua a chiedere una grande quan-tità di giudizio umano e di capacità intellettuale». Non basta: tali operazioni sfociano – grazie appunto a mosse informatiche – in grafici di pacchetti che sono rappresentati da aree incorniciate; in altri termini, grazie a modalità visive e non solo verbali, eterogenee rispetto a quella ‘sistematica’, univoca nella sua flessibilità, che Romano prospetta nel XV volume dell’Enciclopedia, come fondante la sua costruzione e ausilio per la sua consultazione.
L’applicazione di modalità ibride di selezione e gestione delle informazioni, esposte nel XVI volume in cui si resocontano le operazioni computer assisted, non si esaurisce qui. Torniamo al XV volume dove, in una sezione finale, si assimila il nostro sapere odierno a un labirinto acentrico, «un labirinto senza forma, senza percorsi», il labirinto per eccellenza5. Immagini di labirinti di tipo diverso illustrano le pagine in cui si parla della forma dedalica del sapere attuale, ma tale addizione non riesce a dare maggio-re chiarezza ai brani che trattano del labirinto acentrico. Ancora una volta sembra trattarsi di una procedura ibrida e l’impressione che se ne ricava è di un approccio analogo in entrambe le grandi operazioni di sistemazione: da un lato, per assicurare la coerenza del lavoro fatto, si è ricorso a procedure informatiche, i cui risul-tati sono presentati in via figurata; dall’altro, per rendere meno faticoso il lavoro di consultazione, ci si è avvalsi di una serie di compattamenti, spostamenti, aggiunte, sottrazioni, rappresentate ancora una volta in maniera iconica. Tale natura composita della parte sistematica rivela che l’ambizione di costruire una gramma-tica, la quale deve stabilire delle regole non «di comportamento
5 «Il sapere è un labirinto» (Vol. XV: 763). Sull’immagine del labirinto proposta da Calvino come figura di una determinata situazione culturale si veda la nota 1 di questo saggio.
156 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
rigido, quanto di libera costruzione» (Romano, 1982: 763), capaci di affrontare «una lettura infinita» (Ibid..: XXI), come dovrebbe essere quella dell’Enciclopedia, è di tale difficoltà che la si può – par-zialmente – realizzare solo abbozzando un sistema non univoco, applicabile sia al testo verbale, che a degli ibridi testuali, dove anche la vista ha una funzione disambiguante irrinunciabile. Ma si tratta ancora di una grammatica, di un insieme di norme codificate che sovrintendono a un linguaggio? E che pertanto non si applicano contemporaneamente a più linguaggi? Oppure di una didattica, di un ausilio per il lettore – che in fondo è il latente, ma grande protagonista dell’opera – più volte invitato a «impegnarsi in una lettura infinita» (Ibidem) per cui gli vengono offerti mezzi anche disparati per eseguire tale compito non certo agevole? Regole, quindi, ma anche un più elastico outillage per meglio apprendere un corpus di nozioni da assimilare; un armamentario fatto di titoli, riassunti, tavole, illustrazioni, che accompagnano questo eccezio-nale e infaticabile lettore nella sua immane lettura, rendendogliela meno affannosa, più gratificante? Si tratta, beninteso, di un’ipotesi paradossale, che, nel quadro affatto complesso e ricco di contrad-dizioni dell’Enciclopedia, non è forse azzardato proporre e che ben segnala il problema centrale di questa operazione culturale: la reale scomparsa del destinatario dal quadro del progetto enciclopedico.
Di un’ipotesi circa l’utilizzo dell’opera in termini di istruzione, il grande libro è il ricco maestro, il paziente e volonteroso lettore il discepolo, fuori da aule, istituzioni, obblighi, in un’inesausta opera di ricerca, non in una scuola. Perché l’Enciclopedia non vuole essere, qua talis, un grande prontuario culturale cui attingere per fini scolastici, e “scuola” nell’Enciclopedia non è una parola, né il termine compare nel repertorio alfabetico, dove pur sempre avrebbe dovuto esser nomi-nato, in quanto di scuola parlano, oltre che Fernando Gil, di cui si è detto, e Philippe Ariès, cui si accennerà, anche Alfredo Salsano, in un nutrito paragrafo intitolato appunto Scuola, all’interno della voce En-ciclopedia che inaugura il I volume. Qui l’Autore connette strettamente la vicenda delle produzioni di opere enciclopediche alle loro funzioni scolastiche: «Enciclopedia è termine di scuola. Come tale nasce nel mondo ellenistico, viene ripreso nella cultura romana e rinasce con l’umanesimo, in un contesto di pratiche e preoccupazioni didattiche dalle quali si renderà autonomo solo quando, con la enciclopedia settecentesca, passerà a designare la pragmatica unificazione di tutte le conoscenze e abilità umane» (Salsano, 1977: 22).
Salsano caratterizza la funzione delle enciclopedie classiche, dall’età ellenistica al Seicento, in termini di “azione pedagogica”, di ordinamento delle “cose da imparare”, e tale tratto connota le più celebri opere che presentano lo scibile umano in forma ordinata a fini di insegnamento e di apprendimento. Sarà con il Dictionnaire di
“Enciclopedia è termine di scuola” 157
ESSAYS – SAGGI
d’Alembert e Diderot che la funzione didattica delle enciclopedie entrerà in crisi e verrà sostituita da un’organizzazione aperta «sotto forma di inchiesta» dei vari campi del sapere (Ibid.: 54). Si tratta di un modello difficile, non sempre ripreso e imitato nelle enciclopedie del XIX e del XX secolo, dove la preoccupazione didattica in molti casi resiste. Pur sempre nelle enciclopedie di ultima generazione – quale l’Einaudi intende essere – l’idea di disciplina non viene abolita: «Le pratiche disciplinari con la loro struttura organizzativa (che si concreta in istituzioni d’insegnamento e di ricerca dotate di meccanismi di produzione e di riproduzione specializzati […]) rappresentano l’universo con il quale ci si deve necessariamente confrontare» (Ibidem). Allora l’Enciclopedia potrebbe servire non da prontuario di consultazione, ma come idea ispiratrice di una didat-tica della ricerca, dell’incursione nel nuovo, della costruzione del sapere, da usarsi anche nell’aula, come approccio originale a un mondo di nozioni nuove e senza nessi predefiniti, a delle discipline come modalità di una conoscenza che procede per via di indagine.
Quelli di Salsano e di Fernando Gil non sono gli unici approcci al tema della scuola. Pur nelle differenze, li accomuna un’idea di scuola come realtà di trasmissione formale del sapere, luogo dove si insegnano e si apprendono contenuti di un sapere dell’intelletto, dove gli allievi sono messi a confronto con le esigenze cognitive di corpi oggettivi di conoscenza. Non sono gli unici contributi all’argo-mento che viene trattato anche in un quadro ‘teorico’ assai diverso, nella voce “Educazione” da Philippe Ariès (vol. V). Il tema non è occasionale per lo storico, che fin dalla sua prima opera, l’Histoire des populations françaises et de leurs attitudes devant la vie depuis le XVIII siècle, rileva come fenomeno significativo, da un punto di vista di demografia storica della famiglia, il ridursi della natalità alla fine del XIX secolo e il contemporaneo aumento della scolarizzazione (Ariès,, 1971[1948], pp. 340 e sgg.). Ma è soprattutto ne L’enfant et la vie familiale (nell’edizione italiana Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, 1968), ripubblicato nel 1973, che alla scuola Ariès riserva una considerazione di riguardo. Quasi metà del volume è infatti dedicato alle agenzie di istruzione formale. Nei capitoli della se-conda parte, intitolata significativamente La vita scolastica, l’Autore si muove, a partire dal Medioevo, da dati di storia locale e da ricer-che sui collegi dal ’500 al ’700, facendo particolare attenzione alle esperienze degli allievi nella scuola, alla loro promiscuità nel corso di studi, alla progressiva distinzione di età e alla formazione di classi tendenzialmente omogenee per livello cronologico, in una ricerca di indizi significativi circa il tortuoso cammino di quel sentimento dell’in-fanzia che si viene esprimendo lungo tutta l’età moderna. La storia secolare della scuola serve anche per comprendere con chiarezza le
La famiglia in classe›
158 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
dinamiche di quel disciplinamento delle nuove generazioni, che per Ariès è strategia irrinunciabile nell’esperienza formativa, dove scuola e famiglia elaborano alleanze e la famiglia finisce coll’apprendere dalla scuola il modo per rendere “ragionevoli e civili” i costumi dell’infanzia. Per tale approccio, Padri e figli è senz’altro un testo di storia della scuola oltre che di storia della famiglia; ma, pur sem-pre, a Ariès sta soprattutto a cuore l’educazione fuori da schemi istituzionali, il formarsi non scolastico dell’enfant – più tardi anche dell’adolescente –, la sua socializzazione prima e accanto alla scuo-la e non solo nell’ambito domestico. Egli rileva, insomma, quelle dimensioni pedagogiche che Gil ha accantonato e che fanno parte di un passato da ricostruire, non di un presente dove poteri politici e dialettiche istituzionali ledono e ottundono le positività della vita privata. Si tratta, quindi, di orientare sempre di più lo sguardo a ritroso, verso secoli lontani. È questo, della ricostruzione dagli albo-ri dell’apprentissage non scolastico nel mondo protomedievale, lungo l’istituzionalizzarsi dell’acculturazione, fino alla scuola come fenome-no di massa in tempi recenti, il senso complessivo di un suo lungo saggio pubblicato col titolo “Problèmes de l’éducation” (Ariès, 1972: 871-961). Lungo tale periodo millenario, si avverte un progressivo distanziarsi dei giovanissimi e dei giovani dagli adulti fino a quella che egli chiama “l’esplosione scolastica” che, a ondate, caratterizza non solo il sistema di istruzione francese dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta. Il saggio si chiude con un paragrafo dedicato a una classe di età, l’adolescenza, che tra il 1920 e il 1960 popola in misura massiccia l’insegnamento secondario, e, successivamente, quello superiore, perché vi viene mandata da famiglie desiderose di preparare i figli a professioni emergenti in un mercato del lavoro allora fiorente. Anche nella voce “Educazione” dell’Enciclopedia, Ariès prospetta una vicenda millenaria dei fatti educativi extrafamiliari dove, con accentuazioni diverse, resta pur sempre ferma la tesi della potenza dell’acculturazione informale, specie di quella propria delle classi di età, e, successivamente, del gruppo tutelato da adulti esperti. Tra il XV e il XVII secolo, progressivamente, la trasmissione del sapere funzionale alla società accade in un luogo separato, la scuo-la, che diventa «una componente essenziale del divenire politico e sociale» (Ariès, 1978: 256). Contrario alla tesi che la scuola, assunta dai poteri pubblici, sia stata sottratta alla famiglia, egli sostiene che, al contrario «i progressi della scuola sono legati a un rafforzamento simultaneo della famiglia e dei rapporti fra genitori e figli» (Ibid.: 257). Si tratterebbe di una sinergia di competenze fra due agenzie, dove quella scolastica risulta dotata di saperi che la famiglia non ha in misura compiuta, mentre quella parentale – ente tutelante apparentemente privo di didattiche – opera secondo una pedagogia implicita, ma pur sempre efficace e superiore nella promozione della
“Enciclopedia è termine di scuola” 159
ESSAYS – SAGGI
crescita dei non adulti. Questo fatto è sempre più visibile lungo il XIX secolo, quando cessa la diffusione dell’internato e aumenta l’espansione delle istituzioni di istruzione formale. Già alle pp. 329 e sgg. di Padri e figli, Ariès afferma che, alla fine dell’Ottocento, “la fa-miglia si sostituisce alla scuola nel compito di inquadramento morale (e questo nel momento in cui la funzione della scuola diventa sempre più importante sul piano della formazione professionale)”. L’idea si precisa nelle righe conclusive della voce “Educazione”: estinta la vis socializzante della «comunità anonima» in cui vivevano genitori e figli, cui competeva, per lunga tradizione, la socializzazione delle nuove generazioni,
la famiglia contemporanea ha concentrato in sé tutte le funzioni di socializzazione e di educazione assicurate un tempo dalla comunità (o anche dall’apprendistato), e ha chiesto alla scuola di fornirgliene gli strumenti. In questa teoria, la scolarizzazione della società risponde ai nuovi bisogni di una nuova famiglia, e se la sua estensione è stata in effetti favorita dai poteri e dai partiti, essa è stata resa possibile dalla complicità e dalla collaborazione della famiglia (Ibid.: 259).
Una teoria, come egli la chiama, o piuttosto un’ipotesi, che prospetta la scuola in posizione subalterna in una gerarchia di istituzioni del sociale, minor rispetto alla famiglia; funzionale al ri-potenziamento della domesticità, a un suo appropriarsi aggiornato dei perduti strumenti della socializzazione (Ibid: 258).
In tale teoria sembra venir accolta l’esigenza recente della fa-miglia di assumere in proprio competenze educative fondate, forse richiamandosi a un fenomeno di entità non indifferente, proprio dell’ultimo ventennio del XX secolo, vale a dire l’espandersi sia – in area britannica – della letteratura sul parenting, sulla preparazione pedagogica dei genitori, sia soprattutto – in area francofona –, delle écoles des parents, che anche nelle grandi città italiane hanno avuto un certo successo. In tali scuole per grandi, mamme e babbi, nella loro indefessa ricerca di una competenza educativa specifi-ca, frequentavano corsi di istruzione fatti per loro, allo scopo di abilitarsi in un insieme di tecniche di socializzazione da usarsi nella pedagogia domestica nei confronti dei bambini che in nu-mero sempre più ridotto popolavano la casa. La scuola potrebbe essere considerata un laboratorio educativo per piccoli e grandi e dovrebbe reinventare curricola, didattiche, materiali istruzionali, desumerli dall’informale e tradurli in nuove metodologie di educa-zione parentale, controllabili nella loro efficacia, per riconsegnarle, potenziate, alla famiglia. Non credo che Ariés sia stato al corrente di questo fenomeno, ma certamente un tassello forte a una teoria – questo sì – della scuola come agenzia privatizzabile – e privata – del sociale, è rintracciabile nel suo discorso.
160 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
Guardati a più di trent’anni di distanza i testi enciclopedici ci appaiono come i documenti di una stagione ideologica italiana che, messa di fronte alla crisi incipiente dei quadri sociali e cul-turali della democrazia del dopoguerra, prova a indicare una via d’uscita postnazionale in direzione della scienza e dell’Europa. Nella convinzione che la storia culturale del vecchio Continen-te, colta kantianamente, nel suo centro seicentesco e galileiano, fosse in grado di sostenere le esigenze di rinnovamento culturale oggettivamente poste dallo svuotamento della prospettiva nazio-nale. Una prospettiva, va anche detto, che nel caso italiano era ulteriormente gravata da quel sospetto del passato che ha segnato costantemente di sé la vicenda intellettuale del nostro paese dalla fine della seconda guerra mondiale in avanti. La debolezza di que-sta proposta appare nella pretesa di dare per assodato proprio il terreno su cui tutti i nostri autori pensavano di poggiare saldamente i piedi della propria argomentazione, quell’Europa Universitas che negli anni Novanta sarebbe diventata il modello soggiacente delle riforme dell’istruzione secondaria e superiore nel nostro paese. La fine della guerra fredda non restaurava nessun primato europeo e soprattutto occultava un’ulteriore, drastica, riconfigurazione del potere internazionale che avrebbe visto il Vecchio Continente in una posizione di svantaggio. Se la base della rinascita era l’impresa scientifica europea costruita a partire dal XVII secolo e fondamen-to del suo predominio mondiale in età moderna, l’Europa doveva fare i conti con uno scollamento, molto simile tra l’altro a quello vissuto dalle vecchie nazioni, tra prestigio di un passato glorioso e trasferimento attuale dell’iniziativa. Altri erano diventanti infatti i luoghi in cui quell’impresa prosperava e altri sarebbero stati gli scenari decisivi della competizione mondiale. L’inaffidabilità di un simile modello e pure la sua adozione come riferimento nella co-struzione dell’orizzonte di pensabilità dei nuovi sistemi formativi ha generato tensioni fortissime nell’universo scolastico, che si è ten-tato di ricostruire su nuove basi, decisamente non nazionali. Non solo il conflitto latente tra i vecchi codici culturali che lottavano per la loro sopravvivenza e le nuove direzioni della riforma, più spesso della sua rappresentazione ideologica, hanno minato alla base la stabilità del sistema formativo italiano, ma di fatto la scuola degli anni Novanta ha sostanzialmente mancato l’opportunità di ripensare adeguatamente la sua funzione in rapporto alla profon-da modificazione delle strutture sociali e culturali del paese. Da questo punto di vista gli anni Novanta acquisiscono una parados-sale centralità nella vicenda recente del nostro apparato educativo. Sono centrali in quanto esprimono l’occasione mancata di dare a una nuova Italia, post-industriale, nuova nella sua composizione sociale, nei suoi stili di vita e nelle sue rappresentazioni culturali,
Pedagogia della scuola›
“Enciclopedia è termine di scuola” 161
ESSAYS – SAGGI
una adeguata cornice culturale, le basi intellettuali, di preparazio-ne delle nuove generazioni, di formazione professionale di massa, necessarie per affrontare le sfide poste dal mondo altrettanto nuovo sorto a sua volta dalla fine della guerra fredda. Per questo ci pare molto importante considerare la vicenda culturale che si organiz-za attorno alla sistemazione enciclopedica del sapere degli anni Ottanta in rapporto a quello che, a metà del decennio successivo, sarà il primo tentativo (primo di un lungo ciclo più che decennale, conclusosi solo con i primi anni del nuovo secolo) di tradurre quel complesso di questioni in una forma nuova della scuola italiana e in una nuova pedagogia.
Pensiamo, nella serie di testi che circa una nuova idea di scuola sono stati prodotti alla fine dello scorso secolo, non ultimi quelli ufficiali, al più celebre tra di essi, quello composto dall’insieme dei lavori della Commissione istituita negli anni 1996-98 dal Mi-nistro Berlinguer «per individuare le conoscenze fondamentali su cui si baserà l’apprendimento dei giovani nella scuola italiana nei prossimi decenni» (Maragliano, 1997), e al documento che lo ri-assume, opera di Roberto Maragliano, che dell’impresa era stato l’organizzatore principale. Da questa Sintesi dei lavori si evince che i 44 saggi o esperti, appartenenti a aree disciplinari diverse e dotati di professionalità culturali assai differenziate hanno saputo «pensare in generale», non legandosi alle specifiche competenze, tenendo presente che la scuola è l’unica sede del sociale dove si «presentano in forma completa le istituzioni dei vari saperi» (Ibidem). In questa loro opera comune, essi si sono mostrati disponibili a collegamenti e a forme di conoscenze e di cultura trasversali. In tale quadro si è rivisitata la cultura tradizionale trasmessa nelle nostre istituzioni formative, in un’ottica di aggiornato rispetto per la sua storia, ma anche di integrazione con saperi fin qui considerati appartenenti all’extrascuola. Un ideale tutto sommato modernamente pansofico, che la scuola, nei suoi gradi e tipologie, avrebbe dovuto declinare; ma, nello stesso tempo, una concezione generica nel suo spirito di non “lasciar fuori nulla”, rimandando alla scuola il compito – non solo culturale, ma didattico e organizzativo – di farne oggetti di istruzione. E a una scuola solo accennata, quasi fosse una nozione originaria, metastorica e metasociale dello spirito umano.
Scopo della Sintesi era di socializzare la proposta dei saggi, di costituirne oggetto di dibattito. Ma la scuola non sembrava pronta a farlo né le si davano le occasioni, gli strumenti e gli stimoli per affrontare un compito di democratizzazione culturale e – giova ribadirlo – di esemplarità pedagogica per realizzarlo. Fatto si è che poco tempo dopo la pubblicazione della Sintesi, che ha fomentato un dialogo debole e di breve durata, si dava avvio, nel 2000, alla Riforma Berlinguer, che riguardava il riordino dei cicli dell’istruzio-
162 Egle Becchi, Adolfo Scotto di Luzio
ESSAYS – SAGGI
ne; a un’opera di ingegneria istituzionale, quasi immune da tratti di una pedagogia della scuola. Il documento dei 44 saggi convocati dal Ministro Berlinguer, testo per più versi significativo, si colloca quindi, a ben vedere, non all’inizio di una nuova formulazione di un’idea di scuola, ma al termine di una parabola ideologico-culturale cominciata con gli anni Settanta e che trova con il primo ministro dell’istruzione pubblica ex comunista della storia dell’Italia repubblicana anche il suo compimento istituzionale, e la diade di chi insegna e di chi apprende si presenta debole alla vana ricerca di modalità efficaci per ricostituirsi. Una rappresentazione signifi-cativa di cultura scolastica si è infranta – e questo già prima della grande contestazione della fine degli anni Sessanta – sostituita da brani di saperi affatto rapsodici, che si sono variamente espressi nella riorganizzazione strutturale delle istituzioni formative, tra autonomizzazione e inserimento di nuovi soggetti – le famiglie – nella loro gestione; nell’esaltazione acritica dell’interdisciplinarità; nella fiducia ingenua verso le mai ben sgranate scienze dell’edu-cazione; nell’aggiornamento magistrale in didattiche specialistiche; nei tentativi di sperimentare nuove modalità di attivazione della vita scolastica… L’elenco sarebbe lungo – e certamente prima o poi andrebbe seriamente studiato – per ricostruire, commentare, valutare questa storia recente della nostra scuola, fatta di decultu-razione, di perdita di un’enciclopedia, che non risulta ormai più “termine di scuola”.
La consultazione dell’Enciclopedia Einaudi, nelle sue forze e nelle sue debolezze, ci è servita per dare un primo sguardo a que-sta vicenda.
Aries, Ph. (1971[1948]), Histoire des populations françaises et de leurs at-titudes devant la vie depuis le XVIII, Paris: Les Editions du Seuil.
Id. (1972), “Problèmes de l’éducation”, in La France et les Français, sous la direction de Michel François, Paris: Gallimard, Encyclo-pédie de la Plèiade.
Id. (1976[1960]), Padri e figli, Roma-Bari: Laterza.
Id. (1978), “Educazione”, in Enciclopedia, vol. V, Torino: Einaudi.
Betti, R. (1984), “Introduzione”, in Enciclopedia, vol. XVI, Torino: Einaudi.
Braudel, F. (1989), Scritti sulla storia, Milano: Mondadori.
Calvino, I., (1995), Saggi 1945-1985, t. I, a cura di Mario Barenghi, Milano: Mondadori.
Calvino, I., (2002), Una pietra sopra, Milano: Mondadori.
Bibliografia›
“Enciclopedia è termine di scuola” 163
ESSAYS – SAGGI
Gil, F. (1977), “Conoscenza”, in Enciclopedia, vol. III, Torino: Ei-naudi.
Id. (1979), “Insegnamento”, in Enciclopedia, vol. VII, Torino: Ei-naudi.
Id. (1990), Prove. Attraverso la nozione di prova/dimostrazione, Milano: Jaca Book.
Giorello, G. (1986), “La lezione del Seicento”, in J. Jacobelli (a cura di), Dove va la filosofia italiana, Roma-Bari: Laterza.
Giorello, G., Regge, T., & Veca, S. (1993), Europa Universitas, Mila-no: Feltrinelli.
Maragliano, R. (a cura di) (1977), Sintesi dei lavori della Commissione dei 44 Saggi, 13 maggio 1997, in www. fisicamente.net.
Papagno, G. (1979), “Istituzioni”, in Enciclopedia, vol. VII, Torino: Einaudi.
Romano, R. (1982), “Premessa”, in Enciclopedia, vol. XV, Torino: Einaudi.
Salsano, A. (1977), “Enciclopedia”, in Enciclopedia, vol. I, Torino: Einaudi.
Veca, S. (1993), Alcuni dilemmi, in G. Giorello, T. Regge & S. Veca, Europa Universitas, Milano: Feltrinelli.
Zancan, M. (1996), “Le città invisibili”, in A. Asor Rosa (a cura di), Letteratura italiana. Le opere, vol. IV.II Il Novecento. La ricerca letteraria, Torino: Einaudi.