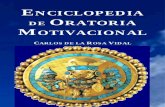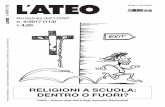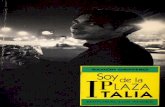Enciclopedia delle religioni in Italia
Transcript of Enciclopedia delle religioni in Italia
CESNURCentro Studi sulle Nuove Religioni
Massimo Introvigne - Pierluigi Zoccatelli
Enciclopediadelle religioni in Italia
Introduzione
II pturalismo religioso itatianoneI contesto postmodernoTcntare l'awentura di una rasseqna di ca-rattere enciclopedico delle religioìi - e delIe v ie :p i r i tua ì i rhe . benche nòn re l ig iose ,nentrano tuttavia in una fenomenolosiar lcc ì i . ì ccos tament i con temporane i a l ia -cro - presenti in ltalia, nell'attuale conresropostmoderno, costituisce insieme una sfidaattascinante e un rischio.ll contesto. infatti.c d i .con t inua mutaz ione de l quadro re l ig io -so . i l
"he rende impo 's ib i le - nonosrdnre
ognl cura - una ttattazlone esaustiva. AÌcu_ni dati cambiano con Íiequenza, letteral-mente, quotidiana. Mentreìiamo fin da oragrati a chi volesse 'egnalarci omissioni e in_tegrazioni, siamo intenzionati a dare contodelle modifiche tramite il sito lnternet delCESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Reli-gioni, che ha ideato e promosso questa ini-zlatrva (www.cesnur.org). Questo lavoronon e un mero agg iornamento de l le nos t reprecedenliedizioni dcll 'Erric loped io dellereligíoni in /rri l ia - pubblicare ;i,perriva_mente nel 2001 e nel 2006 -, su cur pure mbuond parte ' i basa: vuoìc essere piuttostouno 5 t rumento nuovo. che s ia inc lude mol_to nuovo materiale, sia lo dispone in modoparzialmente diverso. lnvitiamo a indiriz-zare a l CESNUR ogn i segna laz ione o r ichresta ( cesnur_ro@virgil io.it ).Lopera. per cosi dire. plrla di per se ste,sa.La sceka d isudd iv iderè i lmate i ia le r run perord ine a lfabet ico. ma prer famiglie spiritua-t r . con ampte rn t roduz ìon i , dovrebbe ren_
dere .il .lavoro_nelle intenzioni degli autorileggib i le - da l l ' in iz io a l ìa f ine - e 'non soloutile come testo di riferimento. Non vo-gliamo tuttavia rinunciare ad alcune consr-derazioni di fondo sul momento storico esul contesto in cui awiene la sua pubblica-zione,.né sul significato di alcuni dei datiemersl.ll beato Giovanni Paolo II (1920-2005),nell'enciclica Flrles et ratio del lggg - un te-sto tante volte richiamato dal suo succes-sore Benedetto XVI -, aln. 9l rilevava: <Lanostra epoca è stata qualificata da certipensatori come l'epoca della "post-moder-nità". Questo termine, utilizzaio non di ra-do in contesti fra loro molto distanti, desi-gna l'emergere di un insieme di fattorinuovi, che quanto a estensione ed efficacias i sono r ive lat i capaci d idererminare cam-biament i s ign i f icat iv i e du revol i , . . ln par t i_colare, nel quadro di tali ocambiamenti>, sisarebbero manifestate <reazioni che hannoportato a una radicale rimessa in questio_ne) della <pretesa razionalista> tipica dellamodernità. fencichca Fides et ratio - dopoavere sottolineato la necessità che l,uomoutilizzi entrambe le sue <ali,',la fede e la ra-gion_e. per rispondere alle domande crucia-l r su l la sud or ig ine e su l suo dest ino _ de_scrrve una lunga stagione, in iz ia ta con lacr is i de l Medìòevo, in cu i Ia ragione hadapprima cercato d'inglobare la fe-de, qu in-di ha preteso di farne a meno, infine l,hacombattuta-in_ modo esplicito; dalla ragro-ne senzala fed,e alla ragìone contro la féde.Benedetto X\4 adotta ló stesso schema nel-
LE RELIGIONI IN ITAIIA
I'enciclica Spe salvi del 2007. Ma nell'epocapostrnoderna si ripresenta - peraltro nonper la prima volta - anche la possibilità diun rovesciamento di questo scenario. Le-poca della crisi della ràgione è il tempo incui si ripresenta una fede - non necessaria-mente cristiana - talora separata, a diversotitolo e in diverso grado, dàlla rasione.Cattolici e non cattolici potrann; rrovarsld'accordo con il beato Giovanni Paolo IInel constatare che, in effetti, con il passag-gio all 'epoca cosiddeIa poslmoderna sr so-no determ inati .cambiamenli sisnificativie durevolfr anche nel settore dellàreligiosi-tà. Sarebbe sufficiente una rapida scoisa aititoli dei Iibri.piùr diffusi, degii.articoli piùsrgn rflcauvt, ol numerose lelazton I presen-tate in congressi di socioloeia o di storiadelle religio=ni per accorgersi che qualcosaè veramente cambiato. Neeli anni 1970 - enella prima parte degli an;i 1980 - il temadominante era quello della crisi della reli-gione. La tesi deila secolarizzazione, nellasua versione quantitatiya, postulava che,mentre progr€diva la mentalità scientifica,nelle società industriali avanzate c'cra sem-pre meno religione; non mancava chi pro-spettava come futuro evolutivo della reli-gione addirittura I'estinzione. Uno stru-mento interpretativo importante rimane-va in quegli anni l'opera del teologo batti-sta americano Harvey G. Cox The SecularCi4, (Macmillan, New York 1965; trad. it.,La città semlare,Yallecchi, Firenze 1968), incui - come lo stesso Cox ha scritto Diir re-centemente - il teologo di Harvard iercavadi elaborare una teoógia per I'epoca "po-streliqiosa^ il cui awen-to òolti rit.n.uunolmmrnente. Le cose, oggr, sono certamentecambiate. Testi importanti fanno riferi-mento al <ritorno del religioso>, alla <ri-vincita di Dio) o alla <fine> della secolariz-zazione, Lo stesso Cox- a trent'anni da lacittà secolare - scriveva nel 1995 in Firefrom Heaven. The Rise of Penteconal Spiri-tuqlity and the Reshaping of Relipion ii theTwen t y- F i r st Certaiy { Addiso"n-Wesley,Reading [Massachusettsl 1995) che.<oggi èla secolarrta lseculariry), non la spirituaìità,che può essere vicina all'estinzione>, e che èdiventato <ovvio che al posto della "mortedi Dio" che alcuni teologi avevano dichia-
4
rato non molti anni fa, o del declino dellareligione che i sociologi ave\,?no previsto, èawenuto qualcosa di veramente dverso>.A proposito d.e.La città secolara il teologoamerrcano aggrungeva: (torse ero troppogiovane e impressionabile quando gli acca-demici facevano queste previsioni tristi. lnogni caso le avevo assorbite dawero troppofacilmente, e avevo cercato di pensare qua-li avrebbero potuto essere li loro conse-guenze teologiche. Ma ora è diventato chia-ro che le predizioni stesse erano sbagliate.Chi le faceva [...] ammetteva che la fede sa,rebbe potuta soprawivere come un'ereditaculturale, forse in ridotti etnici o abitudinidi famiglia, ma insisteva che i giorni dellareligione come forza capace di dare formaaìla cuìtura e alla storia erano finiti. Tuttoquesto non è accaduto. AJ contrario, prìmache i futurolosi accademici facessero rntempo a ritiraie la loro prima pensione,una rinascita religiosa - di un certo tipo -ha cominciato a"manifestarsi in tutio ilmondo> (ibld., p. XVI).Celebrando, ulteriormente, i quindici annidalla pubblicazione di Fire from Heaven,lostesso Cox scriveva nel 2011 - in risoosta aun saqqio su quel suo volume del professo-re di tàologiii,,timi Wariboko liFire fromHealreni Penfecostals in the Secular Ciw>.Pneuma: The Journal of the Society for Pen-tecostal Studies, vol. 33', n. 3, 20ll', ip. 391 -408), dove si sosteneva che la secóìàrizza-zione è semmai awenuta all'interno dellereligioni, compreso quel pentecostalismoche era il punto di riferimento del libro diCox - ché la sua visione oggi è piuttostoquella di una <cosmopol dove coesistonoforme diverse di secolarizzazione, di mo-dernità, di ritorno del relisioso che vivonoinsieme e si alternano in quella che il teolo-go definisce non una sinfonia ma una sedu-ta di jazz, che unon si basa su uno spartito,',nnon ha un conduttore che la suida con lasua bacchena, e dove ciascunJimprowisasulla base di come hanno appena improwi-sato altri (H. Cox, <Response to ProfessorNimi Wariboko>, ibid., pp. aO9 - alQ,Naturalmente, chi ritiene che oggi - nell'e-poca postmoderna - sia la secolarizzazio-ne a essere <vicina all'estinzione> fa riferi-mento a una nozione meramente auanli-
, Jella\ l i to, è. I S O r .
.(ìlogo:roPPo. l Jcca-r \ r i . I n:roPPo'!'qua-;onse--r chra-reliate.:ile sa-:rcditàt ud in ii t le l Ìato rmaTutto
pr imarro ins ione,Il l ìortto i l
I J n n lr . ' r t , lO(ìsta atèsso: liomCitv,r,. Petr. , r 9 t -rtzza-, delleI i smorro dittostostonoi mo-i rono:eolo-
'trtO),
.on lar\t-lsa'o\-vl-
( 'sSOI
elÌ 'e-Jzio-itèri-Lrtlti-
tatfuadr secolarrzzazione. Se invece si pen-sa alla secolarizzazione - secondo la defini-zione di Bryan Wilson (1926-2004) - comea un processo prevalentemer]fe qualitatiyo,in cui la religione - pur continuando a in-teressare molte persone - non determinapiìr la gran parte delle scelte culturali, poli-tiche e sociali, si può concludere che la se-colarizzazione è ancora saldamente fra noi.Tn queslo senso, ii giurista americano Ste-phen L. Car ter 1nàì suo importante Ty ' reCuhure of Disbelief. How Ameríran Law andPol it ic s Triv iali ze Rel igiou, Devot io n, BasicBooks, New York 1993) parla di <trivializ-zazione> di una religionè che pure nel suoPaese continua a essere importante, a livel-lo individuale, per la maggioranza dellepersone. La secolarizzazione quantitativa,definita semplicemente comè l'interessesempre minore delle persone per la sferadel reìigioso e del sacio, appaie effettiva-menle in decl ino nel l 'epocà postmoderna.ln alcuni Paesi del mondo i sòcioloei dubi-tano perfino che un processo quanlitativodi secolarizzazione sf sia mai vàrificato. lnaltri, vi è stata un'inversione di tendenza apartire dalla seconda metà degli anni 1980.Uno dei_piu nor i specia l is t i d i indagin i so-ciologiche quantitative in tema di ieligio-ne. Laurence R. Iannaccone, scr iveva-nelset tembre 1998 che i dat i mostrano ormaicon evidenza come la tesi secondo cui <lareligione deve inevitabilmente declinarequando la scienza e la tecnoloqia avanza-no> è stata <dimostrata falso, ethe <a ma-no a mano che isondaggi , le s tat is t iche e iddt i s tor ic i s i sono accumulat i , la cont inuavitalità della religione è diventata eviden-te) (<Introduction to the Economics ofRe-Irgion> , Journal of Economic Literature,vol.XXXV I fsct tembre lq98l , pp. t465- j496lp. 1468ì) . Menlre i l n umèro del le personeche si dichiarano atee e agnostiche non au-menta in modo s igni f icat ivo, in quasi tu t t ii Paesi del mondo - con I'eccezióne di al-cuni Paesi europei a fungo sottoposti a pro-paganda antireiìgiosa diparte di regimico-munisti - i l numìro di coìoro che dlchiara -no di credere in_una qualche forma di po-tere superiore alla persona umana, o a unavita dopo la morte, o affermano di consa-crare qualche tempo durante la settimana a
forme di preghiera o di meditazione, si at-les ld in lorno a l l 'o t tanta per cen to del ìa po-polaz ione, con Duntc in Paesi nou s((on.dari - Stati Uniti compresi - oltre il novan-ta per cento.Il fenomeno del <ritorno del relisioso) èdunque così evidente da non poreie essereignorato. Si tratta però di determinare, conmaggiore precisione, qaaletipo di religiosonritorni> nell'epoca póstmoderna. Ne,-l suovoltme Fire t'ròm Hiaven, Cox mefteva aIcentro della sua indagine e considerava c<.r-me il maggiore ..segno dei tempi" per il ri-rorno cet retfgloso, ta correnle pentecostd_le-carismatica nel cristianesimo, e conside-rava quindi caratteristiche salienti del nuo-vo dccostamento aÌ sacro I'interesse per isegni, i m iracoli. le guarigioni, la demono-Iogia, I'escatologia, ia finÉ del mondo. An-che presc indendo dal l ' indaeine d i Cox -che riguarda esclusivamentJil cristianesi-mo - si nota il crescente interesse Der formedi rapporto con il sacro dove il'percorsoprevale s u,l discorso , iI mythos sul logos, frnoa queìle " fedi senza ragione" paveniare nel-la ltdes et ratlo-Diversi sociologi invitano del resto, quan-do si. t ratta_del iac ro poslmodernu, a par-t r re da un dato d i cdrat tere nesal ivo: dal lafine degli anni 1980, il consenio dr massanei confronti della scienza - particolar-mente della medicina, la scienza <pratica>con cu,i le persone comuni vengóno piunormdtmente a contd l lo - non e p iu una-n ime. A par t i re dagl i u l t imi anni del de-cennio 1980, in diversi Paesi, il consensopopolare nei conlionti della scienza e del-la medicina scende a quelli che sono pro-babilmente i l ivelli piu bassi del secolò se-condo.g l i inquìetant i dat i propost i , peresempio. nel l ' indagine Í iancese d i Danie lBoy e Guy Michela t tìn La pensée scientilì-que et les parasciences, Albin Michel - Citédes sciences et de l'industrie, Parigi 1993).Per converso, qualunque forma-di curamedica che si piesenti iome (alternativa>rispetto alla medicina <ufficiale>, o da que-sta disapprovata, incontra immediàta-mente un vasto consenso popolare. Sem-bra dar-vero che il termomìtio scientificoscenda e che salga il termometro del sacro,in direzione però sempre più spesso di for-
L! REL]GIONI IN ÌTALIA
me di sacro aperte al meraviglioso e al <rein-canto del mondo>.Per comprendere chi veramente beneficiadel contemporaneo ritorno del sacro oc-corre superare - forse, ora, con I'aiuto diquesta dcerca- alcuni pregiudizi tanto dif-fusi quanto infondati. Anzitutto, non è deltutto vero che il ritorno del sacro si verifi-chi completamente al di fuori delle religionimaggioritarie e delle Chiese storiche. Cer-to, mentre le statistiche sul numero di per-sone che si dicono interessate alla religioneo al sacro sono notevolmente simili da Pae-se a Paese, le statistiche sul numero dei pra-ticanti sono molto diverse. Tuttavia, esisto-no elementi per ritenere che il declino del-la pratica relìgiosa in Occidenle sid stato inquaìche modo soprawalutato. e che si siadiffi.rso un <mito della chiesa vuota>, comelo chiamava già nel 1993 Robin Gill (TheMyth of the Empty Church, SPCK,Lond,ra1993). Benché le statistiche sul numero deipraticanti siano molto controverse, in al-cuni Paesi * fra cui l'Italia - molti studiosihanno notato almeno una certa tenuta. Lechiese non sono certamente piene, Ma nonsono sempre e dovunque vuote.All'interno delle religioni tradizionali, e del-lo stesso cristianesimo, vi sono poi movimenti i cui ritmi di crescita non hanno nul-la da invidiare a gruppi neo-religiosi. Dopol'11 settembre 2001, una certa <magia del-l ' l I set tembre ' sp inge mol t i credent i - eanche alcuni non credenti- a riscoprire l'e-redità cristiana. Prescindendo dai lenomenicomplessi che ar'wengono all'interno del-l'Islam, dell'induismo e dell'ebraismo - ta-lora accomunati dall'etichetta, non sempreprecisa, di <fondamentalismi>> - si può no-tare, con Harvey Cox, che i movimenti dirinnovamento carismatico alf interno dellaChiesa cattolica e le comunità pentecostalinel mondo protestante contano nel nondoqtalche centinaio di milioni di fedeli e pos-sono vantare r i tmi d i cresc i ta super ior i aquelli, spesso citati come spettacolari, deimormoni o dei Tèstirnoni di Geova. Non ri-mane peraltro meno vero che, per quantoquesti [enomeni siano inleressantie impor-tanti, unaparte di rilievo del ritorno del sa-cro va cercata al di fuori delle grandi reli-gioni e delle Chiese storiche.
6
Nell'ultimo suo articolo che abbiamo cita-to, Cox rileva come il dibattito sulla secola-rizzazione sia stato cambiato dall'impattopressoché mondiale del volume del 2007del filosofo cattolico canadese Charles Tay-lor L etii secolare (trad. it., Feltrinelli, Mila-no 2009). Anche Taylor distingue fta un li-ve l lo d i secolar izzazione qual i ta l iva - laprogressiva e per lui irreversibile (in Occi-dente) separazione fra Chiesa e Stato - euno di seèolarizzazione quantitativa, a suavolta articolato sul piano delle credenze - chenon accennano a venire meno anche nellasocieta moderna e postmoderna - e suquello della pratica religiosa, che il filosofocanadese vede invece, almeno nella mag-gioranza dei Paesi occidentali, in declino,seppure non univoco e non lineare, Ma perTaylor la verità della tesi della secolarizza-z ione - ancora, a lmeno in Occidente. s tain un terzo livello, cuello delle <condizionidel credere, . Mentre un tempo l 'opz ioneper così dire di deÉulrper un giovane cheiniziava la sua vita adulta era auella d'in-serirsi in un contesto di relisionè e di Chie-sa e di considerare questo cónlesto impor-tante, oggi l'opzion e di àefaub è la lonta-nanza dal la re l ig ione is t ì tuz ionaìe, cu j c i s ipuò certamente riawicinare ma agendo incontrotendenza rispetto all'ambiente so-ciale. Cox discute le conclusioni di Taylorosservando che il suo principale punto diriferimento. come rischia soesso di aweni-re quando si parla di secolàrizzazione, so-no le Chiese e comunità cristiane storiche.con una cefia sottovalutazione per esem-pio del mondo pentecostale. E a Taylor so-no state rivolte diverse altre critiche, alcu-ne delle quali raccolte - con una rispostadello stesso Taylor - in un volume pubbli-cato nel 2010 e curato da Michael Warner,Jonathan VanAntwerpen e Craig Calhoun(Varieties of Secularism in a Secular Age,Harvard University Press, CambridgelMassachusetts] - Londra 2010). L'etii se-cokîe rrmane un testo estremamente in-fluente su tutto il dibattito sulla presenzadelle religioni nel mondo moderno e post-moderno. Ma le discussioni invitano aconsiderare che esistono forme di secola-rizzazione diverse, in contesti nazionali di-versi - si veda la tesi del socioloso Franco
Garelli su un,ci occuperenpre rivoÌgerenl e al mo\'[dizionali.Un altro elente mitologiccrà forse a m;quelìo relatidelle sette". (qualche modl. Gordon \frme anche n(tracciare un:tra uvecchie.za, Per raglorto di "setta ",presta facilmscriminatoriuna certa coll 'ottava edizipedia ot .\nu1009 ) . In ungioso è piu r
" nuove" SOnnumero dr almane pluttole statistichemente, sr F)rle religioni .rt i religiosi -.Paesi dell ' .\tsono possibistatistico rel:l igiosi" a secrn quesla calstanti di t iposta indipend,rebbe comurse uti l izzarementi religicnemente lamondo protmentalista inormalmenlmeno dell 'u\folte sigle, tsta culturalenumero minche d i una .vrebbe parlagle'..{Ìtro è
a > ta to - e.ì: i\ 'a. a sual('nze - chernihe nellan . ì - e s ut i l tììosofont' l l l magrn dec l ino ,r r. ' . \ la perea(rrdrlZZa-ú.nte - sta.ond iz ion i' lo i - .z ioner . ' ' , rne cher!.11.ì d' in-c t tì i Chie-\to ìrnPoI-a i.t lonta-
.!:.. .ui ci sir .rgcndo inlb r r 'n te so-:r Jr Ta,vlorit ' Punto di'' Ji an-eni-.ì,/LOne, sorc itoriche,
l '( 'r esem-r l.rr lor so-t r .hc . a lcu-nl nslrostam. Pubbli-.rcì \\arner,rr (-alhounr -a: t l t l r Age'
t ì rmbr idgeì . l c r d s s -Jmcnte in -i.r p.resenzalrnrl e Post-in i i l i rno a
.' di secola-.rzionali di-(ì{t l Franco
Garelli su una <religione all'italianao, di cuici occuneremo oltre -, e che occorre sem-pre rivólgere lo sguardo anche alle religio-ni e ai rrovimenti <emergentr> o non tra-dizionali.Un a l t ro e lcmento d i carat tere amPidmen-te mitologico, che questa ricerca contribui-rà forse Jmandare in pensione, è peraltroquello relativo alla cosiddetta <.invaslonedel le set te- . Cer lo , i moviment i re l ig ios i inqualche modo a l ternat iv i sono mol t iss imi .J. Gordon Melton - che peraltro rifiuta, co-me anche noi facciamo in questa sede, ditracciare una linea di demarcazione nettafra <vecchie> e <nuove> religioni, né utiliz-za, per ragioni su cuì torneremo, i lconcet-to di .setia^. che e ambiguo. impreciso e sipres la f . ìc i lmente d un uso valutat ivo e d i -'c r iminator io - ne rubr i<a o l t re 2.300 d iuna certa consistenza negli Stati Uniti nel-l'ottava edizione della sua Melton\ Encyclo-pedia ol AmeriLon Re/rgions 1Cale. Detroit)66o7.
- ln un Paesc dove i l p lura l ismo re l i -
gioso è piìr recente, come l'Italia, le sigle(nuove> sono comunque numerose. Ma ilnumero di aderenti a questi movimenti ri-ma ne p iut tosto contenuto. Ndtura lmentele s la t is t iche d ipendono da dove, esat ta-mente, si pone la linea di demarcazione frale reì ig ion i -s tor iche" e i "nuovi movimenti reliÀiosir>. In America Latina e in alcuniPaesi ie l l 'A f r ica e del l 'As ia, per esempio.sono possibili.enormi variazioni del datostatistico relativo ai <nuovi movimenti re-ligiosi', a seconda dell'inclusione o meno,in questa categoria, delle comunità prote-staiti di tipo pintecostale o fondamèntali-sta indipendente. Da questa ricerca risulte-rebbe comunque confermato - se si voles-se ut i l izzare la ca legor ia d i -nuovi mor i -menti reliqiosi>' nel senso in cui piii comu-nemente ia si usa, che no, comprende ilmondo protestante pentecostale e fonda-mentalista indipendente - che le realtànormalmente così et ichet tate r ìun isconomeno dell'uno per cento degli italianiMolte sigle, talora rilevanti dal punto di vi-sta culturale e tipologico, hanno però unnumero minuscolo di aderenti così che, piiiche di una <invasione delle sette), si do-vrebbe parlare di una <invasione delle si-gle>. Altro è il discorso sulle minoranze re-
INTRODUZIONE
ligiose, cioè, in Italia, sulle religioni diversedàlla cattolica. Complessivamente, chi avràmodo di consultare la presente enciclope-dia vi troverà esposte 836 minoranze reli-*iose e spiritualfpresenLi in mdniera orga-i izzata nel nostro Paese; nel la pr ima edi -zione, pubblicata nel 2001, erano 658.Questa ricerca saluta e congeda anche il da-to - molte volte ripetuto, ma che almenodaqli anni 1980 non è mai stato vero - se-coido cui le minoranze religiose in Italiarappresentano globalmente solo I'uno percenio della popólazione. Anche se in molticasi le statiitièhe sono difficili, i totali diouesta ricerca relativi a quanti chiaramen-tè manifestano un'identità religiosa diver-sa dalla cattolica in Italia sono di circa1.417.000 uni tà se . i prendono in esame icittadini italiani, e di circa 4.635.400 unità5e s idSgiungono Sl i immigrat ì non c i l ladì -n i . i l che ha r i ì ievo pr inc ipalmente Per i lmondo islamico e secondariamente perun'imrnigrazione cristiano-ortodossa dal-l 'Est euròpeo dì proporzioni notevoli' maanche - per esempiò - per l ' ìnduismo. i lbuddhismo. le reìigioni sl kì e radhasoami,un robusto protestantesimo pentecostale ebattista di oìigine cinese, coreana, filippi-na e africana, o f immigrazione copta pro-veniente da diversi Paesi dell'Africa.Anche fra i cittadini - un dato che includecuanti hanno acquisito la cittadinanza, conuna media che nel set tennio 2005-2011 s iawicina alle 50.000 unità annue -, siarno auna percenluale sul totale della popolazio-ne--fissata a 60.820.764 residentisecondo ipiii recenti dati delbilancio demografico re-si notinel2012 dall'Istituto nazionale di sta-tistica, dei quali gli stranieri sono 4.859.000,pari al 8,00/o (un'incidenza suPeriore allamedia dell'Unione Europea, pari al6,670) -che si attestaal2,5%, più del doppio del mi-tico uno per cento pitl volte infondatamen-te menziónato. Se ii considerano i residentisul territorio la percentuale di aPpartenentia minoranze religiose sale intorno al 7,60ó.PresenL iamo queste conclus ioni insìemesenza trarne aliuna specifica conseguenza dicarattere generale - il che andrebbe ben oltrei compiti di questo nostto lavoro - e consa-pevoli del fatto che documentare il plurali-imo è un gesto a suo modo <politico>.
LÈ RLI IGIONI ÌN ITALÌA
Nel dettaglio e con le precisazìoni che se-guiranno - la composizione del 2,5% dicittadini italiani che appartengono a mrno-ranze religiose è la seguente:
Tob. 1 Minoranze religiose fra i cittadiniitaLiani (stímd CESNUR 2012)
Molte di queste cifre necessitano di unaspleSazlone.. Per gli ebrei, i l dato dei membri dell 'U-
nione delle Comunità Ebraiche Italiane èstato corretto aggiungendo i (non molti)membri di realtà di origine ebraica chenon s'identif icano con tale Unione.
. Per cattolici <di frangia e dissidenti> in-tendiamo i membri di tutti quei movr-menti non in piena comunione con laChiesa cattolica o in situazione oggetti-vamente marginale, come meglio spiega-lo e de f in i to ne l tes to . e non i ro l i Srupp id ich ia ra tamente ' c i 'ma l i i i . Come ' i vcdrà, si tratta di un mondo normalmentesommerso, ma tutt'altro che irrilevante,su cui questa ricerca ha l 'ambizione di
8
gettare una luce nuova; la stima di 25.000persone coinvolte 10.000 nella solaAs-sociazione La Missione Luigia Paparel-li- dev'essere intesa come conservatlce etiene conto del fatto che molte di questepersone si considerano comunque sogo é t t i v ) n é n f a , ) f r ^ l ; . h é
Gli ortodossi in Italia sono ben oltre i lmil ione - particolarmente per l ' immrgrazione dalla Romania, che nel2012 haraggiunto una quota di 997.000 unità,owcro i l 20 ,50" de l l in te ra immigraz io -ne in ltalia - ma rolo in minoranza cittJ-dini italiani.Quanto ai protestanti, ci si dovrà riferirealle ricostruzioni ciìpitolo per capitolo, esi tratta di un terreno per molti versi con-troverso. Le nostre valutazioni si rifletto-no - sempre in tema di cittadini italiani,owero ancl.re di quella fetta, partìcolar-mente pentecostale, che ha acquisito lacittadinanza italiana - nelìa tabella se-guente;
Tab. 2 - Diy ribuzion? úci pro!es!anticittadini italiani (stima CESNUR 2012)
Pf otestanti (storici), 65.000 11,90/a
Movimento di Restaurazione 5.000 1,14/o
Movimento dei FrateÌli )1.000 4,64/0
Chiese Ìibere (non pentecostaìi),holiness 9.000 2 ,10u
Pentecostali 313.00072,nha
AvveDtisti 20.000 1,6tla
{tfi 2.000 0,5%Totale 415.000100,0lo
Per le definizioni, ci si riferirà alle vartesezioni della ricerca. I l dato penlecosta-le - che emerge immediatamente come ilpiir rilevante all'interno del protestante-simo italiano - è composto da 150.000fedeli delle Assemblee di Dio in Italia e daloJ .000 fcde l id ia ì t r i g rupp i . l l da lo leg-germente inferiore spesso citato normal-mente non comprende il mondo discretoe poco noto dei pentecostali <ztrccardia-ni> e <petrell iani>, su cui si troverannoqui diversi dati inediti, e talora non con-sidera pentecostali movimenti che sono
EbLei 36.000Cattol ici di i r ;ngi;r ' e d sidenti 25.000 1,84/o
Ortodossi It0.000 7,84,ó
Pfot€stanti 435.000 34,70k
lèstimoni di Geova (eassimiliìti) 4Ì5.000 2e,10ó
l\4orrnoni (easrin Lt i) 25,000 1,80/a
Aìtrigmppi di orìgìne cristima 5.000 4,40,t
Musulnani ÌÌ5.000 8,10/ò
Bahi'i e altri gruppidimatrice islamica 4.000 0,34o
lnduisti," neo induisti 26.000 1,84a
Buddhisti 11s.000 9,54/o
Crut pidr Osho e derl,at i 4.000 0,3%Sikh, radhasoami e derivazioni 6.000 0,44a
\ l t r igruppi di, ,r iqi re oriertale 2,000 0,14/o
Nuove reliqioni giapponesi 3.000 0,2%,{rea e$tericaedella ranticasapienar 15.000 l,1a/o
l\,f or'ìmenti deì potenziale umlno 30.000 2,100
NIo\.inenti or!arizzrtiNelv Age e Next Age 20.000 I,40,t
Altri 6.000 4,10/o
Totale 1.417.000I00,0ao
r srima di 25.000C0 nr'lla sola As-Luiria Paparel-
i consen.atrice emolre di queste;omunque sog-
rno ben oltre ilìle per l ' immi-che neÌ 2012 ha99;.000 unità,ra rmmigrazio-rinoranza citta-
si dovrà riferirer per capitolo, emolti versi con-rioni si rifletto-nadini italiani,'ita, particolar-ha acquisito laclla tabella se-
,îote:tantícsxL'R 2012)
ó:.1-r,[ì 14,90k
5. r4 1,14/o
:. t10 4,8q0
v . , { l 2,1%
, l l , l . ' f l 72,00k
4,60,4j . , , r j 0,5a,ó
{r5.000I00,0ok
:rirà alle varieo pentecosta-mente come ilfl protestante-to da 150.000o in Italia e dapi. I l dato leg-itato normal-ondo discreto.i "zaccaldia-
si trorerannolora non con-rnti che sono
nati nel mondo pentecostale latino-ame-ricano e che oggi hanno membri anchetra i cittadini italiani. Anche il dato delleChiese .storiche" - valdesi, luterani, ri-formati, calvinisti, battisti, metodisti - de-v'essere a nostro awiso leggermente riva-lutato rispetto a staListiche corren ti, men-tre per gli awentisti abbiamo indicato inembri reputati <attivi>r.
. Sulla difficoltà di calcolare il numero deiTestimoni di Geova - comuncue certa-mente Ia maggiore reallà, organizzata inmodo unttariopîesente nel Paese dopo laChiesa cattolica - si troveranno elementinelìa scheda relativa; in ogni caso. consi-derare "Tèst imoni d i Geova" iso l inoro-cf amatori " sarebbe gravemente ridutiivo,e abbiamo ponderato un dato legger-mente.inferiore a queìlo dei partecipàntiannual l a l la commemorazione del la Ce_na del Signore - cui partecipano ancheslmpattzzantt -, tenendo conto nel con-tempo della presenza in Italia anche di al-tri piccoli gruppi diversi dai Testimoni diGeova, che derivano dallo stesso filonedegli Studenti Biblici.
. Nel computo dei mormoni abbiamoconsiderato non solo la Chiesa di GesìrCristo dei Santi degli Ultimi Giornr, maanche i membri - statisticamente assaiinferiori - afferenti a comunità rn unacerta misura appartenenti al medesimoramo genealogico.
. Cl i . ,a l l r i_gruppi d i or ig ine cr isr iana"comprendono i membri di una certa va-rietà di movimenti fra loro eterosenei -dalla Christian Science a The Fariilv e aVita Universale -, tutti normalmenie dipiccole dimensioni, ma con eccezioni si-gnificative, come la Chiesa Neo-Aposto-lica, che supera i2.000 ledeli.
. La stima dei musulmani cittadini italianiin | 15.000 è soggerta a rapide variazionituture nel caso di più rapido accesso allacittadinanza di musulmani immisrati:oggi appare ragionevole, forse peisinogenerosa, sia perché i musulman i "etnici',che hanno acquisito la cittadinanza nonsono molti - pur dovendosi tenere contodi musulmani venuti da ex-colonie ita-liane già in anni lontani -, sia perché ildato dei convertiti, per ragioni óeglio il-
I NTRODUZIONE
lustrate nel relativo capitolo, è normal-mente sovrastrmato.
. Distinti dai musulmani - ancorché natiin ambiente islamico -vanno certamen-le tenuti i.Bahd'í, cui si aggiungono altreromazlonl plu Drccole.
. Agli induisii adbiamo aggiunto iseguacidei numerosi movimenti neo-induistipresenti in ltalia, senza che il confine frale due categorie sia veramente suscettibi-le di essere tracciato; essi, come si vedra,sono veramente molti, e non tutti picco-lissimi: fra le piir grandi realtà, con oltre2.000 membri ciascuna, ricordiamo l'Or-ganizzazione Sathya Sai Baba e i menoconosciuti Amici di Amma. Nell'area in-duista non abbiamo, per scelta, inclusotalune realta, come i seguaci di Osho Raj-n9:Lh, un maesho - comunque si giudi-chi il suo rapporto con il giainismoìn cuiera nato - certamente non <induista).
.Il dato buddhista (135.000 praticanti)tiene conto di 61.000 fedeli dell'area con-cettualmente rappresentata dall'UnioneBuddhista Italianà- theravada, zcn e val-rayana: peraltro non tutti fanno parte àicentri U.B.i. -, 63.000 membri della SokaGakkai, 11.000 buddhisti di altre tradi-zioni (la stessa area Nichiren non si ridu-ce alla sola Soka Gakkai). fincrementodi quest'area, e in particolare della SokaGaRai, è il dato pii: significarivo di que-sto primo scorcio di-secolo )fiÌ sè siescludono i fenomeni relativiasli immi-srati.
. Tra i sikh, radhasoami ne derivazioni"abbiamo incluso i numerosi piccoli grup-pi ispirati al maestro di orieine sikh-BabaBedi XVI: il risultato finalé in termini dicittadini italiani rimane modesto.
. Gli .altri gruppi di origine orientalencomprendono i pochi zoroastriani e quel-li cinesi e indoiinesi, quando in essì siapossrb e scorgere una vera pratica religio_sa e non semplicemente I'uso di tecnicheorientali a fini terapeutici o di altra natura.
. Il dato delle nuove religioni giapponesr(3.000 iedeli) - intese óme iormazionigiapponesidiorigine recente e non bud-dhisra - deriva per la melà I t.500 fedeli)da Súkyó Mahiliari, benché siano presen-ti come si vedrà altre siele.
tadini italitre la possmigraztordrverse adi unità -,cile. Neglìpunto di rrapporto isti dati sorassume ccstranieril 'anno pr<sofferen:ftattemP(che nel codall'ester<categonetonomr,ecc. -, co2012 pe5.011.30t2012. X,ldos, Rorin questoI dati Caun PuntchiunquItalia, m.ti sull'iPrrelta quaaPPalonrtutto dai- che glila stessaorigine..e datt chcristian€ti di <mtfezzali>valutan(nere>. Cdati sulsuoi cittCaritas/ni iì 99ozza conslirrilevalno conlrilevantnuto akveIlIa,tas/Mi8
IE RELIGIONI IN ]TALI,{
. Diversi capitoli trattano di movimentiche occupano la vasta area che specialistiamer icani ch iamano deì l - ,ant ica sapien-za> (ancient wisdom), sigla comoda peridentificare realtà diverse nel mondo del-1a ricerca delle tradizioni arcaiche, dell'e-soterismo e talora dell'occ ult ismo, cui siaggiungono i movimenti ispirati allo spi-ritismo o ai dischi volanti. I 15.000 ade-renl icompless iv i non sono mol t ìss imi , afronte del proliferare di sigle, di cui peròpoche - la Società Tèosofica ltaliana, l'As-sociazione Antroposofica, I'AMORC, ilLectorium Rosicrucianum, aÌcuni gruppignostici ispirati all'esoterista colombia-no Samael Aun Weor, forse in futuro iGruppi di Pratica di Tènsegrità di CarlosCastaneda o la Religione Raeliana - su-perano, raggiungono o, considerati i tas-si di crescita, possono aspirare a raggiun-gere i mille membri. dato complessivorisulta dalla somma seguente;
Tab.3 - Area esoterica e della -antírasapienza>) (stima CESNUR 2012)
dicare che i dati comprendono i solimembri di associazioni o realtà formal-mente costituite, certamente non tutticoloro - numerosi, specialmente fra igìovani - che si danno a pratiche spiriti-che o a un satanismo .fai da le" o "sel-vaggio", e questo - beninteso - senzaconlondere spiritismo e satanismo, real-tà assolutamènte non analoghe e quiaccomunate solo dal fatto di avere prati-canti giovanili (spontanei> accanto aquelli che fanno parte diorganizzazìoni.
. Assai delicati sono i discorsi rruantitativiin tema di movimenti del potenziale uma-no e di NewAge.e Next Age.perché qui,quasr per oennzrone, non cl sono vera-mente <membri" in un senso paragonabi-le a quello in cui il termine è usato, peresempio, per una Chiesa, masolo parteci-panti a varie attività, <clienti>, <Íiuitor .Certamente coloro che partecipano occa-sionalmente a corsi, seminari, convegni diqueste aree sono numerosi, Mentre in pre-cedenti edizioni di questa ricerca avevamoproposto una ciframolto superiore, riferi-ta aipartecipanti regolarì e continuativi.ora - in armonia con le Diii recenti dcer-che straniere - riteniamó didorere circo-scrivere la ciÍÌa soltanto a coloro che vivo-no la loro partecipazione a questi gruppicome una vera e propria identità religiosa,alternativa a ogni altra, stimando così i ve-ri e propri <membri di minoranze religio-se> - distinti dai semDlici. e certamente as-sai più numerosi, simpatizzanti - in cir-ca 3b.000 nell'area del potenziale umano -molti dei cuali Iìequentatori della Chiesadi Scientology, antorché il successo direaltà di origine italiana, come il ParisEnergy Method, non vada sot tovaluta-to - e dì 20.000 nell'area del New Age,Nert Age e delle comunità .acquariane) opost-NewAge, fra cui emerge Damanhur,anche se il New Age per sua natura vrvesoprattutto nell'accostamento fluido dipartecipanti uoccasionali> che quindi sisottraggono alle statistiche.
Molto più incerte - e fonte di dibattiti sen-za fine. politicamente condizionati - sonole statistìche sulle minoranze religiose pre-senti sul territorio se si considerano anchegli immigrati non cittadini e non solo i cit-
Neo-pagani, neo-sciamanici,Wicca 3.000 20,006
Rosacroce 2.000 13,306
Martinif i, kemmerziani,magia cerimon iaÌe 900 6,00/o
N€o{emplari 800 5,Jak
Gruppi teosofici e derìvati 3.000 2,04/o
Fraternità universali 700 4,7%Spirîisfio organinato 1.000 6,7%Movimenti dei dischi volanti 1.000 6,7%Chiese e movimenti gnostici 1.500 10,0o/o
Satanismo otgafliuato 300 2,006
Altfi 800 5,3o/o
Totale 1s.000I00,0o/o
Per qualche verso a questa stima potreb-bero essere aggiunl.i. in quanto non privìd'interessi esoterici, i circa 35.000 iscrittialle varie obbedienze massoniche, chetuttavia abbiamo scelto di consioerare aparle per le ragioni meglio precisate inseguito e nell'appendice dedicata a que-sto ambito.Si rileverà I'insistenza sulle nozioni dispiritismo e satanismo organizzati, a in-
1 0
-:r J,r no i soli:..r.:a fblmal-: '.: a non tutti
..,.:::c nte fra i:. i : r.: 'ra spirit i-,: -1 ia, O (Sel-
a : l : s0 senza::-r::ì i Íì-ìo, real-. ' l i . c qu i ac-i: l \ are pratl-. : laaanto a::t:ì izzilzioni.:.. i-rantitativi\ \:a:lZìale uma_.:( :.rché qui,_. a: irrno vera-r': 'Jrasonabi-r . ! USi l tO, PeI' rr !r)lo Parteci-: l i . tìuitori).::!a1lìlno occa-.t::. a(ìn\.egni di\1.rtre in pre-
:-(':a-l <lye\amo
:.-:.!.iore, riferi-( . . \ r t inua t iv i ,
ri: :c.anti ricel-j: .jf\ rre circo-., ' ,, 'r.r che vivo-, - , i F ( r i o r r r n n l
ic:t it.r religiosa,:r.rnJo così i ve-:t,r:.ìnzc reìigio-I ai::.lnlente as-:, ' ,, lnti - in cir-:nz i l le umano-,'. .t.'1la Chiesa' : . . u c c e s s o d i
..rrre i l Parisir iotto\-aluta-: i i l \ew Age,| .ìalluiìriane) o;:ic Damanhur,.. i.r natura vivercr:t,r f luido di: ;he quindi si
i: Jibattit i senl:TLirnall - sono,r. ' :t l i ir iose Dre-'\ lJtriìnO ancnei r.rn solo i cit
tad in i i l a l ian i . l l da to PresuPpor rebbe ino l
t re la pos . ib i l ì rà d i avèrc d i t i cer t i su l l ' im-
- ig rur ion . i r regotare - va lu ta ta ,da fon t i
dir"er.e fra le cinque.entomiJa e i l mil ione
ai"nita-, it.he e notoriamente assai diffi-c i le . Neg l i u l l im i ann- i sono emers i comeprn to d í t i f . t i t "n to de l d iba t t i to i da t i de l
rappor lo annua le Ca r i tas / M ig ran tes ' Que-iLiàati sono ba.ati su u na meiodologia che
assume come Punto d i Par tenza i res ident is t ran ie r i acce i ta t i da l l ' l s ta t a l la f ine de l '
i'anno precedente, li integra con i casi di
"rotfatÈntu anagrafiea' che sono stati rel
f id t tempo r iso l t i ' I i agg iunge g l t s l ranrer l
che nel iorso dell anno sono venut i ex t?ovo
ài '.rt"to o ,ono ttati in Italia nonché altre
ca tegor ie d i m igran t i - nuov i ìavora tor l du-
tonòmi , r i cong iu ng imen t i ' sogg io rnant t 'ecc . - , cosr chàg l i immigra t i in I ta l ia ne !
2012 pcr Car i ìa : i M igran tes sarebbero
5.01 1.j07 | Dossier St otist ico. Im m.ígraz.ione
2012. XXII Rapporlo sull tf lm1Eraz.tone'
Idos, Roma 2012, p. 192), con un'incidenzain ouesto caso Pari all'8'20/o.t dàti CaritaVMiglantes sono certamente
un punto di rifeiimento ineludibile per
ch iunque s ' in te rcs" i a l l ' im m ig raz ione in
Italia, Àa quanto alla religione so.no fonda-
ti sull'ipotesi di partenza - se det caso cor-
re t ta quando i f luss i m igra tor i da un Paese
aooa iono Da lesemen te a ì imenta l i sopra t -
rùiro dai sèguaci di una specifica religione- che g l ì s t ràn ìer i p resent i in l ta l ia abb iano
la.tes-"sa ripartizione relìgiosa dei Paesi di
o r ig ine . Questa ipo tes i s ibasa su manua l i
e díti che. sopratiutto nel caso delle Chiese
cristiane, sPesso non chiariscono se sr trat-
ti di <membri>, attivi owero soltanto <bat-
tezzati)) o <nominali>, e in molti casi sotto-
valutano l'area del <credere senza apparte-
nere". Così' per esempio' se- in jpote-sì dai
da t i su l Marocco cmerge che r l 99ub de l
suoi cittadini sono musulmani, il rapporto
Caritas/Migrantes conterà come musulma-
ni il99% dégli immigrati marocchini, sen-
za ron\iderare la prescnza modesLa ma non
i r r i levante d i ma iocch in i che in l ta l ia s i so-
no convertiti al cristianesimo né quelÌa piit
rilevante di coloro che non hanno mante-
nuto alcun rapporto con la religione Per la
verità, nei fù recenti raPPorti Cari-
tas/Migranteì si è tenuto conto del fatto
INTRODUZIONE
che i dati forniti dai governt sono spesso
ina t tend ib i l i . quando non. man ipo la t t per
iae ion i po l i t i che ' e s i è dec ìso d i p r iv i leg ia '
re?at i s ìa t i s t i c i non governat iv i , l c f "Nuo 'va metodo log ia per la s t ima de l l .aPPar te -
nenza reliqiola dèglì immigrati ' , in Dossier
Srorkricoimmisrizione 201 I X'XI Rappor-
to sull ' inmigra2ione. ldos' Roma 201 l ' pp'
io i -zos l . f però confermata la sce ì ta d i
fondo d i r iba ì ta re su l l ' l ta l ia i da t i de i Paes i
diorigine, all ' interno di un quadro dove per
uppoit"n"nta retigiosa s'inlende.deì resto
^ia'formazione rici\ uta nell 'ambito di una
detelminata comunità e il conseguente n-
fe r im.nro o l l . su . t rad iz ion ia p resc indere
àalla relativa partecipazione ai rit i religiosi
e a l l ' a t tegg iahento in t imo ne i con f ron t i
a. i iu ai ' í í i ta" \ ib id"p.202) Pertanto laCaritas conta come ortodosso anche unimmierato dall'Europa dell'Est che si è for-mato in ambiente ortodosso m4 se intervi-i ia to. d ich iara d i non credere in r l io e d inon uartecipare mai a riti religiosi SceÌtaleeittima, e ihe porta a forn ire dati comun-,r;" pt"tioti, ma diversa dalla nostra inq 'ue" ia sede. che dunque forn isce dat i d ivìrsi da quelli Caritas/Migrantes'La stima'Caritas/Migrantés è riportata nel-la Tabella 4.
Tab. 4 - Appartenenza religiosa deglíimmigrati (stima CaritaslMigrantes -
Dossier 2012)
Ortodossi 1.482.648 29,60/o
Cattolici 960.359 19,24/o
Protestantl 222.960 4,40/o
Altri cristiani 16 .107 0,7o/o
Musulmani 1.650.902 32,90 o
Ebrei 7.300 0,14/a
Induisti t ]L254 2,60/o
Buddhisti 97.362 1,90/o
Altre religioni orientali ó9 .215 1,14/o
Atel e agnosllcl 2r5.135 4,3%
Religioni tradizionali 50.498 1,00/o
Altri 87.567 1,9o/o
lomle 5.011.307100,0o/o
Su una base di .alcolo-diversa - t le parte
anzitut to ddl contdno diret to e dalla riìer a
1 l
LE RELIGIONI IN ITALIA
zione delle forme organizzate della religio-ne decl i immigraLi , e che peraì t ro t ieneconto ie l l 'es is tànza d i una mir iade dì P ic-cole reaìtà. per esem pio Chiese pentecosta-li africane che operano solo su scala locale.difEcili da identificare una per una - rite-niamo di potere ipotizzare il seguente sche-ma alternativo, che non comprende I cat-tolici, iiene conto dei dati presentati dalministro oer la Cooperazione Jnternazio-nale e I'lnìegrazione-Andrea Riccardi all'i-nauzurazione della Conferenza Permanen-te <Èeligioni, Cultura e Integrazione> il 19marzo 2oI2 (pur discostandosene per al-cuni elementi), vorrebbe - pure con tuttele difflcoltà del caso -tenere conto dei clan-destini e ha valore di semplice congettura:
Tab. 5 - Principalí minoranze religiosedi immigrati in ltalia Gtima CESNUR 2012)
Musulmani 1.360.000 Q,3oo
Ortodossi 1.294.700 40,2%
Protestanti 212.200 6,60/o
Induisti 114.200 3,54ó
Buddhisti 103.400 3,2%
Sill e radhasoami 00.000 t,9o/o
Altri di origine orientalee africana 43.500 1,4o0
Testimoni di Geova 17.400 0 ,500
Ebreì 7.600 0,24/o
Altri 5.400 0,20/o
Totale 3.218.400100,0o/o
rappor to d i qua lche per iod ic i tà con unafo ima organ izza ta d i le l ìg ione - anche setalora embrionale o elastica, non necessa-r iamente leqata a ed i f i c i d i cu ì to - per g ì ialtri. Per i protestanti, in particolare, sitratterà così di cercare di contare chi perdawero è in contatto con una Chiesa o co-munità - pentecostali afiicani, latino-ame-ricani o filippini, battisti cinesi, metodisticoreani, lutèiani e riformati del Nord Eu-ropa che soggiornano in Italia - e non so-lo chi dovreblbe ersere protesrante sulla ba-se d i un dd to r i fe r ì to a l Paese d 'o r ig ine . I ltotale d'immigrati <in contatto> - il che,come si è vistò, r'uol dire cose diverse perreligioni diverse - con una religione di-verJa dalla cattolica è da noi stimato a3.218.400 unità.Emerge, in ogni caso. insieme.a una sPet-Lacolare avanzata dei cristiani ortodossì,una centralità dell'Islam come seconda re-l iqione presente sul territorio dopo la cat-to-l ica, incorché non suscettibile di esserericondotta a uriunica organizzazione o en-te esponenziale, il che è peraltro vero ancheper gli ortodossi; in quesl.o secondo senso.ia seconda rea l tà q iu r id icamente cos t i tu i tain Italia è la Con-gregazione Cristiana deiTestimoni di Geova (circa 415.000 fedeli)'sesuita dalle Assemblee di Dio in Italia( 150.000 membd). Sofferto, tra l'altro, è ilda to sue l i immigra t is ikh e radhasoami . ingran paite.dì'peisi nelle campagne dove la-vorano nel settore agricolo, ma certamentein crescila, cosi che per questa edizione ab-b iamo r i tenuto d i àder i re a ì da to p iu a l tolornilo dal Ministero per la CooperazioneInternazionale e I'Integrazione.
La questione de[[e <<sette>
La nostra ricerca - in conformità, come slè accennato, ai più autorevoli modelli sta-tunitensi - non distingue fra (sette) e (re-l ie ion i " . La socio los ia del le reì ig ion i deì ìeoiisini si era propoita di definirè ìn termì-ni óbiettivi la differenza fra "Chìese" e<sette>. Nei primi decenni del secolo XX,il teologo e sociologo Protestante ErnstTroeltsCh (1865-1923) propone la sua fa-mosa distinzione fra: il tipo Chieso, un
La discrepanza con il dato Caritas/Migran-tes e, in una certa misura, con quello delMinistero per la Cooperazione Internazio-nale e l'Intiqrazioneìeriva, qui, anche dalfatto che stiàmo in realtà cercìndo di con-tare cose diverse. Per Caritas/Migrantes ein parte anche per il Ministero si tratta delretàesìo religióso o della costeìlazione dicredl-nze im-portata dal Paese di originelper no ì i l c r i le r io var ia a seconda chc s ii ra t t i d i musu lman i - cons idera to i l cara ttere non decisivo del contatto con una mo-schea o associazione per essere musulma-no, si dara rilievo alla pratica della pre-eh iera o del d ieiuno -, e cosi per alcune re-ig ion i o r ien t i l i , o invece d i un e [ [e t t i vo
1 2
gruppo religcircostante;gioso che coil tipo-mtst:s'interessa s(stante, Pref(ne sull'autcmembri. Qtni e modifi<dibattito sae sono tutt(via, la situecomplican<presuppostiroposta drtutto - coÍvono: per elte (sefia), rlo XIX - a1ormai pernella loro tDopo Ia Segiunta la cIgrosr 01 memente orl(chiamati <<sette> di rvite da mozo elemenlla cosiddeAmerica Lgio cattolirsemPre anevangeliccgioni del r(SetteD e Cteristichelroeltscrl.
Questi elegere una.smmotogr(logi e - incampo sonote era sney Starknel loro v,cularizati(UniversiLos Angeldistinguegiosi devinon oevlí
ì
: . : ao l l Una-:nahe se
: t : lecessa-: ì-ìer gli: . . , ,1 ,1 re , s i: : . . h l P e r: : : . l ù O C O _
. i :.:Ì l) ame-. : lr.todisti- . \L r rd Eu-
! l lon SO-ì : . i u l l a ba -. : . , : i r i n e . I l: . i l che,.i: ' , trse per
. . : : ì , lne d i -i : I Ì lato a
.i !: i].l sPet-. . : l odoss i ,
.(arìnda Ie-
,:..',.o la cat-. . . a d l esse re' i , : \ jnr ' o en-. \ (rtl ùnche
- , : ' . r lo senso,r i ( . r r s t i t u l t a
:: .r i . tna deiI , ' rLt feciel i) ,. , : . , in I tal ia: . l , , r l t r o , è i l;r l . t lan-r i , in
i lr t Jove la-
l aartamente, . i rzione ab-;-11. ' piu.alto.\ \"rcrazlone
te)
:t::.r. come si: ::ìùdell i sta-
\ ( i t c , e ( Ie -
: . . : : ion i de l le.:: r:; ir ' ì termi-' . r Ch iese> e: . . . cco lo XX '( . : . Ì i l te Erns t..:: t l l sua fa-: r - i l irsrl, un
* ruppo re l ig ioqo in a rmon ia con la 'oc ie ta
li*f""ti.i it ùpo-selta' un g'ruPPo reli-q io5o i ì ìe contcs l . ì l J soc ie ta c i rcos tdn te i e
7 t - t ;oo ̂ ; t t i ro , un grupPo re l ig io5o che
,tini"rarru . 'a"troteÀte deìla soc-ietà cirto-
stante, preferendo concentrare l'attenzlo-
ne sullàuto-perfezionamento.del Proprlmembr i . Que5te ca tcEor ie , con . ln tegraz lo -
n i e modì f i che ' sono r imaste d lcen l ro oe l
à iÙo i i i ,o to . i " tog ico per -d ivers i deccnn i
à -no tu t ,o tn uù ì i t t i t " do a lcun i Tu t ta -
ì iu , iu r i ,u r r ion" soc io log ica s i .è andata
, .o ìp t l . rnao e hr messo in -c r i s i a lcun i
, t " i luo . i ' i fondamenta ì i de l ìa t ipo log ia
uroposra da Troe l tsch l mov iment l ' anz l -
iu t to - aoa. d ice i l lo ro nome - r r muo-
rono: pcr esempio ì mormor i - cer tamen '
i . ' t . , iu - ,
n " t sènro d i T roe l tsch ' .ne l seco-
io X IX - appur iu rno ne l se ' 'o lo XX come
oì*u l p " i tè t r um"n te in tegra l i ' . a ìmcno
ne l la lo io soc ic t . l s td lun i tense,d l o r Ìg lne '
óouo lu S" .ondo guer ra mond ia le s i è ag-
Iiui,iu i, .t. '."n,.'visibìlità di gruppi reìi-
iiosi di matrice non cristiana, Partrcolar-il"nt" otie"tule, ancn-essi popoìarmentechlamati "sette,,
ma moltò-diversi dalle.set te- d i or ig ine cr is t iana che^erano scr-r i te da model lo a Troel tsch ln l ine 'untcr-,o .t"trl"n,o nuouo cra. ed è' costituito dal-la cos iddet ta "csplos ione del le se l te" rn
America Latina, d-ove tuttavia nel linguag-g io cat to l ico per '5et te ' s ' in tendono qudsr
" ' * tp t . rn , l ,à igruppi protcstant id i t ipo
"iiÀ'rclico e peÀtccottalc' che in aÌtrc re-
g ionidel mondo non sono del ln l t l comeisetteo e che comunque pr€sentano carat-ìàtir,i.ft" àlu"tt. rispetto al modeìlo di
Troeltsch.ouest i e lemcnt i nuovi hanno la t to emcr-
aàre una ser ie ampì iss ima d i ProPoste ter-
il inologiche da pirte di :ociologi' di teo
i . * i " - Í " mirura minore - -d i ps ico logi ln
.-u"moo ,-.iologico. una delle Iroposte piir
nÀ," . tu t t r ,u fórmulaLa nel lc85 da Rod
n" i s" t f . e da Wiì ì iam Sims-Bainbr idgen"í toto uolurn. The I ut ure of Religion Secular izat ion, Reviva l , c tnd Lul l I ormat ton
iÚniuet t i t l o f Cal i forn ia Press ' BerkeÌcy-Lo. , . tnselés- fondra l985J l due socio logiairtinnit.tuno fra <sette> - <gruppi reli-
c io t ià" .v iunt i u l l in terno d i una t radiz ione"non a.u lont" . - q .qu l1 i " . "gruppi reì ig io-
INTRODT]ZIONE
' i dev ian t i a ì l ' i n tc rnod i una t rad iz ionede-
r ian te- 1 ib ld . pp . 24-26) Cost ' Pcr csem
oio . i les t imon i d i Ceova e r mormont sa-
i.út .- ".,,." in quanto adotlano iì siste-
*n d l . i t "bo t i "
m. j l t i pun t i d i r i fe r imento
d i u n a t r a d i z i o n e " n o n d e v l d n t e " o m e
cue l la c r is t iana ' anche se ìc lo ro tdee sono
. lon" id " ro t . -dev ian t i ' da t l r a l tn SrupPrche ' i s i tua no a l l in te rno d l qucs ta . t rao l -
z ione, GI i Hare Kr i "hna "areb 'bero lnvece
; ; j ; "1 , . ' , perche 'a lmeno in occ ìden-
L - non io tL ,ono con ' idera t i come de-
v ian t i in quanto S, ruPPo ' ma la s tcssa t ra -
à i r ìon" t . t iq io "u - -o r ien ta ìe - da cu i t r rg
sono i lo ro i i l e r iment i c s imbo l t -e PercePI -ia comc es t ranea ed e"o t ica da l ln socre td
;ìt;;;i;"* In seguito, peraltro' gli stessi
Stark e Bainbridge hanno invltafo a servlr-
sidit r-i"otogi. diverse, perché iì dibat-
ii.'i,ì"ì" "t,.ii"tmente
cìmplicato dal-
i'""ro ài.ipt.ttio"i come usettà' e uculto'
ì" "ì
t""i" non sociologico o teologico'
ma criminologico.iàìr. iìt i t. aópt i tragici awenimenti che
úu in i .o inuo i to a lcún i g rupp i de f in i t i: ; ; i te , - t rd cu i i su ìc id i -omic id ì de l l ' o r -
a ìn" de t f "mp io So lare neg l i ann i l9q4 '
l9q5 e 1997 i i ' a t ten ta to co l gas comptu to
ne l la met ropoì i tana d i To \o ne l l9q5 da
*** f ià" t l l n" . Shinr ikyo: i l su ic id io d i
ou1ìiutti I -e-Uri del culto dei di"chi vo-
iui-ti ù"0".n t cut. nel 1997r i suit.idi c gli
.Àì . ià i a" t sruppo 'cat to l ico d i f rangìa '
É.r , " r* i i " ' í . a ! i o icc i Comandamcnt i d i
óìo in Ugonau nel 2000 - giornalìsti ' cri-
minotogi ì anche a lcune commtsstonl par '
i . . . ì i i i europee sono andat ia l la r icerca
di un cr i ter io ' o d i una ser ie d l cr l (er l ' Perd is t insuere f ra "set tc ' Per ico lose e EruPPl
"re l ic ios i " innocui . Par t ico larmente . Inf rani ia e in Belg io i r isuì ta t id i ( luc( te I .n-
daein i par lamentar i - che hanno lns ls t l lo
sul'ia nozione. a sua volta vilga" ontestald
ai Àot t i "p . . iu t i t t i
ac. .ademic i e d i f f ic i ìeàu J. i i " i rJ . d i manipolaz ione mentd lc"ia iora usata come s inònimo d i quel ìa ' an(ora p iu controversd. d i " la \d8€Ìo del cer-
ve l lo ' - non sono " tdt i S iudlcat l Par t lco la. r -i l fn te,oddi r facenr i dà mol t i s tudios i Le
critiche sono state vivaci soprattutto.quan-do, insieme ai rapporti, le commlssronl
futtuÀ."tuti t-tuntió proposto lunghe liste
1 3
LERELICION] IN ITALI,{
di (sette pericolose), o comunque di grup-pi presi in esame, dove sono comparse an-che realtà rispettate e rispettabili, tra cuimovimenti cattolici riconosciuti dallaChiesa d i Roma. Al t r i rappor t i europei -pure nat i dd l le s tesse preoccupazioni epubblicati negli anni seguenti- come quel-lo del ìa Commiss ione d ' inchiesta par la-mentare tedesca, del 1998, e il successivo diuna commissione governativa svedese, pu-re del 1998 - si sono mostrati assai piìr cau-ti e hanno ritenuto impossibile fissare unalinea di demarcazione precisa fra (sette)pericolose e <religioni> legittime.Senza approfondire qui il merito di questecontroversie, le quali partono dal proble-ma molto reale dei crimini - talora gravi ograv iss imi - commessi da a lcuni gruppiche a vario titolo si presentano come reli-giosi, è evidente che - in seguito a tali di-scussioni - la parola <setta) ha assunto,par t i (o larmente in Europa. due d ivers i s i -gn i f icat i che s i sovrappongono. A un s i -gnrficato criminologíco secondo cui la <set-ta> è un gruppo religioso - o che si preten-de tale - pericoloso, di cui si può dire conun certo grado di probabilità che commet-terà reat i e cr imin i d i maggiore o minoregtavità, fa da p endar r un significato di tiposociologico, secondo cui la <setta> è sempli-cemente un gruppo religioso le cui idee so-no piuttosto diverse rispetto a quelle con-divise dalla maggioranza dei consociati.Tutto questo crea notevole imttarazzopresso gli studiosi e anche rischi per la li-bertà e la tolleranza religiosa. Quando auno studioso - per esempio in un'intervi-sta televisiva - si chiede se questo o quel-l 'altro gruppo è <una setta), si vuole inrcaìtà :apere da lui se il gruppo è "perico-loso" o potrà commettere dei cr imin i .lÌintrecciarsi fra significato criminologicoe significato sociologico del termine creaqui una pericolosa ambiguità. Se per esem-pio uno studioso risponde a un intervista-tore che i mormoni sono una "5et ta" - r i -sposta in tesi corretta con riferimento allecategorie di Troeltsch - il rischio è che chilo ascolta alla televisione si convinca che imormoni sono un gruppo <pericoloso>, ilche è certamente falso e ingiusto.E per ragioni di questo genere che- mentre
1 4
i giornalisti, i criminologi e chi desideramettere in guardia l'opinione pubblica neiconfronti dei pericoli delle <sette) conti-nuano a utilizzare questo termine - gli stu-diosi hanno preferito a lungo parlare di(nuovi movimenti religios o <nuove re-ligioni>. Molti chiamano <nuove religioni>rigruppi p i i , r grandi e consoì idat i come imormoni o i Testimoni di Geova - le cuidimensioni superano ormai quelle di unsempl ice movimento - e invece nuovimovimenti religiosi> le realtà piìr piccole odi origine più recente. La stessa Chiesa cat-to ì ica, in a lcune sue autorevoì iespress ioni .ha tenuto conto delle preferenze degli stu-diosi. La Relazione generale Ia sfida dellesette o nuoli morimenti religios;: un approc-cio pastorale d.el cardinale Francis Arinze alConcistoro straordinario del 1991 - cheaveva appunto questo fra i temi all'ordinedel giorno - raccomandava <di adottare untermine che sia il piu imparziaìe e precisopossibile>, almeno <finché non vi sarà unaterminologia universalmente accettata>, escegì ie d i usare " in genera le i l termine"nuovi movimenti religiosi" (abbreviato inNMR) perché è neutrale e abbastanza ge-nerale>, Peraltro, dubbi sono stati recente-mente sollevati in alcune sedi scientificheanche su categor ie come "nuovi movimen-ti religiosi>r e <nuove religioni>' che pure al-cuni degì i autor i hanno usato per anni , eche continuano a essere usate - e lo saran-no, quasi inevitabilmente, in futuro - perdesignare cattedre o associazioni scientifi-che, CESNUR compreso.Nel febbraio 2012 un importante saggio delsociologo David G. Bromley e del già citatoJ. Gordon Melton ha proposto di distin-guere le religioni e i movimenti sulla basedel grado maggiore o minore di alignmentlc ioe d icongruenza con i va lor i dominan-ti nella società) in dominanti, (settarie) - ssc-taria4 espressione che in inglese non ha unvalore particolarmente spregiativo -, alter-native ed emergenLi. Le religioni dominanti hanno acquisito questo sfdtrs dopo de-cenni d i rappor t i non sempre id i l l iac i , maul t imamente col laborat iv i con le ìs t i tuz ioni . Le re l ig ion i "set tar ic , non hanno grav icontrasti con le istituzioni sociali, ma acausa di peculiarità teologiche non sono
]
considerate orreligiosa di orsono quelle dche hanno diaccettate quarconvertltl -area geografidel buddhisn<emergent ilpo disparato rmovimenti ctso di alígnmedominanti (c(Reconceptuiganization: Dtive, and Emeva Religio: TiEmergent Rel2012, pp. 4-:emergenti), rstata della rivtato il saggio,implicare alcrPure questa 1problemi, e glligioni e i mspostano, taluna casella alDove si situ;<emergentr) -tr sempre m€Per esemplo,nea di un mocrnquecentes(ligioso? Doprreligioni cheaderenti comstimoni di Grre chiamate<nuove) le Iperché non sorigine settecquest'operaOccidente, ddottrinale e rma quanti soun accostamdisposti ad a<trinale in cuitazioni teololpera che prestorevoli e re
hi desidera-ubblica nei. t l c " con t i -:nc - glì stu-r parìare al, ìruoue te-rc religioni>..1Jtl come r' . , r a - 1 e c u iruc l le d i un\ ' j . r ' " n U O V i
: 'ru lì iccole o.r r.hiesa cat-l aifresslonl,rr( iesli stu-l . ; : ' tds de l le,: :T; LTPPTOC'.: - : i . ì r lnze a t. : ' r ' ) l - chen: : . l l l ' o rd inei: .r i..ttare unIl.c . Precisox : . r r t t t ì u n a' tr--.: lìta), ek r . :a rmlne.t:!' :f v LìtO ln
i \ .:-rlza ge-!i i :: recente-
l: r icntif iche'\: r lLrr_imen-' . i :t pureal-
:{r :ar .ìnnlr e. - !' lo sarani : - l tu ro - Per:..r r scientif i-
rric saggio dele .icì gìiì citato' . ro J i d is t in -, 'n'. i ìulla base. Ji ,t i t lnmenti, 'r!don.rinan-..ctt.rrie, - seC-lct non ha unx.r:i\ o -, aÌter-1..:ri. lominan-'.;::, i r lopo de-:c :. i i l l iaci, maon l. ' istituzio-,n hlnno gravr
! ! ìarJ l l , ma a
ia ]]a non sono
considcrate ortodo:se dalla ìoro tradizione
reìiqio'a di originc. Le religìoni dlrcrndtrve
sorù que l le dorn inant i in a l t re socre td ma
che hanno d i f f i co l tà a e \serc P iennmenteaccet ta te quando - g raz ie a immigra l i .o a
.onu. t r i t i ' - s i t rd fe r iscon-o- . in . un 'a l t ra
area qeogra f ica : è i ì caso dc l l Indu lsmo o
A"i UiaC"t irrno in occidente. Le religioni<emergenti) infine costituiscono quel grup-po à i r i r tu to. res iduo d i denominazioni eiloilÀ.nti ct.te ttunno un grado moìlo ba'-lo di olisnm"nt ,on i valori e le istituzioniàoÀi"u'"ti (cf D. Bromley - l. G' Melton'', Reconcepr uali/ing Types oI Religious Or-saniza l ion: Dominìnt . Sectar ian ' Aì terna-iiue, and Emergent fradition.Group'"' No-,vo Relipio: The lournol ol Allernoltvc afiaEnergínt Religíons. vol. 15. n. J' lebbraiozo f : , " pp. 4 '2 '8 t . Lespressione' re l ig ion iemereènti-' usdta del resLo nelld stessa te-stata ie ì la r iv ìs td sPecia l iz la ta che ha ospi -ruio il saecio, ha tirto il vantdSSio di nonimplicarààlcun gìudizio di valore Ma nep-puie questa risolve, evidentemente' tuttl I'problJm
i. e gli au tori am met tono che le re-
l is ion i e imovìmenl i ne l la loro s tor la s l
iíortuno, talora molto rapidamente, dauìa casella all'altra'Dove si situa il confine fra (nuove,, - onemereenti,, - e ovecchieo religioni è infat-ti semire meno chiaro: gli Hare Krishna'per esempio, tono und [orma contemporanea d i un movimento devozionale ind ianocinquecentesco o un nuovo movimento le-l ig idso? Dopo quant i anni o secol i d i v i tate i le ion i .É" cóntano svar ia t i mi l ion i d iade-rcnti come Tenrìkyo. i mormoni o i Te-stimoni di Geova devono smettere di esse-ie chiamate <nuoveo? Se si considerano(nuove)> le religioni nate nell'Ottocento'ucrche non sono inve.e nuove quelle di
brisine settecente.c.r? Alcuni degìi autori dtquJst'opera hanno suggerito, almeno rnOccidcnte, d i in tendere 'nuovo in sensodottrinale e non meramente cronologico:ma quanti sociologi della religione, legati aun a(costamento laico e va/us-frse. sonodisposti ad adoltare criteri dì carattere dottriiale in cui potrebbero nascondersi valu-tazioni teologiche? Per questa ragione l'o-uera che preúntiamo - seguendo i piii au-lnr.uoli à recenti model[ statunitensi -
IN'1'RODUZIONE
non solo non utilizza la categoria <(sette>'
md neppure ident i f iLa "nuove re l tg Ìon Ì " o' 'nuor i mov iment i re l iE ios- i " se .non Ìn un
con l .es to par t i co la re ' que l lo E ldPPonese 'dou. l t " tp ' t . t t ion . -nuove re l ig ion i - ha un
scnso dcceltalo e sPecifico. Un esame caso
p. i .1 to à"1 t . .uo luz ion i ' deg l i sc ismi ' de l -
L r i compos iz ion i a l l ' i n te rno d iun i tà iden-
tif icate come [amiglie spirìtuali ' se e certo
fù futi.oro e diffi;ile, può rivelarsi anche
piit fruttuoso'
La definizione di <<religione>>
Uno cìe i pr inc ipal i problem. i .che chiunquedir ipa un 'encic lopedia del le re l lS lonl s l
trovà di fronte riSuarda ìa definiztone c t
Ì iÀ i i l a i - t " t ;s io ie . . ln ef fe t t i . una del leo iJ f t .ou.nr i " "Ui"z ioni che c i s iamo v is t iiare da parte di grupPi inten istdti Per que-st 'oDerà è s ta(a: .Noi non s idmo una re l l -nioie'. tl problerna deìla dcfinizione di re'f i * ion.
" i tu i p i i - r d ibaLtut i ne l la s tor ia e
n?ita .ociotoglà deìle religioni e anchc nelrliritto ecclesiastico. Si pot rebbe d ire' sem -
oii..-""t., che si traita di un problemaintotut i l . ' ma l 'a f fermazione non potrc l r -b" . r r " r . suf f ic iente a i g iur is t i ' daì mo-mento che diverse leggi e trattati interna-zionali concedono sPecifici vantaggi -non
soltanto fiscali - alle organrzzazronr re-l ig iose r ispel . to a quel le sempl icemente-
ral e;ello stcsio tempo le escludonoda a lcune possib i l i tà . I t r ibunal i d i nume-rosi Paesi hanno così dovuLo decidere casiche hanno coinvolto la Chiesa di Sciento-loev- che afferma con vigore di essere unat . Î i 'n ion" . r ich iedc i re lat iv i vantaggi f i -scali e di altra natura - e, all'estremo op-posto, la Meditazione Trascendentale' che
ion a l t re t tanto v igore nega d l essere una
religione e chiede di potere proporre t suot
.àì í i u t .uot" pubbl ìchc o ènl i s ta la l i che
"oi pàit"Ub"tio *cettare insegnamenti di
natura relrglosa',q À. tu a" ; t i unnl 1990 a l l ' in terno del lala .o i ru O; i .o log iu deì l Univers i tà d i Le idaI'siaio fondatoil Leiden Institute for theStudy of Rel ig ion (LISOR ) . che ha awia locon la cooperazione.di varl organlsml eu-ropei un Proget lo ch iamdto MTSR (Me-
l 5
LEREL]GIONIIN ITAIIA
thods and Theories in the Study of Reli-gion, <Metodi e teorie nello studio dellareligione>), consacrato prioritariamenteallo studio delle possibili definizioni di<religione>. Al progetto LISOR-MTSR hapartecipato uno degli autori di questa ri-cerca, Massimo Introvigne, che è ancheuno degli autori dei saggi raccolti nel vo-lume finale del progetto, curato da Jan G.Platvoet e Arie L. M olendijk, The Pragma-tícs of Defining Religion. ContexÍs, Conceptsand Contests (Brrll, Leida 1999). Una delleconclusioni del progetto è che non esisteoggi, nelle scienze sociali e nello studiodel le re l ig ion i in genere. una def in iz ionecondivisa di nreligione>. Le definizioni chefanno riferimento a un Dio personale equelle che insistono sulla distinzione frauna sfera del sacro e una del profano sonoormai minoritarie. Alcuni giuristi, e alcunigovern i . ins is tono sul l 'auto-def i n iz ìonecome criterio per identificare una religio-ne: ma questo criterio, già di per sé del tut-to soggettivo, è stato messo in crisi negliStati Uniti dagli scandali delle mail-orderchurches, <religroni>> fasulle di cui chiun-que può diventare <ministro> pagandouna somma e che nascondono elaboratischemi di evasione fiscale. fidea, diffusanel l 'op in ione pubbl ica, secondo cui unareligione, per essere tale, dovrebbe esserenecessariamente <benevola> o operare peril bene comune non è accettata dagli stori-ci, che ritengono normalmente <religiosi>movimenti di terrorismo <sacro> e altri,come quello indiano dei thug - almenonel ìa sua fase or ig inar ia - , ins ieme cr imi-nali e fondati su una complessa teologia,né dubitano della natura di oreligioni', disistemi fondati sul sacrificio umano. Sepa-rare la religione da un'immagine necessa-riamente positiva e sottolineare che l'eti-chet ta d i re l ig ione non è obbl igator iamen-te un marchio di qualità o un certificato dibuona condotta, potrebbe attenuare alcu-ne delle polemiche suscitate da chi vorreb-be negare lo statasdi religioni a <sette> ac-cusate di praticare la <manipolazionementale>, il <lavaggio del cervello> o losf rut tamento dei propr i membr i . A pre-scindere dalla già citata ambiguità della ca-tegoria di (setta>, dovrebbe essere eviden-
t 6
te che <derive> criticabili si ritrovano sianel le "vecchie, s ia nel le "nuove" re l is ion ienon Dossono essere utili l late comicriterio pèr distinguere le <vereo religioni dalle<pseudoreligioni>: un'etichetta, quest'ulti-ma, puramente polemica, che se può tro-vare un suo Dosto nella oredicazione o nel-la controveisia. è oeró sostanzialmentepriva di contenuto informativo.11 progetto LISOR-MTSR conferma che lanatura di oreligione> non è, o non è piii, uncarsttere che inerisce a certe realtà, ma unarivendicazione politicamente contestatanelle società contemDoranee, dove troviamo peraltro anche rivendicazioni <negati-ve> di gruppi che non vogliono essere con-siderati religioni. Il problema non può per-tanto essere risolto con definizioni di tipo<<essenzialista>', e lo studioso non può chepremellere che lutte le possibili defin izionisono socialmente costruite, politicamentenesoziate e orientate a determinati risulta-ti. Dopo questa premessa, si potrà aggrurrgere che, se il risultato che si vuole ottene-re è un'ampia difesa della libertà religiosae del pluralismo, le definizioni piìr recentiproposte dalle scienze sociali - pure nonpiìr né meno <vere> di altre - sembranoprestarsi meglio allo scopo. Esse.descrivo-no, Per esemPro e spesso, te relrgronr.comeslstemr - cne generano orSanrzzazronr estrutture - di risooste nÒn Duramente fat-tuali né suscettiblli di verifiia emoirica alledomande ultime sull'orisine e sul destinodella persona umana che ógnì uomo e ogn idonna si pongono. Descrizioni. come si ve-de, che non considerano decisiva l'auto-de-finizione, che escludono sia la necessità diun riferimento a un Dio - nersonale o me-no - sia la nbenevolenza, e il contributooositivo albene comune. e infine che evita-no dì awenturarsi sul terreno di nozionicontroverse come quelle di <rito> o di <co-munrta>.Così come sembrano adatte a ottenere rr-sultati di tipo politico sul piano della dife-sa deìla libertà religiosa, queste definizionio descrizioni della relisione sembrano uti-li a ottenere anche risultati di tipo cogniti-vo quando si tratti - ed è questo, tipicamente, il caso di un'enciclouedia - di rico-st ru i re mappe del "campó re l ig ioso" . i
I
perché queslperché sonobiamo adottaque trovano lsoltanto sec(non sono relire secondo nrne del tutto zaltri contestigiuridici. Pepagine di realigiose - dazione Trascedel movimeTeosofica - rro auto-defirsta sede, cons'intenda ritdella loro nrdi realta relitto delf inclusede giuridi<tà che si defirealtà religiora religiosa ,non soltantavrebbe senrIl punto di pve è che fr.rtrchetta <reli<orientati aqui si vuolesta area delplesso di crcon il sacromeo, che quinon mancagre> - non cdella parolagiuridici, chni fiscali o dsuffrcientenre essere insNon spetta ípedico risolmente, e pltin questo lirealtà che clsto genere sigan per cornon sono (mente partj
: lrovano sta( religioni e;oÌne crtte-
,. ir ioni dalle.i. quest'ult i-: \. pLlò tro-,izione o nel-.rnzialmente
r.rma che lar.rn è piii, un:.rì: i. ma una. i.lr'ìt€stataii(ì\'e tIOYla-l(ìnl .negatl-
. ' asse re con -c,'n può perrzi.'ni di tipo:r,ìn Può cheLir icirnizionir.liticamentet:n.ìri rislllta-$r:.ì aggiun-r!rìk'ottene-<:t: r.ì igiosa:l
" ':u recenti
! - PUre non- \ 'mbrano'.t descrivo-: , rg ion i comern izzaz ion i errJmente fatcmpirica alle.' sul destinouLrlìlO e Ognl
l l. aom€ st ve-irl l auto-de-a necessità di:\(rnil le o me-il contributoìnc che evita-r,r di nozionii ro " o d i <co-
l !ìttenere rino della difè-t. 'definizionicmbrano uti-ri lo cogniti-
i.rcsto, t iPica-:. l ia - di rico-rallgloso). -g
i
t
perché queste descrizioni sono utili, nonperché sòno uvere, - o nfalseo - che le ab-biamo adottate in questa ricerca, dove dun-que trovano posto numerose realtà che nonrolLanto tecóndo ìa loro auto-definizionenon sono religiose, ma non lo sono neppu-re secondo ntimerose definizioni di relìgio-ne del tutlo accetlabili c forse necessarie inaltri contesti, per esempio, in certi ambitigiuridici. Pertanto, I'inclusione in questepagine di realtà che si considerano non re-i ig iose - da Nuova Acropol i a ì ìa Medi ta-zóne Trascendenta le, dJ d i r erse branchedel movimento radhasoami alla SocietàTèosofica - non significa né che questa lo-ro auto-definizione non sia trdtlata. jn que-sta sede, con il rispetto che merita, né ches'intenda risolvere il problema <ultimo>della loro natura affermando che si trattadi realtà religiose. Utilizzare il semplice fat-to del l ' incìus ione in quesla r icerca in unasede giuridica per affermare che certe real-tà ché si defini:cono non religìose sono tnrealtà religioni - o per confermare la natu-ra religiosa di altre quando è contestata -non soltanto sarebbe sbagliato, ma nonavrebbe senso.Il punto di partenza da cui la ricerca muo-re è che tani g ì i u5 i de l ìa conl rovers. ì e t ì -chetta (religione) sono result-oriented,<orientati a un risultator: e il risultato chequi si vuole ottenere è documentare la vasta area del <canpo reìigioso,, quel com-plesso di credenze, aspirazioni, relazionièon il sacro, risposte alle <domande ulti-mer, che qualunque estensione gli si dia - enon mancano casi difficili né <zone gri-g ie - non coinc ide in ogni (aso con 8 l i us iie ì la paro la . rc l ig ione ' ór ientat i a r i i - r l ta t igiuridici, che si tratti di concedere esenzro-ni fiscali o di decidere quali tecniche sonosufficientemente <non religiose> per pote-re essere insegnate in una scuola pubblica.Non spetta a un'opera di carattere enciclo-pedico risolvere questi problemi. Ultima-mente, e piir modestamente, si troverannoin questo lavoro in formazioni su quel lerealià che chi si accost.ì a un'opera di questo genere si aspetta divedere discusse: ma-gari per concludere, soggettivamente, chenon sono <religiose>. Casi a parte, vera-mente particolari, sono quello delle mas-
INTRODUZIONE
sonerie - certamente di per sé non <reli-gioni>, ma che hanno un rapporto con Iarelisione che non può essere ignordto - er l ì c -h i è " re l ie io 'amentc i r re l i [ ioso" . c ioèc le i l i ber i peÀsator i o rgan izzaù <omc ta l i ,alcuni perhno dotati di una specifica ritua-lità: esii sono discussi infatti in appendicifinali separate.
I1 <<credere senza appartenere>e [a rilevanza del pluralismo
Del ìa p iu grande , re l ig ione ' i ta l iana - u t i -liz.ziamo il termine in modo volutamenteparadossale - non si troverà peraltro quiiraccia, se non in questa introduzione. Damolti anni diversi sociologi hanno conclu-so che in tutto I'Occidente la vera religionedi maggioranza relativa è quella delle per-sone lmPegnate m un (cleoere senza ap-partenere " : be I i e v i ng w i t hou t bel on gi n g,se -condo la formula proposta da Gtace Davienel suo Religion in Britain since 1945. Belie-tíng wíthout Belonging (Blaclavell, Oxford1994).Quella sul nctedere senza aPpartenere,, esulla teoria della Davie è stata una delle di-scussioni più importanti nella sociologiadelle religioni tra la fine del secolo XX e ilorimo decennio del XXI. e ha coinvolto so-iiologi del calibro di Danièle Hervieu-Lé-ger, Peter Berger ed Eileen Barker. Un pri-mo risultato della discussione - ultima-mente condiviso dalla stessa Davie (si vedarl slo Europe: The Exceptional Case. Parame-ters of Faíth in the Modern World, Daton,Longman and Todd, Londra 2002) - avevariferito il (credere senza appartenere) a uncontesto geografico specifico, quello deiPaesi eu ropei occiden tdÌ i econ om icd men tepiù avanzat i . cu i s i aggiungono l 'Ausl ra l iae i l Canada. mentre l ' "appar tenere ' t ienenegli Stati Uniti, in Africa, in Asia.In qual-chà Paese si verifica anche un fenomenoopposto. l '-appartenere senza credere" lùe-IòÀging wítiout believingt. nel senso chepersone che talora non credono neppurein Dio si dichiarano religiose o anche fre-quentano riti religiosi per affermare un'ap-parl.enenza ndziónale o el n icd - Israe]e - ouna protesta che è ins ieme cul tura le e pol i -
t 7
LE RELICIONI IN ITALIA
tica (Polonia e Paesi baltici prima della ca-duta del comunismo, cattolici nell'Irlandadel Nord). Successivamente, tuttavia, è sta-ta ripensata I'intera questione di quali Pae-sì abbiano un comportamento -ec(e/iona-le> in materia di religione rispetto alle ten-denze prevalenti nel mondo: una proble-matica che ha visto molti sociologi passaredall'idea di un'<eccezione americano -percui gli Stati Uniti sarebbero l'eccezrone aun generale declino delle appartenenze - aquella di un'<eccezione europea>, occiden-tale, per cui l'area industriale avanzata del-l'Europa rappresenterebbe il vero caso ec-cezionale in un contesto mondiale in cui leappartenenze religiose tengono. Più che di<eccezioni>, nel secondo decennio del se-colo XXI si è cominciato a parlare di <mo-dernità multiple>, che mettono in discus-sione il modello di un unico rapporto fiareligione e modernità. Quanto al <crederesenza appartenere>,la stessa Davie parla dadiversi anni (cf il suo Religion in ModernEurope. A Memory Mutates, Oxford Uni-versity Press, Oxford 2000) di modi multi-pli e diversi di <appartenenza>, all'internodei quali si potrebbe dire che in alcuni Pae-si dell'Europa occidentale non si nappar-tiene) attraverso la pratica personale matuttavia rimane una forma di <apparte-nenza vicario, per cui anche chi partecipamolto raramente ai riti religiosi spesso so-stiene con il suo appoggio <culturale> ipraticanti, ritenendo che essi pratichinoanche per suo conto, e che attraverso lapratica altrui possa manifestarsi una for-ma postmoderna di appartenenza tramiteterzi, Questa appartenenza <vicario per-petua, sia pure in modi nuovi, la presenzadella religione come memoria collettiva,una nozione sottolineata anche da DanièleHervieu-Léger a partire dalla sua operafondamentale Religione e memoria (frad,.it., il Mulino, Bologna 1996) e approfondi-ta negli anni proprio in dialogo con GraceDavie.In Italia, se si crede al dato che emerge dal-la quarta indagine del programma EVS(European Values Study) - awiato nel 1 98 1e replicato nel 1990 e nel 1999 con una co-stante estensione delle comunità nazionalie del campione complessivo - svolta nel
1 8
biennio 2008-2009 nei 27 Paesi dell'UnioneEuropea e in aìtri 20 Paesi limitrofi, le per-sone religiose prati canli in maniera regola-re- cattoliche e non - sono il 32olo, oltre al16.40/o che dichiara di frequentare le fun-zioni religiose in manierà quasi regolare(cf Clemente Lanzetti, <La religiosità inItalia: ascesa o declino?>, in Giancarlo Ro-vati [a cura di], Uscire dalle tisi. I valori de-gli italiani alla prova"Vita e Pensiero, Mila-no 2011, pp. 181-229 fp.205]). Dati nondel Lutto dissimili. ma che oure lestimonia-no la difficoltà di perveniie a cuadri stati-stici univoci, emergono da un'iltra rmpor-tante indasine svol ta in l ta Ì ia in anni re-centi. in cúesto caso condotta da FrancoGarelli dell 'Università di Torino, secondola quale il livello di p raríca regolnre si. atfeslaal26,50/o e qtello quasi regolare al 15,8o/o(cf Franco Garelll, Religione all'italiana.L anima del paese messa a nudo, il Mulino,Bologna 2011, p. 58). Per quanto riguardala pratica regolare - cioè la frequenza allaMessa tutte le domeniche - si deve tenereconto anche del fen omeno dell' over-repor-tirg, per cui non tutti coloro che dichiara-no di andare a Messa osni domenica di fat-to ci vanno. Oltre alle iicerche di Alessan-dro Castegnaro in Veneto, si può citare alriguardo - sempre avendo cura di precisa reche non si tratta di dati nazionali - un'in-dasine curata dal CESNUR nella Siciliacentrale (Massimo Introvigne - PierluigiZoccatelli, La Messa è lìnita? Pratica catîoli-cq e minoranze relisiose nella Sicilia Centra-le. Salvatore Sciascia Editore. Caltanissetta -Roma 2010). In questa indagine, nel terri-torio di riferimento coloro che dichiara-vano di avere una Dratica settimanale opiìr che settimanalel al netto dei non cat-tolici - erano il 30,1ol0, mentre i frequenta-tori rilevati di tutte le Messe cattoliche inun week-end orescelto come tioico erano il18,5%0. Sarebbe naturalmenteibagliato, incuesto come in altri casi. considerare ilfrimo dato nfalsoo e il secondo <vero>.Chi afferma di andare a Messa esprime giàun'identificazione religiosa chiara, di cuinon s i può non tenere-conto. f immaginepiìr adeguata è dunque quella dei cerchiconcentrici, dai. dominicantes contati allaporta delle chiese ai praticanti dichiarati,
e da questi ache nella rictmunque catttuita dal nusto di color,esplicitamercitata indagitl 4,7 o/o e le p
Si deve certostenza sociolambigua dei ,ché per i l catbìigatoria -,gronl cul noquenza religiI Crtstlant ofdifficoltà a tconcetto ditenendo couna popollnella sua crvrebbe cool
P€r cenlo a.credereD, !non .aPPúlnel senso 1icanollco, irE-Sa$rùdctli it |i-mioodlrinidiE-uDpdilotifrr€if-lcie roò |trr|rÉ IÌdri-niÉr tE ÓLfuT{
, . . , : . . L n i o n e::: : r. ':ì. le Per- ' .: ...1 t (gola-
. ' l . oltre al. - r : ì : - ì :a Le fUn
. . . : , . . : : rcgo la re. , : r r : ios i tà in: , .-,: lC.rrlO RO-.':.: . ' , alori de-: . : ' . ! . ro , M i la
: : . l ) a t i n o n. : : ( : c i I l m O n ì a -
! . . . i , : . rdr ì s tat i -
i : : - i . i r . ì lmPoI-
. t . : . t . n a n n i r e -:. ' : : . l i l Franco
' : : : : ! ì . 5eCOndO
.i. . . ; ' r 's l attesta; . . . i ' i . t l 1 5 , 8 0 ó': , . ; . i i rql iana.
: : . . ; . . i l \ lu l ino,, , - , , ì r ì o , r . r . l ,
i : : . luenZa al la- . : ! :Sve tenele:c.t ." , rr-rep1r-' ,, .:rc,.lichiara-:,' lcnica di fat--:.c ii -\lessan-': i..rtr citare al
- , , l i n r n r i c r r e
- ':,.r: l i un'in-I rella Sicil ia
;rc PìerLuigi' i -. i i icu cuttoli-,r ' :,: i ta Centra-j. \..ì.t. l l l iSSetta.l i::ìc'. nel terl i-,,-;rc dichiaraL . c : t i n l a n a l e o: : { , ú ! ' l n o n C a t -' r ' . , t ' " . ' . p n t " -
x ;.rttoliche inc Ì: 'aiao erano il::( \:r.ìgÌiato, in
.ons iderare i l- , , " t .1o uve to>.:\\.t .\prime già.r .;: i . ira, di cui:o. - immagine: . - ì : de i cerch i: ; . i .oo ta t i a l la.l r: i dichiarati,
e da questi a quel 92,2% degli intervistatiche nella ricerca siciliana si dichiarava co-munque cattolico. La controprova è costl-tuita Aal numero relativamente mode-s to d i co lo ro che in I ta l ia s i d ich ia ranoesplicitamente non credenti: secondo lac i ia ta indag ine LVS, g l i a te i in l ta l ia sonoiI4,7% e le persone <non religiose> il 9,770r r i l n l q ) l
s ì 'à ; i ; ; ; ; ; cons iderdrc che, o l t re a ì le ' i -stenza sociologicamente e teologicamenteambigua dei *cattolicinon Prdticanti- - per-che p-er i l cattolico. in tesi, ìa pratica èbbbligàtoria -, vi sono in ltalia fedeli di reli-g io ì i cu i non s ì app l i ca un obb l igo d i f re -quenza rclrgro5a settrmanale - per esemPlo.l cflslranl orlodossl - o cne possono avefedifficoltà a ricondurre le loro pratiche alconcetto di ufrequenza religiosa>. Anchetenendo conto di queste correzioni, c'èuna popolazione difficile da determrnarenella sua esatta proporzione, ma che do-vrebbe comprendere comunque oltre il 40per cento degli italiani, che dichiara diucredere>, ma nello stesso tempo di fattonon (appartiene) a una comunità religiosanel senso pieno del termine, i l che, per i lcattolico, implicherebbe la pratica regola-re. Naturalmente questa grande <religione>der . ì i i t , r l i an i non è omogenea. A l suo in te r -no" i sondagg i r i ve lano un . r gamma d ipo" i -zioni diverse. Si va da coloro che credonoin un potere superiore che non sanno peròidentif icare ai <credenti a modo loro>, ar
"cristiani a modo loro> e anche ai (cattoli-ci a modo loro>: <sono cattolico, ma nonpratico); (sono cattolico, ma non sonod'accordo con la Chiesa>; o anche - posi-zione non infrequente in Italia - <sono cat-tolico, ma sono contro i preti). Questo fe-nomeno che la socioìoga francese DanièleHen'ieu Léger chiama <disistituzionalizza-zione" della religione appare come una del-le caratteristiche salienti del sacro postmoderno.5e dunque è bene da una parte tenere con-to del ucredere senza appartenere), senzauna cui analisi nessuna descrizione del pa-norama religioso italiano sarebbe comple-ra, e dall'altra prendere nota della contro-rrrsa ma rilevante tenuta dell'area dei cat-tolici praticanti, si ha ugualmente torto
INTRODUZIONE
quando . i sonova lu tdno lc minoranze re l i -c iose present i in l ta l ia . Esse, in fa t t i ' non so-io importanti soltanto per le loro dimen-síoni quantitative - minoritarie ma, comesi è visto, tutt'altro che irrilevanti -, ma perla loro capacità d'influenzare cerchie moltop iu vas te d i persone. Un gruppo re ìa l i va-men le p icco lo come la ISKCON. popoìar -mente no l .o come Hare Kr ishna. ha d is t r i -buito milioni di copie dei suoi libri e opu-scoli. Il testo sulla reincarnazione piìr dif-fuso dag l i Hare Kr i "hna tBhak t ivedanta S.Prabhupada, La reincarnazione: lo srienzaeterna àella vita,trad. it., Edizioni Bhakti-vedanta, Firenze 1983) è diventato popola-rissimo in numerosi Paesi dell'Occidente,e spes :o c i la to anche in contes t i in .ospettati e ha cerl.amente lontribuito dlla modadella reincarnazione: anche presso personeche non si sognerebbero mai di aderire almovimento degli Hare Krishna. Piir in ge-nerale, di quelà percentuale di italiani Chencrede senza appàrtenere), manifesta un'aspirazione aì sacro ma non partecipa rcgo-lirmente aìle attivita di nessuna confessione religiosa sappiamo, tutto sommato,molto poco.In che cosa credono tutte queste Persone?Una fon te per r i spondcre a l la domanda eof fe r ta da i sondagg i demoscop ic i e da l leindag in i de i soc io log i , cer to imPor tan t ima che non possono costituire l 'unicostrumento di indagine: com'è noto, le ri-sposte sono del resto influenzate dalle do-mande e dal tipo di questionario. Un altroindicatore - la cui importanza non può es-sere trascurata - è costituito dalla lettera-tu ra popo lare . da l la mus ica . da l c inema.dalla televisione, dove emergono spesso te-mi " re l ig ios i . Tu t ta r ia . l ind ica tore pr incipale dèlle credenze diftuse nel popolo dicoloro che <credono senza appartenere) ècostituito, precisamente, dalìe minoranzere l iq iose . G iacché, come qu i s i documen-ta , ós is tono cent ina ia d i p ropos te reJ ig io -re . da un cer to punto d i v is t . ì imPegna le jn
una sorta di lotta darwiniana per la so-prarvivenza (a fionte di poche che soprav-vivono ve ne sono molte che non hannosuccesso e muoiono), st:udi.are quali pro-poste hanno successo e perché ci riveleràquali aspirazioni, quali 'domande, quali
1 9
LE RELIGIONI IN ITALIA
sentimenti profondi si agitano - al di làdella piÌr ristretta cerchia degli apparte-nenti alle minoranze - in quel grande FarWest della religione dove abitano coloroche <credono senza appartenere>. Ancheper questo lo studio delle minoranze re-ligiose non è una semplice curiosità, macostituisce un elemento essenziale per lacomprensione dello scenario religiosocontemporaneo.Se ci si chiede - all'interno dell'area del be-lieting without belonging- in che cosa chinon (appartiene> vuole comunque <<cre-dere>,la risposta deve fare riferimento nonsoltanto - forse non principalmente - acredenze di tipo tradizionale, ma anche acredenze nuove, Da questo punto di vistatracciare una mappa delle minoranze cheoggi hanno un certo successo è importan-te. perché ogni ' famigì ia" sp i r i tuaìe c i se-gnala esigenze e credenze diffuse ben al dilà dei suoi confini. Così,le Chiese e deno-minazioni cristiane o di origine cristianache crescono piii rapidamente sembtanoessere quelle che manifestano particolareinteresse per I'escatologia, le prolezie apo-calittiche e la fine del mondo, da alcunigruppi pentecostali ai Testimoni di Geova.I movimenti di origine orientale piii diffu-si spesso - anche se non mancano eccezio-ni - rimandano al grande interesse che cir-conda le teorie della reincarnazione. Le re-ligioni del potenziale umano e altri gruppinati in Occidente per innovazione, comepure il New Age. rinviano a un tema oggimolto diffuso: quello che Paul Heelas chia-ma <<sacrahzzazrone del Sé>, o <spiritualitàdel Sé>, che peraltro rischia, nel secolo XXI- con il passaggio dal NewAge al cosiddet-to Next Age - di diventare semplicemente<spiritualità del Me>. Infine, una serie dimovimenti e ordini di tipo esoterico o ma-gico fanno da pendant alla crescita, o al ri-torno, di diffuse credenze nella magia, delricorso a pratiche magiche, della consulta-zione di <professionisti dell'occulto>; fe-nomeni che, in quanto non s i espr imanoin moyimenti, rimangono estranei a que-sta rrcerca.Così, lo studio delle minoranze religioseaiuta non soltanto a capire quali esigenzemuovono i loro aderenti ma anche quali
20
idee religiose o spirituali circolano all'in-terno di un'area molto piìr vasta. Senza pre-sumere di proporre previsioni precise - percui occorrerebbe, dawero, una sfera di cri-stallo affìdabile - gli interessi escatologici eapocalittici, il tema della reincarnazione, laniacralizzazione del Sé> e il <ritorno dellamagio sembrano essere temi emergentinel variegato pluralismo religioso che ca-ratterizza l'Italia del secolo XXL
Atcune osservazionimetodo[ogiche
Come si è accennato, questa presentazioneenciclopedica delle religioni in Italia - ope-ra, per definizione. di riferimento - aspiraanche a essere leggibile da chi voglia farsiun'idea complessiva del panorama religio-so italiano. Per questo, dedica ampio spa-zio alle introduzioni di carattere storico-dottrinale, sempre essenziali e cui si devenecessariamenté risalire da ogni singolavo-ce per intenderne il contesto, nonché perritrovare elementi non presenti nelle vociproprio perché comuni a più realtà e quin-di trattati in un'introduzione. Si noterà su-bito che le voci non sono cuantitativamen-te omogenee, e che la lunghezza di una vo-ce non è necessariamente orooorzionale alnumero degli aderenti. Talorà per renderecomprensibili vicende o dottrine comples-se di gruppi molto piccoli è necessario piÌrspazio che per rendere ragione di realtà piùgrandi e piìr note. Si consiglia, comunque,l'uso sistematico dell'Indice alfabetico dellevoci enciclooediche, tuttavia dcordando chealcune niccòle realtà non hanno una sche-da autonoma, ma sono citate all'interno dischede di aìtri gruppi di cui, per esempio,costituiscono scismi. Una biblioerafia è sta-ta indicata dove possibile e facilmente ac-cessibile; non, invece, in presenza di soleoubblicazioni a circolazione molto limitataò di distribuzione di pubblicazioni comunra un'intera famiglia spirituale o corrente,Per religioni o spiritualità presenti <in Ita-lia> si è inteso riferirsi alla presenza dimembriitalianii non necessariamente di se-di o chiese; in tal caso, si è indicata la sede oun riferimento internazionale. Quando
possibile,sono sta{(ogni singcrò che le
Pre srare ilesto sonci collaborqui tutti imovlmenautorl, ansull ' impoinclusionsi presentdica udell,esclusi, n<particolala?pfezzacoloro chdenti ediquesto nschede, ir
PrezÌoslsparte, colsono res[autori.Fra questzionati: ichard; iì Ipr; i profeU E L N I T
Evangelirdottor Cdiverse pstante; i Iseppe \ r\fovimeranche aul'ambascisull ' lslanridell 'anca dell ' lr;sciita; SlInduistaBombierfèssoressBuddhistme a T izlasciati dcolare coalla cui nomaggiocui abbia
rrcoìano all ' in-asta. senza Pre-ni precise-perIna sfera di cri-ri es(atologici encarnazione,la| .ritorno dellaemi emergentil igioso che ca-\\t.
r Presentazronein I ta l ia -ope-
mento - aspirachi loglia farsinrama religio-Ka amPlo sPa-
"ttere storico-
.li e cui si devergni singola vo-to, nonché peri.nti nelle vociu realtà e quin-e. 5i noterà su-antitativamen-rzza di una vo-oporzionale alrra per renderelrine comples-necessario piìrne di realtà piirba, comunque,altàbetico delleùordando chemno una sche-e all'interno dii, per esempio,rliografia è sta-facilmente ac-nsenza di solemolto limitataazioni comunie o corrente.res€nti (in Ita-a presenza diriamente di se-Ci!:aîa la sede onale. Quando
possibile, ma non in tutti i casi, le schedesono state verificate con i resoonsabili diogni singola realtà: questo non implica pe-rò che le richieste di modifica siarro sem-pre state accolte, così che responsabili deltesto sono sempre e in ogni caso gli autori ei collaboratori. Sarebbe lungo ringraziarequi tutti i responsabili di gruppi, religioni emovimenti che hanno collaborato con sliau lor i , anche quando non erano d 'accordosull'impostaziòne del lavoro o sulla stessainclusione del loro gruppo in un'opera chesi presenta come una rassegna enciclope-d ica,deÌ lere l ig ion i - .Pernon fare tor toagl iesclusi, non se ne menziona qui nessuno inparticolare, ma a tutti va il nostro srnceroa pprerr ,amen to. Così pure r ingraz iamocoìoro che hanno riletto, già per le prece-dent i ed iz ioni de l 2001 e del 2000 o perquesto nuovo lavoro, al di là di singàleschede, interi capitoli dell'opera fornendopreziosi suggerimenti e opinioni, accolte inparte, cosicche - naturaìmente - essi nonsono responsabili di eventuali errori degliautorl.Fra questi, ma altri potrebbero essere men-zionati: il pastore valdese Giorgio Bou-chard; il pastore delle ADI Francesco Top-pi; i professoriPietro BoJognesìe LeonardoDe Chir ico del i ' ls t i tu to d i FornrazroneEvangelica e Documentazione (IFED); ildottor C iuseppe Lo Voi 1 I 929-2005). perdiverse parti riguardanti il mondo prote-stante; i pastori Giuseppe Mirabelli e Giu-seppe Neglia, per la parte riguardante ilMovimento di Restaurazione, dove sonoanche autori di diversi paragrafi storici;l 'ambarciatore Mario Scialoja r I 9J0-20ì 2 ).suìl' lsÌam sun n ita; ildottor Zaccaria Zake-ri dell'ambasciata della Repubblica Islami-ca dell'Iran presso la Santa Sede, sull'Islamsciita; Swaminj Hamsananda dell'UnioneInduista Italiana, sull'induismo; MauroBombieri. sufle tra diÀoni gaudiya;lapro-fessoressa Maria Anqela fàià dell'UnioneBuddhista ltaliana, s-ul buddhismo, assie-me a Tiziana Procesi, che purtroppo ci halasc iat idopo avere col laborato con par t i -colare competenza all 'edizione del 2ó01. ealla cui memoria vogliamo qui rendere unomaggio; il professor Karel Dobbelaere, dicui abbiamo utilizzato elementi per la rico-
lNTRODUZIONE
struzione storica e dottrinale nella schedadell'Istituto Buddhista Italiano Soka Gak-kai; il dottor Alfredo Ferraro di Genova,sul lo sp i r i t ismo e igruppi d i der ivaz ioneparapsicologica; il dottor Stelio W Vences-ìa i . su i gruppi neo- templar i . In lormazionisu realtà che hanno sede negli Stati Uniti cisono state trasmesse continuativamente dalprofessor J. Gordon Melton della BaylorUniversity (Waco. Texas) e direttore del-l'Institute for the Study of American Reli-gion, mentre il professor don Andrea Paci-ni della Facoltà Teoloeica di Torino ha cor-tesemente riletto Dartì del iesto e condivisovalutazioni di carattere statistico.Particolare cura è stata consacrata alla ri-cerca delle date di nascita e di morte di tut-te le persone defunte menzionate: anche inquesto caso, dobbiamo ringraziare per laloro cortesia sia un gran numero di re-sponsabili di movimenti, sia Ie anagrafi e iresponsabili di banche dati anagrafiche ind ivers i Paesi , dagì iStat i Uni t ia l Ciappone.Non sempre, nonostante sforzi talora lun-ghi, si sono potuti ottenere risultati, e an-che in questo caso ant ic ipatamente: i r ingrazia chi volesse trasmetterci correzionieintegrazioni in vista di edizioni future.Questa enciclopedia è, a diverso titolo,un'opera collettiva. La direzione e il coor-dinamento della ricerca e redazionale - inogni loro fase - sono di Massimo Introvi-gne e Pierluigi Zoccatelli, con i quali han-no strettamente colìaborato Raffaella DiMarzio e A nd rea Menegono, e ai quali hanno offerto un importante contributo, par-ticolarmente per i materiali confluiti nellaprima edizioni dell'opera, Verónica Roldóne Nelly Ippolito Macrina - con l'ausilio diGianluca Del Moro, Giuseppe Macrina,Eìena Riccio e Fabrizio Suinetti -. anch'es-si redattori di un certo numero di voci eche hanno inoltre svolto interviste e visitesul campo, nonché un lavoro di ricerca ar-chivistica, con la collaborazione di MariaAntonietta Massimi e Piccarda Orlandi.Al-cune schede e sezioni sono di altri collabo-ratori, anche se la presentazione che se neofÉre è il risultato d'integrazioni ed. editingda parte di Massimo Introvigne e Pierlui-gi Zoccateììi. Taìi collaboratori sono, in or-dine alfabetico:
E
21
LE RELIGIONI IN ITAL1A
. Andrea Arnaldi (elementi storici nellascheda sulla Chiesa cattolica)
. Luigi Berzano (Damanhur)
. Anàrea Cassinasco (prima versione delcapitolo sulle Chiese ortodosse, schedesulla Chiesa Cattolica Liberale e sur ra-stafariani)
. Sisto Capra (Fellowship of Isis - IstitutoShaman, 666 Realtà Satanica)
. Kennet Granholm lDragon Rouge - Ordo Draconis et Atri Adamantis)
. Michael Homer (Comunità di Cristo -Chiesa Riorganizzata di Gesù Cristo deiSanti degli Ultimi Giorni)
. Alessandro Iovino (Chiesa a Napoli)
. Constance A. lones (elementi dottrinalinelf introduzione generale all'eredità. diGurd.jieff)
. Davide Lopez (Chiesa Cristiana AnticaCattolica e ADostolica, Chiesa CattolicaNazionale Polacca, Chiesa Presbiterianadi Verona, Chiesa Evangelica Presbiteria-na di Viterbo, Chiesa Evangelica Presbi-teriana di Legnano, elementi storici nel-l'introduzione alla sezione sui battisti ri-formati, Chiesa Evangelica <Sola Gra-zia>, Chiesa Cristiana Evangelica <ForteTorre>, Chiesa Cristiana Evangelica <So-li Deo Gloria>, Chiesa Evangelica Rifor-
mata di Roma - La Storta, Chiesa Cri-stiana Evangelica <Gesù Parola di vita,,Chiesa Crisiiana Evangelica di San Laz-zaro, Chiesa Evanqelica nluce sul Santer-no>, Chiesa Evanlelica di Isola del GranSasso)
r Jean-Frangois Mayer (Associazione JakobLorbet Spiritual Human Yoga)
. I. cordon Melton (Chiesa di Scientology,Chiesa Universale e Tiionfante, Scuola diIlluminazione Ramtha, Unarius - Aca-demy ofScience)
. Silvia Scaranari Introvigne (introduzio-ne all'Islam sunnita)
. Federico Squarcini (ISKCON e altri mo-vimenti di àerivazi one gaudiya math)
. Paolo Urizzi (introduzione al sufismo ecuratela delle schede Naqshbandirya-Haqqàn i1rya al-'Aìiyya, Naqshbandip a-Vujaddidiyya, Shàdh iliyTa-îlawiyya-Ismà'îli1ya, Tijànirya)
A questi collaboratori, il cui impegno è statoessènziale per la riuscita del lavoro - senzadimenticare il bibliotecario del CESNUR,Luca Ciotta, la cui preziosa assistenza nellericerchebibliografiche,anagrafiche e archivi-stiche si è spesso rivelata assai preziosa -,va il più calóroso dei nostri ringrìziamenti.
Ì
22
1. [eb
L ebraismo èpossa vantarrininterrotta rnostante alculre, rit i dell 'anon si può parotta. La rehgtmatasi in simlnon potersi qcennare a quepalmente perI'Halakhah, <portamenlo>khet, che inditcammino - cltiva della tractoprassi ebraigadah, <<raccoserie di nanmassime, omlore etico, divterpretati- Lapretazronl peparati; tuttavì'ebraismo ficon I'Halakhste di due condifferenze flmediterrane;centro-euroIfondamentalse, anche se èelementi delnei Paesi dovesistono sinzashkenazite.piccola, nonkenaziti riur