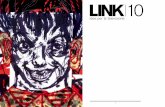Diversidad de anfibios anuros en dos sitios localizados dentro de los límites del bosque templado
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI? - UAAR
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI? - UAAR
Bimestrale dell’UAARn. 4/2017 (113)€ 4,00
ISSN 1129-566X
RELIGIONI A SCUOLA:DENTRO O FUORI?UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici RazionalistiB
imestrale–PosteItaliane
s.p.a.–SpedizioneinAbbonam
entoPostale–D.L.353/2003(conv.inL.27/02/2004
n°46)art.1,com
ma2,DCBFirenze
n.4/2017
(113)
2 n. 4/2017 (113)
In copertina: Maurizio Di Bona (www.thehand.it)
Nell’interno vignette di: pag. 3, 7-8, 14, 18, 21, 25, 29, 31, 34: fonte ignota; pag. 4, 33: UAAR(https://www.uaar.it/); pag. 9: EHF (http://humanistfederation.eu/); pag. 10-11: BHA (Bri-tish Humanist Association); pag. 12: ALBI; pag. 14: ABA (http://www.atheeshumanistes.be/blog/); pag. 20: Joshua Held (da www.aduc.it); pag. 22 Turco (Maria Turchetto); pag. 27: MauroBiani (http://maurobiani.it/); pag. 28: Moise (www.flickr.com/photos/moisevivi/); pag. 37:Vauro; pag. 38: PV (Pietro Vanessi, http://www.unavignettadipv.it).
“L’ATEO” È IN VENDITA
FeltrinelliAncona: Corso Garibaldi 35Bari: Via Melo da Bari 119Bologna: Piazza Ravegnana 1Caserta: Corso Trieste 7Cosenza: Corso Mazzini 86Ferrara: Via Garibaldi 30/aFirenze: Via de’ Cerretani 40/RGenova: Via Ceccardi 16-24/RLecce: Via dei Templari 9Milano: Via Foscolo 1-3; Piazza Piemonte 1Modena: Via Cesare Battisti 17Napoli: varco Corso A. Lucci (int. Stazione
F.S.); Via Cappella Vecchia 3 (piano –2);Via T. d’Aquino 70
Padova: Via S. Francesco 7Parma: Strada Farini 17Pisa: Corso Italia 50Ravenna: Via Diaz 14Roma: Via V.E. Orlando 78-81; Largo di Tor-
re Argentina 5-10Torino: Piazza Castello 19Varese: Corso Aldo Moro 3Verona: Via 4 Spade 2
RinascitaEmpoli (FI): Via Ridolfi 53Roma: Largo Agosta 36
Altre librerieAndria (BT): Libreria Diderot, Via L. Bono-
mo 27/29Barletta (BT): Punto Einaudi Barletta, Cor-
so Garibaldi 129Bergamo: Libreria Fassi, Largo Rezzara 4-6Bologna: Libreria IBS, Via Rizzoli 18Bolzano: Libreria Mardi Gras, Via Andreas
Hofer 4Cosenza: Libreria Ubik, Via Galliano 4Cossato (BI): La Stampa Edicola, Via Maz-
zini 77Ferrara: Libreria IBS, Piazza Trento/Trieste
(pal. S. Crispino)Firenze: Libreriacafé “La Cité”, Borgo S. Fre-
diano 20/R; Libreria Cuculia, Via dei Ser-ragli 1-3/R; Libreria IBS, Via de’ Cerreta-ni 16/R; Libreria Marabuk, Via Maraglia-no 29
Foggia: Libreria Ubik, Piazza Giordano 76Forlì (FC): La Botteghina del Libro: Via G.
Regnoli 38/aGenova: Libreria Buenos Aires, Corso Bue-
nos Aires 5/RLecce: Samarcanda libri e caffè, Via Liborio
Romano 23Mantova: Libreria IBS, Via Verdi 50Milano: Libreria Popolare, Via Tadino 18Modena: Libreria “Il tempo ritrovato”, Stra-
dello Soratore 27/ANettuno (RM): Progetto Nuove Letture,
P/le IX Settembre 8Pescara: Libreria dell’Università – Eredi
Cornacchia, Viale Pindaro 51Pisa: Libreria “Tra le righe”, Via Corsica 8Porto Sant’Elpidio (FM): Libreria “Il gatto con
gli stivali”, Via C. Battisti 50Ragusa: Società dei Libertari, Via Garibal-
di 2Reggio Emilia: Libreria del Teatro, Via Cri-
spi 6; Associazione Mag 6, Via Vincenzi13/a
Roma: Libreria “Odradek”, Via dei BanchiVecchi 57
Salerno: Edicola Elia (c/o Stazione F.S.), Piaz-za Vittorio Veneto
Scandicci (FI): Centrolibro, Piazzale della Re-sistenza 2/B
Torino: Libreria “Linea 451”, Via S. Giulia40/a; Libreria Comunardi, Via Bogino 2
Trani (BT): Luna di Sabbia, libri & caffè, ViaMario Pagano 193/195
Trento: La Rivisteria, Via S. Vigilio 23Udine: Edicola Carnevaletti, Via Bartolini 14Vicenza: Galla Libreria 1880, Corso Pal-
ladio 11Vittorio Veneto (TV), Libreria Fenice, Via-
le della Vittoria 79Viterbo: Libreria dei Salici, Via Cairoli 35;
Etruria Libri, Via Cavour 34
L’ATEO n. 4/2017 (113)ISSN 1129-566X
EDITOREUAAR – Via Ostiense 89
00154 RomaTel. 065757611 – Fax 0657103987
www.uaar.it
DIRETTORI EDITORIALIFrancesco D’Alpa
Maria [email protected]
REDATTORE CAPOBaldo Conti
GRAFICA E IMPAGINAZIONEEdizioni Polistampa
DIRETTORE RESPONSABILEEttore Paris
REGISTRAZIONEdel tribunale di Padovan. 1547 del 5/12/1996
Per le opinioni espressenegli articoli pubblicati,
L’Ateo declina ogni responsabilitàche è solo dei singoli autori.
L’Ateo si dichiara disponibilea regolare eventuali spettanze perla pubblicazione di testi, immagini,o loro parti protetti da copyright,
di cui non sia stato possibilereperire la fonte.
Contributi e articolida sottoporre per la pubblicazione,
vanno inviati per e-mail [email protected]
oppure per posta ordinaria aBaldo Conti
Redazione de L’AteoCasella Postale 755
50123 Firenze CentroTel. Fax: 055711156
Distribuzione alle librerie Feltrinelli:Joo Distribuzione
Via F. Argelati 35 – 20143 Milano
STAMPATOGiugno 2017 – Polistampa s.n.c.
Via Livorno 8/32 – 50142 Firenze
COMITATO DI REDAZIONE
Stefano [email protected]
Enrica [email protected]
Stefano [email protected]
COLLABORATORI
Stefania [email protected]
Andrea [email protected]
Marco [email protected]
Luciano [email protected]
Massimo [email protected]
Carlo [email protected]
Alba [email protected]
Federica Turriziani [email protected]
NORME REDAZIONALI
Gli articoli inviati a L’Ateo devonoavere le seguenti caratteristiche:• battute comprese fra le 6.000
e le 18.000 (spazi inclusi);• indicare i numeri delle eventuali
note in parentesi quadre, nelcorpo del testo e in cifre arabe,riunendole tutte a fine articolo(cioè non utilizzare la funzionenote a piè pagina di Word, mafarle a mano);
• citazioni preferibilmente in linguaitaliana, se straniera tradotte innota;
• qualche riga di notizie biografichesull’autore a fine articolo.
ARCHIVIO ONLINE DE “L'ATEO”
I numeri fino al 2014 sonoliberamente scaricabili all'indirizzowww.uaar.it/uaar/ateo/archivio/
Eccoci qua, miei cari, a par-lare di scuola e, in partico-lare, di insegnamento reli-gioso nella scuola.
Punto dolente, in Italia! Enon perché nel resto d’Eu-ropa – l’ambito che più ci ri-guarda – non esista l’ora direligione. Solo tre paesi nefanno decisamente a meno:Francia, Slovenia e Albania.Ma nella maggior parte de-gli altri paesi (dodici in tut-to) l’insegnamento è multi-religioso, nel senso che pre-vede diverse religioni cri-stiane (protestantesimi va-ri, cristianesimo ortodosso,cattolicesimo) e non cri-stiane (ebraismo, islam,buddismo). L’Italia fa partedello sparuto gruppetto,considerato “conservato-re” e “nazionalista”, in cui,come se vigesse ancora ilprincipio cuius regio eius re-ligio, si insegna solo la “re-ligione di Stato” (ancorchénon prevista come tale nel-le rispettive Costituzioni):da noi e in Irlanda solo quel-la cattolica, in Grecia solo quella orto-dossa e in Danimarca solo quella lute-rana.
In molti paesi l’insegnamento della re-ligione è comunque facoltativo e noncurricolare; in molti casi è alternativoa insegnamenti laici (debitamente or-ganizzati, non come la nostra fanto-matica “ora alternativa”, come ben sisa programmaticamente povera per-ché – come scrive Enrica Rota – «sivuole assolutamente evitare che facciaconcorrenza a quella di religione»): in-segnamenti di “etica”, “storia delle re-ligioni”, “filosofia pratica”, “educazio-ne alla filosofia e alla cittadinanza” –quest’ultima materia è stata recente-mente introdotta in Belgio, come ci spie-ga Yves Ramaekers dell’associazioneALBI (Action Laïque Belgo-Italienne).Ancora, in molti paesi europei (undi-ci) i titoli richiesti per insegnare reli-gione sono lauree o diplomi in teologiarilasciati da università statali, mentrein Italia (anche in qualche altro paese,per carità) basta una vaga fede com-provata da un non meglio precisatocertificato ecclesiastico.
Nel complesso, non è che ci facciamouna gran bella figura. In questo nu-mero, comunque, non ci siamo limita-
ti a lagnarci per la nostra condizionedecisamente arretrata rispetto alle at-tuali sfide del multiculturalismo: ab-biamo cercato di proporvi un quadroquanto meno europeo di come il pro-blema viene affrontato. A parte l’Ita-lia, che si segnala anche per l’immo-bilismo, la situazione in questi anni èdecisamente in rapida evoluzione. Ciscuserete quindi se in qualche casoabbiamo mancato l’aggiornamento evi invitiamo – se la sapete più lunga dinoi – a darci le dovute dritte.
Oltre alla questione dell’insegnamentodella religione nelle scuole pubblichec’è poi quella delle scuole “confessio-nali” private. Esistono ovviamente intutti i paesi europei, e in tutti sono qua-si sempre sovvenzionate a vario titolodal denaro pubblico. Ma oggi che la con-vivenza di diverse culture pone nuoviproblemi si fa strada una nuova sensi-bilità nei loro confronti: ci si rende con-to che, proprio quando diventa più chemai importante assicurarsi che le per-sone di origini differenti e differenti con-vinzioni si comprendano e rispettino avicenda, le scuole confessionali opera-no nel senso della segregazione più chedell’integrazione – come scrive Jay Har-man della BHA (British Humanist As-sociation).
Un’ultima osservazione: la battagliaper una scuola laica è davvero dura,soprattutto in un paese cattolico co-me il nostro. «Dateceli [i bambini] daicinque ai dieci anni e saranno nostriper tutta la vita», diceva l’ultracatto-lico Joseph de Maistre, fautore dell’u-nione del potere temporale e politiconelle sole mani del papa. E credete ame, le gerarchie cattoliche tengonotutt’ora ben presente questa massi-ma: non molleranno facilmente l’osso.
Maria [email protected]
3n. 4/2017 (113)
EDITORIALE
4 n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
Ore dieci, diciamo, di una normale mat-tinata scolastica. Un gruppetto di allievisi prepara ad emigrare dalla classe: perlo più islamici, qualche cinese, qualcheevangelico, uno sparuto testimone diGeova … italiani, a dire il vero, non mol-ti nella scuola primaria e media inferio-re, molti di più alle superiori, soprattut-to negli ultimi anni.
Dunque, tornando al nostro gruppettodi allievi, tutti, siano essi musulmani, ateicinesi, evangelici, Testimoni di Geova,atei italiani, odinisti [1] o pastafariani,sono costretti ad abbandonare la classeper andare a fare la lezione di “alterna-tiva”. Alternativa a che? – vi chiederete.Ma all’IRC (Insegnamento della Religio-ne Cattolica), naturalmente! Loro – i cat-tolici – spesso e volentieri se ne stannotranquillamente in classe, talvolta anchenel caso in cui siano meno numerosi diquelli di alternativa. Alla faccia della pa-rità dei diritti.
Ma seguiamo il nostro gruppetto di pro-fughi: ecco, finalmente hanno trovatoun’auletta sgangherata dove fare la le-zione – e magari, colmo dei colmi, c’è pu-re un crocifisso appeso alla parete. Macomunque si comincia. E cominciamo adire due parole sull’insegnante. Mentrequello di religione, infatti, oltre ad ave-re l’indubbio vantaggio di essere divi-
namente ispirato, è un professore di ruo-lo perché la sua materia “fa cattedra”,quello di alternativa può essere un in-segnante di qualsiasi materia (alterna-tiva “non fa cattedra”) che necessiti dicompletare il suo orario oppure che de-sideri arrotondarsi lo stipendio facendoqualche ora aggiuntiva: nessuna ispira-zione divina qui, quindi, spesso soltan-to prosaicissime questioni burocraticheo pecuniarie.
E i programmi? Be’, mentre quelli del-l’IRC sono completi e ben definiti, quellidi alternativa sono vaghi e lasciati all’ar-bitrio delle scuole o degli insegnanti, emolte volte si risolvono in un pot-pourricomprendente un po’ di educazione allacittadinanza, la lettura di qualche quoti-diano e discussioni su questioni di at-tualità – tutta roba piuttosto soft, insom-ma … Questo perché, per legge, nell’oradi alternativa non possono venire svoltii programmi curriculari delle varie mate-rie, e questo viene spesso interpretato (atorto) come un divieto di affrontare qual-siasi aspetto (anche non curriculare) del-le materie stesse, perciò niente mate-matica extra, per esempio (anche se inItalia ce ne sarebbe molto bisogno), nien-te conversazione in lingua straniera, nes-suna preparazione degli allievi per qual-cheesame linguistico internazionale, perdire, o per la patente europea di compu-
ter, edanchenienteattivitàsportivesup-plementari, oppure esercitazioni per unabanda di musica rock, eccetera: tutto ciòequivarrebbe infatti – si dice – ad offrireun ingiusto vantaggio agli allievi di al-ternativa rispetto a quelli dell’IRC – an-che se, a ben vedere, godendo della pro-tezione divina questi ultimi non dovreb-bero avere nulla da temere ed anzi do-vrebbero andare benissimo in tutte lematerie senza fare il minimo sforzo. Matant’è. Ovviamente non si vuole correreil rischio che l’ora di alternativa sia trop-po attraente per gli allievi, perché si vuo-le assolutamente evitare che faccia con-correnza a quella di religione! [2].
E così, mentre i privilegiati dell’IRC ven-gono illuminati dallo Spirito Santo e siguadagnano un sacco di punti in para-diso per il solo fatto di frequentare que-sta materia “spirituale”, gli sfigati di al-ternativa, spesso annoiati e demotiva-ti, non vedono l’ora di tornarsene inclasse per poter seguire le loro lezioni“normali”.
Come si può chiaramente comprendere,così com’è congegnata attualmente l’o-ra di alternativa costituisce una finta of-ferta formativa (già soltanto la parola “al-ternativa” sottintende il suo ruolo su-bordinato – nella fattispecie all’IRC); unaofferta formativa seria implicherebbe
Ora di alternativa: una trovata diabolicadi Enrica Rota, [email protected]
5n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
una materia seria con programmi bendefiniti e con insegnanti di ruolo, così co-me lo è l’IRC. Che l’alternativa non co-stituisca attualmente una vera e validaopzione educativa è evidente soprattut-to nelle scuole superiori, dove a questaora viene spesso preferita quella di “stu-dio individuale assistito” – traducendo:gli allievi si fanno i compiti delle altre ma-terie sotto la supervisione di un inse-gnante; o quella di “studio individualelibero” – idem come sopra ma senza in-segnante; oppure infine l’uscita dall’e-dificio scolastico, un’opzione, quest’ul-tima, che naturalmente scelgono in mol-ti, facendo anche risparmiare allo Statoun bel po’ di soldini!
E, mentre ci siamo, parliamo per l’ap-punto un pochino dei costi. Perché i co-sti ci sono, e anche alti! Secondo le sti-me, circa un miliardo di euro all’anno pergli stipendi degli insegnanti di IRC [3], alquale vanno sommati i costi degli inse-gnanti di alternativa – e dunque l’ora diIRC viene a costare allo Stato quasi ildoppio delle ore delle altre materie, es-
sendo rimasta una delle poche a preve-dere la presenza di due insegnanti sullastessa classe nella stessa ora. Una cosaindegna, visti tutti i tagli che sono statifatti all’istruzione!
Concludendo: anche se probabilmentenon era nelle intenzioni di chi l’ha pro-posta, l’ora di alternativa, così come es-sa viene attualmente e diabolicamente(!) realizzata, non fa altro che avallare egiustificare l’esistenza dell’IRC, senzaperaltro offrire una alternativa di so-stanza. Il punto è comunque sempre lostesso, cioè che l’ora di IRC, ossia di in-dottrinamento cattolico, non dovrebbeaffatto esistere nelle scuole di uno Sta-to laico e democratico, e di conseguen-za neanche quella di alternativa. Abo-lirle entrambe sarebbe di gran lungal’opzione migliore, una opzione però adoggi impossibile grazie al vecchio e alnuovo Concordato. Non restano allorache due possibilità: o rendere quello dialternativa un insegnamento veramen-te attraente per gli studenti, in grado difare seria concorrenza all’IRC (un obiet-
tivo al quale l’UAAR lavora da anni) op-pure, trattandosi in entrambi i casi dimaterie facoltative (ed è davvero incre-dibile, tra l’altro, che una materia facol-tativa come l’IRC venga insegnata daprofessori di ruolo dello Stato!) offrirleagli allievi al di fuori dell’orario scolasti-co – al pomeriggio, ad esempio – una co-sa che, se fattibile, in concreto, equi-varrebbe ad eliminarle entrambe!
Note
[1] Adoratori di Odino.[2] L’UAAR fa da anni una campagna per l’o-raalternativa,propriopermigliorare laqualitàdeisuoi insegnamenti, tra l’altro fornendoma-teriale per i docenti e collaborando su loro ri-chiesta (in proposito vedi: https://www.uaar.it/uaar/campagne/progetto-ora-alternativa/materiale-insegnanti/).[3] Ad esempio, Curzio Maltese,La questua,Feltrinelli 2008, cap. 5, “Un’ora che vale unmiliardo”. Vedi anche l’inchiesta dell’UAARI costi della chiesa, uno studio chiaro e det-tagliato sui costi della chiesa cattolica pergli italiani.
SÉVERINE MATHIEU e JEAN-PAUL WILLAIME (a cura di), Des Maîtreset des Dieux. École et réligions en Europe, ISBN 978-2-7011-4231-9, Belin, Saint Étienne 2005, pagine 304, € 20,30.
Nel primo centenario della legge del 1905 che sancì in Francia laseparazione della Chiesa dallo Stato, esce questo libro che fa ilpunto sui rapporti tra scuola e religione nei paesi europei. Si trat-ta di un testo affidato a diversi studiosi europei ma molto coe-rente nell’impostazione di fondo, ben documentato sia sulla sto-ria di tali rapporti, sia sulle tendenze allora in atto non dissimili,ci sembra, da quelle odierne. Il libro, pur risultando per certi aspet-ti datato, è perciò tuttora utile per la profondità delle analisi chepropone.
Come scrive Jean-Paul Willaime nell’Introduzione, in linea di mas-sima «le scuole, in Europa, sono fortemente secolarizzate nei pro-grammi, negli obbiettivi e nei metodi, e anche attraverso il per-sonale docente e gli allievi» e conoscono un processo di omoge-neizzazione; ciò che rimane diverso è il rapporto tra scuola e reli-gione, che dà luogo nei diversi paesi a diversi approcci, per altroin corso di trasformazione sotto la spinta della secolarizzazione edi un’accresciuta diversità religiosa. Le tendenze in questo sen-so vanno dal sostanziale immobilismo rispetto alla tradizione cheprivilegia la religione dominante del paese (Italia, Grecia, ma an-che Danimarca), all’evoluzione verso un insegnamento religiosomulticonfessionale (Inghilterra, Germania, Svizzera), alla convi-venza di approcci confessionali e laici (Belgio, Spagna, Russia), fi-no alla radicale laicità francese (condivisa solo dalla Slovenia).
In questa differenziazione giocano un ruolo importante, secondogli autori, in primo luogo il peso delle identità nazionali e del fat-tore religioso come elemento identitario (ciò spiega ad esempioeccezioni regionali come l’Alsazia-Lorena in Francia, la Tracia inGrecia o il Brandeburgo in Germania). Il vecchio principio cuiusregio eius religio ha infatti determinato in Europa una complessa“geografia confessionale” di cui gli Stati multietnici, per non par-lare degli Stati confederati, debbono tener conto. In secondo luo-go, nei diversi paesi europei lo Stato non ha ovunque un ruolocentrale nell’educazione: la competenza spetta in alcuni casi al-
le regioni (Svizzera, Germania) o è lasciata all’autonomia scola-stica (in Russia sono i direttori delle scuole a decidere l’introdu-zione o meno di certe materie) oppure viene dato un peso mag-giore all’iniziativa privata (Irlanda). Infine, la stessa laicità è in-tesa diversamente nei diversi paesi, anche se l’Unione Europeafavorisce un processo di omogeneizzazione attraverso la Con-venzione europea dei diritti dell’uomo e i numerosi indirizzi del-la Corte e del Consiglio d’Europa, garantendo quanto meno il prin-cipio della libertà di convinzione e il principio di non discrimina-zione.
Questa diversa concezione della laicità, applicata all’insegna-mento scolastico delle religioni, dà luogo a due diversi atteggia-menti che Jean-Paul Willaime definisce rispettivamente “secola-re” e “laico”. Il primo consiste nel considerare la religione comeuna delle dimensioni umane e sociali: una concezione del mondo,in ogni caso, di cui tener conto. Dal punto di vista pratico, questoapproccio si risolve nel riconoscere la religione come una disciplinaa sé. Il secondo atteggiamento, tipico dell’ordinamento francese,non considera la religione come una disciplina particolare: è unadimensione di cui si parla attraverso altre discipline, come la sto-ria, la letteratura, ecc.
La situazione europea rimane in ogni caso estremamente etero-genea. Per dare un’idea della varietà degli approcci abbiamo ri-preso dal libro curato da Séverine Mathieu e Jean-Paul Willaimeuna tavola sinottica che dà conto delle diverse soluzioni adotta-te dai paesi europei al problema dell’insegnamento della religio-ne. Abbiamo cercato, per quanto possibile, di aggiornarlo con lenovità legislative introdotte negli ultimi anni in alcuni paesi, le piùrilevanti delle quali riguardano l’Austria, che dal 2012 ha abolitola bocciatura nella materia eliminandola, di fatto, dal curriculumscolastico; e soprattutto il Belgio di lingua francese che dallo scor-so anno ha eliminato una delle due ore di religione precedente-mente previste sostituendola con l’insegnamento di “educazio-ne alla filosofia e alla cittadinanza”.
Maria [email protected]
6 n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
PaeseCondizione
di erogazione e accessoReligione insegnata Disciplina alternativa
Stato giuridico degliinsegnanti di religione
Austria
Obbligatoria con dispensa.Facoltativa nelle scuoleprofessionali. Dal 2012
non è previstala bocciatura
Cattolica, protestante, ebraica,islamica, buddista
Nessuna
All’insegnamentoprovvede la comunità
religiosa di appartenenzalegalmente riconosciuta
Belgio
Opzione obbligatoria:o corso confessionale o corso
di morale. Dal 2016un’ora viene sostituita
con l’insegnamentodi “educazione
alla filosofiae alla cittadinanza”
Cattolica, ebrea, ortodossa,protestante, islamica
Morale
Sui programmiesercita il controllo
la comunità linguistica,agli insegnanti
è richiestoun certificato ecclesiastico
di competenza
BulgariaFacoltativa e presente solo
nella scuola primariaOrtodossa, islamica Nessuna Catechista volontario
Cipro Obbligatoria con dispensa Ortodossa NessunaControllo statale,corso di teologia
nell'università statale
CroaziaFacoltativa nella primariae nella media, opzionale
nella secondariaCattolica Etica (nella secondaria)
Controllo statale,certificato ecclesiastico
di competenza
Danimarca Obbligatoria con dispensa Luterana o altre religioni NessunaControllo statale,
studi di teologia nelleuniversità statali
Finlandia Obbligatoria con dispensaLuterana o altra confessione
evangelicaEtica
Controllo statale, laureain scienze religiose nelle
università statali
FranciaNessun insegnamento
(salvo in Alsazia-Lorena)In Alsazia-Lorena cattolica,luterana, riformata, ebraica
NessunaIn Alsazia-Lorenadiacono o pastore
con controllo statale
Germania
Obbligatoria con dispensa.Aggiuntiva a richiesta
a Berlino e in Brandeburgo(l’istruzione è competenza
dei diversi Land)
Cattolica, protestante.Ebrea e islamica in alcuni
Land. Multireligiosaad Amburgo
Etica, filosofia pratica, storiadelle religioni
Controllo dei Land, corsouniversitario di teologia,certificato ecclesiastico
di competenza
Grecia Obbligatoria con dispensa Ortodossa NessunaDiploma di teologia rilasciato
dalle università statali
InghilterraObbligatoria con dispensa;non è prevista la bocciatura
Educazione religiosamulticonfessionale
con prioritàalla tradizione cristiana
NessunaControllo statale,
titolo di studio conseguitonelle università statali
IrlandaFacoltativa (obbligatoria
nelle scuole confessionali)Cattolica Nessuna
Abilitazione e certificatoecclesiastico
7n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
PaeseCondizione
di erogazione e accessoReligione insegnata Disciplina alternativa
Stato giuridico degliinsegnanti di religione
Italia Facoltativa CattolicaAttività decise scuola perscuola o nessuna attività
Abilitazione e certificatoecclesiastico, dipendente
statale
LettoniaFacoltativa come
alternativa al corso di eticaLuterana, ortodossa,
cattolica, battista, ebraicaEtica Certificato ecclesiastico
LituaniaFacoltativa come
alternativa al corso di eticaLuterana, ortodossa,
cattolica, battista, ebraicaEtica Certificato ecclesiastico
LussemburgoFacoltativa come
alternativa al corso di eticaCattolica, luterana, calvinista Etica Certificato ecclesiastico
Malta Obbligatoria con dispensa Cattolica Nessuna Certificato ecclesiastico
NorvegiaObbligatoria
con dispensa parzialeGrandi religioni,
umanesimo, eticaNessuna
Controllo statale, teologianelle università statali
PoloniaFacoltativa come
alternativa al corso di eticaCattolica, protestante,
ebraica, ortodossaEtica
Controllo statale.Certificato ecclesiastico
PortogalloFacoltativa come
alternativa al corso di eticaCattolica Etica
Controllo statale.Certificato ecclesiastico
RomaniaObbligatoria nella primaria,opzionale nella secondaria
Ortodossa, cattolicae altri 12 culti
NessunaStudi teologici
nelle università statali
Russia FacoltativaOrtodossa, islamica(ebraica e buddista
solo in teoria)Storia delle religioni
Dipende dalle regionie dagli istituti scolastici
SlovacchiaFacoltativa come
alternativa al corso di eticaCattolica Etica
Certificato ecclesiasticoo studi teologici nelle
università statali
Slovenia Nessun insegnamento
Spagna FacoltativaCattolica, protestante,
ebrea, islamicaNessuna
Certificato ecclesiastico.Lavoro a contratto
SveziaObbligatoria soloin alcune località
Multireligiosa NessunaControllo statale.
Studi in scienze religiose
UngheriaFacoltativa
ed extrascolasticaCattolica, protestante Nessuna Certificato ecclesiastico
8 n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
L’educazione
L’educazione dovrebbe preparare l’in-dividuo alle varie situazioni della vitaper poter fare di lui un membro attivodella società ed insegnare il rispetto perse stessi e per la dignità degli altri.
L’educazione dovrebbe promuovere l’o-nestà intellettuale e la capacità critica.Dovrebbe far acquisire l’amore per lostudio e far riconoscere il primato dellaragione e dell’uso del metodo scientifi-co nella ricerca della conoscenza.
L’educazione alla cittadinanza dovrebbetrovare i suoi fondamenti in una cornicedi diritti umani e responsabilità indivi-duali, fornendo le conoscenze, coltivan-do la comprensione e facendo sviluppa-re abilità critiche essenziali nel coinvol-gimento sociale e politico dell’individuo.
Dovrebbe preparare i bambini e i gio-vani alla vita in una società democrati-ca sostenuta dall’empatia, dai dirittiumani e dallo stato di diritto.
Lifestance
(Dal termine tedesco Weltanschauungtraducibile come «concezione del mon-
do, modo in cui singoli individui o grup-pi sociali considerano l’esistenza e i fi-ni del mondo e la posizione dall’uomo inesso»).
• L’educazione dovrebbe assicurareche i bambini siano informati su unavarietà di posizioni religiose e laiche eche possano avere l’autonomia nelleloro scelte.
• La scuola dovrebbe introdurre una di-sciplina accademica atta a supportarela presentazione di differenti pratichee valori di “lifestance”, al fine di ren-dere i bambini capaci di sviluppare leloro risposte personali.
• Le scuole che ricevono finanziamentipubblici non dovrebbero promuovereuna “lifestance” legata ad una partico-lare religione o ad una “non religione”come l’unica via corretta, ma insegna-re atteggiamenti valoriali, incluso l’U-manismo, fattualmente e oggettiva-mente. Laddove ai genitori o ai giovanistudenti venga offerta un’opzione edu-cativa orientata ad una particolare “li-festance”, l’Umanismo deve essere unadelle opzioni accanto alle religioni.
• L’educazione tendente a promuoverela comprensione interculturale che in-
globi punti di vista religiosi, deve ancheinserire l’Umanismo e gli stili di vita nonreligiosi includendo le prospettive e lacultura di chi non ha religione.
Alcune implicazionidella nostra politica generale
(a) Lo Stato deve supportare scuole con-nesse alle religioni o altri credo?
Molte scuole intendono insegnare co-me veri i principi derivanti dalla reli-gione, in particolare da quella cristia-na, ma non solo, e sono una realtà nel-la tradizione educativa di molti Stati.Tali scuole sono quasi sempre a variotitolo sovvenzionate in maniera più omeno cospicua dalle tasse, quindi condenaro pubblico.
L’equità, la non discriminazione e un cer-to grado di neutralità dello Stato può es-sere ottenuto se tutti i genitori abbianola possibilità di fare la scelta di una scuo-la che rifletta il loro credo, includendoscuole laiche o umaniste che insegninol’ateismo o una moralità non legata allareligione.
Tale scelta, se fosse mai data, potràanche soddisfare i desideri dei geni-tori, ma il sistema considera implici-tamente i bambini come “proprietà”dei genitori, dando a questi ultimi ildiritto all’assistenza dello Stato nel-l’educare i figli in una particolare tra-dizione religiosa o non religiosa. Ciòsignifica che quelle scuole violanol’autonomia dei bambini e dei giova-ni, rendendo molto difficoltoso uncammino che porti a conclusioni au-tonome rispetto alle domande esi-stenziali. Ciò si configura come unaviolazione della Convenzione sui di-ritti del bambino.
Educazione: la posizione dell’EHFdell’European Humanist Federation, http://humanistfederation.eu/
L’EHF (European Humanist Federation, ovvero Federazione uma-nista europea) è un’organizzazione che raccoglie più di cinquan-ta associazioni analoghe all’UAAR, in tutta Europa, dalla Spagnaalla Russia, dall’Islanda alla Grecia.
Tutte le nazioni hanno problemi legati alla sfera della religione edella laicità, ma molto spesso i problemi sono diversi e sono quin-di affrontati in maniera diversa. L’EHF, che porta tutte queste
istanze alle varie istituzioni europee, tra Bruxelles, Strasburgo eoltre, deve quindi sforzarsi di conciliare i diversi approcci distil-lando una visione comune.
Il documento che segue è un esempio di questo lavoro, relativoalle problematiche dell’educazione.
Massimo Redaelli, [email protected]
9n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
La maggior parte degli umanisti si op-pone a “scuole umaniste” proprio sul-la base di questa violazione e perchénon amano la “segregazione” deibambini legata a un credere, che è pro-prio ciò che questo sistema compor-terebbe.
L’educazione senza finanziamenti sta-tali, sia a casa che in scuole private, èun diritto garantito dall’articolo 2 delprimo ProtocolloConvenzione europeaper la salvaguardia dei diritti dell’uo-mo e delle libertà fondamentali: «Il di-ritto all’istruzione non può essere ri-fiutato a nessuno. Lo Stato, nell’eser-cizio delle funzioni che assume nelcampo dell’educazione e dell’inse-gnamento, deve rispettare il diritto deigenitori di assicurare tale educazionee tale insegnamento secondo le loroconvinzioni religiose e filosofiche».
Qualunque cosa si possa pensare sulmodo in cui l’educazione privata siacondotta, questa rappresenta comun-que una valida difesa contro uno Sta-to che potrebbe assumere uno stra-potere educativo.
(b) Le scuole che ottengono finanzia-menti pubblici devono avere l’inse-gnamento della religione fra i loro pro-grammi?
Quando le scuole non sono legate auna religione o un credo, devono co-munque impartire insegnamenti reli-giosi o connessi con una particolarefede, con lo scopo di darne mera co-noscenza, piuttosto che incoraggiar-ne il credere?
Per esempio, in Francia, come negliStati Uniti, le scuole per legge esclu-dono questa possibilità, mentre in al-tri paesi le scuole adottano un ap-proccio che in teoria appare oggettivoed educativo, sebbene talvolta na-sconda un pregiudizio nel bilancia-mento del tempo dato a materie diffe-renti o nella gamma delle materie re-ligiose e “non religiose” trattate.
Questa, per esempio, è la situazionein Inghilterra, nella quale le linee gui-da ufficiali stanno suggerendo l’inclu-
sione dell’Umanismo nei programmidi “educazione religiosa” accanto agliinsegnamenti delle principali religio-ni del mondo. Ci sono alcuni buoniesempi di questa pratica, ma la situa-zione si sta ancora evolvendo.
Approcci umanisti e laiciall’educazione religiosanon confessionale e umanista
Le organizzazioni europee umaniste elaiche mostrano una vasta gamma diopinioni su ciò che è desiderabile nell’e-ducazione religiosa, morale e umanista.
L’EHF e le associazioni umaniste e lai-che non possono dettare i modelli edu-cativi, ma l’EHF può chiarire le pro-blematicità in gioco e provare a pre-venire o rimediare a discriminazionicontro le persone basate sulla loro fe-de o sugli atteggiamenti religiosi o nonreligiosi.
Possiamo definire varie opzioni chenon offendano i principi umanisti e lai-ci (per come espressi nella nostra po-sizione di base sull’educazione) e la-sciare che la scelta fra queste opzioniabbia modalità definite in loco. Devecomunque sussistere un trattamentonon discriminatorio, equanime di tut-te le lifestance e lo Stato e le sue isti-tuzioni devono mantenere una posi-zione neutrale.
L’insegnamento delle “lifestance” reli-giose e non religiose può essere impar-tito da insegnanti impiegati e formatidallo Stato. In questo caso, un’organiz-zazione o più organizzazioni umanistedovrebbero essere consultate per la re-dazione dei programmi che riguardanol’Umanismo.
Dove ai genitori o ai giovani sono offer-te delle opzioni educative in una certa“lifestance” queste scelte devono es-sere fatte su base volontaria. Tale tipodi educazione dovrebbe essere sotto laresponsabilità di organizzazioni reli-giose o umaniste competenti che do-vrebbero prendersi la responsabilità perla formazione degli insegnanti e la ste-sura dei programmi, che devono inclu-dere un approccio standard pedagogi-co e didattico.
In alcuni paesi esiste la combinazionedei due approcci: una materia ugualeper tutti e una scelta facoltativa per igenitori e/o per i ragazzi che riguardala “lifestance”.
Esistono molti buoni esempi di “life-stance education”, inclusi alcuni spe-cificatamente umanisti, sviluppati co-me alternativa all’educazione in unaspecifica religione offerta in alcunipaesi.
Gli argomenti in gioco
Nei diversi Stati europei c’è una gran-de variazione nel trattamento delle re-ligioni e delle diverse credenze, inclu-se quelle non religiose, a scuola. Que-sto deriva dalle differenze nel back-ground religioso culturale e storico pre-senti da luogo a luogo. Ci sono moltimodi in cui queste differenze si mani-festano ed includono:
Strutture legali e amministrative dellascuola
Ognuna di queste può essere finan-ziata, completamente o in parte, dafondi pubblici. Talvolta le chiese o al-tre organizzazioni esterne possono es-sere responsabili per la “lifestanceeducation” all’interno di istituzioni lai-che (per es. una chiesa può provvede-re a un corso sulla cristianità in unascuola pubblica).
Scopo dei programmi
Un’altra chiave distintiva ha a che farecon l’ampiezza prevista dall’Istruzione.Una scuola potrebbe non offrire alcuninsegnamento rilevante; un corso suuna singola denominazione di una reli-gione (es. un corso sulla religione cat-tolica romana); un corso su una singo-la religione (es. cristianesimo); un cor-so su più religioni (es. “le sei grandi re-ligioni del mondo”); un corso sulle reli-gioni e sulla laicità (es. religioni del mon-do e umanismo).
Approccio pedagogico
Un’importante distinzione viene fattatra quei corsi che suggeriscono che unaparticolare concezione della vita (o tipodi “lifestance”, ad es. religiosa) sia cor-retta e quelli che adottano un approc-cio educativo aperto e oggettivo.
Fatti o morali
C’è inoltre la distinzione fra i corsi che siconcentrano sui “fatti” relativi alla con-cezione del mondo (es. la conoscenzadella bibbia, la storia delle religioni), equei corsi che pongono l’attenzione sul-l’insegnamento morale derivato dalle di-
10 n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
verse “lifestance” (es. educazione mo-rale cristiana o umanista).
Opzioni e diritti genitoriali e dei bambini
Talvolta i genitori possono scegliere frauna gamma di corsi alternativi (che puòessere più o meno vasta). In altri casi aigenitori è data l’opzione di ritirare i fi-gli da corsi che la scuola offre. Alcunevolte i ragazzi ad una certa età sono au-torizzati ad esercitare il loro diritto discelta.
Attività di culto
C’è un’altra questione, separata daquelle che riguardano l’insegnamento:in alcune scuole vengono svolte delleattività di culto relative ad una singo-la religione (e in questo caso possonoessere svolte da rappresentanti del cle-ro o da insegnanti). In altre scuole cipossono essere altri atti di culto reli-giosi che sono sincretici o interreligio-si e che cercano anche di includere inon credenti. Altre scuole possono nonsvolgere affatto atti di culto o qualco-sa del genere.
Dove ci sono culti religiosi questi pos-sono svolgersi in orario scolastico o aldi fuori del normale orario di insegna-mento. Inoltre possono essere obbli-gatori o facoltativi in relazione ai desi-deri dei ragazzi o dei genitori.
Nella vita reale gli approcci si presen-teranno spesso confusi e non risulte-ranno in modo chiaro da un solo prin-
cipio ispiratore. Ad ogni modo l’anali-si sulle basi di questi paradigmi saràsempre rivelatrice e aiuterà a com-prendere.
Note
• The OSCE Guidelines on Teaching aboutReligion and Beliefs in Public Schools.
• Article 2 of the First Protocol to the Eu-ropean Convention on Human Rights:L’articolo 2 garantisce che lo Stato non in-terferisca con il diritto dei genitori di cre-scere i propri figli in accordo con il propriocredo:A nessuna persona può essere negato il di-ritto all’educazione. Nell’esercizio delle suefunzioni assunte, in relazione all’educazio-ne e all’insegnamento, lo Stato deve ri-spettare il diritto dei genitori ad assicura-re tale diritto all’educazione e all’insegna-mento in conformità con le loro convinzio-ni religiose o filosofiche.
• The Convention of the Rights of theChild. L’EHF è strettamente collegata aquesti importanti articoli della Conven-zione per i diritti del fanciullo: Conventionof the Rights of the Child (CRC):Articolo 14(a) Gli Stati parti rispettano il diritto delfanciullo alla libertà di pensiero, di co-scienza e di religione. (b) Gli Stati parti ri-spettano il diritto e il dovere dei genitorioppure, se del caso, dei tutori legali, di gui-dare il fanciullo nell’esercizio del sum-menzionato diritto in maniera che corri-sponda allo sviluppo delle sue capacità. (c)La libertà di manifestare la propria reli-gione o convinzione può essere soggettaunicamente alle limitazioni prescritte dal-
la legge, necessarie ai fini del manteni-mento della sicurezza pubblica, dell’ordi-ne pubblico, della sanità e della moralitàpubbliche, oppure delle libertà e diritti fon-damentali dell’uomo.Articolo 29Gli Stati parti convengono che l’educazio-ne del fanciullo deve avere come finalità:(a) favorire lo sviluppo della personalità delfanciullo nonché lo sviluppo delle sue fa-coltà e delle sue attitudini mentali e fisiche,in tutta la loro potenzialità; (b) svilupparenel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomoe delle libertà fondamentali e dei principiconsacrati nella Carta delle Nazioni Unite;(c) sviluppare nel fanciullo il rispetto deisuoi genitori, della sua identità, della sualingua e dei suoi valori culturali, nonché ilrispetto dei valori nazionali del paese nelquale vive, del paese di cui può essere ori-ginario e delle civiltà diverse dalla sua; (d)preparare il fanciullo ad assumere le re-sponsabilità della vita in una società libe-ra, in uno spirito di comprensione, di pace,di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e diamicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, na-zionali e religiosi e delle persone di origineautoctona; (e) sviluppare nel fanciullo il ri-spetto dell’ambiente naturale.Nessuna disposizione del presente articoloo dell’art. 28 sarà interpretata in maniera danuocere alla libertà delle persone fisiche omorali di creare e di dirigere istituzioni di-dattiche, a condizione che i principi enun-ciati al paragrafo 1 del presente articolo sia-no rispettati e che l’educazione impartita intali istituzioni sia conforme alle norme mini-me prescritte dallo Stato.
(Da: http://humanistfederation.eu/our-position.php?page=education). Tradotto dall’inglese da Maria LisaRodaro.
In Inghilterra e Galles oltre un terzo del-le scuole statali è costituito da scuole“confessionali”. Si tratta di 7.000 scuo-le, frequentate da quasi due milioni diallievi e questi numeri stanno aumen-tando.
Prima di esporre i motivi per cui ritenia-mo che questa situazione costituisca unproblema vogliamo chiarire che cosa in-tendiamo con il termine “confessionale”attribuito ad una scuola. A grandi linee
ciò che caratterizza una scuola “confes-sionale” è la libertà di cui gode di poterdiscriminare su basi religiose. Può di-scriminare su basi religiose quando de-cide quali allievi accettare, può discri-minare su basi religiose quando decidequali insegnanti assumere, licenziare opromuovere e può discriminare su basireligiose nei suoi insegnamenti facendoproselitismo nei confronti degli allievi edimpartendo loro un’educazione religio-sa distorta e faziosa.
Le scuole “confessionali” e il ruolo della BHA(British Humanist Association)di Jay Harman, [email protected]
11n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
Sulla base di questa definizione non èdifficile capire perché la maggioranzadelle persone sia contraria alle scuole“confessionali”, specialmente a quel-le a finanziamento pubblico. Si tratta,dopo tutto, di scuole finanziate dalloStato che per loro natura escludono lagrande maggioranza delle famiglieche contribuiscono al loro manteni-mento. Permettere alle scuole “con-fessionali” di fare discriminazioni co-me descritto sopra non soltanto è unacosa assolutamente ingiusta, ma haanche causato enormi danni a livellosociale.
Nella nostra società sempre più diver-sificata non è mai stato così importan-te assicurarsi che le persone di originidifferenti e differenti convinzioni si com-prendano e rispettino a vicenda. In al-tre parole, l’integrazione è un elemen-to cruciale se si vuole che la diversità siaun fattore di forza e non invece una fon-te di debolezza e divisione. E qual è illuogo migliore per favorire l’integrazio-ne se non la scuola, dove i bambini nonnotano le differenze e le etichette chesono fattori di divisione all’interno del-la società?
Sfortunatamente il nostro sistema edu-cativo è caratterizzato più dalla segre-gazione che dall’integrazione e la cau-sa principale di questo è la presenzadelle scuole “confessionali”. Uno stu-dio pubblicato da tre istituti no-profitindipendenti che operano nel campodell’istruzione e dell’integrazione ha ri-levato che più di un quarto delle scuo-le primarie inglesi e quasi la metà diquelle secondarie sono segreganti sul-la base di fattori etnici, e le scuole “con-fessionali” sono notevolmente più se-greganti dal punto di vista etnico ri-spetto a quelle non confessionali. Tut-to questo non è affatto nuovo. Nel 2001,in seguito ai disordini a sfondo razzialeche si erano verificati nel nord dell’In-ghilterra, uno studio realizzato per in-carico governativo [1] rilevò come la vio-lenza non fosse esplosa nelle aree di-versificate dove gli allievi frequentava-no le scuole insieme a compagni pro-venienti da differenti religioni e cultu-re ed imparavano a conoscere le loroconvinzioni. D’altro canto, nelle zonedove invece la violenza era esplosa, lescuole mettevano in atto politiche di-scriminatorie nelle quali le affiliazionireligiose proteggono le divisioni etni-che e culturali.
È anche importante ricordare che que-sti problemi non riguardano esclusiva-
mente una particolare religione o unospecifico tipo di scuola “confessiona-le”. Le scuole musulmane hanno le lo-ro problematiche, naturalmente, maconsiderato il fatto che in Inghilterra cisono meno di 30 scuole musulmane fi-nanziate dallo Stato su un totale di piùdi 20.000 scuole statali, esse ricevonomolta più attenzione mediatica di quan-to forse si meritino. È vero che ci sonocasi di scuole musulmane che boicot-tano l’uguaglianza di genere, manife-stano atteggiamenti omofobi e cercanodi indottrinare ed isolare i bambini, matutte queste cose si verificano anche inmolte scuole cristiane ed ebraiche.
Per la verità le scuole “confessionali”sono problematiche in qualsiasi formasi presentino. Anche quelle che sonoconsiderate “moderate” – quelle tran-quille scuole rurali della Chiesa Angli-cana, per esempio – non possono sot-trarsi all’accusa di (a) etichettare i bam-bini per mezzo di fedi che essi sono trop-po piccoli per poter professare autono-mamente con sicurezza, e (b) proteg-gere dalle critiche le scuole “confessio-nali” più estreme e fondamentalistepresentandosi falsamente come rap-presentative delle scuole “confessio-nali” tout court.
E dunque che cosa sta facendo la BHAper affrontare queste questioni? Pro-babilmente il nostro ruolo più impor-tante è semplicemente quello di ac-crescere la consapevolezza del fattoche le scuole “confessionali” costitui-scono un problema. Sono così tanti an-ni che le scuole “confessionali” esi-stono in questo Paese, e sono consi-derate da molti come una parte cosìimportante del sistema educativo chesaremo già a metà strada se riuscire-mo a fare in modo che la gente si ren-da conto dei danni che procurano. Na-turalmente questo comporta mante-nere una forte presenza mediatica, fa-re ricerche che mettano in evidenzaqueste problematiche e comunicare alpubblico i risultati delle ricerche e i no-stri messaggi in maniera chiara ed ef-ficace. Una delle nostre recenti inizia-
tive a questo fine utilizza il sitoweb/blog di denuncia Faith SchoolersAnonymous [Studenti Religiosi Anoni-mi], che permette a chiunque abbiaavuto problemi in una scuola “confes-sionale” di condividere la sua espe-rienza. Dal momento della sua apertu-ra l’anno scorso abbiamo già contri-buito a smascherare una scuola priva-ta cristiana coinvolta nell’esorcismo diallievi gay, una scuola statale ebraicache dava la priorità ai futuri possibili al-lievi sulla base della vita sessuale deiloro genitori e una scuola musulmanache dissuadeva le ragazze dal cercarequasi ogni genere di lavoro. Quandocerchiamo di influenzare il Governo eil Parlamento – altra parte fondamen-tale del nostro lavoro – questi sonoesempi cruciali a sostegno della nostracausa.
E quale concezione alternativa dell’i-struzione propone la BHA? Noi cre-diamo che i nostri figli meritino un si-stema educativo migliore di quello de-scritto qui sopra – scuole che siano in-clusive di tutti, a prescindere dalleconcezioni religiose o non religiose diognuno e che permettano ad allievi diuna ampia gamma di differenti origini(religiose o non religiose) di imparareinsieme, l’uno dall’altro e reciproca-mente riguardo l’un l’altro in una ma-niera equilibrata, aperta ed integrata.Come membri del Religious EducationCouncil for England and Wales [Con-siglio per l’educazione religiosa di In-ghilterra e Galles] sosteniamo l’impor-tanza dell’educazione religiosa non co-me strumento di indottrinamento, macome mezzo per promuovere la com-prensione reciproca. E attraverso il no-stro sito web Understanding Humani-sm [Capire l’umanismo] offriamo aiutigratuiti alle scuole che cercano di ren-dere l’educazione religiosa più inclu-siva di tutti gli allievi e più conformealla loro curiosità naturale e alla lorolibertà di pensiero.
Il nostro sistema educativo è ancora benlontano da questa concezione laica enegli ultimi anni la situazione potrebbe
12 n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
anche essere peggiorata. Ma in segui-to all’intensificarsi delle nostre campa-gne, e come conseguenza del fatto chela popolazione diventa sempre meno re-ligiosa [2], non può se non avvicinarsisempre più la fine del periodo dell’in-fluenza religiosa nelle nostre scuole esulle menti dei nostri figli.
(Traduzione dall’inglese di Enrica Rota).
Note
[1] Il report completo, in inglese, è consul-tabile qui (https://goo.gl/rKplWQ).[2] Per statistiche sull’affiliazione religiosain Gran Bretagna, si veda (https://goo.gl/jVS96v).
————————
Jay Harman è il responsabile della cam-pagna sulle scuole confessionali e l’edu-
cazione della British Humanist Associa-tion. Lavora su tutte le problematiche le-gate all’educazione, dalle iscrizioni alle di-scriminazioni sul posto di lavoro, all’edu-cazione religiosa, agli atti di culto colletti-vi e al creazionismo nelle scuole. Jay fa par-te del gruppo direttivo della Accord Coa-lition per l’educazione inclusiva della cam-pagna “Iscrizioni eque”, e rappresenta laBHA nel Consiglio per l’Educazione Reli-giosa per l’Inghilterra e il Galles.
La situazione dell’insegnamento in Bel-gio è per molti aspetti simile a quelladell’Italia. In entrambi i paesi c’è, da unlato, una scuola pubblica e cosiddettalaica e, dall’altro, un insegnamento pri-vato, che è prevalentemente cattolico inBelgio, e quasi esclusivamente cattoli-co in Italia. I due sistemi d’insegna-mento sono finanziati con fondi pubbli-ci e concorrono al moltiplicarsi di queifenomeni che in Belgio vengono chia-mati “comunitarismo” (linguistico, re-ligioso, etnico, filosofico, ecc.).
Oltre la qualità degli edifici scolastici,l’ambiente che vi regna e i fondamentifilosofici, la piccola ma considerevoledifferenza tra Italia e Belgio gira attor-no alla questione dell’insegnamentodella religione.
In Belgio, innanzitutto, quale religione?Molte religioni sono infatti suscettibilidi essere insegnate dai professori desi-gnati dalle diverse autorità religiose, equindi al di fuori della scuola e delle sueistituzioni. In Italia, invece, la scelta ètra il corso di religione cattolica e il nul-la. In Belgio, la scelta è tra il corso dimorale, detta laica, e un menù compo-sto da diversi corsi di religione: cattoli-ca, protestante, ebrea, ortodossa, mu-sulmana (tutte monoteistiche e ispira-te da un medesimo Libro).
In un articolo pubblicato di recentesulla rivista Espaces de libertés, il pre-sidente del CAL (Centro d’Azione Lai-ca), Henri Bartholomeeusen osserva:«Nel momento in cui la nostra societàtende a chiudersi attorno a vecchieidentità comunitarie, nel momento in
cui la scuola si appoggia in manieramassiccia su logiche di separazione (ac-cademiche, etniche o religiose), occor-re sostenere un insegnamento inclusi-vo ed emancipatore. E questa è preci-samente la vocazione del corso di filo-sofia e di cittadinanza», ed aggiunge:«L’instaurazione di questo corso è ov-viamente una vittoria per il movimen-to laico. Ma una vittoria sbiadita, per-ché incarna uno spiacevole compro-messo alla belga» [1].
In Belgio, infatti, da qualche anno, sista discutendo e gettando le basi diun corso di “cittadinanza” alternativoall’insegnamento tanto della religio-ne quanto della morale laica, la cui de-nominazione, con un accordo rag-giunto alla meno peggio dovrebbe es-sere CPC (Cours de Philosophie et deCitoyenneté).
Fino a poco fa, la scuola belga vivevasotto il regime del cosiddetto Patto Sco-lastico del 1959. Una sorta di Concor-dato per l’insegnamento, tanto per con-tinuare il paragone con l’Italia e con ilregime istituito dall’aberrante articolo7 della Costituzione italiana. Un Con-cordato, come abbiamo detto, apertoperò a più religioni nel caso del Belgio.
Questo Patto scolastico istituiva unasorta di tregua al violento confronto tra,da un lato, i fautori di un insegnamen-to pubblico, di tutti e per tutti, il solo lo-gicamente a poter essere finanziato dal-la fiscalità generale e, dall’altro, quellidell’insegnamento cattolico che esige-vano – ed hanno ottenuto – che anchele loro reti private d’insegnamento fos-
sero in grandissima parte sovvenzio-nate dal denaro pubblico.
Ma il 12 marzo 2015 succede un fattodirompente: la Corte costituzionale dàragione ai genitori (italiani!) di un bam-bino di una scuola di Bruxelles: il lorofiglio non sarà obbligato a scegliere traun corso di religione e un corso di mo-rale laica. Questa sentenza fa giuri-sprudenza e spinge la classe politica aistituire un insegnamento alternativo enon “morale”: il cosiddetto “corso di fi-losofia e di cittadinanza” (CPC), ap-punto.
Con questa decisione, la situazione cer-tamente evolve, ma soltanto nell’inse-gnamento pubblico. In quello confes-sionale (sostanzialmente cattolico),nulla cambia. Là, gli studenti restanonella loro bolla di vetro, e tanto peggioper la cittadinanza e la filosofia. Ma, inquesto breve articolo, tralasceremo diparlare della scuola cattolica e dei suoilimiti, che gli italiani conoscono già be-ne. Esamineremo dunque, rapidamen-te, la situazione della scuola pubblica,la sola in cui si sta istituendo l’inse-gnamento della filosofia e della citta-dinanza.
Istruzione pubblica e religioni in Belgio e in Italia:la “piccola differenza”di Yves Ramaekers, [email protected]
13n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
Di per sé, il CPC è un’eccellente idea, ilcui obiettivo è «favorire le condizioni chepermettono agli allievi che provengonoda orizzonti diversi di costruire insiemeuna società».
Pensate: due ore per costruire insiemeuna società, due ore per riflettere in-sieme per un miglior benessere, per pre-parare il mondo di domani, prepararsi almondo e partecipare alla sua elabora-zione. Due ore per aprire i propri oriz-zonti, interrogarsi sul senso della vita,sintetizzare le grandi evoluzioni, dotar-si ciascuno di una cultura condivisa econtaminata da altre culture. Due ore
per inserire il proprio “io”, così impor-tante per lo sviluppo individuale, nel“noi”, noi gli esseri umani di qualsiasiorigine, di qualsiasi luogo.
La realizzazione di un tale corso avrebbepotutoessere idealmenteperfetta,se l’in-segnamento pubblico non avesse dovu-to fare nuove e ulteriori concessioni allediverse religioni e ancora una volta ta-gliare la mela in due: un’ora di religionee una di filosofia-cittadinanza, per gli al-lievi che seguono (per scelta o per co-strizione)uncorsodi religione;glialtri, os-sia tutti coloro che non vogliono sotto-porre la propria educazione alla religio-
ne, la scelta sarà tra un’ora di morale piùuna di filosofia-cittadinanza oppure dueore di filosofia-cittadinanza.
Ma le cose dovrebbero potersi sistema-re meglio, non appena si sarà un po’ sbro-gliata la matassa. Per ora passiamo so-pra con pudore sul lato farsesco di uncorso di filosofia assegnato comunque aprofessori di religione: anche questo do-vrebbe sistemarsi presto, con professo-ri specificamente formati per il nuovo in-segnamento. È probabile che quest’in-segnamento, messo su in fretta e conmezzi di fortuna, e che è soltanto ai suoiinizi, possa trovare gradualmente la sua
La Carta della laicità nelle scuole francesi
Nel settembre 2013, al rientro dalle vacanze estive, gli studentifrancesi hanno trovato affissa in tutte le 54.000 scuole statalifrancesi, insieme al tricolore e alla Dichiarazione dei Diritti del-l’Uomo del 1792, la “Carta della laicità”, fortemente voluta dal-l’allora presidente François Hollande e dal ministro dell’Educa-tion Nationale, Vincent Peillon.
Secondo Le Monde, 9 francesi su 10 erano favorevoli a questa ini-ziativa. Non sono mancate ovviamente le proteste e le critichedai vertici religiosi. Il Consiglio francese per il culto musulmanoha protestato perché la Carta contiene riferimenti all’Islam. Ilcardinale Scola ha dichiarato che «la giusta e necessaria acon-fessionalità dello Stato finisce per dissimulare, sotto l’idea di neu-tralità, il sostegno dello Stato a una visione del mondo che pog-gia sull’idea secolare e senza Dio». Come sempre più cauto e pos-sibilista, papa Francesco ha detto che «il principio di laicità chegoverna le relazioni tra lo Stato francese e le diverse confessio-ni religiose non deve significare in sé un’ostilità alla realtà reli-giosa». Ovviamente sono esentate dall’esposizione della Cartale scuole private.
La Carta, dopo un breve preambolo, consta di cinque articoli cheenunciano principi generali e altri dieci che ne regolano l’appli-cazione in ambito scolastico. Ecco il testo:
La nazione sancisce comemissione fondamentale della scuola nonsolo la trasmissione di conoscenze, ma anche la condivisione congli alunni dei valori della Repubblica.
11.. La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica esociale. Essa garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davantialla legge sull’intero territorio e rispetta tutte le religioni.
22.. La repubblica laica stabilisce la separazione tra le religioni e loStato, che è neutrale nei confronti delle convinzioni religiose o spi-rituali. Non esiste una religione di Stato.
33.. La laicità garantisce la libertà di coscienza di tutti: ognuno è li-bero di credere o non credere. Essa permette la libera espressionedelle proprie convinzioni, nel rispetto di quelle degli altri e nei li-miti dell’ordine pubblico.
44.. La laicità consente l’esercizio della cittadinanza, conciliando lalibertà di ciascuno con l’uguaglianza e la fraternità di tutti, nel con-testo dell’interesse generale.
55.. La repubblica garantisce il rispetto di tutti questi principi ne-gli istituti scolastici.
66.. La laicità della scuola offre agli studenti le condizioni adegua-te per forgiare la propria personalità, esercitare il libero arbitrio eformarsi alla cittadinanza. Essa li tutela da qualsiasi forma di pro-selitismo e da ogni pressione passibile di pregiudicare le loro liberescelte.
77.. La laicità garantisce l’accesso a una cultura comune e condivisa.
88.. La laicità consente agli studenti l’esercizio della libertà di espres-sione nei limiti del buon andamento della scuola e del pluralismodelle convinzioni.
99.. La laicità implica il rifiuto di ogni violenza e discriminazione,garantisce l’uguaglianza tra maschi e femmine e trova il propriofondamento nella cultura del rispetto e della comprensione del-l’altro.
1100.. Spetta a tutto il personale trasmettere agli studenti il senso eil valore della laicità, come pure degli altri principi fondamentalidella repubblica, nonché vigilare sulla loro applicazione nel con-testo scolastico. Il personale è altresì tenuto a portare la presentecarta a conoscenza dei genitori degli studenti.
1111.. Il personale deve essere assolutamente neutrale: nell’eserciziodelle proprie funzioni non deve pertanto esprimere le proprie con-vinzioni politiche o religiose.
1122.. Gli insegnamenti sono laici. Al fine di garantire agli studentil’apertura più obiettiva possibile alle diverse concezioni del mon-do, nonché all’ampiezza e al rigore dei saperi, nessuna materia èesclusa a priori dalla sfera scientifica e pedagogica. Nessuno stu-dente può appellarsi a una convinzione politica o religiosa percontestare a un insegnante il diritto di trattare una parte del pro-gramma.
1133.. Nessuno può appellarsi alla propria convinzione religiosa perrifiutare di conformarsi alle regole applicabili nella Scuola e nellaRepubblica.
1144.. Le norme di comportamento relative ai diversi ambienti sco-lastici, specificate nel regolamento interno, sono rispettose dellalaicità. Negli istituti scolastici pubblici è vietato esibire simboli odivise tramite i quali gli studenti ostentino palesemente un’ap-partenenza religiosa.
1155.. Con le loro riflessioni e le loro attività, gli studenti contribui-scono a far vivere la laicità all’interno del proprio istituto.
[MT]
14 n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
vera dimensione e che, alla fine, possa re-stare un solo corso di filosofia e di citta-dinanza, di due ore per tutti, con un uni-co professore appositamente formato edun po’ di ragionevole coerenza.
Piccola parentesi: in modo più generale,ci si chiede cosa c’entri la religione (co-sa eminentemente soggettiva, intima eprivata) con la scuola. E ci chiediamo, an-che, che bisogno ci sia di una scuola fon-data su un’appartenenza religiosa (ine-vitabilmente particolare e settaria) inuna società che si vorrebbe inclusiva eaperta a tutti. Sono domande fonda-mentali, che aspettano ancora di esserechiaramente formulate. In Belgio comein Italia.
A questo proposito, il presidente delCAL (Centro d’Azione Laica) conclude:
«In fin dei conti questa vicenda dimo-stra l’esistenza di due concezioni radi-calmente opposte. Da un lato, si trattadi dotare i ragazzi di una pluralità di ri-ferimenti e di strumenti di pensiero perrenderli atti alla autodeterminazione(sviluppare l’autonomia del soggetto).Dall’altro, si tratta di ancorare gli stes-si ragazzi ad un sistema di valori – o dog-mi – prima di lasciarli aprire ad altri ri-ferimenti (sviluppare un’identità delsoggetto conforme alla sua famiglia, al-la sua comunità)».
E aggiunge giustamente: «Sì dunque,il movimento laico continua a sostene-re che tutti gli allievi di tutte le scuoledovrebbero seguire due ore di filosofiae di cittadinanza alla settimana. Per-ché si tratta di una materia fonda-mentale che giustifica un corso speci-
fico che nessuna lezione di religionepuò sostituire» [2].
L’idea che dovrebbe guidare tale corsodi filosofia e cittadinanza è che tutti i ra-gazzi e le ragazze dovrebbero essere aiu-tati a sviluppare una cultura generalesolida, che permetta di fare la sintesi trai diversi altri corsi detti generali: lingue,letterature, scienze, storia, ecc., e di le-gare così pensiero, ragione, esperienzae conoscenza alla vita quotidiana del cit-tadino.
Note
[1] Henri Bartholomeeusen, «Conjuguer ap-prentissage de la liberté et de la démocra-tie?», Espace de libertés, Avril 2017 (tradu-zione in italiano a cura dell’autore di questoarticolo).[2] Henri Bartholomeeusen, idem.
————————
Yves Ramaekers è membro del Consigliod’Amministrazione dell’associazione ALBI(Action Laïque Belgo-Italienne). L’associazio-ne ALBI sostiene le persone e le associazioniche difendono, in Italia, i valori della laicità po-litica e filosofica, e che si battono per la sepa-razione tra Chiesa e Stato e per i diritti degliatei e degli agnostici, in nome del libero pen-siero. (Per saperne di più: www.albi.be).
Il primo emendamento della Costitu-zione degli Stati Uniti – oltre a enun-ciare le fondamentali libertà di parola,di stampa e di riunione pacifica – san-cisce la terzietà della legge rispetto al-la religione, vietando al Congresso e agliStati di «promulgare leggi per il ricono-scimento ufficiale di una religione o chene proibiscano la libera professione».Questo forte principio di laicità è statospesso violato, soprattutto in materiadi insegnamento scolastico e in occa-sione dei ricorrenti scontri tra evolu-zionisti e creazionisti, dando luogo auna serie di processi noti come monkeytrials (processi alla scimmia).
Il primo monkey trial risale al 1925,quando i legislatori del Tennessee ap-provarono il cosiddetto Tennessee Bu-tler Act, che dichiarava «illegale per
qualsiasi docente di qualsiasi univer-sità, scuola secondaria e ogni altra scuo-la pubblica […] insegnare qualsiasi teo-ria che neghi la storia della creazionedivina dell’uomo qual è insegnata nel-la Bibbia, e insegnare invece che l’uo-mo è derivato da un ordine inferiore dianimali». L’Unione Americana per i Di-ritti Civili (ACLU) si offrì allora di so-stenere le spese legali per qualsiasi in-segnante che fosse disposto a sfidarela legge. Lo fece John Thomas Scopes,un semplice supplente di biologia in unascuola superiore di Dayton, una picco-la cittadina del Tennessee, che avevasvolto il suo breve incarico spiegandoagli studenti la teoria di Darwin. Il pro-cesso che ne seguì divenne un caso di-scusso oltre i confini nazionali e tennebanco per mesi sulla stampa, che coniòper l’occasione l’espressione monkey
trial illustrandola con vignette che ri-traevano scimmioni seduti ai banchidella giuria o tra il pubblico.
Dalla vicenda giudiziaria vennero trattiracconti, lavori teatrali e il celebre filmInherit the wind con Spencer Tracy (ve-
Processi alla scimmiadi Maria Turchetto, [email protected]
15n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
di Box). La ACLU fornì a Scopes un av-vocato di grande prestigio, Clarence Dar-row, mentre l’accusa venne sostenutada William Jennings Bryan, due voltecandidato alla presidenza USA e segre-tario di Stato sotto la presidenza Wilson:uno scontro tra titani. Di W.J. Bryan è tri-stemente nota la seguente frase, ripor-tata in numerosissimi testi e commenti:«tutti i mali di cui soffre oggi l’Americasi possono far risalire alla teoria dell’e-voluzione. Sarebbe meglio distruggeretutti i libri che sono stati scritti e salva-re unicamente i primi tre versetti dellaGenesi».
Scopes perse la causa, venne condan-nato al pagamento di un’ammenda e ab-bandonò l’insegnamento. Solo qua-rant’anni dopo la Corte Suprema dichiaròincostituzionale il Tennessee Butler Actin quanto in contrasto con il primo emen-damento della Costituzione.
Forse è il caso di fare una riflessione ul-teriore su questo primo monkey trial. Og-gi siamo abituati a considerare il cosid-detto “darwinismo sociale” come un’i-deologia reazionaria e razzista – come ineffetti fu negli anni ’30 e ’40 del Nove-cento – ma negli anni ’20 ne circolavanoversioni progressiste e socialiste. In par-ticolare, negli Stati del sud degli USA, latesi autenticamente darwiniana del“monogenetismo”, ossia l’idea che le di-verse razze umane appartenessero tut-te alla medesima specie, veniva giocata
in funzione antirazzista. Probabilmentei promulgatori del Tennessee Butler Actpensarono anche a questo aspetto delpensiero darwinista, e il monkey trial diDayton aveva alle spalle anche la gran-de popolarità e influenza politica di cuigodette il Ku Klux Klan negli anni ’20.
Ma veniamo al secondo, molto più re-cente, round dei processi alla scimmia.Nel 1981 venne proposto in numerosiStati dell’Unione, e poi approvato inArkansas e in Louisiana, il BalancedTreatment Actche obbligava i professoridi scienze a insegnare, oltre alla teoriadell’evoluzione, anche la “scienza dellacreazione”. Dopo un primo pronuncia-mento di incostituzionalità da parte diun tribunale distrettuale dell’Arkansasdel 1982, nel 1987 intervenne la CorteSuprema dichiarando che il BalancedTreatment Act costituiva una violazionedel primo emendamento.
I creazionisti, tuttavia, non demordono.Poiché il monkey trialdel 1987 aveva con-testato il termine “scienza della crea-zione”, introducono quello di “disegnointelligente”, in modo da svincolarlo dariferimenti espliciti ai testi sacri. Nel 2004il distretto scolastico di Dover, in Penn-sylvania, stabilisce che, prima delle le-zioni di biologia in cui si spiega l’evolu-zione, gli insegnanti debbano leggere lafrase «poiché la teoria di Darwin è unateoria, continua ad essere in discussio-ne. La teoria non è un fatto» e suggeri-
re agli studenti la lettura di Of Pandasand People, un libro di testo per le scuo-le superiori che sostiene il “disegno in-telligente” (si tratta del libro che intro-duce per la prima volta il termine). Danotare che sia la frase obbligatoria sia iltitolo del libro consigliato contengono ri-ferimenti polemici agli scritti del grandebiologo evoluzionista Stephen J. Gould– in particolare a L’evoluzione come fat-to e come teoria (1981) e a Il pollice delpanda (1980) – una delle voci più auto-revoli contro il creazionismo.
Si va ancora per vie legali. Alcune fami-glie di studenti citano in giudizio i diri-genti scolastici di Dover, sostenendo chehanno violato il primo emendamento del-la Costituzione. Questo nuovo monkeytrial si svolge nel 2005 e vede al bancodei testimoni il biologo Kenneth Miller.Più che una deposizione, Miller svolgeuna splendida lezione affermando, inconclusione, che la frase che viene lettanelle scuole di Dover è «terribilmentedannosa, dato che mette in discussioneil valore scientifico dell’evoluzione, diceagli studenti che la scienza non è atten-dibile e quindi non è una professione daseguire. La verità è che non c’è alcunacontroversia in campo scientifico sullateoria dell’evoluzione». «La lezione è fi-nita», dice a quel punto il giudice JohnE. Johnes III del distretto di Harrisburgdove si svolge il processo. E sentenziache il disegno intelligente non è scienza,che «non può distinguersi dai suoi pre-
STANLEY KRAMER, E l’uomo creò Satana (USA, 1960), conSpencer Tracy, Fredric March, Gene Kelly, Dick York.
Il titolo originale di questo film, che racconta il monkey trial del1925, è Inherit the Wind, “ereditare il vento” (il titolo adottato perl’edizione italiana lascia molto a desiderare), con riferimento al ver-setto della Bibbia «chi getta lo scompiglio in casa sua erediterà ilvento» (Proverbi, 11:29) citato nell’arringa finale dall’avvocato di-fensore dell’insegnante (John T. Scopes nella realtà, il prof. Ca-tes nel film) arrestato per aver insegnato in una scuola di Daytonla teoria dell’evoluzione. Tale arringa, riproposta nella sceneg-giatura con le testuali parole impiegate dall’avvocato ClarenceDarrow (Henry Drummond nel film, interpretato da un indimen-ticabile Spencer Tracy), accusa i fanatici cristiani di «mettere l’uo-mo contro l’uomo e un credo contro un altro credo», col risultatodi «farci marciare all’indietro con bandiere spiegate e rulli di tam-buri verso i tempi gloriosi del Cinquecento, quando i bigotti ac-cendevano le fascine per dare alle fiamme gli uomini che osava-no portare l’intelligenza e l’illuminazione e la cultura alla menteumana».
A uno spettatore contemporaneo il film suona forse un po’ enfa-tico e teatrale (del resto da un vecchio lavoro teatrale era tratto);risulta comunque interessante per la seria e rigorosa ricostruzio-ne storica e godibile soprattutto per la recitazione di SpencerTracy e Fredric March (che per questa interpretazione vinse aBerlino l’Orso d’argento).
Del film è stato proposto un remake piuttosto fedele, 1925: pro-cesso alla scimmia (USA, 1988), diretto da David Green; non a ca-so, il film fu girato subito dopo il monkey trial del 1987, che videla sconfitta dei creazionisti.
Un’ultima curiosità: anche i creazionisti hanno tentato la viadel cinema con il film Expelled: no intelligence allowed (USA,2008) diretto da Nathan Frankowski, con l’intento di denun-ciare «la cospirazione scientifica che vuole cacciare Dio dai la-boratori e dalle scuole del Paese». Il protagonista rivela infattial mondo che tutti coloro che rifiutano di credere alla teoria del-l’evoluzione sono oggetto di una persecuzione sistematica etenta di dimostrare che il darwinismo ha condotto l’umanità al-l’ateismo, al materialismo, al razzismo, ai gulag del comunismo,alle leggi razziali fasciste, al nazismo e all’Olocausto. Il film èstato stroncato senza pietà dalla critica (il New York Times loha definito «una lunga, blaterante teoria cospirativa masche-rata da inchiesta investigativa»). Alcuni scienziati hanno ri-sposto annunciando scherzosamente il sequel Sexpelled, chemette in scena il conflitto tra due teorie sulla riproduzione uma-na: la teoria del sesso e la teoria delle cicogne. I sostenitori del-la teoria delle cicogne affermano che insegnare ai giovani lateoria del sesso conduce a oscenità e perversioni, tant’è veroche Hitler, Stalin e Mao sostenevano la teoria del sesso – e pro-babilmente lo avevano perfino praticato.
[MT]
16 n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
decessori creazionisti, e quindi religio-si», e che quindi la sua promozione daparte del distretto scolastico viola il pri-mo emendamento della Costituzione.
Eppure la questione non è ancora chiu-sa. I creazionisti e il potente DiscoveryInstitute – un think tank con uffici a Seat-tle, noto per la sua campagna, intitolataTeach the Controversy (insegna la con-troversia), per portare l’insegnamentodelle credenze del creazionismo nei cor-si scientifici delle scuole superiori – la-vora negli ultimi anni su due strategie:da un lato, rielaborando l’idea del “dise-gno intelligente” evitando non solo ogniriferimento ai testi sacri ma anche qual-siasi qualificazione (tanto meno in ter-mini di God) dell’intelligente personag-gio che avrebbe messo in atto l’intelli-gente disegno; dall’altro, promuovendola falsa impressione che l’evoluzione siauna “teoria in crisi” a causa di un’ampiacontroversia all’interno della comunitàscientifica. Avremo nuovi monkey trials?
Per concludere, è il caso di ricordare cheanche l’Italia ha avuto il suo monkey trial– anche se la vicenda non è passata perle aule giudiziarie. Mi riferisco al DL 19febbraio 2004, n. 59 con cui l’allora mini-stro dell’istruzione Letizia Moratti eli-minò con un colpo di spugna l’insegna-mento della teoria dell’evoluzione daiprogrammi scolastici. Ci furono interro-gazioni parlamentari, decine e decine discienziati si sdegnarono e scrissero arti-coli di fuoco, tanto che il ministro Morat-ti fece marcia indietro: non solo promisedi reintegrare nei programmi scolasticile teorie darwiniane, ma istituì una com-missione con il compito di indicare i cri-teri migliori per l’insegnamento delle ma-
terie scientifiche in generale e dell’evo-luzione in particolare. La commissione,presieduta da Rita Levi Montalcini, do-po alcuni mesi consegnò al ministro la re-lazione, che misteriosamente ... scom-parve, per ricomparire in una versioneampiamente corretta e purgata da ze-lanti censori ministeriali. Nuove prote-ste, finché la Moratti dovette obtorto col-lo accettare il documento e far rientrarel’insegnamento dell’evoluzione nellescuole. Con una formula – per altro infi-lata in un decreto legge riguardantetutt’altro argomento – che così recita: «Ilglobo terracqueo, dimensioni e struttu-ra. Origine, evoluzione, ere geologiche, ifossili. Darwin». Come commentò un’in-segnante di scienze su questa rivista (ve-di bibliografia): «il nostro eroe (Darwin)torna sì, ma chiuso com’è tra due punti,senza né ah né bah, sembra invitato a to-gliersi al più presto dai piedi».
Nota bibliografica
Gli articoli, le ricostruzioni e i commenti deimonkey trials sono moltissimi. Le stesse vocidi Wikipedia (soprattutto quelle in inglese,come Scopes Triale Monkey Trials) sono mol-to complete e documentate.Sul monkey trialdi Dalton del 1925 rimane in-superata la ricostruzione proposta e com-mentata da Stephen J. Gould in Una visita aDalton (in Quando i cavalli avevano le dita.Misteri e stranezze della natura, Feltrinelli,1984, pp. 266-282). Su questa vicendagiudiziaria segnalo inoltre un interessante ar-ticolo di Giovanni Boaga, Il “processo dellescimmie” (http://goo.gl/0zJOHH) com-parso anche in una versione semplificata nel-la rubrica Accadde oggi di Iniziativa Laica(http://goo.gl/WGUbRu).Sul Balanced Treatment Act e sul processodel 1987 è scaricabile da internet un lungo ed
esauriente testo (per altro piuttosto tecnicosul piano giuridico) di Randy E. Schim-melpfenning, Louisiana’s Balanced TreatmentAct and the Establishment Clause Edwardsv. Aguillard (https://goo.gl/OiwzX5).Una ricostruzione molto chiara e ben argo-mentata si trova inoltre alla voce Edwards v.Aguillard di Wikipedia inglese.Del processo del 2005 (Kitzmiller v. Dover AreaSchool District) è contenuta una bella rico-struzione nel libro di Nicola Nosengo e Danie-la Cipolloni, Compagno Darwin. L’evoluzioneè di destra o di sinistra?, Sironi, 2009. Il libro, at-tualmente scaricabile da internet, è interes-sante anche per molti altri aspetti. Su questoprocesso ha scritto un libro ricco di considera-zioni interessanti il biologo che vi fu chiamatocome testimone: Kenneth Miller, Only aTheory. Evolution and the Battle for American’sSoul, Viking Adult, 2008. Benché non faccia ri-ferimento al processo, essendo stato scrittoprima, ma all’affermazione dei creazionisti «lateoria non è un fatto» che circolava ampia-mente negli USA, rimane fondamentale la let-tura del saggio di Stephen J. Gould, L’evolu-zione come fatto e come teoria (in Quando i ca-valli avevano le dita. Misteri e stranezze dellanatura, Feltrinelli, 1984, pp. 255-265).La vicenda italiana di cui si è parlato in chiu-sura è stata tempestivamente seguita dallanostra rivista, con gli articoli Maria Turchet-to, Darwin censurato. MicroMega e i misteridei ministeri, L’Ateo n. 1/2006 (42), pp. 8-10(Telmo Pievani, in L’Affare Darwin/Moratti.Un giallo darwiniano al ministero, MicroMe-ga n. 20, ottobre 2005, ha fornito una splen-dida ricostruzione della curiosa scomparsadella relazione firmata da Rita Levi Montalci-ni e della sua ricomparsa in forma purgata;quello stesso numero della rivista proponevaun confronto sinottico del testo originale e diquello emendato) e Alessandra Magistrelli,Insegnare scienze naturali nella scuola supe-riore italiana, in L’Ateo n. 1/2007 (49), pp. 5-6(che racconta tra l’altro come andò a finire il“giallo darwiniano”).
Agli inizi del Novecento, mentre la sto-ria italiana si preparava ad affrontare unlungo periodo di apnea per le libertà, unodei più grandi studiosi della libertà reli-giosa, il giurista Francesco Ruffini, ele-vava la sua voce per affermare la neces-sità che la scuola fosse aconfessionale.
Si dovrà aspettare il 1989 quando la Cor-te Costituzionale, con la celebre sen-tenza n. 203, definisce lo Stato “laico”ed erge la laicità a Principio supremodell’ordinamento, caratterizzante unodei profili della forma di Stato delinea-ta nella Carta costituzionale. Una sen-
tenza di portata storica che giunge tranumerose difficoltà: la laicità non eramenzionata esplicitamente nel nostrotesto costituzionale, quindi i giudicihanno dovuto evincerla dall’interpre-tazione di alcuni suoi articoli, in un con-testo che risentiva, e risente ancora, de-
Laica scuola in laico Stato. A proposito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1388 del 27.03.2017di Silvia Baldassarre, [email protected]
17n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
gli effetti del favor accordato dal regi-me fascista alla religione cattolica.
A distanza di quasi trent’anni da quel-la sentenza possiamo davvero ritener-ci uno Stato laico? Indubbiamente il ter-mine laicità è entrato nel nostro voca-bolario quotidiano, ma appare essereun significante senza significato, unaformula che non si pone più in discus-sione ma che in realtà risulta esseremolto discutibile.
Cosa significa per lo Stato essere laico?Lo chiarisce ancora una volta la CorteCostituzionale in un’altra celebre sen-tenza, la n. 508 del 2000, quando ponea carico dello Stato un obbligo di im-parzialità e di equidistanza dalle diver-se credenze in campo religioso.
Eppure conviviamo con una lapalissia-na contraddizione: uno Stato laico chesopporta ed a volte supporta la pre-senza di simboli di un solo credo nei luo-ghi pubblici, nei tribunali, all’entrata deicimiteri, nelle scuole ove si devono for-mare criticamente e pluralisticamentele menti di ragazze e ragazzi; nei pro-grammi scolastici si prevede, seppur co-me facoltativo, l’insegnamento della re-ligione cattolica; l’elenco potrebbe es-sere molto lungo. Una laicità sui gene-ris o forse “battezzata”, enunciata conuna formula che, se fosse applicata con-cretamente, farebbe del nostro uno Sta-to veramente laico; invece viene co-stantemente calpestata nella fattualità,tanto da far sembrare incerta l’abroga-zione del principio confessionista av-venuta con la revisione dei Patti late-ranensi nel 1984.
In questo quadro si pone la recente sen-tenza n. 1388 della VI sezione del Con-siglio di Stato, che ha riformato la sen-tenza n. 166/2016 con la quale il TARdell’Emilia Romagna ha annullato la de-libera del Consiglio d’istituto dell’Isti-tuto comprensivo n. 20 di Bologna, au-torizzante l’apertura di tre plessi scola-stici in orario extra scolastico per le be-nedizioni pasquali. Ripercorriamo bre-vemente la vicenda: tre parrocchie diBologna avevano chiesto il permesso dicompiere il rito della benedizione pa-squale per gli alunni della scuola di ri-spettiva competenza territoriale.
Il Consiglio d’istituto delibera (deliberenn. 50/2015 e 52/2015) l’apertura dei lo-cali scolastici a condizione che le bene-dizioni avvengano in orario extra scola-stico e sotto la sorveglianza degli adultiaccompagnatori dei bambini. Avverso
tale delibera un gruppo di docenti, ge-nitori ed il Comitato Bolognese Scuola eCostituzione, supportati economica-mente dall’UAAR, propone ricorso alTAR, ritenendo che lo svolgimento di unrito religioso, seppur fuori dall’orario sco-lastico e senza obbligo di partecipazio-ne degli alunni, avrebbe accostato l’isti-tuzione scolastica al cattolicesimo, le-dendone di conseguenza l’imparzialità,la neutralità, la laicità, l’aconfessionalità,oltre a creare discriminazione nei con-fronti degli studenti non credenti o cre-denti in altre religioni.
Il TAR accoglie il ricorso ed annulla ladelibera, affermando che il rito della be-nedizione non rientra in quelle attivitàche realizzano la funzione della scuolacome centro di promozione culturale,sociale e civile per le quali l’art. 96, com-mi 4 e 6, del T.U. in materia di istruzio-ne (d.lgs. 297/94), autorizza l’impiegodegli edifici e delle attrezzature scola-stiche fuori dall’orario delle lezioni.
Afferma il TAR: «[...] Le attività di cul-to religioso attengono alle pratiche diesercizio del credo confessionale di cia-scun individuo e restano confinate nel-la sfera intima del singolo, mentre unarilevanza culturale, non lesiva della li-bertà religiosa e non incompatibile coni principi di laicità dello Stato – quindinon escludente quanti professano unafede religiosa diversa o sono atei – han-no tutte le attività che, nel diffondereelementi di conoscenza e approfondi-mento circa le religioni, la loro storia ele relazioni nel tempo intessute con lacomunità, contribuiscono ad arricchireil sapere dei cittadini e ad assecondarein tal modo il progresso della società».
La pronuncia del TAR viene però rifor-mata in secondo grado dal Consiglio diStato che ritiene invece legittima la con-cessione di un locale scolastico per lacelebrazione della benedizione pa-squale, a condizione che l’evento si svol-ga al di fuori dell’orario di lezione e suadesione volontaria. Il Consiglio di Sta-to afferma che la benedizione pasqua-le è un rito religioso che vuole ricorda-re la presenza di Dio nei luoghi dove sivive o si lavora; quindi ha senso che sisvolga nella scuola alla presenza di chivolontariamente decide di partecipare.La volontarietà della partecipazioneesclude la lesione della libertà religio-sa dei credenti in altre fedi o dei noncredenti.
Il Consiglio di Stato inoltre esprime unrilievo critico in chiaro stile censorio:
«[...] c’è da chiedersi come sia possibi-le che un (minimo) impiego di temposottratto alle ordinarie attività scola-stiche, sia del tutto legittimo o tollera-bile se rivolto a consentire la parteci-pazione agli studenti ad attività “para-scolastiche” diverse da quella di cuitrattasi, ad esempio di natura cultura-le o sportiva, o anche semplicemente ri-creativa, mentre si trasformi, invece, inun non consentito dispendio di tempose relativo ad un evento di natura reli-giosa, oltretutto rigorosamente al difuori dell’orario scolastico».
Infine, in contrasto con il TAR dell’E-milia Romagna, i giudici di Palazzo Spa-da affermano che lo svolgimento di unrito religioso ben può rientrare nelle at-tività che realizzano la funzione dellascuola come centro di promozione cul-turale, sociale e civile, e quindi può rien-trare nella previsione di cui all’art. 96del Testo Unico in materia di istruzione.Una sentenza, quella del Consiglio diStato, che arriva a fine marzo 2017,quando le benedizioni pasquali del 2016sono già state abbondantemente offi-ciate e giusto in tempo per legittimarele prossime dell’anno scolastico 2016/17e le future!
A parere di chi scrive un rito religiosodovrebbe essere svolto nelle sedi a ciòadibite o, come nel caso delle benedi-zioni pasquali, nelle case delle famiglieche ne fanno richiesta. I genitori, cui ègarantito il diritto di educare i propri fi-gli secondo le proprie convinzioni reli-giose (ed il dovere poi di lasciar cresce-re autonomamente e criticamente il lo-ro pensiero), potranno accompagnare iloro bambini nelle chiese, potranno farassistere legittimamente il proprio fi-glio alla benedizione della casa familia-re, senza pretendere che una scuola sitrasformi in una chiesa, senza preten-dere che l’istituzione per eccellenza perl’esercizio del libero pensiero diventiveicolo per continuare a tramandare unsolo credo. Una delle finalità essenzia-li della scuola pubblica è di contribuirealla formazione di una mentalità aper-ta al dialogo, al confronto, al riconosci-mento ed al rispetto della diversità, inpoche parole alla formazione di unamentalità laica.
Non si comprende quindi come conti-nuare ad assicurare una posizione diprivilegio, attraverso l’autorizzazione diriti, simboli, insegnamenti di una solareligione, possa contribuire a rendereaperta e plurale la mentalità dei ragaz-zi. Privilegiare significa differenziare i
18 n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
piani attraverso una scala di superio-rità ed inferiorità. È così che la laicitàviene costantemente calpestata, men-tre essa è uno degli strumenti più effi-caci per assicurare una pacifica convi-venza tra le diverse credenze teiste, nonteiste ed atee.
La responsabilità di chi continua a rin-viare l’attuazione concreta del Princi-pio di laicità è grave: irridere questa te-matica, sminuirla, denigrarla, evitarla,continuare a sostenere la superioritàdella tradizione cattolica su tutte le al-tre cosmogonie teiste e non teiste non
fa altro che instillare direttamente edindirettamente nelle nuove generazio-ni un contorto senso di appartenenzaad una religione, che sfocia nel ritene-re giusto tutto ciò che ad essa si confor-ma ed ingiusto tutto ciò che con essacontrasta.
Alla logica dell’aut-aut, oppositiva e con-flittuale, di chi continua a ritenere asso-luto il proprio punto di vista, forse è oradi sostituire la logica dell’et-et, dell’in-clusione, della convivenza pacifica, del ri-conoscimento e del rispetto dell’altro dasé. La scuola non può rinunciare, in no-
me di tradizioni sempre più obsolete nel-la nostra società plurale, ad una dellesue funzioni principali, quella di esserepalestra di esercizio della ragione, dellospirito critico, della laicità intesa non co-me semplice opinione, ma come tuteladella libertà di averne una.
————————
Silvia Baldassarre, nata a Popoli (Pescara) il25.05.1989. Laureata in Giurisprudenza pres-so l’Università di Teramo; abilitata all’eser-cizio della professione forense; attualmenteDottoranda di ricerca in Giurisprudenzapresso l’Università di Padova.
«Se insegni, insegna allo stesso tempo a du-bitare di ciò che insegni».
(J. Ortega y Gasset)
L’ora di religione. L’ho sempre fre-quentata, poiché rifiutarmi sarebbe sta-to un anatema per mia madre, cresciu-ta in un ambiente ultracattolico per cuiblasfemo sarebbe stato perfino assi-stere a una messa che non fos-se in latino. Tuttavia, non ricor-do molto, ho come il sospettoche non seguissi affatto, tenen-domi quell’ora scarsa per fanta-sticare sul mio futuro. Ma devodire che dai pochi ricordi rimasti,soprattutto durante il liceo, l’o-ra di religione era uno spazio diconfronto e di riflessione. Nonl’ho mai vista come un indottri-namento, sebbene il nostro in-terlocutore fosse un prete. Soche non è sempre così, sono sta-to fortunato.
Lasciando momentaneamenteda parte il giudizio sull’oppor-tunità di dare a scuola un pesocosì grande a una sola religio-ne o alla religione stessa e i co-sti sostenuti dallo Stato per pa-gare questi insegnanti, ciò chequi mi preme è farvi rifletteresull’innegabile condizionamento fami-gliare che subiscono i più piccoli i qua-li non hanno certo il potere di esimer-si dal frequentare l’ora di religione, puressendo per legge facoltativa. Ma fa-
coltativa non può essere la scelta di unragazzo che non ha (ancora) gli stru-menti critici per sostenerla con co-scienza. Di qui la contraddizione.
Mi chiedo: come mai a scuola non mi èmai stata insegnata educazione civi-ca? Alle scuole medie, invero, nella miasezione sperimentale inserirono un’o-ra a settimana di questa materia, ma se
andassi ora in soffitta troverei il mio li-bro ancora nel cellofan. Perché? Per-ché la professoressa era la stessa checi insegnava anche italiano, storia, epi-ca, poesia e preferiva dare più spazio
a queste piuttosto che farci rifletteresul vivere insieme. Materie fondamen-tali per la nostra formazione, ma la pra-ticità di un’educazione civica, a pen-sarci ora, ci avrebbe fornito qualchestrumento in più per interpretare larealtà in cui viviamo.
Dico educazione civica e non filosofiaper non spaventare chi della filosofia ha
una visione distorta – cioè prati-camente tutti. Ma filosofare nonè altro che coltivare il pensiero el’arte del ragionamento, insom-ma sviluppare una coscienza cri-tica utile alla nostra vita e al vi-vere comune. Con le dovute dif-ferenze di metodo, la filosofia èuna materia, o meglio un modo dispronare a riflettere, che an-drebbe praticato a tutte le età.Certo, c’è anche chi attraverso lafilosofia dedica la propria vita acercare di capire come spezzareun capello in quattro, ma di ma-niaci ce n’è ovunque.
In questa direzione, all’inizio del2017, è arrivata sui nostri giorna-li la notizia che l’Irlanda avrebbedeciso di introdurre l’insegna-mento della filosofia – ancorché,per il momento, solo attraversobrevi corsi facoltativi – fin dalle
scuole elementari. E perché un Paese do-vrebbe investire sulla filosofia? Non sa-rebbe meglio investire su altro, come lematerie scientifiche, economiche o tec-nologiche? No, e il perché lo spiega l’as-
Più filosofia per tuttidi Stefano Scrima, [email protected]
19n. 4/2017 (113)
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
sennato presidente irlandese MichaelHiggins: «L’insegnamento della filoso-fia è uno degli strumenti più potenti cheabbiamo a nostra disposizione per farimparare ai ragazzi come comportarsi inmaniera libera e responsabile in un mon-do che è sempre più complesso, inter-connesso e incerto». È ovvio, che ce nefacciamo della tecnologia se non sap-piamo come armonizzarla alle nostre vi-te, se ci fa male invece che aiutarci a mi-gliorare la società?
Naturalmente non è tutto così semplice,non basta inserire la filosofia nei pro-grammi scolastici per ritrovarci magica-mente in una società perfetta. Ma è sìnecessario far diventare la scuola un ve-ro e proprio laboratorio di pensiero, do-ve i ragazzi inizino a confrontarsi tra lo-ro insieme agli insegnanti su ciò che licirconda. Inoltre, non ha molto senso co-stringere gli studenti a studiare cose che
gli serviranno in futuro senza però spie-gargli come e perché. Ha senso inveceguidarli a ragionare sul significato e l’im-portanza di quello che fanno. E in que-sto la filosofia può tornare molto utile.Filosofia che, attenzione, non va confu-sa con lo studio della storia della filoso-fia fine a se stesso che solitamente si at-tua nei licei – quella è storia, per quantoutile, ma non filosofia. Ecco da dove ar-rivano i pregiudizi che danno della filo-sofia una visione così distorta. Non dob-biamo rischiare di finire, come dice Se-neca nelle sue Lettere a Lucilio, «con l’im-parare per la scuola e non per la vita».
Ciò che è necessario alla formazione de-gli individui è un metodo filosofico, chepuò essere anche veicolato attraversola storia della filosofia, ma che deve es-sere poi messo in pratica, sperimenta-to, finanche messo in discussione da pe-sate argomentazioni per arrivare a nuo-
vi equilibri. Fine ultimo la coscienza cri-tica, la consapevolezza del peso dellenostre azioni, della responsabilità, del-la libertà, del vivere insieme.
Per quanto mi riguarda si può anchecontinuare ad avere nelle scuole la fa-coltativa ora di religione, ma al suo fian-co devono costruirsi spazi di riflessione– questi sì, obbligatori. Perché nellascelta consapevole è custodito tutto ilnostro futuro e non si può parlare di so-cietà libera precludendo ai nostri figlidi scegliere chi essere e cosa pensare.Non possono essere i genitori o peggiolo Stato a decidere per loro. I figli van-no sempre guidati e protetti, ma all’in-terno di una cornice che permetta lorodi esprimersi e formarsi una propria vi-sione del mondo. E questo, senza stru-menti che solo noi possiamo trasmet-tere, non potranno mai farlo, e nemme-no immaginarlo.
L’idea dell’obiezione di coscienza, valea dire il rifiuto per ragioni etiche diadempiere a un obbligo imposto dallalegge, trova la sua origine nella propo-sta della disobbedienza civile avanzatada Henry David Thoreau nel saggio Re-sistance to Civil Government, più notocol titolo Civil Disobedience, del 1849[1]. In questo saggio Thoreau giustifi-cava il suo rifiuto di pagare le imposteal fine di boicottare la politica schiavi-sta e guerrafondaia del governo degliStati Uniti e teorizzava la legittimità del-la disobbedienza alle leggi valutate in-giuste secondo i dettami della propriacoscienza.
L’idea che sia moralmente legittimo ri-fiutarsi di obbedire alle leggi che se-condo la coscienza dell’individuo ap-paiono ingiuste non è priva di ambi-guità. Se da un lato, infatti, sarebbecertamente auspicabile che ciascunopossa agire senza entrare in conflittocon la propria coscienza, dall’altro la-to, se prendiamo atto che qualsiasi so-cietà non è omogenea, dobbiamo rite-nere che ogni legge sia il frutto delcompromesso tra valori disomogeneie non condivisi da tutti, sicché è im-
probabile ch’essa sia ritenuta giustadall’intera collettività. In una societàplurale solo le norme tecniche non ri-ferite a valori potrebbero essere con-divise da tutti (per esempio, la disob-bedienza civile nei confronti della re-gola che stabilisce la marcia a destraper i veicoli sarebbe probabilmenteconsiderata unanimemente bizzarra).Ma ogni altra norma consentirebbe unmargine di disobbedienza più o menoelevato, che potrebbe rendere vana l’e-sistenza stessa delle regole. Diversosarebbe il caso di leggi che non rap-presentino un compromesso tra diver-se posizioni morali, ma rappresentinol’imposizione della scelta di uno solo odi piccole minoranze. La disobbedien-za civile nei confronti delle leggi raz-ziali fasciste, per fare solo un esempio,avrebbe potuto legittimarsi solida-mente su basi di coscienza.
L’ordinamento giuridico, dal cantosuo, è ben consapevole del potenzialescarto tra le regole giuridiche e il sen-so morale di certi individui o di certigruppi componenti la società e dellaconseguente problematicità della“giustizia” delle leggi. Il nostro Codi-
ce Penale, per esempio, prevede, al-l’art. 62, tra le attenuanti che possonocomportare la riduzione fino ad un ter-zo della pena, quella dell’aver agito«per motivi di particolare valore mo-rale o sociale», motivi che ovviamen-te differiscono dai valori sottostanti al-la norma penale, ma offrono una giu-stificazione morale al reato commes-so. Per questa stessa ragione, in alcu-ni casi che implicano valori che le isti-tuzioni stesse stimano come fondantidella morale degli individui, pur diffe-rendo dai valori che ispirano la legge,la legge stessa concede l’obiezione dicoscienza. Il principio è previsto dallastessa Carta europea dei diritti fonda-mentali all’art. 10 secondo comma «Ildiritto all’obiezione di coscienza è ri-conosciuto secondo le leggi nazionaliche ne disciplinano l’esercizio».
Il diritto all’obiezione di coscienza tro-va, dunque, il suo presupposto in un ob-bligo stabilito dalla legge per la viola-zione del quale sarebbe prevista unasanzione se non fosse riconosciuto ap-punto il diritto di obiettare. Come si puòben immaginare, i casi in cui è conces-so il diritto ad obiettare sono piuttosto
Obiezione di coscienza di Valerio Pocar, [email protected]
CONTRIBUTI
20 n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
rari. Nel nostro Paese per contarli ba-stano le dita di una mano.
Prima di passare in rassegna questi po-chi casi è opportuno osservare che es-si sono alquanto dissimili tra loro sic-ché non tutti rientrano propriamentenella definizione che abbiamo dato. Nonsolo, ma il loro significato etico e giuri-dico si differenzia anche in relazione albene che la norma alla quale si conce-de di derogare per motivi di coscienzaintenderebbe tutelare.
Il primo caso di diritto all’o.d.c. vennestabilito dalla legge 15 dicembre 1972 n.772 con riferimento all’obbligo di pre-stare il servizio militare. Il riconosci-mento del diritto ad obiettare seguivaun lungo percorso di resistenza civile nonviolenta, iniziato già sul finire degli anni’40. Il primo caso fu forse quello di Pie-tro Pinna, seguace dell’insegnamentonon violento di Aldo Capitini, che vennecondannato per renitenza alla leva. Se-guirono numerosi casi, motivati anchedall’appartenenza a movimenti religiosi(per esempio, i Testimoni di Geova). Sul-l’o.d.c. al servizio militare, importantis-sima come affermazione del principio,non ci pare il caso di soffermarci, perchél’abolizione della coscrizione obbligato-ria ha reso superfluo l’esercizio del dirit-to a obiettare. Dobbiamo, però, osserva-re, ai fini del nostro discorso, che il benetutelato dalla coscrizione obbligatoriaera costituito da un interesse di caratte-re generale, ma quanto mai vago, quel-lo della «difesa della Patria» come «sa-cro dovere del cittadino» (art. 52 dellaCostituzione). Non per caso, a quell’in-
teresse si è inteso, successivamente, ri-spondere con forze armate non di leva,ma professionali.
Occorre piuttosto soffermarsi sul dirittoall’obiezione riconosciuto dalla legge 22maggio 1978 n. 194 che, all’art. 9, stabi-lisce che il «personale sanitario ed eser-cente le attività ausiliarie non è tenutoa prendere parte alle procedure [d’in-terruzione della gravidanza] quando sol-levi obiezione di coscienza». Analoga-mente, la legge 19 febbraio 2004 n. 40,all’art. 16, riconosce, con le medesimemodalità e quasi le stesse parole, il dirittoa non partecipare alle pratiche di pro-creazione medicalmente assistita. Inquesti campi e soprattutto nel primo laquestione è da tempo oggetto di atten-zione critica. Qui infatti il diritto a obiet-tare si contrappone non a un genericointeresse collettivo, come nell’obiezioneal servizio militare, bensì a un diritto fon-damentale della donna. È noto che lagrande maggioranza dei ginecologi cheoperano negli ospedali pubblici ha op-tato per l’o.d.c., mettendo in serie diffi-coltà le donne che intendono interrom-pere una gravidanza indesiderata. Le ci-fre sono impressionanti. Il 70% dei gi-necologi italiani, con punte fino all’85%in alcune regioni, ha scelto di obiettare.Le percentuali degli obiettori tra gli ane-stesisti e il personale ausiliario sono in-feriori, ma non di molto. Percentuali co-sì elevate fanno sorgere il dubbio chepiuttosto che motivazioni etiche si trat-ti di ragioni professionali e di carriera.
Lasciando alla coscienza degli obietto-ri la genuinità della scelta, resta da sta-
bilire se il diritto del medico a obietta-re, che pone a rischio il rispetto del di-ritto della donna all’integrità fisica e psi-chica, sia compatibile, anzi di fatto pre-valente rispetto a quel diritto fonda-mentale. Occorre tener anche conto delfatto che se la legge stabilisce l’obbli-go del ginecologo operante in struttu-re pubbliche di praticare le interruzio-ni di gravidanza, nessuna legge stabi-lisce l’obbligo di scegliere di svolgerela professione di ginecologo nelle strut-ture pubbliche. Vogliamo dire chel’o.d.c., nel 1978, poté rappresentarenon solo un compromesso politico, co-me certamente fu, ma anche una scel-ta volta a evitare che i ginecologi, aiquali da sempre l’Ivg era stata presen-tata come un reato e un crimine mora-le e deontologico, si trovassero costrettiad adottare comportamenti imprevistie indesiderati. Dobbiamo, però, anchericordare che tutti, salvo poche ecce-zioni, i ginecologi operanti allora nellestrutture pubbliche – sono trascorsiquarant’anni! – sono ormai in pensionee che coloro che ne hanno preso il po-sto non potevano non essere consape-voli che tra i compiti loro assegnati v’èanche quello di praticare l’Ivg. Non ap-pare irragionevole ritenere che il dirit-to all’obiezione avrebbe dovuto esseretemporaneo ovvero non avrebbe dovu-to e non dovrebbe ora essere previstoa favore degli operatori sanitari che han-no preso o prendono servizio nelle strut-ture pubbliche.
La questione è tornata recentementealla ribalta della cronaca per via delbando emanato dall’ospedale San Ca-millo di Roma, in accordo con la Regio-ne Lazio, per l’assunzione di ginecolo-gi non obiettori. Lo scandalizzato car-dinale di turno e la scandalizzata mini-stra della salute si sarebbero dovutirammentare la disposizione di cui alquarto comma del citato art. 16, chestabilisce che «gli enti ospedalieri e lecase di cura autorizzate sono tenuti inogni caso ad assicurare … l’effettua-zione degli interventi di interruzionedella gravidanza … La regione ne con-trolla e garantisce l’attuazione …». Ciòsignifica che tutte le strutture devonogarantire il servizio e là dove tutti i gi-necologi si sono dichiarati obiettori ènon solo corretto, ma necessario che siassuma personale non obiettore peradempiere a un obbligo istituzionale diservizio. Di passata, la ministra – cheignora o finge d’ignorare questa di-sposizione, al punto da permettere cheil ministero rilasci dichiarazioni ufficia-li secondo cui la legge «non prevede in-
21n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
terventi di ivg in tutte le strutture ospe-daliere» [ma sì in tutte quelle che pos-sono praticarla, ndr] e si assicura che«il numero dei punti ivg appare più cheadeguato rispetto al numero di ivg ef-fettuate» – si compiace della diminu-zione del numero delle Ivg, dovuto al-l’uso della RU486, della pillola del gior-no dopo e dei cinque giorni dopo, non-ché ovviamente all’accresciuta educa-zione e consapevolezza riproduttiva didonne e uomini, tutte cose e special-mente l’ultima nelle quali il ministero,che si è speso piuttosto in iniziative co-me la campagna del fertility day, non hadavvero alcun merito. Che il numerodelle Ivg sia diminuito, ovviamente, fapiacere anche a noi, trattandosi di unevento comunque doloroso e trauma-tico per le donne implicate.
Recentissimamente (mentre scrivo lalegge è stata approvata solo da un ra-mo del Parlamento e quindi potrebbeessere modificata), le disposizioni sulfine vita ammettono l’obiezione di co-scienza da parte del medico circa il ri-spetto delle scelte del malato. Questenuove disposizioni meriterebbero unlungo discorso, ma qui interessa soloappunto il diritto del medico all’o.d.c.Anche in questo caso l’obiezione colli-de con l’esercizio di un diritto costitu-zionale dell’individuo, che la legge inquestione finalmente regola, con la stra-nezza che nella maggior parte dei casisi tratterebbe dell’o.d.c. nei confronti discelte volte a evitare il c.d.”accani-mento terapeutico”, cioè dell’obiezio-ne all’astensione. In ogni caso la leggeprevede che gli enti ospedalieri, pub-blici e privati, facciano in modo che lescelte del malato siano rispettate e vo-gliamo sperare che non si riproduca lasituazione creatasi con l’o.d.c. nei con-fronti dell’Ivg.
Se l’o.d.c. avverso il servizio militare dif-feriva da quella nei confronti dell’Ivg,delle pratiche di Pma e ora delle sceltedi fine vita, ancora diverso è il caso deldiritto all’o.d.c. nei confronti della spe-rimentazione sugli animali previsto dal-la legge 12 ottobre 1993 n. 413, una pe-culiarità del nostro Paese, l’unico nelquale tale diritto è sancito. Si tratta diattività che non costituiscono un obbli-go di legge, per cui valgono le osserva-zioni sopra svolte per l’obiezione all’Ivge alle pratiche di Pma, ma, al contrariodi queste, l’obiezione alla sperimenta-zione non si pone in contrasto con undiritto, ma anzi, nell’ottica degli obiet-tori, è volta a tutelare diritti, quelli de-gli animali, senza ledere alcun interes-
se collettivo, giacché chi obietta per mo-tivi etici contesta anche l’utilità e la ne-cessità della sperimentazione sugli ani-mali per il progresso della ricerca, ancheper il benessere umano, e anzi la con-sidera rischiosa, per cui l’obiezione ga-rantirebbe anche l’interesse collettivo.Sull’utilità e sulla liceità etica della spe-rimentazione sugli animali v’è stata,qualche anno fa, un’ampia discussionesulle pagine di questa rivista e a quel-la rimandiamo, senza qui tornare ad ap-profondire. Di fatto, come subito ve-dremo, il diritto all’o.d.c. appare stabi-lito allo scopo sia di garantire la libertàdi coscienza sia soprattutto di garanti-re l’obiettore da conseguenze negativederivanti da una scelta motivata da ra-gioni etiche.
La legge n. 413 sancisce il diritto per«i cittadini che, per obbedienza alla co-scienza, nell’esercizio del diritto alle li-bertà di pensiero, coscienza e religio-
ne riconosciute dalla Dichiarazioneuniversale dei diritti dell’uomo, dallaConvenzione per la salvaguardia deidiritti dell’uomo e delle libertà fonda-mentali e dal Patto internazionale re-lativo ai diritti civili e politici, si op-pongono alla violenza su tutti gli es-seri viventi» di «dichiarare la propriaobiezione di coscienza ad ogni attoconnesso con la sperimentazione ani-male». Di conseguenza, «i medici, i ri-cercatori e il personale sanitario deiruoli dei professionisti laureati, tecni-ci ed infermieristici, nonché gli stu-denti universitari interessati» – l’elen-co non comprende purtroppo tutte lecategorie, soprattutto ai livelli esecu-tivi più modesti – non sono tenuti aprendere direttamente parte alle atti-vità e agli interventi «specificamentee necessariamente diretti alla speri-mentazione animale» (artt. 1 e 2) sul-la base della loro dichiarazione, che
non è sottoposta ad alcun controllo diveridicità, al pari di quella di obiezio-ne all’Ivg e alla Pma, come viceversaera quella al servizio militare.
Da una parte, il legislatore si rivela suf-ficientemente consapevole che l’utilitàscientifica della sperimentazione ani-male è controversa, al punto da non po-ter rappresentare una valida ragioneper imporne la pratica anche ai ricer-catori che non ne apprezzino l’utilità ola necessità. Dall’altra parte, il legisla-tore si dimostra sufficientemente con-sapevole del fatto che la liceità eticastessa della sperimentazione animaleè almeno dubbia e ha inteso consenti-re ai ricercatori che la ritengano immo-rale di non essere costretti a praticarlaper via della loro dipendenza gerarchi-ca all’interno dei laboratori o dei luoghidi ricerca. Al fine di consentire l’eser-cizio del diritto, deve essere data pub-blicità ai dipendenti e agli studenti, daparte degli enti tanto pubblici quantoprivati, dell’esistenza del diritto al-l’o.d.c. e, ciò che più conta, viene sta-bilito il divieto di discriminazione, percui “nessuno può subire conseguenzesfavorevoli, per essersi rifiutato di pra-ticare o di cooperare all’esecuzione del-la sperimentazione animale”, cosicchéagli obiettori è riconosciuto il diritto,qualora siano lavoratori dipendenti,pubblici o privati, «ad essere destinati,nell’ambito delle dotazioni organicheesistenti, ad attività diverse da quelleche prevedono la sperimentazione ani-male, conservando medesima qualificae medesimo trattamento economico»(artt. 3 e 4).
Anche nell’applicazione di questa leg-ge non mancano problemi non piccoli.Non solo l’informazione rispetto alla fa-coltà di obiettare appare alquanto ca-rente, specialmente ai livelli più bassi,ma le garanzie per il lavoratore, chesembrerebbero efficaci nel settore pub-blico e specialmente in quello univer-sitario, non lo sarebbero altrettanto nelsettore privato, dove in pratica la leg-ge tutela solo coloro che abbiano di-chiarato di essere obiettori prima di es-sere assunti; mentre non è prevista unatutela per chi avesse maturato tale de-cisione dopo l’assunzione. È interes-sante osservare che la maggioranza deiricercatori ritiene giusta la facoltà diobiettare e che solo una minoranza ladisapprova per la ragione che, se vi fos-se obiezione di massa, la ricerca ne sa-rebbe paralizzata. Di fatto, pochi sonogli obiettori, al contrario dell’obiezioneall’Ivg.
22 n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
La valutazione di questa legge – qualeche sia l’opinione in merito alla liceità eall’utilità della sperimentazione suglianimali – non può che essere positiva,come di ogni norma che assicuri all’in-dividuo di poter seguire senza danno ipropri convincimenti morali, quandonon vi sia lesione dei diritti di terzi nédi un interesse collettivo.
Una considerazione conclusiva. Tor-niamo alla disobbedienza civile, che èla madre dell’o.d.c. In una società plu-ralista, connotata da un diffuso relati-vismo dei valori, la disobbedienza civi-le potrebbe essere invocata per giusti-ficare o addirittura per nobilitare qual-sivoglia comportamento non conformealla legge e i casi non mancano. Fermorestando che la disobbedienza civile èper sua natura non violenta e intendemutare le regole semplicemente rifiu-tando di sottoporvisi, l’uso strumenta-le del richiamo ai propri princìpi mora-
li per giustificare scelte contrarie alleleggi deve fare i conti, a mio parere, coicriteri fondanti dell’ordinamento so-ciale e anche giuridico delle modernesocietà occidentali e anzitutto col prin-cipio della laicità dello Stato e col dirit-to, che su tal principio riposa, alla li-bertà di coscienza, che comprende lalibertà di culto ovvero di non credenza,di opinione, di pensiero e di manife-stazione del pensiero.
Sulla base del principio di laicità le scel-te pubbliche che s’indirizzano a tutti imembri della collettività, dovrebberorimanere neutrali e astenersi dal re-golare i settori della vita umana chenon abbiano a che fare con interessicollettivi e, soprattutto, che non sianoin contrasto con diritti fondamentalidell’individuo. Vale a dire che le isti-tuzioni devono garantire il rispetto deidiritti fondamentali e di certi impre-scindibili interessi collettivi e solo do-
po averli garantiti possono riconosce-re il diritto all’o.d.c.. Per questa ragio-ne è da ritenere che la pretesa del ri-conoscimento del diritto all’o.d.c. neiconfronti della coscrizione obbligato-ria fosse civilmente giustificata, al pa-ri di quella nei confronti della speri-mentazione sugli animali. Per l’obie-zione nei confronti dell’Ivg, delle pra-tiche di Pma e delle scelte di fine vitala pretesa apparirà giustificata soloquando i relativi servizi saranno pie-namente garantiti a tutte e a tutti co-loro che vi hanno diritto.
Note
[1] H.D. Thoreau, La disobbedienza civile, acura di F. Meli, Editore SE, Milano 1992.
————————
Valerio Pocar è presidente onorario UAAR dal2003 (vedi: http://www.uaar.it/uaar/presidenti_onorari#Pocar).
Noi europei, non solo con l’opera di mis-sionari, ma a volte anche attraverso vio-lenze, conquiste e stragi, ci ostiniamo dasecoli a contrabbandare ai quattro angolidel mondo una religione e una fede chetra l’altro ci derivano da lontano, da unebreo ritenuto figlio di dio, messo incroce e risuscitato sulla terra, come rac-contano i suoi discepoli, che poi, conun’ardita e fantasiosa impalcatura ultra-terrena, ci attenderebbe insieme al pa-dre suo e nostro, in non si sa quale uto-pico luogo dell’universo, a distribuirepremi e castighi per l’eternità.
Ma alcuni di quei popoli, ritenuti infe-riori e verso i quali ci siamo autoinve-stiti del ruolo di portatori di civiltà e pro-gresso e di una fede poi imposta solocon la forza, avevano invece già rag-giunto in materia di credenze religioseuna ammirabile concezione dell’esi-stenza e della vita terrena, senza ricor-rere a favolette e a complicazioni meta-fisiche e, incredibile a dirsi, perfetta-mente in sintonia con i grandi problemiche affliggono ora la scienza e l’umanitàcontemporanea. Che sono soprattutto itemi dell’ecologia, del rispetto della na-tura e delle fonti compatibili per sfa-
mare una popolazione in rapidacrescita, senza doversi affidare amoltiplicazioni miracolistiche dipani e di pesci! Nessuna civiltàportammo mai in quelle terre esiamo debitori a quelle comunitànon solo dei tesori prelevati aforza, di una cultura messa a ferroe a fuoco e praticamente annien-tata, ma anche delle malattie tra-smesse a chi non ne aveva né co-noscenza, né difese naturali. Enon intendo solo quelle virali e ve-neree, la peggiore infezione fusenza dubbio l’imposizione for-zata della fede cattolica, che par-lava di angeli, di demoni, di santi,di dèi vendicativi e di saette cele-sti, a chi credeva invece nelle forze dellanatura, della Terra e del Sole e ne ri-spettava i cicli, i modi, le aspettative.
Questa concezione dello spirito, unicafede dell’uomo rosso, è anche alla basedella nobile lettera che il capo indianoSeattle inviò nel 1864, al tempo delle pre-tese dei bianchi sulle terre occupate damillenni dagli uomini rossi, al Presidentedegli Stati Uniti, dalla quale stralciamoalcune frasi più significative:
«Come è possibile comperare o vendere ilcielo, il calore della Terra? L’aria è preziosaper l’uomo, perché tutte le cose respirano: al-beri, animali, uomini, tutti la respirano. E al-lora la Terra non appartiene all’uomo. L’uomoappartiene alla terra».
Dove il nobile Capo indiano dimostrachiaramente quale fosse la civiltà real-mente superiore, tra le due venute in con-flitto. Ma quale America operò questolento genocidio contro le popolazioni in-
Chi ripagherà i nativi americani?di Fulvio Caporale, [email protected]
23n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
digene, che durò diverse centinaia dianni? L’America delle contraddizioni,quella dei primi coloni europei che nonerano nemmeno i migliori prodotti delvecchio continente, se e vero che fattricie fattori di quello che diventerà poi il po-polo americano furono prelevati dai po-striboli e dalle carceri europee e imbar-cati a forza, insieme ad altri comunque giàincapaci o impossibilitati a realizzarsinelle madrepatrie? O quella puritana e bi-gotta, che aveva saputo ospitare e far cre-scere nel suon seno finanche le sette piùrigide e retrive sul piano morale (mor-moni, avventisti del settimo giorno, pen-tecostali, metodisti e tantissime altre),che finanche l’Europa aveva espulso daisuoi territori? Dell’una e dell’altra Ame-rica e ancor meno di quella attuale, delconsumismo incontrollato e del buco del-l’ozono, chi avrebbe potuto mai ammet-tere di aver scientemente perpetrato lascomparsa di una civiltà indigena cheaveva posto il rispetto della Terra e deisuoi cicli naturali come principio costitu-tivo elevato a dignità di fede e soprattuttodi aver imposto come divinità una pallida,improbabile donna ebrea a uomini cheportavano anche in faccia il colore dellaMadre Terra? A chi invece da millenniaveva i piedi saldamente ancorati sullarealtà e aveva saputo darsi delle “leggiumane non differenti dalle leggi naturali,al di fuori delle quali è impossibile vivere…”. Ancora più esplicitamente, nel suo“La comunità cosmica”, capitolo pubbli-cato in “2941“ (già il titolo evidenzia chia-ramente l’esigenza paradossale di capo-volgere anche l’anno stesso della prima
occupazione e tutte le false convinzioni einterpretazioni che i cattolici e gli europeihanno dato all’evento!), Vallecchi Edi-tore, Ramiro Reynaga così sintetizza la“fede” e l’altissima spiritualità degli in-dios di qualche secolo prima,
«Il pensiero indio non cade nella metafisicaastratta. Pensare indio è azione concreta sucose e fatti concreti e utili. È sentire nella men-te l’Acqua, la Terra, il Vento, il Sole, che si fon-dono in perfetta armonia, dove tutti noi esse-ri, dalle formiche alle stelle, abbiamo il nostroposto. Tutti siamo formati dagli stessi elementichimici in differenti proporzioni, e siamo sog-getti alle medesime leggi naturali che regola-no la fecondità, la nascita, la morte».
E ora un europeo, Bartolomeo Las Ca-sas, nella sua “Relazione sulla distru-zione delle Indie” a raccontare un epi-sodio che chiarisce forse meglio qualefosse il pensiero degli indio, ritenuti“primitivi”, al tempo dell’arrivo “salvi-fico” e “civilizzatore” degli europei:
«Eravamo nel 1511, nell’isola di Cuba. Fuggitoda Haiti, per salvarsi dalla ferocia degli spa-gnoli, vi si era sistemato con la sua gente il ca-cicco Hatuey. Giunse voce che gli spagnoli, in-saziabili predatori, stavano per arrivare an-che in quell’angolo dell’isola. Il cacicco radunòi suoi uomini e disse loro: “Sapete che già sidice che stiano venendo i cristiani e sapete an-che quel che hanno fatto ... E sapete perchélo fanno?”. Risposero: “No, ma sappiamo chesono di natura malvagia e crudele”. E lui dis-se: “Non è solo per questo, ma anche perchéhanno un dio che adorano e amano molto eper averlo qui e poterlo adorare ci sottomet-tono e ci uccidono”. Aveva con sé un piccolo
canestro pieno d’oro e di gioielli e disse: “Ve-dete qui il dio dei cristiani: se lo teniamo, perportarcelo via finiranno con l’ammazzarci tut-ti, gettiamolo nel fiume”. Tutti decisero cosìe buttarono il dio dei cristiani in un gran fiu-me che scorreva lì vicino».
Il libro di Bartolomeo Las Casas, l’unicomissionario spagnolo che difendeva gliindigeni, racconta anche la fine orrendadel cacicco. Legato al palo, prima che siaccendesse il rogo, fu avvicinato da unprete “cristiano”, che gli offrì la grazia(ovviamente, solo quella spirituale!) e lapossibilità di entrare in extremis in pa-radiso, evitando l’inferno. Il cacicco glichiese se in paradiso erano presenti al-tri esseri come lui. Alla risposta affer-mativa, dichiarò con grande dignità chepreferiva l’inferno ed evitare per l’eter-nità la convivenza con persone tantocrudeli e feroci.
Ed ecco, per concludere, l’invocazione diun indiano Sia per favorire la pioggia: lasua fascinosa semplicità, l’umanissimaattendibilità di un canto che non è rivoltoa entità invisibili ma a forze naturali chefanno parte del vissuto quotidiano, gli an-tenati, gli animali della terra e del cielo, lenuvole e gli astri della volta celeste e percontrasto mi riporta alla mente alcunispezzoni della preghiere che imparai amemoria da bambino e che io recitavo al-lora, innocente e inconsapevole:
«... perché peccando ho meritato il vostrocastigo ... che ti fui affidato dalla pietà ce-leste ... prega per noi peccatori ... sia fattala tua volontà ... rimetti a noi i nostri de-
Di scuola si può morire? Le scuole residenziali indiane
La questione dei nativi americani – di cui parla Fulvio Caporale nel-l’articolo qui pubblicato – non è storia vecchia. Certo, è storia moltorisalente, risale alla sanguinosa conquista delle Americhe, ma si pro-trae purtroppo fino al XX secolo inoltrato: fino al 1998, per l’esattez-za, anno di chiusura delle “scuole residenziali indiane” del Canada.La questione è tornata alla ribalta molto di recente, in occasione del-la visita al papa del premier canadese Justin Trudeau, reduce dal G7di Taormina dello scorso maggio. Trudeau ha invitato papa Bergo-glio a recarsi in Canada, per uno scopo ben preciso: chiedere scusaai nativi americani per le “scuole residenziali indiane”, appunto, isti-tuite dal governo canadese a partire dal 1840, chiuse soltanto nel1998 e gestite dalle chiese Cattolica (per il 60%), Anglicana (per il 30%)e Chiesa Unita del Canada (per il restante 10%). Il loro scopo era to-gliere i bambini aborigeni – inizialmente soprattutto Inuit e Metis,poi anche di altre comunità – alle loro famiglie e alla loro cultura, co-stringendoli ad una “integrazione” a dir poco violenta.
Migliaia di bambini infatti sono morti in queste scuole a causa di in-curia, malnutrizione, violenza fisica e sessuale. Le testimonianze rac-colte dalla “Commissione per la verità e la riconciliazione nel Cana-da”, istituita dal governo canadese nel 2008, che ha consegnato ilsuo rapporto nel 2015, sono impressionanti. La Commissione ha de-finito la vicenda delle scuole residenziali un “genocidio culturale”.
Nel 2009 papa Ratzinger incontrò Phil Fontaine, capo del-l’Assemblea dei nativi del Canada, cui fece le sue scuse perl’orribile vicenda. Alcuni portavoce del Consiglio che rappre-senta le nazioni Cree, Squamish, Haida, Metis e Anishinabe,tuttavia, comunicarono di non accettare le scuse del papa«perché non si può chiedere scusa per il genocidio e gli omi-cidi di massa».
In internet si trovano moltissime informazioni sulla questione,che è tuttora oggetto di accese discussioni in Canada, prove-nienti da fonti di ispirazione anche molto diversa. Ci limitiamoa segnalare un ampio compendio del ben documentato rapportoHidden From History: The Canadian Holocaust. Untold Story ofthe Genocide of Aboriginal Peoples by Church and State in Ca-nada (goo.gl/pXF6y4); un articolo (piuttosto tecnico, mamolto interessante) sull’impatto del rapporto della “Commis-sione per la verità e la riconciliazione nel Canada” – e in parti-colare del concetto di “genocidio culturale” – nell’ambito del di-ritto internazionale (goo.gl/LJnSiD); l’articolo divulgativoma molto chiaro e completo goo.gl/lmISVg e infine il sitocattoliciromani che riporta integralmente la dichiarazio-ne del Consiglio che rappresenta le nazioni Cree, Squamish,Haida, Metis e Anishinabe sopra citata (goo.gl/gDrMUa).
[MT]
24 n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
biti ... a te ricorriamo esuli in questa valledi lacrime».
E su queste reminiscenze un po’ tristiper la violenza inaudita e cieca allaquale sottomisero la mia infanzia etante altre, dove di fronte alla presuntadivinità pur si atterrisce e disperdequalunque residuo di umana dignità, sierge ancora più alta la nobile voce del“primitivo” e la liturgia di una “vera”preghiera, non adulterata da complica-zioni metafisiche:
«Bianche nubi erranti,nubi come le pianurevenite e bagnate la Terra.Il Sole abbraccia la Terra che esso può rendere fruttifera.Luna, leone del nord,orso dell’ovest,tasso del sud,lupo dell’est, aquila del cielo.Toporagno della terra,vecchio eroe della guerra, combattenti delle sei montagne del mondo.Intercedete per noi presso le nubi,perché possano bagnare le Terra».
(Da “Canti degli indiani d’America”, acura di Silvio Zavatti, Tascabili New-ton).
————————
Fulvio Caporale, nato a Trivigno (Potenza)dove risiede, ha fondato e diretto il mensi-le di cultura “La Grande Lucania”. Musici-sta, già Ordinario di Lettere nei Licei, ha alsuo attivo numerose pubblicazioni, tra letante “Come fosse primavera” (Laterza diBari) e la più recente, “Il Villaggio sull’al-topiano” (Telemaco, Acerenza).
MicroMega ha recentemente aggiorna-to un precedente dibattito su “Intellet-tuali e religione” [1], sottolineando fral’altro che i ripensamenti di alcuni intel-lettuali sulla religione derivano anchedalle acquisizioni della biologia e delleneuroscienze degli ultimi 60 anni, comefa osservare Telmo Pievani [1].
Se, come scrive Mancuso [1], «è erratoporre una contrapposizione di principiotra mentalità scientifica ed esperienzareligiosa, perché vi sono persone chehanno una limpida mentalità scientificae vivono una sincera esperienza religio-sa e, viceversa, ce ne sono altre del tut-to prive di mentalità scientifica e che nonper questo sono desiderose di esperien-za religiosa», dobbiamo ribadire che esi-stono scienziati atei e, d’altra parte, bi-gotti totalmente ignoranti di scienza:però non abbiamo idea delle proporzio-ni nei quattro gruppi. Allora è forse uti-le riassumere alcuni punti fermi che de-rivano appunto dalle scienze biologichee che forse possono portare un contri-buto al dibattito.
Un primo punto intende sottolinearequanto risulta già da un’osservazione siapure superficiale: gli esseri umani sonotutti diversi tra loro e non esiste, specieper l’argomento di cui parliamo, l’esse-re umano “tipo” al quale riferirsi, menoche mai il tipo, ideale, “unificato” au-spicato da molte religioni e da alcuni fi-losofi, il cosiddetto “uomo”. Quando, inalcuni interventi, si parla dell’essereumano come di un’entità definita, por-
tatrice di certe proprietà, probabilmen-te si confonde l’unicità dell’Homo sapiensin quanto specie dotata delle proprietàbiologiche che la contraddistinguono(mammifero, bipede, due mani con cin-que dita, ecc.), con la molteplicità di ca-ratteristiche fisiche, psicologiche e com-portamentali che riguardano ogni indi-viduo. Quando si scrive «l’uomo pensa aDio» bisognerebbe dire, piuttosto, «al-cuni esseri umani (difficile contarli) po-stulano Dio». Risulterebbe che alcuni,non precocemente indottrinati, non san-no neppure di cosa si parli.
Sia la componente genetica sia quellaacquisita, che determinano le caratteri-stiche fisiche e comportamentali dell’in-dividuo, sono diverse da individuo a in-dividuo: a partire dalle impronte digita-li, oggi potenziate dalle impronte di DNA,che banalmente caratterizzano ogni in-dividuo. E basterebbe osservare le dif-ferenze tra fratelli, che hanno buona par-te del DNA in comune e un’educazionemolto simile, per riscontrare differenzecomportamentali anche macroscopiche:figuriamoci la misurazione della religio-sità innata tra un nepalese, un indio, unesquimese e un napoletano! Questa os-servazione per sottolineare la differenzache esiste tra considerare l’uomo comemammifero bipede o invece come indi-viduo, più o meno devoto. Quindi soste-nere che «la ragione umana conosce pervia naturale l’esistenza di Dio, quasi as-similandola alla istintiva ricerca del ci-bo» (Maritain) [1] è come minimo un’in-genua forzatura o un’illusione.
Naturalmente ogni religione, per ragio-ni a volte nobili a volte meschine o dimercato, ha raccolto un certo numero diindividui “somiglianti” ossia “meno di-versi” (i credenti) e ha creato un model-lo, che ha spacciato per universale comese si trattasse del bipedismo che carat-terizza la specie. Un esempio: i dieci co-mandamenti della religione cattolica in-tendono rendere universali alcune pro-prietà comportamentali umane comuniad un largo numero di individui, impo-nendo di non uccidere e non rubare: in-dicazioni quasi universalmente condivi-se. Poi estendono il divieto a scelte me-no universali come il non fornicare e ilnon desiderare la donna d’altri, e omet-tono di raccomandare perentoriamentela cura e l’amore nei riguardi dei figli,spinta di solito abbastanza universale.Il teologo, o meglio lo storico delle reli-gioni, può indagare se si sia trattato diun artifizio utilitaristico per costituire ungruppo e instaurare una gerarchia nel-l’ambito di tale gruppo.
Ma il punto chiave del discorso è un al-tro. Tutte le costruzioni mentali, com-presi i rapporti di causa effetto, la di-stinzione tra sequenza temporale e se-quenza causale, le proiezioni per il fu-turo costruite rielaborando e genera-lizzando le esperienze conservate inmemoria, ecc., sono il risultato dell’at-tività biologica di un organo, il cervel-lo umano, con tutte le sue variazioni, ilsuo sviluppo, dal neonato al dementesenile, e i suoi limiti. Il cervello umano,con i suoi circa 80 miliardi di neuroni
Uomini e cervelli: a proposito del dibattitodi MicroMega su intellettuali e religionedi Franco Ajmar, [email protected]
25n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
(media) che vanno incontro, ciascuno,nell’arco della vita, a centinaia di mu-tazioni somatiche [2] e alle variazioniche ne conseguono, è un organo chederiva da uno simile presente in nostriprogenitori più o meno remoti. Nel cer-vello umano si sono concentrate (perselezione? – per caso?) alcune funzio-ni di astrazione, ma il suo substrato bio-logico è molto simile a quello dei Pri-mati suoi progenitori. Quando è scoc-cata la scintilla che ha fatto diventare“umani” e poi “credenti” alcuni Pri-mati? Nell’Homo erectus? E com’era ilrapporto con Dio negli Ominini?
Il cervello è origine e misura di tuttoquello di cui stiamo discutendo, e perquesto il valore dei suoi prodotti è mol-to relativo. È autoreferenziale. Questodovrebbe suggerire un bagno di umiltàtra quanti discettano di infinito ed eter-no, di creatore e creato, di verità (del-l’ontologia e dell’escatologia) senza ac-corgersi che stanno solo elaborandocon il loro cervello stimoli (concreti) edespandendoli in astrazioni affascinan-ti, ma senza riscontro. E dimenticandoquanto possano cambiare le posizionise, durante il discorso, si sorseggia unbicchiere di vino. Anche il discorso sul-la verità risente di quanto detto sopra.Perfino una verità “oggettiva”, il colo-re dei petali di un papavero, può risul-tare diversa per un daltonico. La veritàche contraddice la verità? Rari casi, mafacciamo la verità a maggioranza? E fi-guriamoci cosa può saltar fuori dalla«verità escatologica che ci dice comele cose non stanno ma potrebbero sta-re» (Givone) [1]. Se non è questa unariprova di dove possano arrivare le co-struzioni mentali del nostro cervello!Se poi aggiungiamo che tale limite go-de anche della variabilità individualeaccennata più sopra (mai sentito par-lare di individui geniali e di imbecilli?)ci rendiamo conto dei limiti di questocostrutto mentale. Credo che perfino ifisici che misurano le forze dell’uni-verso o gli astronomi che contano legalassie e ne misurano la distanza, inapparenza il massimo della concretez-za e oggettività, debbano riconoscereche alla fine il riferimento di ogni mi-sura sono gli stimoli che attraverso isensi arrivano al cervello umano. Op-pure quando invochiamo il caso per unevento imprevisto senza chiederci senon si tratti piuttosto di una sequenzadeterministica così complessa che ilnostro cervello non sa decodificare.
Nell’attività del cervello riconosciamocomponenti diverse. Per esempio ce
n’è una di controllo di attività motoriecoordinate che risultano in comporta-menti istintivi. Siamo abituati a osser-varli negli animali che ci circondano,dai cani e gatti agli insetti, api e for-miche. Il meccanismo che guida l’ere-ditarietà degli istinti è ancora da chia-rire, nonostante siano in corso nume-rosi importanti studi. Altra compo-nente è la capacità plastica del cervel-lo, quella che consente adattamenti al-le situazioni esterne, anche in funzio-ne di precedenti esperienze memoriz-zate. E l’apprendimento. Il linguaggioha probabilmente una componenteistintiva ereditaria per quanto riguar-da i meccanismi concreti dell’espres-sione (fonazione, ecc.) e una acquisitache differenzia l’acquisizione peresempio di una lingua. Credo che nelcervello umano non esista né l’una nél’altra componente deputata a postu-lare istintivamente Dio. Si tratta piut-tosto di un concetto che viene instilla-to in molti fin dalla nascita: basti pen-sare che nella religione cattolica si bat-tezza il neonato e in quella ebraica losi circoncide. E poi il catechismo in pre-parazione della prima comunione, conrelativa grande festa e poi la cresimacon ulteriore indottrinamento e lascuola dalle suore e dai preti con l’oradi religione e il mese di maggio e la con-fessione e il matrimonio in chiesa. Sepoi uno si ritrova credente, non si puòsostenere che si tratti di un atteggia-mento istintivo nei confronti dell’esi-stenza di Dio come sarebbe quello diun’ape che ritrova la propria arnia o diun cormorano che si tuffa sott’acqua.Sarebbe come sostenere che un italia-no, nato in Italia da genitori italiani,parla italiano per ragioni innate, istin-tive come quelle che gli fanno cercareil cibo. (cfr. Maritain più sopra). Ci sa-rebbe da sperimentare il controllo ne-gativo: quanti, non avendo mai senti-
to parlare di Dio, si ritrovano sponta-neamente credenti a cinquant’anni?Che poi questa acquisizione lo soddi-sfi per tutta la vita, buon per lui.
Ovviamente nessuno vuole qui soste-nere che la realtà esista solo nel nostrocervello. Quasi certamente, se una ca-tastrofe cosmica (meteorite, è già suc-cesso) o una pestilenza (tocchiamo fer-ro) facesse sparire il genere umano colsuo cervello, l’universo continuerebbead esistere, imperturbabile. Ma discu-tere di come esso sia arrivato, magari po-stulando un creatore, come si sia forma-to, e quando e perché, e come sia “real-mente” è solo un esercizio del nostro cer-vello, quasi un nonsenso: probabilmen-te il cervello di un macaco vede la realtàin modo diverso dal nostro.
In conclusione: l’antica alternativa federagione dovrebbe essere affrontata av-valendosi di alcuni aggiornamenti chesottolineano le differenze individuali, lequali non consentono, in questo campo,di postulare un essere umano ideale;inoltre ricordare la derivazione antica delcervello e quindi dei suoi prodotti, suiquali si basa tutta la costruzione.
Le discussioni sulle variazioni nella reli-giosità tra individui, nelle varie epochee nelle diverse popolazioni umane, van-no limitate al campo sociologico cultu-rale storico, con i vantaggi e svantaggiassociati. Senza invocare interventi so-prannaturali.
Note
[1] MicroMega, Vol. 1, 2017 (Almanacco difilosofia), (vari interventi di Telmo Pievani,Vito Mancuso, Jacques Maritain, Sergio Gi-vone).[2] M.J. McConnell et al., Science, 356, 395(supplemento) 2017.
26 n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
————————
Franco Ajmar ha conseguito la maturità clas-sica presso il Liceo Chiabrera di Savona, si èlaureato in Medicina all’Università di Genovanel 1960, ha lavorato per 4 anni come Re-
search Associate presso l’University of Chi-cago, dove ha conseguito il PhD in Geneticanel 1967. Ricercatore presso la Cattedra diEmatologia a Genova dal 1970, è stato pro-fessore ordinario di Genetica all’Università diGenova e direttore della Scuola di Specializ-
zazione in Genetica Medica, fino al 2005. Èautore di numerose pubblicazioni scientifichesu riviste internazionali e di capitoli in libri diBiologia. Ha pubblicato per la ESI il libro Chi?Piccolo galateo di bioetica e per la Coedit Ga-leotti cosmici.
... salva il giovanedallo sport e dall’Azione Cattolica.
Zucchero Fornaciari [1]
La raffigurazione di gruppi sociali come“bolle” è di Niklas Luhmann. Bolle co-me spazi di interessi diversi dai qualigli individui entrano, escono, e nei qua-li interagiscono attraverso le comuni-cazioni. Mi soffermo qui su due bollepiuttosto voluminose, e cioè sport e re-ligione. La domanda è: quanto e cosahanno in comune sport e religione, equanto s’influenzano a vicenda?
Su questo tema è però doverosa unapremessa. Lo sport rappresenta un’at-tività umana positiva perché è l’e-spressione della fiducia nelle propriecapacità, della volontà di misurarsi dalpunto di vista fisico e psicologico permigliorarsi, del gioco di squadra conlealtà, della voglia di comunicare, di ag-gregarsi e di confrontarsi, a volte anchedi una visione del mondo esplicitamen-te ecologica. Lo sport, se non è estre-mizzato, è anche l’alleato della nostrasalute. Inoltre ha liberato il corpo dallavergogna di origine cristiana. Donne euomini si sono riappropriati del loro cor-po che oggi è esposto, curato e lavatoanche grazie allo sport. Praticare sportpotrebbe peraltro avvicinare all’ateismoperché aiuta a trovare in sé stessi mol-te risorse.
Eppure, atea e infarinata di sociologiacome sono, provo disagio per lo sportcome forma di appartenenza fedele ...
Nei media le notizie sportive, gli oraridelle dispute o il risultato di una parti-ta, vengono anteposte a fatti importantia volte anche gravi. Lo stesso accade
per le informazioni religiose. I giornaliriempiono più pagine di sport che diinformazioni politiche o scientifiche. LaRAI ha un intero canale – RAI Vaticano– dedicato alla religione che va per lamaggiore cioè non è di Stato ma quasi.
Lo sport e la religione intrattengono, epure distolgono, milioni di persone daproblematiche più concrete. Perché?Perché rispondono ad una esigenza tra-sversale alla dimensione dei singoli cheli coagula in gruppi di una società chesi struttura in linguaggi universali. Losport parla il linguaggio innato del con-fronto con l’altro, della paura e della di-fesa che si sublima nella dimensione lu-dica, il bene contro il male, che è l’altroche non è del tuo gruppo, o squadra.Con lo sport si crea un senso di appar-tenenza che unisce gli individui per ladifesa e che li appaga nel rapporto congli altri al fine di riconoscere sé stessi.Nell’appartenenza ci si specchia.
La religione parla il linguaggio della pro-messa della risoluzione del male nelmondo, dalla morte alle altre sciagure,attraverso la preghiera e la supersti-zione. Dio è il bene contro il male. An-che la religione crea un senso di appar-tenenza forte. L’uomo si specchia in dio,o viceversa!
Lo sport permette il conflitto controlla-to con la competizione. Nella religioneil conflitto viene disinnescato con la ras-segnazione. Sport e religione incanala-no i conflitti reali, cruenti, in qualcosadi governabile. Lo sport parla anche illinguaggio della ricerca del benessere,come la religione. Lo sport ha rapportocon la fisicità, perché attiene al corpo ealla dimensione terrena. La religione
parte dai malanni dell’esistenza terre-na per affrancarsene attraverso la spi-ritualità.
Sport e religione hanno in comune an-che il gioco, la creazione di sistemi pa-ralleli per un intrattenimento in cui i ruo-li e i mondi – con le loro specifiche re-gole – sono invenzioni umane. Lo sportè permeato di religione fin dalla tradi-zione. La religione si è interessata allosport, ieri in forma sacrale, e anche og-gi per utilizzarlo ai propri fini di educa-zione e proselitismo.
Anche la necessità di trasmettere la tra-dizione è comune a sport e religione,perché la tradizione conforta l’identitàdei gruppi e rafforza il potere. Bambinie adolescenti sono così iniziati prestoai giochi, alle partite, alla tifoseria – «Etu per che squadra tieni?» – al catechi-smo e ai “sacramenti”. Nello sport co-me nella religione il singolo deve sot-tomettersi a delle regole e a una disci-plina, il bambino all’adulto. Purtroppoesistono casi di pedofilia negli ambien-ti sportivi così come nella chiesa.
L’atleta come il religioso si sottomettead autorità e a regole non contrattabi-li. L’atleta e il religioso controllano an-che il proprio corpo e la dieta. Gli atletisi allenano in ritiro, come per i ritiri spi-rituali. L’atleta e il prete si concentra-no prima della performance che sia in-dividuale o rituale, così come si con-centrano gli spettatori sportivi, i tifosi,e i fedeli, durante le gare e le funzionireligiose. Il resto del mondo è sospeso.
I raduni sportivi assumono la caratteri-stica di funzioni rituali. La ciclicità per-petua il rito all’infinito ed è calendariz-
Nuovo politeismo: il dio sport.Un paragone tra sport e religione esplorati nella loro dimensionecollettiva e individualedi Cathia Vigato, [email protected]
27n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
zata in feste. I luoghi dei raduni con-centrano il pubblico sportivo che si fapellegrino e assumono caratteristichesimili ai templi, alle arene, alle catte-drali. Il pubblico è spettatore rivolto alpulpito. Come in chiesa anche negli sta-di si odono canti, cori e litanie e si diffon-dono fumi. I colori assumono significa-ti rappresentativi di appartenenza, cap-pellini e sciarpe sono paramen-ti. L’abbigliamento degli atletiè colorato e simbolico, l’arbitroè vestito di nero come succedeper chi espleta le funzioni reli-giose. La società in bolle si re-plica attraverso la comunica-zione e, infatti, lo sport più pra-ticato in assoluto è lo “sportparlato” così come la religionepiù praticata è quella “per tra-dizione”. Le persone sono per-meate di sport e di religione at-traverso le comunicazioni nelgergo degli esperti, che sianodirigenti, giornalisti, vescovi opreti. Così si possono immagi-nare cose mai provate, adesempio slittare con un bob trail ghiaccio alle olimpiadi, oppu-re raggiungere l’estasi divina oil paradiso, o l’inferno.
Sport e religione sono sistemielaborati dalle comunicazioniumane. Sono grandi idee o sto-rie inventate, come ben spiegaYuval N. Harari nel suo libro Daanimali a dèi. Breve storia del-l’umanità. Sono costruzioni che supe-rano i confini della piccola comunità incui le relazioni sono concrete. Il gruppoideale è allargato e così coeso che a vol-te l’individuo coinvolto prova più em-patia per un membro, pur sconosciuto,che per un proprio conoscente che nonvi sia incluso.
Lo sport è stato per molti anni, come lareligione, misogino, cosa da uomini in-somma. Le donne sono state escluseper secoli da allenamenti e competizio-ni sportive che esaltavano l’uso dellaprestanza fisica e della forza ed eranoeventualmente considerate dei premi.Ancora oggi alcune donne, per pratica-re lo sport, sacrificano alcuni dei loroaspetti femminili anche corporali.
Guardando al passato, alle origini del-lo sport, i giochi pubblici hanno tutti ca-rattere sacrale. Nel –776 dell’era comu-ne vennero istituiti i giochi in onore diZeus a Olimpia, in Grecia, sulla miticacollina su cui il dio aveva lottato controil padre Crono e i Titani. I giochi se-
gnavano il tempo e si tenevano ogniquattro anni, per cinque giorni, nellegiornate decise dai sacerdoti e cioè do-po il solstizio d’estate, al plenilunio neigiorni dedicati ad Apollo. Nei trentagiorni di preparazione gli atleti viveva-no nell’area sacra in isolamento insiemeai sacerdoti detentori delle regole e del-le punizioni. Nel santuario ardeva un
fuoco perpetuo. Tutti i concorrenti ga-reggiavano nudi come in una sorta dirito di iniziazione. La cerimonia inau-gurale prevedeva una processione e ve-nivano effettuati grandi sacrifici di ani-mali. La vittoria era un tributo agli dèie un contatto divino di buon auspicio.Anche la fine dei giochi olimpici è sto-ria di religione perché cessarono dopoil 393 era comune per decisione del-l’imperatore Teodosio, su suggerimen-to di Ambrogio, vescovo cristiano di Mi-lano, in quanto manifestazione orgia-stica e sediziosa.
Anche per i Maya e gli Aztechi il giocodella palla rivestiva un carattere sacra-le. Varianti antichissime di giochi con ilpallone erano praticate anche prima del–1000 era comune. In un campo delimi-tato i giocatori usavano giocare con lapalla di dura gomma lanciandola in al-to attraverso dei cerchi di pietra. La pal-la era molto pesante tanto da provoca-re lividi e fratture ai giocatori. A finepartita i capitani delle squadre veniva-no decapitati a fini sacrificali. In un rac-
conto mitologico gli Eroi Gemelli gio-cando a palla disturbano gli dèi dellamorte: il campo rappresenta il confinetra la vita e la morte.
A Roma la lotta tra i gladiatori, secon-do Raymond Bloch, trae la sua originedai combattimenti che venivano offertiai defunti in epoca etrusca. I giochi nel-
l’Arena avevano comunque uncarattere religioso e sacrificaleperché si immolavano animali epersone. Gli spettatori doveva-no indossare la toga e durantegli spettacoli non potevanomangiare e bere.
Nel Medioevo la religione con-siderava il corpo da fustigare,coprire, reprimere. Tuttavia an-che in questo periodo, nei nu-merosi giorni di festa, dopo lefunzioni religiose, nelle piazze,e nelle campagne si giocava apalla in modo rozzo e violento,parrocchiani contro altri parroc-chiani. In Spagna si praticava lapelota facendo rimbalzare lapalla sul muro della chiesa. Eb-bero grande popolarità anche igiochi da tavolo con la simbolo-gia del mondo, della croce, delbianco e del nero, della vita edella morte.
Alla fine del 1300 il vescovo diWinchester in Inghilterra, Wil-liam di Wykeham, adottò per gli
studenti universitari di Oxford le garesportive come forma di educazione. In-tanto la popolazione si dedicava anco-ra a cruente sfide paesane con la palla,come la soule o il calcio fiorentino, o conil golf giocato persino nelle cattedralibritanniche. E arriviamo così al mondomoderno e contemporaneo in cui losport sembra oramai affrancato dallesacre tradizioni. Ma è davvero così?
Lo sport (inglese disport, francese de-sport, cioè divertimento fuori) nasce nel-la seconda metà del 1800, nelle città,quando si ha una netta divaricazionetra tempo di lavoro e tempo libero. Peri borghesi il primo sport praticato fu l’al-pinismo che per anni è stato conside-rato elitario; dal 1900 con il turismo dimassa sulle montagne proliferano lecroci in vetta che oggi segnano l’a-scensione delle montagne degli alpini-sti, anche se atei.
Nel 1828 Thomas Arnold, che era unteologo anglicano, fu eletto rettore del-la Rugby School sostenendo la compe-
28 n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
tizione sportiva come processo forma-tivo degli studenti in quanto il gioco lea-le (fair play) e la fiducia in se stessi era-no scuola di vita. In questa scuola si di-ce sia nato il gioco del rugby. Ad Arnoldsi ispira il barone francese Pierre DeCoubertin che riesce a organizzare i pri-mi giochi olimpici moderni nel 1896 adAtene. Per De Coubertin «lo sport è unareligione con chiesa, dogmi e culto ...ma soprattutto un sentimento religio-so» (Mémoires olympiques, 1931).
Negli stessi anni i salesiani di don Bo-sco pensano al gioco per la loro azio-ne pastorale con il motto «giocare, sta-re assieme, fare catechismo». Il giocodeve seguire il calendario liturgico perscandire la vita dei giovani perché coni giochi si forma la comunità cristianadel domani. In Italia si creano moltopresto gruppi di associazionismo spor-tivo cattolico tanto che nel 1905 sisvolge a Roma un’importante manife-stazione sportiva con la presenza delpapa Pio X.
Gli anni del fascismo vedono il regimeinvestire nello sport e nell’educazionefisica dei giovani, tanto che l’ora di gin-nastica entra a scuola nel 1925 (nel 1929con il Concordato entrerà anche l’ora direligione!). Secondo Mussolini «non ba-sta avere il cervello calcolatore e la men-te che ragiona: occorrono anche muscolisaldi e garretti di acciaio» – e crocifissinelle aule!
Nel 1936 si tennero le Olimpiadi in Ger-mania a Berlino e il nazismo regalò aiposteri il rito sacrale, che nei giochiolimpici antichi non esisteva, della staf-fetta con la fiaccola dalla città di Olim-pia in Grecia. Le Olimpiadi, e tutte leiniziative sportive amplificate dai pote-ri pubblici per ottenere consenso, di-ventano di grande interesse collettivoe anche un grande affare economico, unpo’ come i pellegrinaggi degli anni san-ti. Gli atleti diventano miti, da collezio-nare con le figurine Panini, insieme aisantini. Si vendono e si scambiano pu-re reliquie e simulacri.
Nel 1948, il 14 luglio, Togliatti, segre-tario del PCI e membro della Costi-tuente, viene ferito in un attentato. Neigiorni successivi si contano negli scon-tri di piazza ben 30 morti! Si racconta,che Alcide De Gasperi e Giulio An-dreotti contattarono allora Gino Barta-li che il 16 luglio 1948 vinse il Tour deFrance. Togliatti è vivo e gli italiani gra-zie alla vittoria dimenticano la guerracivile. Solo una leggenda?
Intanto i salesiani hanno fatto un buonlavoro con gli oratori: miti del calcio co-me Rivera, Boninsegna, Tardelli, Toldoe Albertini provengono dai loro vivai. Ilcalcio diviene molto popolare. L’etolo-go Desmond Morris, nel saggio del 1981La Tribù del calcio, lo definisce comecaccia rituale, battaglia, dimostrazionee droga sociale, impresa commerciale,rappresentazione teatrale, e gran par-te di queste definizioni sono attribuibi-li anche alla religione.
I tifosi nell’attesa dell’incontro-scontrorituale sono galvanizzati e euforizzatidal senso di appartenenza, si vestonodei colori della squadra, si colorano il vi-so, si preparano per la vittoria pregan-do per la liberazione dal male, cioè dal-la sconfitta. Adottano pure strani com-portamenti scaramantici: per la partitasi siedono sempre allo stesso posto, in-dossano indumenti affettivi e tanto al-
tro. Molti calciatori prima di giocare sifanno il segno della croce, altri atleti nonsi radono, o praticano altre forme di su-perstizione con vestiario o comporta-menti vari. Alcuni portano le mani al cie-lo in caso di successi, o mostrano ma-gliette dedicate a dio. Il potere media-tico amplifica l’estasi collettiva e l’e-mulazione. A Napoli esistono veri e pro-pri capitelli con fiori, madonnine ed exvoto, dedicati a Maradona, con tanto digrande immagine colorata de Il Messiasche bacia la coppa del campionato.
Le emozioni scatenate dai raduni si al-largano a dismisura fuori dagli stadi odalle chiese, sono molto intense e ap-paganti e possono anche sfociare, peralcuni soggetti, in estremismi e violen-ze. I tifosi che vivono l’appartenenza co-me la cosa più importante della loro vi-ta diventano ultrà, così come i creden-ti possono travalicare nel fanatismo.Quel che è certo è che le emozioni sca-
tenate dalla partecipazione agli eventisportivi e religiosi distoglie da altri am-biti di interesse e di azione. Quel che èprovato è che la propaganda personalee politica attraverso lo sport e la reli-gione è vincente, basta pensare adAgnelli, Berlusconi, Della Valle, Morat-ti ... fino al Sindaco di Venezia Brugna-ro con la “sua” Reyer.
In Vaticano si disputa ogni anno il cam-pionato di calcio per la Supercoppa Va-ticana (la coppa normale non bastava)lo stadio è fuori mura, in Repubblica Ita-liana, ma sul sito viene specificato chesi tratta dello “stadio di casa”. Nel 2016è stata istituita la prima giornata mon-diale di “Sport e Fede” alla quale han-no partecipato, oltre al papa, centinaiadi atleti, dirigenti e sponsor sportivimondiali. Queste le parole del papa deicattolici all’evento: «ll motto olimpico“altius, citius, fortius” (più veloce, piùin alto, più forte) è un invito a svilup-pare i talenti che Dio ci ha dato. Quan-do vediamo gli atleti tendere al massi-mo delle proprie capacità, lo sport ci en-tusiasma, ci meraviglia, ci fa sentirequasi orgogliosi ... quando è così, losport trascende il livello della pura fisi-cità e ci porta nell’arena dello spirito eaddirittura del mistero ...».
Negli stadi scendono oggi anche gliAtleti di Cristo, un’associazione di spor-tivi di tutte le discipline fondata nel1984 da due calciatori brasiliani, lo sco-po è la diffusione del messaggio evan-gelico attraverso lo sport.
Sono dunque molti i termini comuni asport e religione: appartenenza, asce-tismo, autorità, benessere, business,corpo, culto, fede, festa, meditazione,misoginia, passione, pratica, regole, ri-tiro, sacrificio, superstizione, tradizio-ne ... endorfine.
A livello individuale lo sportivo, l’atle-ta, cerca sempre di superare sé stesso,cerca il miglioramento delle proprieperformance. L’allenamento sportivocosta fatica e sacrificio. Praticare atti-vità sportiva attiva dei meccanismi in-volontari nel cervello che aumentano laproduzione di endorfine che ci dannopiacere. Le endorfine sono in grado didare sensazioni che hanno come re-cettori specifici gli stessi della morfi-na e degli oppiacei. La ricerca di en-dorfine può portare a dipendenza. Siparla infatti di sportivi sani nevrotici,compulsivi o di veri dipendenti dallosport. Sto bene solo se mantengo e mi-glioro i miei risultati associando pure
29n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
un regime alimentare arricchito da in-tegratori naturali o sintetici, come adesempio nel culturismo, bodybuilding,costruzione del corpo, che ricorda lacreazione: si crea se stessi come un dioper il culto del corpo.
Anche pregare e meditare produce en-dorfine, a volte anche estasi e visioni.Anche qui il corpo può essere modifi-cato con la dieta, il digiuno, il ritiro, la
fustigazione (De Sade insegna). Per ireligiosi il benessere è anche la comu-nione, il corpo nel corpo, con il loro dio.Siamo proprio sicuri che non siano al-la ricerca di semplici e umanissime en-dorfine?
Note
[1] La citazione in esergo è stata inserita “di-rettorialmente” da Maria Turchetto, che è
ben consapevole del fatto che il testo uffi-ciale della canzone recita “spot” e non“sport”, ma è anche altrettanto convinta chetutti (tutti!) coloro che hanno ascoltato lacanzone hanno capito “sport”: perché è l’u-nico modo in cui la lirica del bravo Zuccheroha un senso.
————————
Cathia Vigato è atea e socia attiva del Cir-colo UAAR di Venezia.
Ancora una religione “alternativa”che proviene dagli Stati Uniti, la TheSt. John Will-i-Am Coltrane AfricanOrthodox Church [1] dedicata al mu-sicista jazz John William Coltrane,“Trane” (1926-1967), anche in questocaso la religione e lo spettacolo sonofenomeni congiunti che possono coe-sistere.
John Coltrane, “santo” della chiesa alui dedicata, è stato un musicista jazz,al sax tenore, che ha, nell’ambito dellamusica jazz, lasciato un’impronta inde-lebile; la sua vita è stata segnata dall’a-buso di droghe e alcool, fino a quandola fede in dio e nel misticismo l’ha por-tato a creare una musica universale,una musica cosmica che ha segnato lasuccessiva storia del jazz. La rivolta so-nora e la perfezione tecnica unita ad unprofondo misticismo l’hanno portato aprodurre un disco storico A Love Su-preme (1964), un inno ad un dio unico.La composizione è divisa in quattro par-ti, tutte dedicate all’essere supremo:Acknowledgement (ringraziamento),Resolution (fermezza), Pursuance (pro-seguimento) e Psalm (salmo) dove nonc’è mai fine. «Ci sono sempre dei suonida immaginare, nuovi sentimenti dasperimentare ... per arrivare a immagi-nare l’inimmaginabile. Solo così riusci-remo a vedere con maggior chiarezzaciò che siamo, solo così riusciremo a da-re a chi ascolta il meglio di ciò che sia-mo» [2].
Era inevitabile che a queste parole se-guisse la nascita di una religione de-dicata al culto di Coltrane, che sorge
nel 1971 a Haight-Ashbury, il quar-tiere della controcultura anni Sessan-ta, a San Francisco. La chiesa fa par-te della African Orthodox Church [3].
La Coltrane Church venne fondatadall’arcivescovo Franzo King e dallareverenda madre Marina King, dopoaver assistito ad un concerto di Col-trane nel ’65, che a detta loro fu un’e-sperienza mistica, fulminante, un bat-tesimo del suono che avrebbe tocca-to il cuore e la mente dei due fonda-tori, viene alla mente la conversione diSan Paolo!, Coltrane, per i due “reli-giosi”, era stato scelto da dio per gui-dare le anime. Ogni domenica la cele-brazione del rito prevede la lettura diun salmo e l’ascolto di A Love Supreme;nell’ambito della African OrthodoxChurch la Coltrane Church è l’unicaad incorporare nella sua liturgia testi,in cui Coltrane esaltava dio e la suaforza salvifica, e musica dell’artista.
La chiesa ospita a orari prestabiliti se-dute di ascolto dei dischi di “Trane”,concerti, letture. John Coltrane com-pare anche tra i 90 santi della St Gre-gory of Nyssa Episcopal Church di SanFrancisco [4]. Come tutte le “santebotteghe” anche la John ColtraneChurch, nel suo sito, oltre a richiede-re donazioni, vende “accessori del cul-to”: candele con l‘effige di Coltrane,icone del “santo”, immagini della cro-ce ottenuta incrociando due sax, lostrumento del “santo”, olio benedet-to ... Una religione in piena regola, del-la quale John Coltrane non ha re-sponsabilità.
Note
[1] (hppt://www.coltranechurch.org). Will-i-am, che corrisponde al secondonome di Coltrane, William, si può tradurre con“lo desidero intensamente”.[2] Da un’intervista a John Coltrane rilasciataa Down Beat nel 1962.[3] Fondata nel 1921, cattolica romana, pra-tica un culto liturgico con riti orientali e oc-cidentali.[4] (hppt://www.saintgregorys.org).Nata nel 1978, a San Francisco, la Gerusa-lemme delle religioni alternative (!) da una co-stola della chiesa episcopale della Californiae dedicata a San Gregorio nisseno, teologo delIV secolo, recupera nei loro riti la vitalità delprimo cristianesimo e crea nuove forme. Unareligione ortodossa.
————————
Carlo Ottone, da Gattinara (Vercelli), laico elibertario, cacciatore di testi, di quisquilie epinzillacchere.
Religioni “alternative”: la Chiesa del Santo John Coltranedi Carlo Ottone, [email protected]
30 n. 4/2017 (113)
CONTRIBUTI
Ho un debole per i personaggi secon-dari delle storie e della vita, quelli cheservono soltanto per riempire uno spa-zio che altrimenti rimarrebbe vuoto.D’altronde non può esserci solo il pro-tagonista, che noia. Simone di Cirene èuno di loro, una comparsa del Vangelo(di tre dei quattro Vangeli canonici edella pellicola – da cui essi sono tratti –della quale sto per parlarvi).
Quando gli sceneggiatori lo contattaro-no, per lusingarlo, gli dissero che aveva-no per lui un cameo in una grande ope-ra, destinata all’immortalità. Accettò sen-za fiatare – e quando gli ricapita? Sul setgli dissero che avrebbe dovuto aiutareGesù, il protagonista, a portare la crocesul Golgota. Nell’inquadratura si vedonodue soldati romani che, tra la folla assa-tanata, scelgono proprio lui per quell’in-grato e faticoso compito. Ma nemmenoun grazie. Ok, Gesù era sfinito, ma ungrazie non costa niente. Dopo la crocifis-sione andò quindi dal regista a chiederespiegazioni. Quello lo liquidò insinuandoche non capiva niente di cinema.
E poi è la vita, c’è chi trionfa e chi subi-sce. Per questo decisero anche di nonpagarlo, anzi lo obbligarono a sborsaredei quattrini per il favore: tutti si sa-rebbero ricordati del Cireneo, l’uomoobbligato a faticare senza nulla in cam-bio. Si sentì gabbato ma sborsò co-munque, d’altra parte quello era il suoruolo. Qualche mese dopo andò alla pri-ma, a Gerusalemme, rimanendo profon-damente deluso dal messaggio del film.Non ci aveva capito niente: perché Ge-sù accusa il padre, Dio – che è semprelui, Gesù – di averlo abbandonato? Cel’ha con se stesso? Ma se lo sapeva chedoveva essere crocifisso per lavare colsuo sangue i peccati del mondo, perchési lamenta? Soprattutto se poi sarebbefinito in Paradiso? E poi, cosa più im-portante, quali peccati doveva lavare eperché? Ma se aveva lavato per bene,morendo crocifisso, perché il mondocontinuava a fare schifo?
Il successo fu immediato, la Trinità(Gesù-Dio-Star) diventò l’idolo delle fol-le. Anche Simone venne riconosciuto
fuori dalla sala, anzi no, in realtà vennefermato dalla polizia (e arrestato perprecauzione) per quella sua faccia unpo’ così. Una volta fuori di prigionechiamò l’attore che aveva interpretatoGesù per capirci un po’ di più di tuttaquella faccenda. Quello lo liquidò insi-nuando che non capiva niente di nien-te. Il resto della sua vita fu un continuotentare di sfondare nel cinema, senzaalcun successo. Andò avanti a lavoraree sudare, costretto almeno per due vol-te all’anno a vedere quell’odioso filmpassare in televisione. Nemmeno unbravo. Ok, era una comparsa ma un bra-vo non costa niente.
Alla fine morì di freddo e di fame, ac-cusando i produttori di averlo truffatoe abbandonato. Con tutti i soldi cheavevano fatto con quel film, avrebbe-ro potuto dargli qualcosa per soprav-vivere, ma non lo fecero. Spirò pen-sando che lui sì – povero Cristo – ave-va tutto il diritto di lamentarsi e so-prattutto che l’interprete di Gesù eraun raccomandato.
Che fine ha fatto Simone di Cirene?di Stefano Scrima, [email protected]
“Atei” schedati nel Casellario Politico Centrale di Roma(dati.acs.beniculturali.it/CPC/CPC)
A seguito della digitalizzazione del Casellario Politico Centraledi Roma, conservato nell’Archivio di Stato all’EUR in piazzale de-gli Archivi, fra i grattacieli dell’INAIL e dell’ENI, ho riscontrato iseguenti “Atei” schedati. Ovviamente, non essendo illegale l’A-teismo nemmeno sotto il Regime fascista, gli “Atei” in questioneerano degli antifascisti che si chiamavano di nome Ateo. Si ricordicomunque che ogni associazione ateistica o similare era vietatadurante il ventennio così come erano soppressi quei pochi pe-riodici che si richiamavano alla nostra opzione filosofica.
Nei secoli XVII-XVIII sono documentati negli archivi inquisitorialiprocessi agli atei a Venezia e a Napoli [1]. L’ateismo rimase per-seguibile penalmente in Italia fino alla soppressione definitivadell’ultima Inquisizione ancora funzionante verso la tarda matti-nata del XX Settembre 1870, con l’ingresso dei bersaglieri aPorta Pia. Fino a quella fatidica mattina qualunque persona so-spetta di ateismo era passibile di immediato arresto ad operadella gendarmeria pontificia su mandato dell’Inquisizione. È peròbene precisare cosa si intende per soppressione dell’Inquisizionepoiché in realtà gli inquisitori rimasero ai loro posti anche dopoil XX Settembre, ma non avendo più a loro disposizione alcunaforza di polizia, non potevano quindi arrestare nessuno: in pra-tica l’Inquisizione era soppressa solo per mancanza della poliziagiudiziaria!
Gli “Atei” schedati sono 13: Ateo Libero Bellini, comunista, mano-vale in Svizzera nel canton Obvaldo, iscritto alla rubrica di frontiera,nato nel 1912 in Svizzera; Ateo Bertoni, anarchico, barbiere, nato a
Pisa nel 1887 e ivi residente; Ateo Corucci, anarchico, bracciante,nato a Pisa nel 1892, ivi residente; Ateo Fiorani, comunista, mano-vale-calzolaio, nato a San Lorenzo in Campo (Pesaro e Urbino) nel1896; Ateo Frassinetti, anarchico, calzolaio-muratore, nato ad An-cona nel 1904 e ivi residente; Ateo Liberti, anarchico, residente ne-gli USA; Ateo Materazzi, anarchico, meccanico, nato a Terni nel1900 e residente in Francia, iscritto alla rubrica di frontiera: AteoMuratori, anarchico, orologiaio, nato a Mantova e ivi residente;Ateo Ricci, comunista, panettiere, nato a Foligno (Perugia) nel 1890e ivi residente; Ateo Roncoroni, antifascista, nato a Zurigo in Sviz-zera, residente nel Lussemburgo; Ateo Scorticati, comunista, brac-ciante, nato nel 1905 a Villa Rivalta (Reggio Emilia), residente adArgenteuil in Francia, iscritto alla rubrica di frontiera, volontario inSpagna in difesa della Repubblica; Ateo Trabalza, comunista, brac-ciante, nato nel 1908 a Bevagna (Perugia), residente in Belgio; AteoVannucci, anarchico, autista, nato nel 1905 a Massa Carrara, resi-dente in Belgio, iscritto alla rubrica di frontiera, volontario in Spa-gna in difesa della Repubblica.
Note
[1] Per i processi contro gli atei di Venezia vedi: Romano Canosa,Storia dell’Inquisizione in Italia, Venezia, volume II, Sapere 2000,Roma 1987, pagg. 139-142, capitolo “Piccole eresie”. Per i pro-cessi contro gli atei di Napoli vedi, ibidem, Napoli e Bologna, vo-lume V, Sapere 2000, Roma 1990, pagg. 119-132, capitolo “Il pro-cesso agli ateisti”.
Pierino Giovanni [email protected]
31n. 4/2017 (113)
PAROLE, PAROLE, PAROLE …
Tratteremo qui di un altro concettoamatissimo ed usatissimo dalla chiesacattolica, ovvero quello di “Persona”, evedremo che anche in questo caso lecose non stanno come potrebbero sem-brare a prima vista, perché l’apparenza(o meglio il linguaggio) inganna.
Generalmente la chiesa sottolinea l’u-nicità della “Persona”, afferma che es-sa è meritevole di rispetto e definiscese stessa come molto rispettosa della“Persona”. Naturalmente dietro questaparola sta nascosta la solita anima,com’era già anche il caso per “Vita”, mavorrei tralasciare un attimo questa que-stione per occuparmi innanzitutto delconcetto di rispetto per la “Persona”.Riguardo a questo, a me sembra cheproprio coloro che si autodefinisconocome rispettosissimi della “Persona” inrealtà non lo siano per niente.
Ora, chiunque sarebbe d’accordo sulfatto che rispettare la “Persona” signi-fica innanzitutto riconoscerle la possi-bilità di autodeterminazione cioè di fa-re le proprie scelte in maniera adulta econsapevole – una cosa che la chiesanega alle “Persone” già fin dalla nasci-ta, imponendo il battesimo ai neonati.E questo disrispetto continua anche du-rante tutta l’infanzia, tramite il lavag-gio del cervello messo in atto sui bam-bini dai vari catechismi, comunioni, cre-sime e ore di religione impartite nellescuole pubbliche fin dall’asilo. Tuttoquesto a me sembra una grave man-canza di rispetto verso le “Persone”, so-prattutto quando si tratta di bambini,troppo piccoli per essere in grado di di-fendersi o di valutare in modo critico ciòche viene loro raccontato dagli adulti.Ma non è finita lì. La chiesa esercita poi(o cerca di esercitare) un controllo an-che sulla vita adulta delle “Persone”,imponendo divieti o richiedendo certitipi di comportamenti, come del restofanno un po’ tutte le religioni.
Per le “Persone” di sesso femminile,poi, la situazione è ancora più pesante,essendo negato loro il diritto di auto-determinazione sul proprio corpo, sitratti di gravidanza non voluta o di fe-condazione artificiale … non sto qui a fa-re l’elenco di tutti i divieti ecclesiasticiin questo campo, essendo essi ben co-
nosciuti da tutti. Passiamo invece al fi-ne-vita delle “Persone”, maschi o fem-mine che siano … alle quali è categori-camente negato ogni diritto di decisio-ne autonoma nei riguardi di se/e comemorire. Ed infine ricordiamo anche le“Persone” non-eterosessuali, nei con-fronti delle quali il disrispetto della chie-sa è particolarmente accentuato, nonavendo esse il “permesso” di sposarsie di formare una famiglia – figurarsi poiquello di adottare dei figli! Se poi a tut-te queste cose aggiungiamo l’atteggia-mento paternalistico che i rappresen-tanti di Santa Madre Chiesa adottanosempre nei confronti dei loro fedeli, an-che qui notiamo ben poco rispetto perla “Persona”, perché il paternalismo im-plica sempre una presunta superioritànei confronti dell’altro, che quindi vie-ne sminuito come “Persona” e consi-derato indegno di un rapporto alla parifra adulti.
Il tanto declamato rispetto per la “Per-sona” non è dovuto, per la chiesa, alle“Persone” concrete in base alle loro con-quiste, abilità, competenze, meriti ac-quisiti nel corso della vita ma alle “Per-sone” in astratto, valorizzate soltantoperché il loro “sottostante” è l’anima,creata da Dio. Il rispetto della “Persona”per la chiesa è quindi semplicemente ilrispetto per Dio [1]. E la “Persona” del-la chiesa ha ben poco a che vedere conle persone reali e concrete che incon-triamo tutti i giorni e con le quali ci rap-portiamo durante la nostra vita.
Ora, in tutte le società democratiche ri-spettare le “Persone” significa porre lecondizioni che rendano loro possibilefare delle scelte autonome ed informa-te, dunque esporre le “Persone” al mag-gior numero di idee, opinioni, cono-scenze, concezioni politiche, filosoficheo religiose possibili permettendo loro divalutare autonomamente le varie op-zioni e di crescere come individui; nonsignifica, invece, bombardarle costan-temente ed insistentemente con il me-desimo messaggio propagandistico pre-sentato come unico ed autentico – co-me avviene, ahimè, fin troppo spesso evolentieri sui “media” italiani, in granparte asserviti a Santa Madre Chiesa.Siamo ben lontani, In Italia, dal rispet-tare le “Persone” in quanto esseri pen-
santi e capaci di autodeterminazione!E questo grazie alla chiesa e ai nostripolitici perennemente genuflessi.
Ma passiamo ad analizzare l’ultima co-setta lasciata in sospeso, cioè il concet-to di unicità della “Persona”. A diffe-renza di quanto pensa Santa MadreChiesa, la “Persona” può essere (o me-glio diventare) “unica” soltanto se vie-ne messa in grado di auto-determinarsicome ho spiegato sopra. Solo avendo lapossibilità di fare delle scelte informateed autonome la “Persona” può diventa-re davvero “Persona”, cioè individuopensante. Diversamente, si avranno del-le persone stereotipate, tutte uguali, tut-te convinte delle stesse identiche cose,nessuna delle quali sarà un individuo. Ilprogrammino che da secoli la chiesa cat-tolica propina alle “Persone” (ossia il lo-ro sistematico indottrinamento) non faaltro che distruggere l’unicità della “Per-sona” rendendo tutte le “Persone” mo-notonamente uguali, uniformate e suc-cubi: non si tratta di rispetto della “Per-sona” ma di distruzione della “Persona”,o meglio ancora di dominio completo, ditotale sottomissione della “Persona”.
Note
[1] Non a caso il Dio cattolico è definito co-me “Persona”, o meglio tre “Persone” – uni-co caso in cui la “Persona” non è unica ma… multipla, diciamo!
Personadi Enrica Rota, [email protected]
32 n. 4/2017 (113)
PAROLE, PAROLE, PAROLE …
AGNOSTICO
In riferimento all’articolo “Il credente,l’ateo e l’agnostico, ovverosia: sì, no,forse ...” di Enrica Rota (“L’Ateo” 111,2/2017, p. 39), vorrei rilevare che i cre-denti, confrontandosi con un agnosti-co, di solito commentano: «se non de-cidi, può essere che».
Vorrei quindi precisare la posizione dichi, da agnostico, sa di non saperneniente di Dio e Dei, e nemmeno gli in-teressa saperne, ma sa per certo chenon c’è mai stata nessuna rivelazione.Se per caso c’è, non si è mai fatto nésentire né vedere da alcuno sulla facciadella terra.
Mi definisco quindi agnostico nega-zionista, nel senso che nego la rive-lazione. Ma non mi piace tanto. Qual-cuno può suggerirmi qualcosa di me-glio?
Davide [email protected]
In generale sono d’accordo con te, ma inmolti casi sembra che le persone non ab-biano evidenti recriminazioni da fare, aparte quelle su basi teologiche, e che sia-no “radicalizzate” dalla sola idea di sa-crificare tutto per la fede. Penso agli oc-cidentali che si sono uniti a gruppi comeal-Qaeda e lo Stato Islamico, per esem-pio. A volte, l’ideologia religiosa apparenon solo necessaria, ma sufficientea mo-tivare una persona a fare queste scelte.Tu dirai che c’entra anche una crisi diidentità, ma chi non ha affrontato a uncerto punto della vita una crisi di iden-tità? Anzi, si potrebbe dire che la vita in-tera non è che una lunga crisi di identità.
La verità è che alcune persone sembra-no essere motivate quasi esclusivamen-te dalle credenze religiose. Senza quel-le credenze, il loro comportamento nonavrebbe assolutamente alcun senso; conesse, diventa invece perfettamente com-prensibile, se non addirittura razionale.Come sai, il dibattito pubblico sul lega-me tra l’ideologia islamica e l’intolleran-za e la violenza dei musulmani è statosoffocato dal “politicamente corretto”.
In Occidente, esiste ormai una grandefabbrica dell’apologia e dell’offusca-mento volta, si direbbe, a proteggere imusulmani dall’assumersi la respon-
sabilità di azioni come quelle di cui ab-biamo parlato. Le facoltà umanistichee di scienze sociali di ogni universitàsono piene di accademici e pseudo-accademici – considerati esperti di ter-rorismo, religione, giurisprudenza isla-mica, antropologia, scienze politiche ealtri campi – pronti ad affermare che l’e-stremismo islamico non è mai quelloche sembra. Questi esperti insistonoche non possiamo mai prendere alla let-tera gli islamisti e i jihadisti, e che le lo-ro dichiarazioni su Dio, il paradiso, ilmartirio e i mali dell’apostasia non han-no nulla a che vedere con le loro realimotivazioni. Se provate a chiedere loro
Una partita truccata?Una risposta a Maajid Nawazdi Sam Harris
NESSUN DOGMA
� SAM HARRIS e MAAJID NAWAZ, L’islam e il futuro della tolleran-za. Un dialogo, (traduzione di Paolo Ferrarini), ISBN 978-8898-60232-2, Nessun Dogma, Roma 2017, pagine 128, € 12,00, bros-sura.
Questo libro presenta ai lettori un dialogo fra Sam Harris, il notoesponente della corrente di pensiero contemporanea denomina-ta “Nuovo Ateismo”, e Maajid Nawaz, un musulmano riformistae liberale di origine pakistana fondatore di “Quilliam”, un’asso-ciazione antiterroristica che combatte l’estremismo in ogni sua for-ma e promuove i valori laici e democratici fondati sul riconosci-mento dei diritti umani. L’edizione originale inglese, dal titoloIslam and the Future of Tolerance. A Dialogue è del 2015.
I temi principali affrontati nel dialogo sono l’islam e le prospetti-ve di riforma di questa fede: l’islam è una religione compatibilecon la tolleranza, ci si chiede e, se attualmente non sembra es-serlo, come parrebbe indicare il fenomeno del fondamentalismoislamico dei nostri giorni, può venire riformato dall’interno per di-ventarlo? Mentre Harris è piuttosto scettico al riguardo, Nawazè tendenzialmente ottimista ed anzi proprio questo è l’obiettivodell’associazione da lui fondata.
Per sviscerare la questione, nel corso del dialogo il fenomeno del-l’islam viene analizzato sia dal punto di vista storico-politico sia
da quello religioso/scritturale e viene anche delucidato il rappor-to fra la religione islamica e l’ideologia dell’islamismo: l’islam neemerge in tutta la sua complessità, come un fenomeno dotato divarie “anime” non necessariamente in accordo fra loro, anzi spes-so in contrasto l’una con l’altra.
Nello specifico, il primo capitolo pone la domanda se l’islam pos-sa essere definito o meno come una religione della pace; il se-condo contiene una breve biografia di Maajid Nawaz che, dopouna gioventù da islamista, è ora diventato riformista e modera-to; nel terzo vengono sviscerate le differenze fra le varie “anime”dell’islam; il quarto esplora il ruolo della fede islamica nel reclu-tamento e nella radicalizzazione dei terroristi; nel quinto si pole-mizza contro la condiscendenza di certi intellettuali liberali nei con-fronti del mondo islamico; nel sesto viene esaminata la questio-ne della interpretazione, letterale o meno, delle sacre scrittureislamiche; nel settimo ed ultimo capitolo, infine, si esplorano pos-sibili strategie atte a sradicare, o almeno a contenere, il preoccu-pante fenomeno dell’islamismo e del jihad globale nel mondo.
Un libro interessante ed istruttivo per chiunque voglia approfondi-re la conoscenza dell’islam in tutte le sue variegate sfaccettature.
Enrica [email protected]
33n. 4/2017 (113)
NESSUN DOGMA
quali siano allora i veri moventi degliislamisti e dei jihadisti, verrete investi-ti da uno tsunami di chimere liberali.Manco a dirlo, l’Occidente è l’unico re-sponsabile di tutto il caos che vediamonelle società musulmane. Dopotutto,come ci sentiremmo noi se delle po-tenze straniere, con una schiera di car-tografi al seguito, avessero smembra-to le nostre terre e rubato il nostro pe-trolio? Sono persone assillate dai pro-blemi, ma che in realtà vogliono le stes-
se cose che chiunque altro desidera nel-la vita: vogliono la stabilità politica edeconomica, vogliono scuole decenti peri figli, vogliono prosperare in libertà, neilimiti di una società civile globale. I li-berali immaginano che quella dei jiha-disti e degli islamisti sia la reazione cheavrebbe chiunque si trovasse in analo-ghe circostanze storiche, nel contestodi incontri sfortunati con l’Occidente. Erifiutano completamente l’idea che lecredenze religiose abbiano un qualcheruolo nell’ispirare un gruppo come loStato Islamico – al punto che per unjihadista sarebbe impossibile dimo-strare di fare qualsiasi cosa mosso dafini religiosi.
A quanto pare, non è sufficiente che unapersona istruita e benestante consacrila propria vita alla versione più estremae austera dell’islam, che spieghi ad nau-seam le sue motivazioni religiose per far-lo, fino al punto di dichiarare la sua cre-denza nel martirio in un video prima difarsi esplodere in mezzo alla folla. Perqualcuno, tali manifestazioni retorichedi fanatismo religioso non bastano, inqualche modo, a dimostrare che costuicredeva realmente in ciò in cui diceva dicredere. D’altro canto, se avesse affer-mato di compiere queste azioni mossodalla disperazione e dalla repulsione neiconfronti dell’umanità, o perché deter-minato a sacrificarsi per liberare la suanazione dalla tirannia, una giustificazio-ne psicologica o politica di questo tiposarebbe stata accettata alla lettera. Due
pesi e due misure, per garantire che lareligione ne esca sempre esonerata. Èuna partita truccata.
Non so se tu conosci gli apologhi liberalia cui faccio riferimento; alcuni sono gior-nalisti, alcuni sono professori universi-tari, alcuni sono anche musulmani. Mail profilo generale è quello di un libera-le bianco non musulmano che conside-ra automaticamente qualsiasi criticamossa alle dottrine islamiche come bi-gottismo, “islamofobia”, o persino co-me una forma di “razzismo”. Si tratta difigure di spicco negli Stati Uniti e il fat-to che abbiano tanta influenza è intel-lettualmente imbarazzante e moral-mente problematico. Nonostante nonintervengano con la stessa forza in ogniquestione, costoro negano l’esistenzadi qualsiasi legame tra la fede sincera ela violenza dei musulmani. Interi gior-nali e siti web sono ormai diventati, defacto, organi di apologia islamista: TheGuardian, Salon, The Nation, Alternet, evia dicendo. Questo ha reso molto diffi-cile intavolare confronti pubblici come ilnostro.
————————
Sam Harris, saggista statunitense, è uno de-gli esponenti più noti dell’ateismo mondialecontemporaneo. Ha scritto diversi best sel-lers, tra i quali La fine della fedee Lettera a unanazione cristiana. Il testo qui riprodotto è trat-to da Sam Harris e Maajid Nawaz, L’islam e ilfuturo della tolleranza. Un dialogo, NessunDogma, Roma 2017, pp. 38-41.
� J. SHELBY SPONG, M. LOPEZ VIGIL, R.LENAERS e J.M. VIGIL, Oltre le religioni,ISBN 978-88-6099-290-1, Gabrielli edi-tori, San Pietro in Cariano (Verona)2016, pagine 239, € 16,50.
Questo libro, scritto, se si fa eccezioneper Maria Lopez Vigil, giornalista e scrit-trice cubano-nicaraguense, da uomini dichiesa – John Shelby Spong è vescovoepiscopaliano, Roger Lenaers è presbi-tero gesuita, José Maria Vigil è presbi-tero clarettiano – ha il grosso merito difornire una critica rigorosa, radicale e,oserei dire, tombale del cristianesimo.L’assunto di fondo è che con l’avventodella modernità è in atto un cambia-mento storico epocale caratterizzato dal-l’affermazione del “paradigma post-religionale”, come loro lo chiamano.
«I sistemi religiosi chiamati comunemente“religioni” – scrive José Maria Vigil – sono co-struzioni umane proprie del tempo agrario,con caratteristiche dipendenti da quello sta-dio concreto della storia dell’umanità, co-struzioni che diventano obsolete quando ter-mina quell’epoca e si accede a un nuovo mo-dello di umanità e al conseguente nuovo mo-do di essere profondamente umani» (p. 189).
Le religioni “agrarie” sono basate sul“teismo”, sull’idea mitica di un Dio con-cepito come un «essere soprannaturalepotente, che dimora da qualche parte aldi fuori del mondo ed è in grado d’inva-dere la storia umana in modi miracolosi»(pp. 56-57). È un Dio severo, da suppli-care, obbedire e compiacere, di fronte alquale prostrarsi come uno schiavo da-vanti al suo padrone. È un Dio antropo-morfo, costruito sul modello umano co-
me una persona che possiede tutte lequalità positive dell’uomo private dei lo-ro limiti e infinitizzate. Esso, come ha ri-levato Freud, risponde al bisogno del-l’uomo primitivo di avere un creatore delmondo, un capo supremo della tribù eun protettore personale.
Queste religioni non solo spiegavano leorigini del cosmo con i miti di creazionee trovavano nelle divinità le cause deifenomeni naturali – cose per noi ormaiinaccettabili a causa delle acquisizioniscientifiche – ma avevano anche la fun-zione, importantissima per la sopravvi-venza del gruppo sociale, di fornire im-mutabili e sicuri codici di comporta-mento (si pensi a tutti i precetti che Diodà nella Bibbia al popolo ebreo) che per-mettessero agli uomini di vivere in so-
RECENSIONI
34 n. 4/2017 (113)
RECENSIONI
cietà, con un diritto, una morale defi-niti e un senso di coesione sociale e diappartenenza. Ebbene, afferma peren-toriamente il vescovo Shelby Spong,
«il teismo come modo di definire Dio è mor-to. Non possiamo più percepire Dio in modocredibile come un essere dal potere sopran-naturale, che vive nell’alto dei cieli ed è pron-to a intervenire periodicamente nella storiaumana, perché si compia la sua divina vo-lontà. Pertanto, oggi, la maggior parte di ciòche si dice su Dio non ha senso» (p. 71).
È evidente oramai che, come aveva giàcapito Senofane di Colofone (570 a.C.-475 a.C.) molto tempo fa, non è statoDio a creare l’uomo a sua immagine esomiglianza, bensì l’uomo a creare Dioa propria immagine e somiglianza. E unDio creato dall’uomo non può essereDio. Ma se crolla il pilastro su cui si reg-ge tutto l’edificio dogmatico cristianotutti gli articoli di fede che ne dipen-dono crollano con lui. Se non c’è il Dio-Padre non può esserci il Dio-Figlio. Edunque, scrive sempre Shelby Spong:
«Dal momento che Dio non può essere con-cepito in termini teistici, non ha senso cer-care d’intendere Gesù come “l’incarnazionedi una divinità teistica”. I concetti tradizio-nali della cristologia sono, pertanto, finiti inbancarotta» (p. 81).
La stessa cosa afferma Roger Lenaers:
«la confessione che Gesù è “Dio da Dio, Diovero da Dio vero”, che a partire dal conciliodi Nicea è stato il pilastro centrale della fe-de cristiana, è ormai insostenibile» (p.138).
Ma se non è vero che Gesù è Dio, la se-conda persona della SS. Trinità che siè incarnata nel ventre immacolato diMaria, allora Maria non è la Madre diDio e perciò cadono tutti i dogmi chela riguardano: il concepimento vergi-nale, la verginità “reale e perpetua”,l’immacolata concezione, l’assunzionein cielo con l’anima e il corpo. A que-sto punto non rimane che «prenderecongedo dal credo» (p. 138). E ciò fan-no con puntiglioso rigore tutti gli autoridel libro sottoponendo a critica spie-tata gli altri capisaldi della dottrina cat-tolica tradizionale: la resurrezione,l’eucarestia, la messa, la preghiera,l’aldilà, il sacerdozio, la gerarchia ec-clesiastica ... Del cristianesimo non ri-mane che un cumulo di macerie.Shelby Spong ha il merito di svelaretutto l’orrore implicito nel mito centraledella religione cristiana. La teologiadell’espiazione
«ha trasformato Dio in un mostro che non saperdonare. Lo ha dipinto come qualcuno cherichiede un sacrificio umano e un’offerta disangue prima di offrire il perdono. Ha fattosì che venisse raccontata la storia di un DioPadre che punisce con la morte suo Figlioper soddisfare la sua necessità di un risarci-mento. Senza rendersene conto, questa con-cezione ha trasformato Dio Padre nel supre-mo abusatore di minori!» (p. 89).
Ora però l’era della sottomissione è fi-nita:
«L’essere umano moderno – rileva José Ma-ria Vigil – è oggi culturalmente consapevo-le del proprio valore e della propria dignità,ha una nuova autostima e non è più capacedi accettare una religiosità che continui a ba-sarsi sul «disprezzo della creatura» e sullasubordinazione totale a una presunta divi-nità onnipotente, su una “ontologia del do-minio” e della sottomissione. Non accettauna religione che, come hanno fatto le reli-gioni successive alla rivoluzione agraria, «lometta in ginocchio», esistenzialmente par-lando» (p. 165).
Senza fede è impossibile salvarsi, que-sto dice il Vangelo, questo ripete sanPaolo nelle sue lettere. Ma José MariaVigil scrive:
«La “fede”, come obsequium rationabile, sa-crificium rationis, o il credere a ciò che nonsi vede, non è più praticabile per l’essereumano di oggi, il quale sente che incorre-rebbe in un atteggiamento indegno di sestesso se si piegasse a tali esigenze di sot-tomissione, e che sarebbe anche indegnodell’umanità un Dio che richiedesse tale sot-tomissione esistenziale» (p. 166).
È difficile immaginare una sconfessio-ne più netta di un fondamentale dog-ma di fede. L’opera di demolizione delcristianesimo continua con l’ultimo ca-pitolo del libro che contiene una pre-sentazione sintetica ma abbastanzacompleta del “nuovo paradigma ar-cheologico”. La Bibbia ha goduto neisecoli di un credito assoluto. Garantita
dalla presunta ispirazione divina, i suoiracconti furono considerati storica-mente certi, inerranti e indubitabili. Og-gi invece la maggior parte degli studio-si, alla luce dei documenti archeologiciin nostro possesso, ritiene che i libri ba-se della Bibbia ebraica (dalla Genesi ailibri dei Re) siano storicamente inat-tendibili e siano stati scritti molto piùtardi rispetto alla data di composizionetradizionale.
«La narrazione da Abramo a Davide è un mi-to fondazionale, come quello che Virgilio creònella sua Eneide sulla fondazione mitica diRoma da parte di Enea» (p. 213).
Grazie a questa geniale invenzione da-tabile a partire dalla fine del VII sec. a.C.un piccolo popolo povero e oppresso,considerandosi “eletto” da Dio e desti-nato a un luminoso avvenire, ha pre-servato la sua identità ed è riuscito asopravvivere nonostante le numerosesconfitte e umiliazioni subite nel corsodella storia. Anche la narrazione delNuovo Testamento viene radicalmentedecostruita:
«Oggi è dato per storicamente certo che Ge-sù non fondò la Chiesa né pensò mai di da-re inizio a una nuova religione. Fu sempreun pio ebreo e si rivolse sempre al popoloebreo. Non fece mai di se stesso le sorpren-denti affermazioni che l’evangelista Gio-vanni mette sulla sua bocca e, con la stessaprobabilità, nemmeno mai le pensò. Fu unpio ebreo zelante per il rinnovamento dellafede ebraica, ucciso infine dal potere roma-no con una crocifissione che non ebbe nullad’insolito in quel paese soggiogato dal po-tere imperiale» (p. 216).
Anche per questa via si dimostra che ilCristo, l’Uomo-Dio adorato dal cristia-nesimo, è solo una figura mitica, inven-tata. Dunque, le scritture non sono Pa-rola di Dio ma parola umana. Il “trucco”ormai è stato scoperto:
«In buona parte della teologia della rivela-zione Dio stesso è stato considerato l’“au-tore” della Scrittura, e ciò ha conferito a es-sa, ai suoi testi e alle sue parole, il carattereassoluto proprio del divino. Attribuire a Diola paternità di tradizioni, racconti, testi chenoi stessi abbiamo creato, è stato un mec-canismo comune nella storia delle religioni,che è servito ad assolutizzare e a preserva-re dalla discussione norme, credenze, tradi-zioni che la società voleva “blindare” controqualsiasi dubbio» (p. 232).
Questa verità colpisce il cuore stessodella fede religiosa in quanto fondata
35n. 4/2017 (113)
RECENSIONI
sul presunto possesso della rivelazionedivina: se questa non c’è il cristianesi-mo perde ogni credibilità. Nonostanteciò, e molto altro, gli autori cercano disalvare qualche brandello dell’antica fe-
de. Ma l’appello a concetti fumosi e con-traddittori (Dio come Amore assoluto,l’incontro con Gesù di Nazareth, la ri-concettualizzazione della spiritualità) èpatetico e insostenibile e non fa altroche confermare la convinzione che ol-tre le religioni c’è solo un sano, schiet-to, onesto umanesimo ateo.
Renato [email protected]
�CESAREBIANCO, Lo sguardo delle Ma-dri di Plaza de Mayo, ISBN: 978-88-6830-517-8, Ed. Imprimatur (Collana “Sag-gi”), Reggio Emilia 2017, pagine 288, €17,00, brossura.
Lo sguardo delle Madri di Plaza deMayo è un romanzo e, come i miglioriromanzi, può essere letto secondo va-rie chiavi interpretative. Anzitutto c’èla trama e il personaggio, diciamo così,narrante: don Alberto Torres, prete cat-tolico argentino ridotto allo stato laica-le dai suoi superiori, che mal sopporta-vano le sue simpatie per i poveri, i di-seredati, e la sua, sia pure non osten-tata, ostilità verso la dittatura dei ge-nerali argentini. Formatosi al CollegioLatino Americano a Roma, dove hastretto amicizia con Ricardo Barrera,torna a Roma dopo circa trent’anni inoccasione dei funerali di Giovanni Pao-lo II, e incontra il suo vecchio compa-gno di studi, diventato nel frattempocardinale.
Scopo del viaggio è convincere Barre-ra a evitare l’elezione al soglio ponti-ficio del cardinale argentino FernandoLopez, che Alberto ha conosciuto altempo della dittatura militare e che erapesantemente favorevole alla sangui-nosa repressione che caratterizzò quelperiodo. I militari perseguitavano nonsolo coloro che, a torto o a ragione, con-sideravano terroristi o loro fiancheg-giatori, ma anche, e forse soprattutto,quelli che aiutavano i più poveri dellasocietà, perché temevano che si ri-svegliasse in questi una coscienza diclasse che sarebbe stata esiziale perla dittatura. I responsabili della Chie-sa Cattolica argentina appoggiavanola dittatura, vista come un baluardocontro il comunismo e la rivolta dei di-seredati: «Dobbiamo aiutare i poveri,certo, ma non aizzarli contro i ricchi.Gli ultimi sulla terra devono rimanereultimi, per essere i primi nel regno delSignore» (pag. 46).
Nei colloqui col vecchio compagno, Al-berto racconta con dovizia di particola-ri gli eventi di quegli anni, le sparizionidi civili, le uccisioni camuffate da inci-denti, le agghiaccianti torture, il terro-re paralizzante dei sopravvissuti e deitestimoni, nonché la nascita del movi-mento delle madri di Plaza de Mayo, dalluogo di Buenos Aires dove le madri (epoi le nonne) degli scomparsi si radu-navano, ogni giovedì pomeriggio, pertestimoniare la loro determinazione nel-la ricerca della verità. Qui subentra laseconda chiave interpretativa del ro-manzo; la vicenda personale di Albertodiventa il modo per ricordare i fatti ac-caduti in Argentina negli ultimi decen-ni, che l’autore racconta con dovizia diparticolari, dal ritorno di Perón nel 1973,alla delusione per la piega autoritariache presero gli eventi, all’instaurarsidella dittatura nel 1976, con il ricordodelle atrocità commesse, la connivenzae la complicità della Chiesa Cattolica apartire dalle sue più alte gerarchie, ilsostegno esterno degli Stati Uniti ed an-che le trame della P2 di Licio Gelli; emer-ge quindi, a poco a poco, e diventa cen-trale nell’opera, la figura delle madri de-gli scomparsi, con la loro determinazio-ne, il loro coraggio, il dolore mai sopitoper la perdita dei propri cari, la solida-rietà che tutte le lega. Se i personaggisono di fantasia, i fatti narrati sono, pur-troppo, veri e reali (al termine del volu-me c’è anche una nutrita bibliografiadelle principali opere consultate).
Alla fine, Alberto riuscirà a convincereil suo amico Ricardo a boicottare la can-didatura del cardinal Lopez, che infattiuscirà sconfitto dal conclave che eles-se Joseph Ratzinger; potrà così tornarein Argentina per continuare a sostene-re le donne che tanto avevano soffertoe che tanto stavano dando per la pacee la giustizia.
Guido [email protected]
� LUCA IMMORDINO, Storia del senti-mento religioso: Nascita, sviluppo e tra-monto delle religioni, ISBN 978-88-99121-10-5, Cavinato Editore Interna-tional, Brescia 2014, pagine 168, € 13,00,brossura.
Un bel saggio quello di Luca Immordino,con esaustiva esposizione delle diverselinee di ricerca sulle cause dell’insorge-re nel mammifero Homo sapiensdel sen-
NONCREDO – LLaa ccuullttuurraa ddeellllaa rraaggiioonnee –È uscito il nuovo volume anno IX, n. 47maggio-giugno 2017, pagine 100; ab-bonamenti: postale € 34,90; digitalePDF € 19,00. Borgo Odescalchi 15/B,00053 Civitavecchia (Roma). Tel.366.501.8912, Fax 0766.030.470 (sito:www.fondazionebancale.it – E-mail: [email protected]). Sommario:
Etica-Laicità. In che senso consiste ecome fare un funerale laico di P. Ban-cale; Religioni senza pace di V. Salva-tore; Elogio della laicità di V. Salvatore;La “buona morte” di F. Rescigno; Santial merito di una sottaciuta psichiatria diL. Pulviani; Il paradosso del crocifisso“debole” di F. Rescigno; La “Salute di-vina” e i facili miliardi dei preti sullapelle dei malati di F. Tulli; Pessimi atei epessimi cattolici di R. Carcano; Diritti ebisogni dell’umanità di E. Galavotti; ”Imezzi prefigurano i fini” di M.G. To-niollo; Disputationes laichedi R. Morelli;I concetti di “bello” e di “buono”: c’en-tra la religione? di D. Lodi; Dulcamara el’esorcista di V. Pocar; ... variazioni sulNulla ... di P. Bancale.
Religioni. Il sufismo, la visione non-duale dell’Islam di P. D’Arpini; Mona-chesimo? di E. Galavotti; Un criminecontro l’umanità, a sfondo religioso, ri-masto nascosto di L. Immordino; Co-scienza della “Presenza” nell’Uno di R.Tirabosco; Guerre di religione di V. Po-car; Cosmismo e comunismo esoterico diL. Ellena.
L’Uomo e il sé. La donna e l’androcra-zia nel Settecento francese di C. Tama-gnone; Si può perdere una vita che fa vi-vere insieme ma non un amore che faamare ancora di P. Bancale;L’astrologianasce nella dura valle dell’Indo ed inquella bellissima del Saraswati (delfiume Swat) di R. Tirabosco.
Pensiero umanistico. Il teatro e la re-ligione in Oriente di P. D’Arpini; La spi-ritualità a-confessionale del Jazz di D.Lodi; La fine del mondo medievale e laChiesa di Roma di D. Lodi.
Pensiero scientifico. La caduta dellecertezze nei fondamenti della geometriadi F. Primiceri; Tempo, spazio e il sognodi Einstein di P. D’Arpini.
Pensiero filosofico. Il male di A. Do-nati.
36 n. 4/2017 (113)
RECENSIONI
timento religioso. L’autore spazia dalleacquisizioni della neurologia, della pa-leoantropologia e della psicologia alle te-si esplicative che da esse derivano. An-che se non sono sempre d’accordo conlui circa queste ultime, resta il fatto cheegli ci fornisce un panorama esaurientedelle possibili spiegazioni a fronte di unproblema antropologico fondamentale.L’insorgere del senso del divino nellamente umana come avviene? Immordinorisponde (p. 48): «La religione non è il pro-dotto di un particolare organo o appara-to, bensì un’elaborazione dovuta alle va-rie funzioni secondarie non create per darvita alle concezioni religiose». Rispostache l’autore ben motiva. Resta il fatto chela scimmia nuda è appiedata e deve so-pravvivere al suolo, senza artigli da pre-datore e senza la velocità di fuga degliungulati. È un eterno viaggiatore in cer-ca di rifugi sicuri senza grandi predatorie risorse alimentari facili. Ma sopravvivetra difficoltà, sofferenza e morte assai piùdegli altri primati a quattro arti prensili.In un’immanenza ostile si può cercareaiuto nella trascendenza?
Immordino dà un po’ per scontate que-ste premesse zoologiche per entrare di-rettamente nel vivo dei problemi psi-cologici e sociologici. Sottolinea giu-stamente come i diversi raggruppa-menti umani abbiano generato culturee costumi differenti, ma con alcune co-stanti; se la fantasia mitogena ha datoinnumerevoli forme al divino, molte sicorrispondono. L’autore vede nellapaura della morte la causa principaledell’insorgenza religiosa, ma mette an-che bene in evidenza gli aspetti gene-tici e neurofisiologici, evidenziando al§ 2.4 che è nel sistema limbico che na-sce l’idea del soprannaturale e del suocontrollo attraverso pratiche magiche,la sottomissione ad esso con la pre-ghiera o l’adorazione e la donazione sa-crificale per ingraziarselo. Nel III capi-tolo si passa ai fattori contestuali e si-tuazionali: l’uomo ricorre al divino peralleviare frustrazioni e incertezze. Op-portunamente, Immordino scrive (p.49): «Dal passato è difficile avere stimedi atei ed agnostici perché spesso era-no uccisi, brutalmente torturati e sot-toposti ad isolamento sociale». Il non-credente è pericoloso perché getta tur-bamento e dubbio nella comunità. Nel-le società iper-religiose si possono stu-prare le donne ed uccidere, ma assolu-tamente “non dubitare del divino”. Loscrittore marocchino Tahar Ben Jellounci ricorda che (ad accezione della co-stituzione tunisina del gennaio 2014)non esiste sul pianeta Stato islamico
che ammetta l’incredulità. La lotta aquesta ha come arma primaria il “sen-so di colpa” e Immordino sviluppa be-ne questo tema nel § 6.2 notando (p.99): «Se Dio manda un buon raccolto al-lora lo si deve ringraziare, mentre sepunisce con la carestia lo si deve ve-nerare ancora di più».
Il VII (pp. 103-109) e l’VIII capitolo (pp.111-127) sono dedicati all’analisi delleallucinatorie percezioni del sacro per ra-gioni alimentari o patologiche e comenascano le psicosi collettive. Nel IX (Lasociologia e le concezioni delle divinità)si evidenzia l’importanza dell’educa-zione infantile per il radicamento dellafede. Ma come può nascere allora lanoncredenza? Immordino risponde (p.133): «L’apprendimento culturale oltreche dal filtro delle informazioni dipen-de anche da come queste vengono in-terpretate dal bambino durante il suosviluppo». Dove prevale addestramen-to orale c’è solido persistere del sensodel sacro; dove prevale lo scritto/letto(p. 137): «La diffusione della scritturaunita alla traduzione dei testi, consentìuna più agevole circolazione delle va-rie idee da una cultura all’altra, decre-tando la rottura dell’isolamento e dellachiusura di certi gruppi o popoli». Lanoncredenza, dunque, nasce più facil-mente se il giovane può acculturarsimolto.
Nel capitolo finale, il X (pp. 143-167),Immordino evidenzia come la culturascientifica sia antitetica a quella reli-giosa, come l’aperto sta al chiuso e lapluralità all’univocità (p. 149). Inecce-pibile la conclusione del § 10.4 (p. 161):
La religione non è l’origine di tutti i mali, maa causa della sua strutturazione che impo-ne una rigida osservanza e staticità, è un ot-timo veicolo per la trasmissione di compor-tamenti aggressivi, di sopraffazione o psi-cologicamente deviati di derivazione arcai-ca. Essa fondandosi sulla convinzione ha per-messo tramite la tradizione il perpetuarsi dicomportamenti anche violenti tipici delle pri-me società umane.
La ragionevolezza e la tolleranza nonsono virtù religiose, ma persino una re-ligione irragionevole e intollerante sot-to la pressione culturale può cambiare.La religione cristiana non è più quelladi quattro secoli fa perché ha dovuto“patire” l’Illuminismo. A quando un “il-luminismo per l’Islam”?
Carlo [email protected]
�MASSIMOFIORANELLI eMARIAGRAZIAROCCIA, Medici eretici: La millenaria ri-volta contro il pensiero omologato, (Pre-sentazione di Giorgio Cosmacini), ISBN:978-88-581-2632-5, Editori Laterza (Col-lana “Storia della medicina e della sa-nità”), Roma-Bari 2016, pagine 136, €18,00.
Saggio storico polibiografico focalizza-to su alcune importanti figure di stu-diosi, pensatori e clinici che si sonoscontrati spesso anche contro dottrinereligiose e loro singoli reazionari espo-nenti. È un testo in difesa della libera ri-cerca scientifica che in Italia è stata di-scriminata se non perseguitata più omeno apertamente prima dalla chiesa,poi dal fascismo e infine dalla Demo-crazia Cristiana e suoi eredi.
L’anatomista Andrea Vesalio (1514-1564) fu giustamente definito “l’altroCopernico” e, come per l’astronomo po-lacco, i suoi scritti furono esaminati dal-l’Inquisizione. Non per caso la sua ope-ra più nota fu stampata a Basilea, cittàsvizzera libera dal controllo censorio delSant’Uffizio romano. Il testo riferiscecon scetticismo le voci secondo cui lasua morte durante un faticoso pellegri-naggio a Gerusalemme non fu del tut-to casuale. Ma è documentato che l’In-quisizione, in casi particolari di ereticipentiti, comminava pene alternative co-me messe, pellegrinaggi, ecc.
Vesalio non era certo ateo ma il suo pri-vilegiare lo studio materiale del corpoumano lo rendeva sospetto di empietà.Allo stesso modo, circa duemila anniprima, Ippocrate di Kos fu sospettato diun “particolare ateismo” avendo scac-ciato gli dèi dal pensiero medico dive-nendo il primo a indirizzare la medicinasu un sentiero scientifico: la sua era unamedicina totalmente “laica”. Leggen-do le sue opere è evidente l’indifferen-za metafisica.
I monaci greci e latini che tradussero ericopiarono gli scritti medici dell’etàclassica sono accusati nel testo di ine-sperienza, trascuratezza e dolo poichégli umanisti del Quattrocento vi trova-rono molti errori. Gli autori ricordanoche pure nei paesi islamici finirono alrogo dei libri medici sospetti di eresiacome nel caso di quelli di Averroè (1126-1198). Lui stesso fu condannato a mor-te per eresia ma il califfo Al-Mansurcommuterà la pena nell’esilio.
Trattando la figura di Paracelso (1493-1541) se ne ricordano i meriti scientifi-
37n. 4/2017 (113)
RECENSIONI
ci ma pure il suo sostanziale agnostici-smo. Non per caso stampava anche luii suoi scritti a Basilea, da principio informa anonima.
René Favaloro, famoso chirurgo argen-tino (1923-2001) si distinse per il suo im-pegno sociale a favore dei malati più po-veri ma fu indotto a suicidarsi in quan-to travolto dalla crisi economica provo-cata soprattutto dalle colossali ruberiedei politici locali e loro complici, clero inprimis. Nel 2016 un politico argentino èstato colto mentre cercava di riciclaretramite un monastero di suore ben 8 mi-lioni di dollari frutto di tangenti(www.rainews.it del 15-6-2016) a ri-prova delle complicità clericali nella tan-gentopoli locale.
Nella lotta contro il dolore, specie quel-lo legato al parto, si ricorda l’opposi-zione della chiesa anglicana contro lepratiche anestetiche. Anche i settori piùfanatici del laicato reazionario medicocattolico italiano si opposero per de-cenni «contro l’uso degli oppioidi nellecure palliative». Certi medici cattoliciintegralisti chiedevano pareri al Vati-cano sulla liceità del ricorso ai narcoti-ci. Erano stati indottrinati da certi as-surdi dogmi della loro religione secon-do cui «siamo nati per soffrire».
Pierino Giovanni [email protected]
� GIANLUIGI NUZZI, Via Crucis (Da re-gistrazioni e documenti inediti la diffi-cile lotta di papa Francesco per cambiarela Chiesa), EAN: 9788861904958, Chia-relettere Editore (Collana “Principio at-tivo”), Milano 2015, pagine 336, € 18,00,brossura. Questo libro, pubblicato contempora-neamente in venti paesi, dà un contri-buto importante per sfondare il muro diomertà e silenzio che protegge da sem-pre il Vaticano. È un’approfondita ana-lisi giornalistica sull’«incredibile sper-pero di denaro da parte di chi governala chiesa». Pur dichiarando che l’operanon è animata da spirito anticlericale,per il suo scottante contenuto e per leaffermazioni polemiche, ha provocatouna reazione oscurantista in una partedella curia.
Nel paragrafo “Jessica e gli altri” si sve-lano le degenerazioni erotiche di cardi-nali e monsignori: «la sera vanno adadescare giovani nei locali di Roma»,
bellissimi «segretari, semplici funzio-nari percepiscono anche 15.000 euro almese» per meriti di alcova. Sui vizi ne-fandi del cardinal Pell si citano le preci-se accuse contro di lui formulate da exchierichetti, sacerdoti e laici vari.
Nel capitolo dissacrante intitolato “Lafabbrica dei santi” si svelano abusi, pre-varicazioni e false promesse moraliz-zanti fatte dalla cricca affaristica vati-cana che vi si arricchisce approfittandodella credulità popolare. I fasti dei «car-dinali a canone zero» sono illustrati sen-za pietà in un paragrafo apposito den-so di notizie documentate sui loro me-ga-appartamenti con relative più o me-no numerose servitù: la casa del cardi-nal Levada sarebbe addirittura «una re-sidenza principesca».
Il testo svela anche «i conti misterio-si» dei papi defunti ma tace su quelli,sicuramente ricchissimi, di papaWojtyla. Pochi sanno che in Vaticanosono attive due banche, lo IOR, notis-sima banca al centro di infiniti scan-dali, e l’APSA, sigla di una strutturaamministrativa vaticana che in realtàsvolge anche attività di tipo bancario,non a caso la famiglia Mennini le diri-geva entrambe. Lo scandalo di mon-signor Scarano, contabile dell’APSA,finito su tutti i giornali, ha rivelato co-me il papato continua a riciclare de-naro sporco cagionando danni econo-mici gravissimi all’economia italiana.Il libro contiene anche foto e riferi-
menti allo scasso di una robusta cas-saforte vaticana a riprova di come que-sto micro-Stato sia spesso in balia del-la criminalità comune.
Il libro indaga anche sul sistema pen-sionistico vaticano ipotizzando truffecolossali sulla base di precisi dati stati-stici. Documenti alla mano, si eviden-zia il “Buco nero” dell’Obolo di San Pie-tro sui cui bilanci vige una certa segre-tezza per nascondere ruberie e malver-sazioni. Nel libro è citato anche unoscottante carteggio riservato fra il Va-ticano il faccendiere piduista UmbertoOrtolani e il banchiere mafioso Miche-le Sindona.
Il papato possiede autentici lussuositesori immobiliari all’estero per un to-tale stimato di ben 591 milioni di eu-ro. Le finanziarie riconducibili al Va-ticano site nei paradisi fiscali hannouna contabilità occulta. Per venire acapo delle sue immense ricchezze ilVaticano ha dovuto versare cifre ele-vate a prestigiose società di revisioneriportate con precisione nel libro. Inconclusione, si riconferma la dop-piezza e malafede del Vaticano il cuicapo predica in una maniera mentre isuoi sudditi (questo Stato è formal-mente una monarchia assoluta) svol-gono continue attività corruttive e ta-lora anche criminali.
Pierino Giovanni [email protected]
38 n. 4/2017 (113)
LETTERE
�Riflessioni su di un recenteviaggio in Iran
Qualche tempo fa ho fatto un viaggio diuna dozzina di giorni in Iran e ne ho ri-portato alcune impressioni che mi piacecondividere con voi. Devo premettere an-zitutto che ero stato informato sulla scar-sa propensione del popolo iraniano, so-prattutto nelle grandi città, a seguire idettami delle autorità in tema di religio-ne e quindi sulla tendenza/aspirazionedella gente ad omologarsi a sistemi di vi-ta occidentali.
[…]
La gente: è stata la più piacevole dellesorprese in quanto, contrariamente al-le leggende metropolitane diffuse in al-cune aree di opinione occidentali (an-che italiane), gli iraniani sono cordialis-simi, allegri, gentili e, quando sentiva-no parlare dell’Italia, si illuminavano.Una piccola nota di costume: nei bazarnon sono assolutamente assillanti (co-me in Egitto o Tunisia) e in certi casi ad-dirittura, anche se non hai acquistatonulla, ti salutano con viva cordialità. Lareligione, soprattutto tra i giovani, nonè affatto sentita e anzi l’invadenza del-le autorità islamiche in questo senso èvista con fastidio. Ragazzi e ragazze fra-ternizzano, in alcuni contesti locali co-me la città di Isfahan (a mio avviso lacittà più bella) tra di loro, con grandedisinvoltura senza (apparenti) tabù.L’obbligo del velo per le donne, impo-sto di fatto anche alle turiste, è stem-perato/aggirato per le giovani ragazzedal fatto di essere portato a metà delcapo lasciando quindi in bella evidenzamolti capelli (che invece i conservatoridelle scuole coraniche, che abbiamo vi-sitato, considerano nella loro visioneislamofobica un chiaro richiamo ses-suale per i maschi) per di più spessobiondi, con le meches e con trucchi al-l’occidentale. Un episodio fra i tanti: nel-la città di Kerman all’ingresso dell’al-bergo uno schermo gigantesco mostra-va, durante i giorni del lutto (l’equiva-lente del nostro 2 Novembre) immagi-ni di uomini che si battevano il petto inmoschea con forme ripetitive e invoca-zioni ossessive. A pochi metri un grup-po di ragazze (giovani e carine) chiac-chieravano tra loro e io avvicinandomicerco di attirare la loro attenzione suquanto passava in televisione chieden-do «che ne pensate?». E loro mi guar-dano divertite, come dire, ma lasciali fa-re quelli lì. Una ha addirittura fatto uncenno di ... scherno e di derisione!
[…]
Conclusione: chi può vada in Iran a vi-sitare un paese meraviglioso ancorain bilico tra passato storico/archeolo-gico affascinante e presente partico-larmente stimolante proprio perché simisurano concezioni arcaiche e vogliadi modernità delle nuove generazio-ni. Ai lettori de L’Ateo raccomando diverificare di persona, se vorranno pro-gettare un viaggio nell’antica Persia,come il secolarismo e la cultura stia-no infliggendo colpi mortali alle ideo-logie religiose anche in realtà comequelle islamiche che si vorrebbe daqualcuno impermeabili alla crescitadei valori laici.
Leonardo [email protected]
� Proposta
Cari amici, sono stato sollecitato a scri-vervi dalla intervista di Stefano Bigliar-di a Claudio Bondì pubblicata su L’A-teo 2/2017 (111) a pagine 25. Sentii par-lare o qualcosa lessi anni fa sul film Dereditu-Il ritorno e ne cercai più volte ilrelativo DVD, ma inutilmente. Ora ca-pisco perché fu inutile la mia ricerca.
Seguendo le vostre informazioni sonoandato su YouTube a vedere il film. L’hotrovato decisamente interessante e icommenti che ho letto ne confermanoil valore. Tuttavia non l’ho molto gu-stato perché un conto è vedere il film al
computer ed un altro è vederlo con cal-ma su uno schermo più adatto ad unfilm. Inoltre si tratta di un’opera che ri-chiede pazienza per la comprensionedei riferimenti e delle affermazioni inessa contenute dal momento che af-fronta temi di livello culturale non sem-pre a portata di tutti e quindi che ne-cessitano di approfondimento. Oltre aproblemi tecnici come per esempio ilfatto che sul mio computer la visone aschermo intero risulta sfuocata.
Vi chiedo: visto il carattere del film, da-ta la sua valenza culturale che dà ri-sposte a domande di ateismo teorico,perché l’UAAR non si fa parte diligen-te nel promuovere o nel produrre unDVD? Io sono pronto ad acquistarne piùcopie. Non mi pare che quanto chiedoesca dai compiti istituzionali della no-stra associazione.
Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti.
Manlio Padovan, [email protected]
�Nota
Agli autori della bibliografia del Prof.Domenico Contartese su Gesù (“Ri-chiesta di dedicare un numero de L’A-teo alla Storicità di Gesù”) – n. 111,2/2017, p. 45 – è doveroso aggiungereAmbrogio Donini e David Donnini.
Davide [email protected]
39n. 4/2017 (113)
COS’È L’UAAR
L’UAAR, Unione degli Atei e degli AgnosticiRazionalisti, è l’unica associazione nazionaleche rappresenta le ragioni dei cittadini atei eagnostici. È un'associazione di Promozione So-ciale (n. 141 del Registro Nazionale presso ilMinistero del Lavoro, della Salute e delle Poli-tiche Sociali). L’UAAR è completamente indi-pendente da partiti politici.
I VALORI DELL’UAAR
I valori a cui si ispira l’attività dell’UAAR sono:l’eudemonismo; la razionalità; il laicismo; l’au-todeterminazione; il rispetto dei diritti umani;la democrazia; il pluralismo; l’uguaglianza; lavalorizzazione delle individualità; le libertà dicoscienza, di espressione e di ricerca; l’acqui-sizione della conoscenza attraverso il metodoscientifico; il principio di pari opportunità nelleistituzioni per tutti i cittadini, senza distinzionibasate sul sesso, sull’identità di genere, sull’o-rientamento sessuale, sulle concezioni filoso-fiche o religiose, sulle opinioni politiche, sullecondizioni personali e sociali.
COSA VUOLE L’UAAR
La nostra associazione persegue questi scopi:• tutelare i diritti civili degli atei e degli agno-stici, a livello nazionale e locale, opponendosia ogni tipo di discriminazione, giuridica e difatto, nei loro confronti, attraverso iniziative le-gali e campagne di sensibilizzazione;• contribuire all’affermazione concreta del su-premo principio costituzionale della laicità delloStato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni,e ottenere il riconoscimento della piena ugua-glianza di fronte alla legge di tutti i cittadini in-dipendentemente dalle loro convinzioni filoso-fiche e religiose. In particolare, pretendere l’a-bolizione di ogni privilegio accordato, di dirittoo di fatto, a qualsiasi religione, in virtù dell’u-guaglianza di fronte alla legge di religioni e as-sociazioni filosofiche non confessionali;• affermare, nel quadro di una concezione laica,razionale e areligiosa dell’esistenza, il diritto deisoggetti a compiere in autonomia le scelte re-lative alla sessualità e alla riproduzione, com-prese quelle sulla interruzione volontaria dellagravidanza; a stringere unioni familiari legal-mente riconosciute, senza distinzioni di sesso,e a recedere dalle stesse; a determinarsi libe-ramente sul proprio fine vita; sostenere la li-bertà della ricerca scientifica, filosofica ed arti-stica; operare perché tali diritti e libertà trovinopiena sanzione ed effettiva garanzia;• promuovere la valorizzazione sociale e cul-turale delle concezioni del mondo razionali enon religiose, con particolare riguardo alle fi-losofie atee e agnostiche. www.uaar.it
Il sito internet più completosu ateismo e laicismo
Vuoi discutere con gli altri socidell’attività dell’UAAR? Iscriviti alla
MAILING LIST [UAAR]
Vuoi leggere ogni giorno notiziesu ateismo e laicismo? Sfoglia il blog
A RAGION VEDUTA
L'UAAR è presente sui socialnetwork: Twitter @UAAR_it
Facebook UAAR.itTi serve supporto legale per questioni
legate alla laicità?Scrivi a: soslaicità@uaar
ISCRIZIONE ALL’UAAR
L'iscrizione è per anno solare (cioè scade il31 dicembre) e consente l'accesso all'areasoci sul sito UAAR in cui è disponibile an-che la versione digitale de L’Ateo. Le iscri-zioni raccolte dopo l'1 settembre decorre-ranno dall'1 gennaio dell'anno successivo,se non specificato diversamente. Le quoteminime annuali sono (per le modalità dipagamento vedi ultima pagina):*Quota ridotta: € 10Socio ordinario web: € 20**Socio ordinario: € 30**Sostenitore: € 50**Benemerito: € 100* quota riservata a studenti ed altri soci incondizioni economiche disagiate, con tes-sera nel solo formato digitale (pdf)** quote comprensive di abbonamento aL’Ateo in formato cartaceo
SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE
È possibile sostenere indirettamente l’UAARsecondo varie modalità. Essendo l’UAARun’associazione di promozione sociale, lesomme ad essa corrisposte a titolo di eroga-zione liberale possono essere detratte dal-l’imposta lorda IRPEF. Sempre grazie al suostato di APS, l’UAAR può anche ricevere do-nazioni e lasciti testamentari. Infine, acqui-stando libri da IBS e LaFeltrinelli.it attraver-so il sito UAAR, l’associazione percepisce unacommissione. (Maggiori informazioni alla pa-gina http://www.uaar.it/uaar/erogazioni). Codice Fiscale: 92051440284.
SEGRETARIOStefano Incani
PRESIDENTI ONORARILaura Balbo, Carlo Flamigni,
Piergiorgio Odifreddi, Pietro Omodeo,Valerio Pocar, Sergio Staino.
COMITATO DI COORDINAMENTOStefano Incani (Segretario)[email protected]
Cesare Bisleri (Eventi)[email protected]
Roberto Grèndene (Campagne)[email protected]
Massimo Maiurana (Tesoriere)[email protected]
Paul Manoni (Relazioni interassociative)[email protected]
Anna Bucci e Liana Moca (Circoli)[email protected]
Adele Orioli (Iniziative legali)[email protected]
Massimo Redaelli (Relazioni internazionali)[email protected] (Comunicazione Interna)[email protected]
COLLEGIO DEI PROBIVIRI [email protected] Albertin,
Gabriella Bertuccioli, Maurizio Mei
RECAPITO DEI CIRCOLIANCONA (P. Mannoni) Tel. 333.5230565
ASCOLI PICENO (E. Angelini) Tel. 320.2593664BARI (M. Schirone) Tel. 366.8951753
BARLETTA-ANDRIA-TRANI(V. Betti) Tel. 392.3366187
BERGAMO (G. Barcella) Tel. 349.2715014BOLOGNA (R. Grèndene) Tel. 331.1331237BRESCIA (F. Zanotti) Tel. 339.2211869CAGLIARI (G. Fancello) Tel. 331.1331244CATANIA (G. Vaccaro) Tel. 331.1330657COSENZA (G. Iovine) Tel. 347.5706965FIRENZE (M. Mangani) Tel. 331.1331149
FORLÌ-CESENA (P. Cortesi) Tel. 347.8962164GENOVA (G. Solari) Tel. 331.1331144L’AQUILA (L. Moca) Tel. 328.1227901LA SPEZIA (C. Bisleri) Tel. 366.8985459LECCE (C. [M.] Mattia) Tel. 348.7616949LIVORNO (C. Sturmann) Tel. 393.3267086MILANO (A. Stevan) Tel. 331.1331121MODENA (E. Matacena) Tel. 059.767268PADOVA (E. Corteggiani) Tel. 331.1331109PALERMO (G. Maone) Tel. 392.9277905PARMA (A. Ricchieri) Tel. 333.7633012PISA (P. Corradini) Tel. 331.1330597
PORDENONE (L. Bellomo) Tel. 392.0632246RAGUSA (M. Maiurana) Tel. 366.8951787RAVENNA (C. Pagnani) Tel 328.0026748
REGGIO EMILIA (A. Morlini) Tel. 340.7304413RIMINI (R. Scarpellini) Tel. 333.7765242ROMA (C. Visciano) Tel. 338.3163509
SALERNO (F. Milito Pagliara) Tel. 328.9147853SAVONA (F. Marzadori) Tel. 349.3827339
SIENA (A. Massi) Tel. 346.8468650TARANTO (G. Malatesta) Tel. 345.0629815
TERNI (C. Coppo) Tel. 331.1330643TORINO (G. Pozzo) Tel. 331.1330651TREVISO (A. Monda) Tel. 331.1330649UDINE (M. Licata) Tel. 328.4151316
VARESE (G. Barbieri) Tel. 328.3971088VENEZIA (S. Paparozzi) Tel. 331.1331225VICENZA (E. Rossi) Tel. 0444.348507
RECAPITO DEI REFERENTIAOSTA (M. Pilon) Tel. 339.1055742
BELLUNO (A. Stulfa) Tel. 347.8678940BIELLA (C. Larghi) Tel. 329.8184158BRINDISI (L. Reale) Tel. 338.9325413
CAMPOBASSO (N. Occhionero) Tel. 333.4591217CASERTA (M. Pignetti) Tel. 328.7082597FOGGIA (G.M. Gasperi) Tel. 335.7184729IMPERIA (A. Gabrielli) Tel. 329.9815451LECCO (M. Zuccari) Tel. 348.6040721
MASSA-CARRARA (F. Bernieri) Tel. 348.8544605NAPOLI (D. Sibilio) Tel. 331.3028925PAVIA (E. De Marchi) Tel. 393.6355201PERUGIA (N. Bernardi) Tel. 349.5639684POTENZA (A. Tucci) Tel. 333.4249093TRENTO (R. Bordin) Tel. 339.1304268TRIESTE (D. Saiani) Tel. 370.1001818
VERBANO-CUSIO-OSSOLA(L. Coppa) Tel. 349.7585574
RECAPITO DEI REFERENTI ESTERI
BELGIO (N. Casano) Tel. +32 479538689GERMANIA (A. Raccanelli) Tel. +49 1639087777SVIZZERA (M. Bianco) Tel. +41 0784053922
Tutti i Coordinatori/Referenti sono con-tattabili anche per e-mail, inviando unmessaggio a: nomecittà@uaar.it(esempio: [email protected], ecc.).
UAARUAAR, Via Ostiense 89, 00154 Roma
E-mail [email protected] Internet www.uaar.it
Tel. 06.5757611 – Fax 06.57103987
40 n. 4/2017 (113)
In questo numeroEditorialedi Maria Turchetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
RELIGIONI A SCUOLA: DENTRO O FUORI?
Ora di alternativa: una trovata diabolicadi Enrica Rota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Educazione: la posizione dell’EHFdell’European Humanist Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Le scuole “confessionali” e il ruolo della BHA (British Humanist Association)di Jay Harman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Istruzione pubblica e religioni in Belgio e in Italia: la “piccola differenza”di Yves Ramaekers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Processi alla scimmiadi Maria Turchetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Laica scuola in laico Stato.A proposito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1388 del 27.03.2017di Silvia Baldassarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Più filosofia per tuttidi Stefano Scrima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CONTRIBUTI
Obiezione di coscienza di Valerio Pocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chi ripagherà i nativi americani?di Fulvio Caporale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uomini e cervelli: a proposito del dibattito di MicroMega su intellettuali e religionedi Franco Ajmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nuovo politeismo: il dio sport. Un paragone tra sport e religione esploratinella loro dimensione collettiva e individuale di Cathia Vigato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Religioni “alternative”: la Chiesa del Santo John Coltranedi Carlo Ottone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Che fine ha fatto Simone di Cirene?di Stefano Scrima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PAROLE, PAROLE, PAROLE …
Persona di Enrica Rota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
NESSUN DOGMA
Una partita truccata? Una risposta a Maajid Nawazdi Sam Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Recensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Lettere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ABBONAMENTO A L’ATEO
L’abbonamento a L’Ateo è annuale e costa € 20, decorre dal primo numero utile e permette di ricevere i numeri pub-blicati nei 12 mesi successivi.
ARRETRATI DE L’ATEO
Gli arretrati sono in vendita a € 5,00 l’uno. Per il pagamento attendere l’ar-ri vo degli arretrati.
PAGAMENTI
Si effettuano sul c/c postale 15906357;o per bonifico bancario (postagiro per ipossessori di conto BancoPosta), sullecoordinate ABI 07601, CAB 12100, con-to n. 000015906357, Codice IBAN:IT68T0760112100000015906357; intesta ti a: Unione degli Atei e degliAgnostici Razionalisti, Via Ostiense 89, 00154 Roma, specificando chiaramentela causale.Pagamenti online tramite carta di creditoo Paypal su www.uaar.itPer l’iscrizione https://www.uaar.it/adesionePer l’abbonamento https://www.uaar.it/abbonamento
PER CONTATTARCI
UAAR, Via Ostiense 89, 00154 [email protected]. 06.5757611 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 17.30).
ATTENZIONE
Per ogni versamento specifica chiara-mente il tuo indirizzo e la causale. Ti invitiamo a compilare il modu-lo online disponibile alla pagina:www.uaar.it/uaar/adesione/moduloin modo da inviarci i tuoi dati e compi-lare l’informativa sulla privacy, o al-meno di comunicarci un numero di te-lefono e un indirizzo e-mail per poterticontattare in caso di necessità.
I dati personali da te forniti sarannotrattati nel rispetto della legge sullaprivacy, così come disposto dall’art. 11del D.L. 30/06/2003, n. 196.
LE LETTERE A L’ATEO
Vanno indirizzate solo a:[email protected] alla:Redazione de L’AteoC.P. 755, 50123 Firenze CentroTel/Fax: 055.711156
Membro dell’IHEU – International Humanist & Ethical Union e dell'EHF – European Humanist Federation

























































![R. Pettazzoni, Saggi di storia delle religioni e di mitologia [1946], a cura di Giovanni Casadio, Loffredo Editore, Napoli 2013](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6342a7746fdf792a6b07e182/r-pettazzoni-saggi-di-storia-delle-religioni-e-di-mitologia-1946-a-cura-di.jpg)