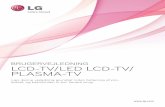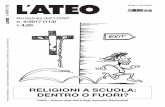Fuori format. Come (e perchè) l'anti-tv si fece tv
Transcript of Fuori format. Come (e perchè) l'anti-tv si fece tv
29
linK 10productFuori
FormatCome (e perché) l’anti-tv si fece tv
una corrente sembra attraversare la stagione tv: quella di programmi-evento che di televisivo hanno
ben poco, e che sembrano persino materia estranea catapultata per sbaglio dentro il televisore. ma se invece anche questo, ormai, fosse poco più che l’ennesimo genere? e se si potesse rintracciarne
la storia tra le pieghe dei programmi e dei volti del passato? del resto, prima di fazio e di saviano, altri autori, da arbore a fiorello, da santoro a celentano,
hanno provato a “domare” l’anti-televisione…
di Massimo Scaglioni
illustrazioni di Elena Rapa
È ricercatore presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Storia dei media. È coordinatore delle attività di ricerca del Ce.R.T.A. (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi) dell’Università Cattolica e collabora con il Corriere della Sera e Il grande talk (Tv2000). Fra le sue pubblicazioni, Tv di culto (Vita e Pensiero, Milano 2006), MultiTv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza (con A. Sfardini, Carocci, Roma 2008), Arredo di serie (con A. Grasso, Vita e Pensiero, Milano 2010) e Televisione convergente (con A. Grasso, Link Ricerca, Milano 2010).
30 31
linK 10product
FUORI FORMAt
linK 10product
FUORI FORMAt
luzione del problema di Diana, almeno nella finzione. Ma il problema, nella realtà, non trova effettive soluzioni: perché l’anti-televisione, nel suo para-dossale statuto ontologico, è insieme il carburante della televisione e la sua antitesi. La soluzione di Diana è giustamente molto pragmatica, un continuo work in progress: se un gruppo di terroristi rossi filma le sue imprese criminose (siamo sempre negli anni Settanta), mi procuro le immagini migliori – “uno spettacolo mai visto prima” – e ci costruisco una serie che chiamo Mao Tse Tung Hour. Piego e manipolo l’“evento” per farlo entrare nel piccolo schermo.
È così che l’anti-tv si fece tv.
Il dIlemma dI dIana e la lIsta dI FazIoTornare su un film che ha più di trent’anni è utile per due ragioni: perché è quella l’enunciazione più esplicita e articolata del problema, e perché il problema si è ripresentato, quasi immemore, nei numerosi commenti e nelle molte analisi che si sono prodotte, recentemente, in Italia. L’inatteso successo – almeno per le sue dimensioni – di Vieni via con me, show in quattro puntate condotto da Fabio Fazio e roberto Saviano, ha generato una varietà d’inter-venti che potremmo chiamare “definitori”. ecco il problema: che cos’è Vieni via con me? e, in virtù di questo suo essere, perché tanto successo?
Vieni via con me è un “nuovo format” televisivo che cambia il rapporto fra tv e politica, che ne inverte i ruoli, con la televisione (meglio, uno scrittore sui generis prestato alla tv) che “fa uso” della politica1. Oppure Vieni via con me non è un format, essendo impossibile “standardizzare il fuori norma”: è piuttosto il calco di un rito religioso radicalmente laicizzato, a rappresentare “l’audience democratica”2.
In fondo, i termini della questione richiamano di-rettamente in causa il problema di Diana Christensen. Vieni via con me ne è una soluzione, ovvero l’ultimo esempio di anti-tv, qualcosa di nuovo, inusuale e mai visto (dove “televisione” si traduce con “norma”), o che, quanto meno, appare tale agli oltre 8.700.000 spetta-tori medi che hanno seguito le quattro puntate. Spet-tatori essi stessi inusuali, come rivela l’analisi dei flussi di consumo: piuttosto giovani (con picchi di share fra i 15 e i 34 anni), prevalentemente maschi, con ottimi e buoni livelli di istruzione e di reddito, con una maggio-re concentrazione al centro-nord. Chiunque sia almeno un po’ familiare con i dati del consumo tv, riconosce la fotografia dell’anti-pubblico tv: che non è costituito da non-spettatori – è una minoranza davvero residuale chi non è, almeno un po’, consumatore di tv –, quanto piuttosto da spettatori-imprendibili, infedeli, dotati di una dieta mediale varia e non esclusivamente tele-cen-trica, interessati al piccolo schermo in certe particolari circostanze. Questo pubblico di light-viewer si è ovvia-mente mescolato a quello generalmente televisivo di heavy-viewer, generando un successo: un’anti-televisione che riesce nell’impresa rara di farsi tv.
Il caso specifico interessa meno in sé che per quello che è in grado di dirci sia sulla società e la cultura italiana contemporanea sia sul sistema tv e sul-le sue logiche. Nonché, ovviamente, sulla connessione fra cultura (intesa in
l’anti-pubblico: spettatori-imprendibili, infedeli, interessati alla tv solo in particolari circostanze.
più che “incarnazione della televisione”, com’è definita dal suo mentore e amante, Diana Christensen, impareggiabile figura satirica disegnata dalla penna di Paddy Chayefsky, incarna del piccolo schermo la sua logica implacabile e, forse, universale. Da intellettuale “interno” alla
macchina mediale, Chayefsky tratteggia fin troppo minuziosamente, nei dia-loghi di Network, tale logica, spingendola all’eccesso nella raffinata parodia del mondo dei tv executive americani. Nel visionare in moviola le immagini di una rapina compiuta alla Flagstaff Independent Bank da un gruppo di marxisti eretici votato alla lotta armata – denominato ecumenical Libera-tion Army che riprende in pellicola le proprie imprese criminali – Diana sente esaltare il proprio fiuto di produttrice (“questa è roba fantastica!”) ed enuncia la propria filosofia: “non ho fatto che dirvelo, da quando ho preso questo lavoro sei mesi fa, che voglio programmi arrabbiati. Non li voglio i programmi convenzionali, su questa rete, li voglio contro-culturali, li voglio anti-sistema”. Diana, “a racist lackey of the imperialist ruling circles”, come si presenta poco dopo, è a capo del “servizio programmi” di una rete che è diventata una “barzelletta industriale” per la sua offerta scadente, ed è alla ricerca di qualcosa di veramente esplosivo: non “l’irresistibile serie sui nuovi avvocati, con protagonisti un ex giudice della Corte Suprema, burbero ma bonario, una bella studentessa in attesa di laurea e un procuratore distrettuale molto brillante e abbastanza di larghe vedute”; non certo “la squadra delle amazzoni, con protagonisti un burbero ma bonario tenente di polizia che viene sempre tartassato dall’ispettore-capo, un testardo e risoluto detective che pensa che le donne debbano stare in cucina e una brillante e bellissima ragazza poliziotto che combatte la battaglia femminista”; non, infine, “un burbero ma bonario direttore di giornale…”. Provvidenzialmente piomba dal cielo, sulla sua scrivania, un vecchio anchorman sboccato e sbroccato, in pa-tetico equilibrio fra un glorioso passato di cronista e un più prosaico presente alcolico: ecco la soluzione per risollevare le sorti della rete. È pressoché noto a tutti il prosieguo di Network, il cui titolo italiano (Quinto potere) perde molto dell’acida vena satirica che Chayefsky riversa sul mondo della televisione, per sposare in toto una critica un po’ scontata del potere del “grande fratello”.
Qui ci interessa piuttosto il cruccio di Diana Christensen. Mente sveglia, fresca e cinicamente lucida, Diana comprende perfettamente che di televi-sioni, in verità, ce ne sono due. C’è quella convenzionale, “formulaica” fino all’esasperazione, che racconta sempre la stessa edificante storia del protago-nista burbero ma bonario e della sua bella controparte femminile… Poi c’è la tv che esplode come dinamite nelle case degli spettatori, che surriscalda il mezzo con la sua lava rovente, che incolla allo schermo gli occhi di tutti, comunque la pensino, solidali con le immagini trasmesse o profondamente indignati per quello che va in onda. Nella finzione di Chayefsky e Sidney Lumet, questa seconda televisione si incarna nelle prediche esasperate di un vecchio anchorman ubriacone, ma anche in un trash show con indovini al po-sto di giornalisti che (anno 1976) anticipa alcune tendenze della tv americana successiva (si intravede già l’ombra sinistra di Jerry Springer). Qualcosa di inusuale, di nuovo, di mai visto, di vitale, …
Il cruccio di Diana è però più profondo, si trasforma in un autentico pro-blema. Perché il suo compito, la sua missione si avvicina alla quadratura del cerchio: spingere l’anti-tv dentro il perimetro della tv. Normalizzare l’ecce-zione, “formattizzare” l’imprevisto. Un omicidio in diretta è la grottesca so-
1. I. Diamanti, “Vieni via con me: il format Saviano”, in Repubblica, 22 novembre 2010.
2. A. Grasso, “Vieni via con me: un po’ come a Messa”, in Corriere della Sera, 24 novembre 2010.
32
LINK 10Product
FUORI FORMAT
senso largo, come un “intero modo di vivere” di una società)3 e televisione.Come ha rilevato John ellis, la televisione non tramonta e non tramonterà,
perché è la migliore messa in forma “del presente, del qui e ora”4. Messa in forma nel palinsesto, orologio a cui ci conformiamo. Le tecnologie mettono a disposizione un’offerta à la carte o on demand sempre più ampia, flessibile e diversificata di audiovisivi, ma la specificità della televisione è di farsi evento. Ciò vale anche per la tv più ordinaria, quella che ripete più o meno stanca-mente delle formule, che annoiava tanto l’arrembante Diana. Non è un caso che il miglior successo del decennio, nei mercati internazionali di tv, sia stato Big Brother, che sa fondere una struttura formalizzata e serializzata estrema-mente semplice e immediata con l’attitudine a “eventizzarsi”, ovvero – nelle edizioni più riuscite – a farsi carico di temi, rappresentazioni, storie, perso-naggi che entrano nello svagato “qui e ora” delle chiacchiere quotidiane, del gossip, persino, in casi eccezionali, della pubblica indignazione. L’anti-tv, allo-ra, rappresenta l’evento alla sua massima potenza: non solo è contingente (qui e ora), ma non è ordinario, è in qualche modo “unico”, catalizza attenzione, discorsi, polemiche più o meno accese e feroci, vive nel presente e condivide spesso con la tv ordinaria l’attitudine a bruciarsi in fretta e a farsi dimenticare rapidamente, una volta consumato.
anatomIa e storIa dell’antI-tvCerchiamo di precisare meglio. La televisione vive di due spinte apparente-mente inconciliabili: da un lato, per ragioni produttive, la tv elegge a proprio standard la formula, ovvero la norma, la routine, la ripetizione. Tecnicamente, la standardizzazione di adorniana memoria5 è la sua regola, fordista e profon-damente moderna. L’industria deve prevedere al millimetro i costi, pianifi-care gli investimenti con ragionevoli certezze sui ricavi (avanzando ipotesi precise sulla quota di viewership e sul suo “prezzo”). Dall’altro lato, la tele-visione deve spingersi sempre oltre la propria norma, andare fuori dai propri perimetri, “scaldare” la relazione col pubblico cogliendo il suo “qui e ora” – dunque i suoi interessi/bisogni/piaceri/paure –, innovare le stesse routine che finiscono presto con lo sclerotizzarsi.
Per anti-tv intendiamo così, paradossalmente, una forma di televisione, con particolari caratteristiche. È il limite cui la tv deve di tanto in tanto tendere per restare in vita e rinnovarsi. Se osserviamo con sguardo storico il passato del piccolo schermo, possiamo persino affermare che l’anti-tv è un genere.
Se ammettiamo che il servizio pubblico, monopolistico – e perciò totaliz-zante – che pareva l’orizzonte assoluto fino agli anni Settanta, era in realtà una (felice?) parentesi dovuta a una particolare contingenza storica (l’impe-gno degli Stati nazionali, la necessità di “educare” alla modernità, di elevare e unificare le popolazioni col nuovo mezzo), la tv emersa in europa dagli anni Settanta/Ottanta ha evidenziato alcune caratteristiche di fondo: è centrata su “formule testate” (i format), che circolano e possono essere adattate e lo-calizzate, è imperniata sulla ripetizione nel flusso e sull’appuntamento atteso in palinsesto, genera un divismo minuto e quotidiano (non Sophia Loren, ma Barbara d’Urso), e i suoi “effetti” sono prevedibili e perlopiù previsti (fi-nanche, con qualche approssimazione e inevitabili errori, nel numero degli spettatori). ecco la norma: ecco quello che chiamiamo, di norma, televisione.
Accanto a essa, vive una forma carsica di anti-televisione che ribalta alcuni suoi capisaldi: si propone come novità assoluta che sfugge alla formula, alla
3. R. Williams, Culture and Society, Chatto-Windus,
London 1959.
4. J. Ellis, “Televisione evento. La tv nell’età
dell’abbondanza”, in Link Mono. Ripartire
da Zero.
5. T.W. Adorno e M. Horkheimer, Dialettica
dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1966.
34 35
linK 10product
FUORI FORMAt
linK 10product
FUORI FORMAt
tanto da essere più volte accostato alla figura del tele-predicatore. Celentano spinge la tv fuori dalla tv, con i suoi continui agganci polemici alla realtà politico-sociale del Paese. Indirizza l’artigianato industriale verso un genere preciso, l’anti-tv: non ha i ritmi ordinari della televisione, usa il silenzio, è simbolicamente e retoricamente fuori norma, fuori formato. Qui avviene la saldatura miracolosa, l’anti-tv si fa tv. Su questa linea ormai tracciata, ritro-viamo altrettanti volti-brand: Gianfranco Funari, ancora più in linea con il modello classico di anti-tv alla Beale; Michele Santoro, che passa da Samar-canda ad Annozero, attraversando anche la tv commerciale con Moby Dick, e ribadendo sempre che il prodotto è, in fondo, uno solo, se stesso; roberto Benigni, che coniuga polemica politica e neo-pedagogismo dantesco; fino ad arrivare a Fazio e Saviano, marchi di un’anti-tv dell’impegno simbolicamen-te contrapposta alla televisione industriale del disimpegno (incarnata, nello stesso slot di programmazione, il lunedì sera, proprio da Grande fratello).
2. Il meccanIsmo: dal tormentone al gIochInoripercorrendo gli esempi appena ricordati, che attraversano un trentennio di tv nazionale, si coglie un secondo elemento di continuità. Come ha osservato Grasso, l’artigianato tv non è “formattizzabile”. La sua logica nondimeno risiede però nell’individuare un meccanismo altrettanto ripetitivo, che sfug-ga all’usura della formula, alla standardizzazione da iper-mercato. L’autore ci trasporta dalla grande distribuzione al negozietto familiare, dove si può inventare un modo diverso di esporre la merce. Questo meccanismo ripeti-bile si avvicina appunto al rito, alla cerimonia, ne è una traduzione prosaica, popolare, laica, tutta basata sulla creatività dell’officiante. Lo stile della tv ar-tigianale di renzo Arbore si fonda così sul meccanismo del tormentone, che è ripreso dalla lunga tradizione della comicità. Il suo utilizzo è molto flessibile, e ben s’adatta alla “provata improvvisazione” (recitare a soggetto, su un cano-vaccio) che è la marca del suo stile, e dei suoi personaggi, da Frassica a Pazza-glia. Il tormentone arboriano eleva una comicità popolaresca, profondamente innervata di tradizioni regionali (il siciliano, il napoletano, il romano) a uno standard nazionale, pescando in un “basso” che viene riportato a galla e reso nazionale (o, meglio, nazional-popolare). L’anti-televisione contemporanea fa un’operazione per certi aspetti analoghi, ma di segno opposto. L’elenco di ciò che è rock e ciò che è lento, proposto come un manifesto politico-culturale dal guru Celentano, piega il tormentone a una visione del mondo personale e soggettiva, cui si può aderire o meno; ha la ciclicità del rito, ma ha reciso, almeno in parte, le proprie radici con il popolaresco e si presenta, piuttosto, come un gioco intellettuale. È su questa strada che si avviano risolutamente Fazio e Saviano: i loro elenchi hanno poco a che fare con il tormentone, ma popolarizzano un “giochino intellettuale” (dall’alto al basso, dunque) che è una vera passione delle culture anglosassoni (la lista come strumento d’ordi-namento, di preferenza, di smaccata parzialità: è la mia lista, è la nostra lista!), praticata per esempio dal Nick Hornby di Alta fedeltà.
3. la Fortuna: dal passaparola alla pIanIFIcazIone Terzo scivolamento. L’artigianato prima mediale e poi televisivo vive, sto-ricamente, di una particolare relazione di contiguità e, oseremmo dire, di complicità col proprio pubblico. Il rapporto fra produzione e pubblico esula dalla pianificazione del marketing, dalla suddivisione in target, dalla previ-
classificazione della tv ordinaria; è saldamente radicata nella cultura nazio-nale, e sfugge alla possibilità di essere esportata, e persino di essere compresa al di fuori di un contesto culturale nazionale; si sottrae alla regolarità del flusso e del palinsesto, perché è evento all’ennesima potenza; almeno in linea di principio rappresenta un rischio, più o meno grosso a seconda di quanto costa, perché gli esiti sono più incerti. In quanto genere, s’avvicina, per molti versi, ai media event di Daniel Dayan ed elihu Katz6, con la differenza pro-fonda di non sincronizzarsi alla “storia capitale” (quella che finisce nei ma-nuali), ma piuttosto, semmai, alla storia della cultura, ovvero della “cultura sottile” contemporanea imperniata sui media7.
Proprio per riprendere una chiave interpretativa proposta da Fausto Co-lombo a proposito della storia dell’industria culturale, da un lato abbiamo una televisione industriale, con produzione e offerta marketing-oriented; e dall’altro lato una tv artigianale o autoriale, profondamente nazionale perché fortemente legata alla sua cultura. Da Quelli della notte e Indietro tutta di renzo Arbore a Stasera pago io e Viva Radio2Minuti di Fiorello, l’artigianato industriale televisivo nazionale ha sviluppato una sua storia peculiare, che sfugge alle logiche correnti della televisione industriale tout court.
Ora – è questo il punto centrale – l’artigianato industriale nazionale ha preso via via le forme di un’anti-tv che fa da contraltare simbolico alla tv ordinaria. Paradossalmente, però, nell’esaltare questa diversità, l’anti-tv ha progressivamente sposato alcune logiche tipicamente industriali, quelle pro-prie della tv “normale”. ecco, in tre punti, come e perché l’anti-tv si fece tv (almeno in Italia).
1. l’orIgIne: dall’autore al brandUn autore – inteso nel senso più pieno, come firma rico-noscibile dotata di uno stile – è la condizione, o meglio l’origine, dell’artigianato industriale televisivo. Nella storia della tv italiana, renzo Arbore ne rappresenta senz’altro il modello esemplare. Alto gradimento, L’altra domenica (e, con essa, Il Pap’occhio), Quelli della notte e Indietro tutta!, pur nella loro diversità anche mediale (radio, tv, cinema), hanno inaugurato uno stile forte-mente personale proprio mentre stava muovendo i suoi primi passi la tv schiettamente industriale, quella com-merciale di Silvio Berlusconi. Che un autore diventi un brand, un marchio di fabbrica che imprime le proprie caratteristiche indipendentemente dal prodotto e dal contesto, è un passaggio semplice e forse inevitabile. Così, l’artigianato industriale televisivo italiano ha imboccato risolutamente questa via maestra. La tv di Adriano Celentano, da Fantastico 8 a RockPolitik, pas-sando per Francamente me ne infischio e 125 milioni di caz…te, è un magma informe e indistinguibile perché
dominato saldamente dalla sua stessa personalità, dalla sua prosa contorta e dalle sue pause, dal suo volto e dalla sua voce. È la tv di Celentano, e basta. Da autore a brand, in un sol colpo. È interessante notare che questo passaggio si compia proprio con Celentano, che – dal punto di vista della rappresen-tazione tv – è colui che si avvicina di più all’Howard Beale di Quinto potere,
6. D. Dayan ed E. Katz, Le grandi cerimonie dei
media: la storia in diretta, Baskerville, Bologna 1993.
7. F. Colombo, La cultura
sottile. Media e industria culturale in Italia
dall’Ottocento agli anni Novanta, Bompiani,
Milano 2001.
santoro, Benigni, fazio e saviano:
marchi di un’anti-tv dell’impegno
contrapposta alla tv industriale del
disimpegno.
36
LINK 10Product
FUORI FORMAT
sione dei consumi, ma si fonda piuttosto sulla condivisione intuitiva di un co-mune retroterra. In questo contesto, contrariamente ai consueti meccanismi dell’odierna distribuzione, non è il prodotto che deve essere adeguatamente promosso per arrivare al pubblico, o ingenerare un desiderio di consumo; è invece lo spettatore o, più in generale, il consumatore che va alla ricerca di quello che vuole. In questa relazione speciale fra produzione e consumo, più che la promozione (dall’alto al basso) funziona il passaparola. È la forza del passaparola, concretizzatasi in una tendenza o in una moda, ancor più che negli effettivi risultati d’ascolto, che ha reso popolari il cacao Meravigliao o le massime di Catalano, per rimanere agli esempi arboriani. La popolarità si manifesta progressivamente, come una palla di neve che cresce. L’anti-tv contemporanea ha adottato un modello di rapporto con il pubblico del tutto opposto. In una prospettiva di pianificazione razionale si assiste alla quasi perfetta sincronizzazione fra l’edizione di un nuovo disco e l’annuncio di un nuovo programma di Celentano. Annuncio che adotta tecniche di promo-zione ben sperimentate, con teaser e polemiche preventive sui giornali che preparano la strada al consueto bagno di ascolti. La fortuna di Vieni via con me si è legata indissolubilmente alla capacità del programma di radicalizzare la retorica anti-televisiva, che ha preparato la messa in onda con una suspense sull’effettiva realizzazione del programma e ha accompagnato ogni successiva puntata con una messe di polemiche circa la parzialità del racconto e della rappresentazione proposta. In una millimetrica partita a scacchi con gli spet-tatori, i giornali, l’opinione pubblica.
una (breve) conclusIone: l’antI-tv a scuola dI tvPur non venendo dal nulla, ma radicando il proprio statuto di genere sui ge-neris nella tradizione dell’artigianato industriale televisivo nazionale, l’anti-tv contemporanea ha compiuto alcuni passi fondamentali che ne hanno assicu-rato l’attrattiva e il successo. È, il genere, un alter simbolico rispetto alla tv ordinaria di produzione schiettamente industriale, che fa di questa eccezio-nalità la sua forza catalizzatrice nei confronti di un pubblico che vi trova un esempio di tv contra tv. e, d’altra parte, l’anti-tv contemporanea ha mediato dalla tv ordinaria alcuni suoi elementi tipici: ha fatto dell’autore un brand; ha trovato un meccanismo narrativo – il gioco (intellettuale) – che si avvi-cina alla formula del gioco mediatico popolare (la nomination), evitandone l’usura grazie a una sua ripetizione rituale pur sempre limitata nel tempo (non più di quattro puntate, per carità!); ha adottato tecniche di promozione non convenzionali, già ampiamente sperimentate (si pensi al sapiente uso delle polemiche che hanno accompagnato la prima edizione di Grande fratello). Fra televisione e anti-televisione, dunque, non c’è più solamente un’inevita-bile, virtuosa antitesi; ci sono reciproci rimandi e influenze. Così, i rapporti fra Grande fratello e Vieni via con me sono forse culturalmente molto più profondi: non possono perciò essere archiviati semplicemente sotto il segno della contingenza di una comune messa in onda, quattro lunedì d’autunno, o di un’altrettanto comune origine produttiva…