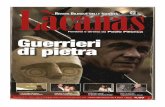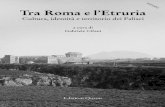G. Cerino-Badone, Gli ultimi 100 metri, Trieste 2013
Transcript of G. Cerino-Badone, Gli ultimi 100 metri, Trieste 2013
Gli ultimi cento metri 79
Introduzione alla battaglia
Accompagniamo la recluta sul campo di battaglia. A mano a mano che ci avviciniamo, il tuono sempre più distinto dell’artiglieria è
presto seguito dal sibilo dei proiettili che attraggono l’attenzione di chi non ha esperienza. Le palle di cannone cadono sul terreno vicino, davanti e dietro di noi. Ci affrettiamo sulla collina sulla quale trovia-mo il generale comandante in capo e il suo numeroso stato maggiore. Qui la caduta delle palle di cannone e l’esplosione delle granate è così frequente che la serietà del pericolo per la propria vita si fa largo nel-l’immaginazione del giovane. Improvvisamente un conoscente cade a terra, una granata colpisce tra la folla provocando un involontario scompiglio: iniziamo a percepire la sensazione che non si è più al si-curo ed in ordine; anche il più valoroso appare sconcertato. Facciamo un altro passo nella battaglia che si svolge davanti a noi quasi ancora come uno spettacolo, fino al più vicino generale di divisione; qui è un susseguirsi di proiettili ed il frastuono della nostra artiglieria accresce lo scompiglio. Passiamo dal generale di divisione a quello di brigata.
Giovanni Cerino-Badone
Gli ultimi cento metriIl volto della battaglia da Solferino alla Marna
Giovanni Cerino-Badone80
Costui, un uomo di riconosciuto valore, si tiene prudentemente die-tro un riparo, una casa o tra gli alberi: un chiaro segnale del pericolo crescente. Colpi di mitraglia squassano i tetti delle case e i campi, palle di cannone sibilano in tutte le direzioni accanto e sopra di noi e si infittisce il sibilo delle pallottole. Facciamo un altro passo verso le truppe, verso la fanteria che regge con indescrivibile tenacia sotto un fuoco che dura da ore. L’aria è piena di pallottole che fischiano; annunciano la loro vicinanza con il suono corto ed acuto con cui sfiorano l’orecchio, la testa e l’anima. A ciò si aggiunga la pena per la vista di uomini feriti e caduti che stringe dolorosamente il nostro cuore già agitato1.[…]Come si procede oggi in una grande battaglia? Da una parte e dal-l’altra si dispongono metodicamente grandi masse di fianco e dietro una alle altre, per non impiegare relativamente che una piccola parte che si lascerà, per molte ore, esaurirsi in un combattimento a fuoco interrotto di tanto in tanto da piccoli assalti alla baionetta e cari-che di cavalleria isolate. Quando questa parte di truppe ha esaurito poco alla volta la sua potenza di fuoco e non ne rimangono che resti, viene ritirata e sostituita con un’altra. In questo modo la battaglia brucia lentamente con un’intensità media come una polvere umida, e quando il velo della notte impone una pausa perché nessuno può vedere e non vuole esporsi al cieco caso, si fa un bilancio di quanti uomini rimangono all’una e all’altra parte che possono considerar-si ancora utilizzabili, cioè che non si siano completamente esauriti come un vulcano estinto. Si valuta che cosa si sia guadagnato o perduto in termini di spazio e quanta sicurezza rimanga ancora alle spalle; a questi risultati si sommeranno le impressioni sul coraggio e la codardia, l’intelligenza e la stupidità propria e del ne-mico in un’unica impressione generale da cui nascerà la decisione se abbandonare il campo di battaglia o rinnovare il combat-timento il giorno seguente2.
Carl von Clausewitz, reduce da intense giornate campali come quella di Borodino, così nel suo celeberrimo Vom Kriege descrive la battaglia. Pochi altri passaggi nel suo lavo-
Karl Wilhelm Wach, Carl von Clausewitz (1780-1831).
Gli ultimi cento metri 81
ro riescono così bene a descrivere quello che egli stesso aveva difficoltà a focalizzare nel dettaglio e che molto acutamente definì “l’attrito”. Gli scon-tri tra eserciti nel XIX secolo furono principalmente battaglie di fanteria. Solo questa può conquistare e mantenere posizioni. Questo concetto è al giorno d’oggi più che mai valido, come hanno dimostrato le operazioni della NATO in Kosovo, e come continuano quotidianamente a dimostrare i combattimenti in Iraq ed in Afghanistan, dove essere presente sul territorio with boots on the ground, per dirla nel gergo anglosassone, consente di fron-teggiare efficacemente il nemico, impedirgli di sfruttare risorse, infrastruttu-re, appigli tattici. A Solferino nel 1859 entrambi i contendenti misurarono i loro successi in base alle porzioni di campo di battaglia occupato. Sul come ottenere questa superiorità tattica i due eserciti avevano sviluppato differenti dottrine. Dagli anni Cinquanta del XIX secolo i tattici europei si trovarono davanti alla necessità di confrontarsi con l’aumentata potenza di fuoco della fanteria, armata con fucili a percussione (maggiore cadenza di tiro) e a canna rigata (maggiore portata e precisione). Il primo importante cambiamento fu l’incremento, presso tutti gli eserciti, europei compresi, delle aliquote di fanteria leggera (Bersaglieri, Jägers, Chasseurs) destinata ad operare in ordine sparso davanti ai reparti in linea. Questo fatto, già negli anni Settanta del
Carlo Bossoli, Battaglia di Solferino, 1859, litografia, 23x16 cm.
Giovanni Cerino-Badone82
secolo, rese possibile la diluizione delle formazioni di fanteria che riuscirono sempre di più a sfruttare il terreno, avvicinarsi al nemico – che rimaneva ‘invisibile’ sino alle brevissime distanze – e cercare riparo sempre maggiore nei confronti delle granate dell’artiglieria divenuta nel frattempo non più un’arma di accompagnamento del soldato ma un agente di distruzione ad azione lontana.
John Keegan ritiene che i ‘momenti’ tecnologici della guerra siano so-stanzialmente tre: armi bianche, armi monoproiettile e armi pluriproiettili. Possiamo però distinguere altre condizioni generali del volto della guerra ed aggiungere che i conflitti dell’era moderna sono segnati dall’adozione di tre tipi di armi: il fucile a pietra focaia, il fucile a retrocarica, il fucile a retrocarica con munizione a polvere infume. La rigatura delle canne ha avu-to in questa storia un’importanza meno decisiva di quello che un tempo si riteneva3.
Il campo di battaglia del fucile monocolpo
La guerra del Settecento non fu la ‘guerra dei merletti’ quanto piuttosto la ‘guerra della potenza di fuoco’. Fu allora che il concetto di ‘potenza di fuoco’ divenne uno degli elementi fondamentali della guerra moderna. Esso nacque con il fucile a pietra focaia alla fine del XVII secolo e si sviluppò nel corso del secolo successivo. Con ‘potenza di fuoco’ indichiamo la capacità di scagliare una massa di metallo contro un nemico, una sua postazione o un mezzo, allo scopo di distruggerlo o di abbattere il suo desiderio di continua-re a combattere. Fu l’elemento che più di ogni altro contribuì a cambiare ra-dicalmente il volto della guerra e la società europea, trasformando entrambi in maniera così profonda che ancora oggi possiamo apprezzarne gli effetti.
Sino a quando l’arma individuale della fanteria rimase a canna liscia e la munizione a polvere nera, gli sviluppi di questo sistema d’arma furono sem-pre compresi tra l’accuratezza della gittata, con conseguente aumento della stessa, e l’incremento della cadenza di tiro. La prima opzione richiedeva una maggiore precisione nella costruzione e la soppressione del cosiddetto ‘vento’, ossia lo spazio esistente tra la palla e la parete interna della canna. La seconda scelta rendeva però assolutamente necessaria l’esistenza di questo spazio, in modo che il proiettile potesse essere facilmente spinto all’interno. Nel XVIII secolo prevalse l’idea di aumentare la cadenza di tiro. Per questa
Gli ultimi cento metri 83
ragione il fucile a pietra focaia Brown Bess, in dotazione alla fanteria bri-tannica dalla metà del Settecento sino alle guerre napoleoniche, disponeva di una canna del calibro di 0,76 pollici (19,30 mm) e di un proiettile che veniva fuso con un diametro di 0,71 pollici (18,03 mm). Questa differenza tra proiettile e canna, di 1/20 di pollice, era deliberatamente così ampia affinché la procedura di caricamento fosse semplificata e, di conseguenza, la cadenza di tiro risultasse aumentata. Sebbene ciò riducesse di molto la pre-cisione e la portata dell’arma, gli svantaggi erano accettati in cambio di una superiore potenza di fuoco alle brevi distanze. Non a caso i sistemi di punta-mento erano del tutto assenti o si limitavano a semplici tacche o rilievi nella parte anteriore della canna4. La portata utile massima di un fucile di questo genere era compresa tra gli 80 e i 180 metri, ma non si deve sottovalutare il suo potere d’arresto. Entro 150 metri gli enormi proiettili di piombo impiegati erano in grado di causare ferite di una gravità tale da mettere im-mediatamente fuori combattimento un uomo5. Nonostante l’avvento della rigatura nel corso del XIX secolo l’agente di distruzione principale rimase sempre non la gittata in termini assoluti quanto la cadenza di tiro.
Un battaglione di 500 uomini, schierato su un fronte di 150 metri, in teoria era in grado di saturare un’area di 100 metri di larghezza con uno sbarramento di 1.500 colpi al minuto, ottenendo che non meno di 500 colpi andassero a segno. Il singolo soldato non mirava contro un nemico in particolare, ma contro la ‘massa’ di nemici. Questo aspetto era sottolineato dagli ordini di puntamento, en joue/present/Schlaget an (letteralmente ab-bassare l’arma) piuttosto di viser/aim/zielen (mirare). Si tratta di prestazioni teoriche, ottenute in poligono da truppa ben addestrata e non in reali situa-zioni di battaglia con materiale umano sotto stress da combattimento. Tut-tavia esse indicano quanto era possibile ottenere in perfette condizioni, cioè prestazioni superiori a quelli di una mitragliatrice della prima guerra mon-diale6. Ad ogni modo un reggimento di fanteria del Settecento e della prima metà del secolo successivo era decisamente più pericoloso da avvicinare che non una unità dell’inizio del XX secolo. Infatti, se quest’ultima era dotata di armi migliori che tiravano a distanze maggiori e con maggiore precisione, se non annullati certamente tali vantaggi risultavano ridotti dalla dispersione dei soldati imposta dal progresso delle armi stesse, e tale dispersione signi-ficava mancanza di controllo sugli uomini impegnati in combattimento, ciò che a sua volta aveva per effetto una scarsa efficacia della fucileria e sul volume di fuoco sviluppato. Ecco i motivi per i quali l’introduzione della
Giovanni Cerino-Badone84
mitragliatrice Maxim fu salutata con entusiasmo; tale arma sembrò aver restituito al comandante di battaglione la possibilità di infliggere numerose e simultanee ferite con una semplice parola di comando7.
Il campo di battaglia non richiedeva precisione nel tiro, quanto l’au-mento della cadenza di fuoco. Nel corso degli anni ’30 del XIX secolo, dopo alcuni tentativi non molto riusciti destinati a sostituire la batteria a pietra focaia, fu messo a punto il sistema di innesco ‘a luminello’, altrimen-ti definito ‘a percussione’. In questo tipo di arma l’accensione della polvere avviene tramite l’utilizzo di una capsula di rame sul cui fondo è spalmata una piccola quantità di fulminato di mercurio. La capsula viene applicata su un tubetto metallico, il luminello, avvitato sulla canna e collegato al fo-cone. Quando il cane si abbatte sulla capsula la detonazione del fulminato al suo interno sprigiona una fiammata che passa attraverso il luminello e giunge alla polvere da sparo nella culatta. Questo tipo di innesco si rivelò il più funzionale e il più rapido tra i tanti sperimentati tra il 1815 ed il 18308. L’esercito francese fu il primo ad adottare l’innesco a percussione su larga scala prima con il Fusil Modèle 1840 e trasformando i fucili a pietra focaia stoccati negli arsenali nel Fusil Modèle 1822 T. Queste armi, rispetto a quelle a pietra, avevano un vantaggio tattico notevole: la cadenza di tiro era di fatto triplicata, e i soldati – a patto di non bagnare le munizioni – riuscivano a fare fuoco anche con il cattivo tempo. In breve tempo il miglioramento delle tecniche di lavorazione del ferro resero possibili anche le rigature delle canne, condizione necessaria per i tiri alla lunga distanza. Ben presto anche le armi rigate e la celebre palla Minié furono estese a tutti gli eserciti.
Il 3 luglio 1863, a Gettysburg in Pennsylvania, circa 12.500 uomini ap-partenenti a nove brigate di fanteria confederata attaccarono le posizioni unioniste di una bassa altura detta Cemetery Ridge. Attraversarono circa un chilometro sotto il fuoco prima dell’artiglieria e poi dei fucili. I sudisti riuscirono a perforare le difese in almeno tre punti ma le perdite subite furono di una tale gravità che non poterono mantenere le posizioni con-quistate e furono costretti alla ritirata. La sola Divisione Pickett perse il 50,5% dei propri effettivi. Solitamente viene spiegato come la potenza di fuoco sviluppata dai fucili ad avancarica a canna rigata dei nordisti fosse in grado di fermare l’attacco dei confederati. In realtà già nel XVIII secolo una simile manovra sarebbe stata respinta con perdite altrettanto gravi. Inoltre, almeno da parte della storiografia militare italiana, poca attenzione è stata
Gli ultimi cento metri 85
prestata all’importante ruolo giocato dai reparti unionisti sui fianchi della direttrice d’attacco confederata9. Molti storici hanno attribuito alle armi rigate la capacità di fermare con gravi perdite qualsiasi attacco sferrato con l’impiego di tattiche mutuate dall’esperienza napoleonica. In altre parole un assalto frontale contro reparti di fanteria in grado di aprire il fuoco tra i 450 e i 300 metri, come appunto avvenne a Gettysburg e a San Martino, non avrebbe mai potuto avere successo. A San Martino nel 1859 i reparti sardi riuscirono in ogni occasione, tranne che nell’attacco delle 17, a raggiungere gli obiettivi tattici a loro assegnati, rappresentati dalla chiesa di San Martino e dalla cascina di Controcania. Ad esempio alle 8.30 del mattino i fanti della Brigata Cuneo furono in grado di avvicinarsi schierati in colonna di batta-glione, aprire il fuoco a breve distanza, e avanzare contro l’avversario che fu costretto a retrocedere. La battaglia degenerò in un continuo attrito tra i due avversari. In linea del tutto teorica questo non sarebbe dovuto accadere e i soldati di Mollard e Cucchiari avrebbero dovuto subire gravi perdite prima ancora di raggiungere la linea di partenza dei loro attacchi all’altipiano di San Martino. Se i reggimenti di fanteria del regno di Sardegna erano ancora armati con il Fucile da fanteria Mod. 1844 a canna liscia, i fanti austriaci
Nathaniel Currier e James Merritt Ives, Battaglia di Gettysburg, 1863, litografia colorata a mano.
Giovanni Cerino-Badone86
avevano come armamento base l’Infanteriegewehr M 1854. Questo fucile, a percussione e a canna rigata calibro 13,9 mm, aveva una munizione più piccola rispetto ai coevi fucili francesi ed inglesi, con una gittata decisamen-te superiore. L’M 1854/II disponeva di un traguardo di mira in grado di inquadrare un bersaglio a 675 metri e le possibilità di colpire un bersaglio a 300 metri erano del 71%, contro un modesto 21% dei fucili Minié.
La teoria della rivoluzione tecnico-militare del fucile a canna rigata è affascinante ma, di fatto, non trova conferme dall’esperienza del campo di battaglia, per varie ragioni:– la dottrina di impiego del periodo prevedeva l’inizio del fuoco difensivo
da parte di soldati schierati in linea a breve distanza (100-150 metri), in modo da infliggere all’attaccante il massimo delle perdite;
– il terreno influenza direttamente il raggio d’azione dell’arma. Ad esempio a Solferino e a San Martino, zona ricca di alberi ed arbusti, esso parcel-lizzava la Kill Zone10 austriaca, e lasciava spazi aperti di una profondità massima di 100 metri;
– il fumo prodotto dalla detonazione di migliaia di fucili e centinaia di cannoni oscurava il campo di battaglia. La polvere nera, una volta bru-ciata, produce dense nuvole di fumo simili ad una fitta nebbia che di fatto impediscono di scorgere non solo i bersagli ma anche le fattezze del terreno a pochi metri di distanza;
– i proiettili dei fucili ad avancarica a canna rigata, come i Lorenz e gli Enfield, compiono una parabola prima di colpire il bersaglio. Sostan-zialmente a causa di questo effetto balistico il soldato del 1859 aveva concrete possibilità di centrare il bersaglio mirando a vista entro i 70 metri di distanza. A distanze maggiori doveva essere in grado di calcolare rapidamente tempi e distanze e regolare di conseguenza l’alzo dell’arma. Impresa che sul campo di battaglia era del tutto impossibile11. I soldati, anche i più esperti, sono in grado di stimare le distanze fino a 450 metri solo con un margine di errore del 25-30%. Una ragionevole probabilità di colpire il bersaglio al primo colpo si aveva quindi a distanze ridotte12;
– mancanza di addestramento al tiro. I soldati non venivano addestrati al tiro mirato e non erano ricreate in tempo di pace situazioni tattiche simili a quelle che avrebbero potuto trovare in battaglia. Questo aspetto penalizzò particolarmente i soldati di linea italiani ed austriaci sui campi di battaglia del 1859 e del 1866.
Gli ultimi cento metri 87
Tutti questi fattori resero gli scontri a fuoco del XIX secolo, dalla Crimea sino alla guerra del 1866, molto ravvicinati tra loro in termini di distanza dal nemico e avvennero tutti tra i 100 ed i 150 metri, come accadde tra il 1861 e il 1865 durante la guerra civile americana. L’idea di una Kill Zone allargata ad una fascia di uno o più chilometri deriva dalla fiducia assoluta che gli storici hanno dato alle testimonianze dei reduci di quel conflitto o ad errate interpretazioni dei rapporti dal campo di battaglia13. In realtà, verificando le fonti scritte con le caratteristiche del terreno, le distanze di combattimento furono molto più ridotte come risulta in questa tabella14:
1861 1862 1864-1865 Media
Distanza percepita 4.500 m 1.100 m 5.700 m 3.760 m
Distanza reale 109 m 114 m 127 m 116 m
Nonostante tutte le mancanze tecniche dei fucili rigati ad avancarica, sui campi di battaglia italiani di San Martino e Solferino fu il fuoco delle armi individuali a dominare la giornata e a causare la maggior parte delle perdite. Gli assalti francesi alla baionetta, così come quelli sardi, servirono solo ad aumentare la lista delle perdite e non risolsero a proprio vantaggio nessun episodio. Anche le analisi più attente di poco posteriori alla guerra del 1859 rilevarono come “i francesi hanno sparato davvero molto e non hanno usato solo la baionetta, così come si è cercato di far credere al mondo”15. Chi visitò il campo di battaglia di San Martino nelle ore immediatamente seguenti la cessazione delle ostilità rimase sorpreso nel vedere “siti ove la carta delle cartucce è alta dieci centimetri”16, segno che il consumo di munizioni era stato veramente elevato. Le colonne dell’esercito sardo, dopo essere state ordinate sulla linea di partenza, muovevano in avanti. Il terreno, il fuoco del nemico, la mancanza di riferimenti tattici, la fatica e il disorientamento dei soldati e degli ufficiali erano elementi che rendevano difficile, se non impossibile, mantenere le formazioni coese ed ordinate: “al primo assalto la brigata erasi scomposta e non formava più che una massa compatta di com-battenti di ogni grado; la quale in tal modo, assalì alla baionetta una dopo l’altra ove cascine ove via via il nemico retrocedendo sgominato, e facendo
Giovanni Cerino-Badone88
fuoco vivissimo, si metteva al riparo”17. La collina di San Martino, specie in corrispondenza della chiesa e della cascina della Controcania, cambia improvvisamente quota. Ciò che a prima vista sembra eccellente posizione difensiva, in realtà a breve distanza garantisce all’attaccante una certa coper-tura dal fuoco radente la cui efficacia era in gran parte vanificata dalle rigo-gliose colture agricole. La ripida collina ‘imprendibile’ e ‘insormontabile’, sulla quale si arrampicarono per tutto il giorno i soldati sardi, permise loro ad ogni occasione di avvicinarsi sino a distanza vantaggiosa di tiro alla linea austriaca. Anzi, la poca distanza era tale che né i cannoni erano in grado di deprimere ulteriormente l’alzo, né i difensori avevano alcuna possibilità di fermare quella massa di uomini che veniva all’assalto e a quel punto, prima dell’urto alla baionetta, regolarmente ripiegavano. Appagati momentanea-mente dal vantaggio tattico conseguito i reggimenti sardi non proseguivano l’azione offensiva, ma non venivano rinforzati e a ridosso delle nuova linea avversaria ingaggiavano un feroce combattimento a fuoco sino a quando, sia per le perdite subite in questo mortifero close combat sia per l’arrivo di un contrattacco austriaco, abbandonavano la posizione.
La baionetta e la sciabola, così care all’epica risorgimentale ed ottocen-tesca in generale, sembra che in battaglia abbiano avuto una sola pratica funzione, eliminare i prigionieri e i feriti: “i Tedeschi uccisero alcuni feriti e prigionieri nostri a furia di sciabolate e baionettate, o li massacrarono a colpi di calci di fucili”18. “Tutto ad un tratto vediamo il nostro Capitano che da una mano teneva fermo il sangue della ferita e da quell’altra la spada, li riva una palla da moschetto e li rompe un pezzo di spada, lui, avelito, guarda la sua spada che ne manca un pezzo e dice: «Ebbene per uccidere un Tedesco sarà sufficiente» e ci comanda la carica alla bajonetta. Noi tutti insieme sia-mo andatti alla carica e lui, il Capitano, trovò un Tedesco che voleva farsi prigioniero e lui avilito colla sua spada gli tagliò mezzo la faccia, e noi ci siamo messi a ridere e lui rideva anche”19. Stress da combattimento e poca predisposizione a fare prigionieri dopo sanguinosi assalti, rendevano questi episodi del tutto legittimi agli occhi dei soldati impegnati in battaglia20.
Il campo di battaglia del fucile a retrocarica
Circondata da potenziali nemici, la Prussia sin dal XVIII secolo sperava di concludere i conflitti armati che la vedevano protagonista il più veloce-
Gli ultimi cento metri 89
mente possibile. Anche nel 1866 il capo di stato maggiore prussiano, Helmuth von Moltke, per la guerra contro l’Austria pianificò una Blitzkrieg in piena regola, allo scopo di colpire la Confederazione Germanica e le forze austriache prima che la mobilitazione dei reparti fosse stata completata. Una volta giunti a contat-to delle forze nemiche queste dovevano essere circondate e tramite una decisiva Kesselschlacht definitivamente annienta-te. La chiave del successo risiedeva nelle tattiche di combattimento dei reggimenti di fanteria prussiani. Mentre gli eserciti europei, suggestionati delle teorie della strategia di Jomini, ritenevano che il suc-cesso fosse solo nel numero degli effettivi, nella massa d’attacco, nelle formazioni tattiche chiuse e nelle posizioni scelte per la difesa, Moltke vide un nuovo approc-cio per ottenere il successo sul campo di battaglia. Riteneva che un’armata ben schierata sul campo ma colpita da una serie di attacchi concentrici di fronte e sui fianchi “avesse sì il vantaggio strategico delle linee interne ma si trovasse comunque sconfitta a livello tattico”21. La formula del successo si basava su tre elementi:
1) L’elevata alfabetizzazione del soldato prussiano. L’alto comando era strettamente controllato da Moltke, il quale silurava e metteva a riposo i generali meno capaci. Ma gli ufficiali dal grado di capitano in giù erano tutti molto giovani, istruiti ed affiancati da numerosi ‘volontari’, ossia studenti universitari ai quali era permesso servire con un grado di ufficiale per un anno di servizio rispetto ai tre previsti se si offrivano volontariamente in caso di mobilitazione. I sottufficiali erano tutti professionisti, orgogliosi del loro grado ed estratti principalmente dalle classi medio-borghesi, ai quali spettava una buona pensione una volta terminato il servizio attivo. Al con-trario delle forze austriache avversarie, e di quelle italiane alleate, i coscritti prussiani erano fisicamente ben allenati, addestrati e disciplinati. Anche i soldati semplici sapevano leggere e risolvere operazioni matematiche, grazie
Helmuth Karl Bernhard von Moltke (1800-1891),
©Collezione Cerino-Badone.
Giovanni Cerino-Badone90
ai programmi di alfabetizzazione delle scuole elementari adottate nel regno di Prussia all’inizio del secolo22. I piani di battaglia potevano essere così pre-sentati impiegando modellini in scala, disegni, mappe ed affrontare esercizi tattici di vario genere ed in svariati contesti. I tre anni di servizio militare erano così intensi e ben organizzati che ai riservisti bastavano solo due o tre raduni all’anno per mantenere in esercizio le proprie nozioni belliche e pressoché nessun raduno alla Landwehr. I coscritti si esercitavano intensa-mente, più che negli altri eserciti europei, al tiro e al fuoco prolungato con la propria arma di ordinanza, sperimentavano le tattiche di combattimento entro scenari verosimili23. L’educazione militare della recluta continuava an-che nelle camerate. I Dienstliche Vorträge o ‘letture di servizio’ risuonavano per i corridoi e le stanze delle caserme dopo le giornate passate in piazza d’armi o nei campi di manovra. I sottufficiali non mancavano di ricordare che “il soldato deve difendere la patria contro nemici esterni e mantenere l’ordine interno”24. Un simile indottrinamento si faceva presto largo tra la giovane truppa, instillando una feroce disciplina che servì non poco a man-tenere coesa l’armata prussiana durante i duri combattimenti nelle guerre del 1864, 1866 e 1870-1871.
2) La potenza di fuoco del fucile a retrocarica. Nel 1866 l’esercito prus-siano era l’unica forza armata al mondo ad impiegare il fucile a retrocarica Zündnadelgewehr M/41, comunemente noto con il nome di Dreyse. Adot-tata già nel 1849, tale arma non suscitava particolari entusiasmi. La chiusu-ra dell’otturatore permetteva la fuga dei gas di combustione della polvere, riducendo così la gettata utile. La cadenza di tiro era sicuramente maggiore rispetto alle altre armi ad avancarica, ma alcuni analisti ritenevano che in mano di truppa poco addestrata le scorte di munizioni sarebbero state esau-rite in combattimenti avanzati prima ancora che la battaglia vera e propria cominciasse25. Un soldato austriaco o italiano nel 1866 portava nella sua giberna circa sessanta colpi, utili per un’ora di fuoco prolungato. La stessa quantità di colpi erano per il Dreyse la munizione sparata in poco più di quindici minuti di combattimento. Mentre i fucili ordinari obbligavano il soldato a caricare in piedi, il fucile a retrocarica permetteva di ricaricare e fare fuoco da posizione inginocchiata e anche prona. Il concetto chiave era piuttosto semplice: interessava maggiormente la cadenza piuttosto che l’accuratezza del fuoco. Inoltre l’addestramento era stato concepito apposi-tamente per incoraggiare le reclute a comprendere sino in fondo le potenzia-lità della propria arma. Mentre i soldati austriaci sparavano non più di venti
Gli ultimi cento metri 91
colpi all’anno, le reclute prussiane potevano spararne almeno un centinaio. I primi si esercitavano in poligono contro bersagli fissi, i secondi in campo aperto, seguiti dai propri sottufficiali.
3) L’impiego tattico di piccole formazioni di fanteria. Le tattiche francesi del 1859 avevano fatto scuola in Europa. Unità di fanteria leggera in ordine sparso avrebbero colpito il fronte nemico, lo avrebbero fiaccato, avrebbero aperto una falla che le colonne di battaglione dei reggimenti di linea avreb-bero sfruttato per lo sfondamento decisivo. I prussiani, grazie alla potenza di fuoco del fucile Dreyse, ruppero la coesione del battaglione come unità tattica di base e formarono una serie di colonne di compagnia o di plotone a seconda delle necessità tattiche, in grado di sfruttare ogni singola oppor-tunità di avanzata e di disporsi in ordine sparso quando e se necessario. Mentre gli eserciti austriaci, italiani, francesi e russi raramente esercitavano la propria fanteria in formazioni più piccole di un mezzo battaglione, il comando prussiano comprese che tali masse di uomini avrebbero ostacolato l’uso del fucile a retrocarica; la potenza di fuoco, e non la baionetta, era la chiave della vittoria. I comandanti di battaglione furono incoraggiati a scindere i propri reparti in mezzi battaglioni, compagnie, plotoni e persino sezioni. Così suddivisa la fanteria prussiana era in grado di incunearsi a forza entro le maglie di un fronte avversario, aggirare postazioni fortemente presidiate e distruggerle con il fuoco incrociato26.
Questi tre elementi formavano l’intelaiatura portante della dottrina ope-rativa prussiana, l’Auftragstaktik [tattica di missione]. Il comandante indica-va gli obiettivi di missione ai subordinati, che potevano eseguire gli ordini nella maniera secondo loro migliore27. Dopo le prove in Danimarca nel 1864, due anni dopo l’Auftragstaktik di Moltke si confrontò, direttamen-te sul campo di battaglia, con la Stosstaktik austriaca. Le prime battaglie sul fronte del nord avevano fatto comprendere al Feldzeugmeister Ludwig [Lajos] Benedek la potenza distruttiva delle nuove tattiche di fuoco prussia-ne. La disposizione tattica della Nord-Armee a Königgrätz il 3 luglio 1866 ricorda molto quella dell’VIII Corpo a San Martino nel 1859. Era un ritor-no alla tipica Stellungstaktik austriaca, ma in questa occasione non si poteva radicalmente cambiare tattica nel pieno di una campagna che era entrata nella sua fase culminante. Inizialmente gli attacchi frontali da ovest della I Armata prussiana furono contenuti con una certa facilità.
Ma l’arrivo della II Armata prussiana da nord aveva completamente stravolto il fronte di battaglia della Nord-Armee austriaca. Nelle prime ore
Giovanni Cerino-Badone92
del pomeriggio l’altura del villaggio di Chlum28 era caduta in possesso della 1a Divisione della Guardia prussiana29 ed ora, per ristabilire la situazione e salvare le proprie forze dall’annientamento, il co-mandante austriaco Benedek doveva rioc-cupare al più presto tale posizione. Ma la situazione stava sfuggendo di mano al-l’eroe di San Martino. Non riusciva più a coordinare qualsivoglia azione di coman-do, continuava a galoppare da un punto all’altro del fronte, come aveva fatto nel 1859. Ora non si trattava più di control-lare tre o quattro chilometri di fronte, ma almeno una quindicina di chilometri e la scala dei combattimenti era a dir poco co-lossale. I primi assalti austriaci a Chlum,
La battaglia di Königgrätz.
August Prinzhofer, Ludwig von Benedek, 1849, litografia.
Gli ultimi cento metri 93
sempre condotti in colonne di battaglione, ebbero esito disastroso. L’IR 52 Herzherzog Franz Carl riuscì a raggiungere le prime case del paese ma venne duramente colpito dalla potenza di fuoco avversaria e rigettato indietro30. La Brigata Prohaska31, appartenente al III Corpo, fu immediatamente lanciata alla conquista delle colline ad ovest del villaggio e, guidata dal colonnello von Catty, avanzò verso il crinale schierata in colonne di attacco. La fanteria austriaca incontrò il solito sbarramento formato dal rapido fuoco dei fucili a retrocarica, fu colpita di fronte sul fianco dalla truppa avversaria attestata alla base del colle a Rosberitz: “quando le masse austriache furono al di sotto dei 100 passi [circa 100 metri, N.d.A.], [i prussiani] tirarono due salve ge-nerali ed aprirono un fuoco continuo con straordinario effetto. Il nemico si fermò per un momento e cadde indietro al riparo della massicciata stradale, soffrendo perdite enormi a causa del fuoco prussiano durante la ritirata”32. Benedek a questo punto si rese conto che doveva riprendere il controllo del villaggio di Rosberitz. Sino a quando non si trovava in possesso di questo centro non avrebbe mai potuto effettuare alcuna controffensiva per ricon-quistare Chlum. Rosberitz era presidiato da truppe di varie unità prussiane che formavano un Kampfgruppe costituito sul momento per la difesa del-l’abitato33. Alle 15.30 dense masse di fanteria austriaca vennero concentrate per l’assalto, fatto questo che non sfuggì all’artiglieria prussiana che venne a prendere posizione sulla collina retrostante: “serrate le une alle altre le dense colonne della fanteria austriaca offrono un bersaglio che non poteva essere mancato, e i cannoni rigati produssero perdite enormi”34. I battaglioni au-striaci “mentre avanzavano per attaccare Rosberitz fermarono la loro corsa al primo colpo tirato dalla collina di Chlum; essi erano colmi di paura, e sembravano paralizzati in quel luogo da una forza magica”35. Oltre cento pezzi austriaci iniziarono il proprio fuoco di controbatteria, ma il primo assalto austriaco contro Rosberitz era stato per il momento respinto. Altre due Brigate, quelle di Jonak36 e Rosenzweig37, avanzarono con una massa di quattro colonne d’attacco lungo i lati sud ed ovest del villaggio. Nonostante le solite gravi perdite subite38, le forze austriache riuscirono ad occupare il villaggio grazie anche al vantaggio numerico che esse godevano sui difenso-ri. Il VI Corpo d’Armata fu incaricato allora di dare l’assalto alla collina di Chlum, presidiata dall’esausta 1a Divisione della Guardia prussiana39. Ma le quattro brigate che formavano la grande unità austriaca non attaccarono in-sieme o in modo coordinato il nemico, bensì una dopo l’altra. Non stavano affrontando truppa italiana o garibaldina ma una divisione della Guardia
Giovanni Cerino-Badone94
prussiana, quanto di meglio Moltke era riuscito a produrre con la sua ri-forma militare. Seguendo come asse di penetrazione una strada campestre affossata nel terreno, definita in seguito ‘la strada della morte’, i reparti au-striaci iniziarono a risalire il pendio, solo per finire in un’imboscata tesa loro da quattro compagnie di fanteria e due batterie d’artiglieria. Il fianco del colle, dolce e privo di significativi ostacoli, permise ai difensori di Chlum di sviluppare tutta la potenza di fuoco che i fucili Dreyse garantivano loro, costringendo gli attaccanti a rintanarsi nel fondo della ‘strada della morte’ dove vennero decimati. Riuscirono ad avvicinarsi a meno di cento metri dalle prime case di Chlum, dopo di che al primo contrattacco gli austriaci andarono in rotta. In sessanta minuti dal primo attacco a Rosberitz il VI Corpo austriaco aveva perso in combattimento 4.805 uomini40. I soldati, rannicchiati al suolo per sfuggire al continuo tiro incrociato dei prussiani, non riuscivano neppure ad alzarsi per caricare le proprie armi. Chi non era stato ucciso non poté far altro che arrendersi.
La guerra austroprussiana del 1866 fu un disastro per l’esercito austriaco. Ogni battaglia aveva seguito praticamente sempre lo stesso copione: una densa colonna di fanteria assaliva senza il necessario fuoco di copertura la linea del fronte prussiano, subendo gravi perdite a causa della rapidità di tiro dei difensori. Nel corso dei primi scontri del 1866 i prussiani uccisero, fe-rirono o catturarono cinque soldati austriaci per ogni perdita subita: 5.000 perdite austriache a Trautenau, 5.500 a Vyskov, 6.000 a Skalice ed infine 44.000 a Königgrätz. Sebbene solo un proiettile ogni 250 sparati dalla fan-teria prussiana colpì qualcosa o qualcuno, tale risultato fu più che sufficiente affinché l’uso del fucile a retrocarica schiantasse il morale del nemico. Gli stessi prussiani riconobbero che “si doveva parlare in tali circostanze di un massacro, non di battaglie”41. Dopo Königgrätz l’armata austriaca aveva a sua disposizione ancora 200.000 uomini pronti al combattimento, ma era-no tanto demoralizzati dal fuoco incessante della fanteria prussiana che i loro ufficiali superiori suggerirono di intavolare al più presto trattative per un armistizio, cosa che l’imperatore fu alla fine costretto a fare42.
Condannare totalmente l’esercito austriaco del 1859-66 e considerarlo un fallimento totale alla luce dei fatti di Königgrätz ha senso solamente se l’impero asburgico avesse dovuto confrontarsi militarmente solo ed unica-mente con la Prussia. L’Austria del dopo Napoleone I doveva combattere prima di tutto le rivolte interne, quindi confrontarsi anche con gli eserciti italiano, francese, turco e russo, solo per citare i principali potenziali avver-
Gli ultimi cento metri 95
sari. L’abbandono delle tattiche del 1859 a favore della Stosstaktik del 1861 fu una scelta razionale per un esercito che, alla prova dei fatti, si dimostrò poco coeso, poliglotta e formato da una massa di contadini per nulla alfa-betizzati. Il rimedio a tali mancanze sembrava essere proprio quello di rag-gruppare questa rozza fanteria e gettarla il più velocemente possibile contro il fronte nemico. Custoza e la campagna trentina del 1866 dimostrano che a livello operativo questa scelta aveva perfettamente senso. Ed avrebbe avu-to senso anche contro qualsiasi altra armata europea, ad eccezione di una, quella prussiana. La Süd-Armee dell’arciduca Alberto ottenne un’importante vittoria sul fronte italiano. La cessione del Veneto al tavolo della pace non deve trarre in inganno. Custoza fu militarmente decisiva, e dopo il 24 giu-gno la minaccia strategica italiana venne praticamente eliminata. Lo stesso discorso vale per Bezzecca e tutta la campagna alpina del 186643.
Completamente differente il discorso a nord. Vienna era scesa in campo con un tipico esercito della metà dell’Ottocento, Berlino aveva invece alle-stito una forza armata pronta per le guerre del XX secolo.
Francia e Prussia 1870
La guerra franco-prussiana del 1870-71 fu il primo conflitto nel quale entrambi gli eserciti in campo erano forniti di armi a retrocarica. La Francia di Napoleone III aveva adottato alla fine del 1866 una nuova arma indivi-duale per la fanteria, il Fusil Modèle 1866 conosciuto come Chassepot44. De-stinato a controbattere lo Zündnadelgewehr prussiano, lo Chassepot aveva un raggio d’azione di 900 m, contro i 300 m del Dreyse. Ma le differenze non si fermavano qui. L’armamento dei fanti francesi era più leggero, più facile da maneggiare ed era in grado di sostenere un rateo di fuoco compreso tra gli 8 ed i 15 colpi al minuto. I prussiani nello stesso tempo non riuscivano a tirarne che 4 o 5, una potenza di fuoco che era risultata eccezionale per il 1866 ma che sarebbe stata superata solo quattro anni dopo. Il calibro, 11 mm, consentiva l’uso di munizioni più leggere lanciate da maggiori quantità di polvere nera. Le ridotte dimensioni dei proiettili permettevano al fante francese di trasportare almeno 105 cartucce, contro le 70 del suo avversario tedesco. Il potere d’arresto era impressionante, come i test effettuati su ca-daveri nel 1868 dimostrarono efficacemente. Nel punto in cui era arrivato il proiettile le ossa erano frantumate, le vene tranciate ed i muscoli strappati
Giovanni Cerino-Badone96
con forza. Il foro d’entrata aveva la stessa dimensione della pallottola, quello d’uscita aveva un diametro sette volte superiore. I cinque colpi sparati ave-vano attraversato il corpo per conficcarsi nel muro del poligono dopo aver trapassato due materassi di protezione45.
Nonostante questi vantaggi tecnologici nelle armi portatili i francesi per-sero la guerra del 1870-71. I prussiani soffrirono gravi perdite e momentanee battute d’arresto a causa della potenza di fuoco del nemico, ma poterono contare su una eccellente artiglieria da campo che, più di quella di Napo-leone III a Solferino, cambiò il volto della battaglia. L’esperienza del 1866 aveva dimostrato a Moltke ed al suo stato maggiore che i prussiani avevano impiegato male la loro artiglieria. I traini, aggregati ai corpi d’armata, erano rimasti spesso esclusi dai combattimenti in quanto sistemati nelle code delle colonne in marcia. I cannoni allora impiegati, 6-Pfünder-Feldkanone C/61, per quanto a retrocarica erano tecnologicamente inferiori alla controparte austriaca mentre la maggioranza degli ufficiali non avevano più avuto alcuna esperienza diretta di combattimento dal 1815. Dopo la guerra del 1866 di-venne necessario operare dei cambi. Mentre i francesi avevano reintrodotto con il liscio Sistema 1858 La Hitte pezzi da 4 e 12 libbre per l’impiego cam-pale, i prussiani scelsero di dotarsi di un pezzo universale da 6 libbre prodotto dalle acciaierie Krupp, che già nel 1864 avevano sviluppato nuovi modelli di artiglieria in acciaio e a retrocarica, il 4-Pfünder-Feldkanone C/6446. Come per lo Chassepot nelle armi individuali, il C/64 era un gioiello ad alta tec-nologia destinato a fornire alla fanteria la necessaria potenza di fuoco per sfondare le linee avversarie. Una cadenza di fuoco di 10 colpi al minuto, una gittata di 3.450 metri, l’impiego di granate ogivali a percussione garantivano ai cannoni di Krupp una maggiore precisione, il doppio della cadenza di tiro e una gittata superiore di un terzo rispetto ai materiali del nemico, ancora ad avancarica ed in bronzo. I cannoni che avevano stupito il mondo nel 1859 erano oramai del tutto superati nel 1870. Lo scontro non era solo sui campi di battaglia, ma anche nei saloni espositivi che venivano allestiti nelle capitali europee. Nel 1867 l’esercito belga rifiutò i materiali francesi per acquistare i cannoni Krupp. Tuttavia l’esercito di Napoleone III mantenne i propri pezzi sostenendone la maggiore mobilità off-road. Anche la dottrina di impiego per l’uso dell’artiglieria fu radicalmente modificata dai prussiani, i quali ammira-rono ed analizzarono l’impiego che nel 1859 e nel 1866 francesi ed austriaci avevano fatto dei loro cannoni ma decisero di intraprendere una nuova stra-da. Le tattiche della fanteria prussiana mal si adattavano alla costituzione di
Gli ultimi cento metri 97
batterie d’artiglieria a disposizione dei comandanti di corpo d’armata, men-tre la dispersione dei pezzi tra la fanteria avrebbe diluito la potenza di fuoco dei cannoni Krupp. L’esercito prussiano dunque decise per l’abbandono delle grossen Batterien [grandi batterie] a favore dell’Artillerie-Massen [massa d’arti-glieria]. La distinzione qui è ben più che solo semantica, in quanto le ‘grandi batterie’ erano statiche linee di cannoni provenienti da varie unità raccolte durante la battaglia e schierate in una sola zona con lo scopo di polverizzare il settore del fronte avversario davanti alla loro posizione. Dopo aver respinto un attacco o aperto una breccia nel dispositivo avversario queste potevano essere mosse in avanti o indietro solo con molta difficoltà e con una grande perdita di tempo. Le ‘masse di artiglieria’ erano dinamiche, si trattava di bat-terie indipendenti le une dalle altre che venivano ammassate dove occorreva, aprivano il fuoco e venivano inviate in altri settori dove era necessaria la loro presenza. La notevole mobilità dei pezzi e il concetto di Auftragstaktik faceva sì che i pezzi prussiani erano sempre a stretto contatto con la fanteria. Men-tre i francesi mettevano in posizione i pezzi ed aprivano il fuoco a notevole distanza, gli artiglieri prussiani si muovevano a stretto contatto con i colleghi della fanteria in modo da ‘vedere’ l’obiettivo ed inquadrarlo con precise salve. Inoltre la tattica di fuoco, basata sul continuo evolversi del combattimento, trovava la sua massima realizzazione nello spostare i pezzi assieme alle colon-ne di fanteria intorno all’obiettivo tattico e saturarlo con un devastante fuoco incrociato che veniva definito zwei-oder dreifaches Kreuzfeuer47.
Un altro grande vantaggio di cui godé l’esercito di Moltke fu la scarsa qualità degli ufficiali francesi, i quali preferirono sempre operare sulla di-fensiva, rifiutando di lasciare le proprie posizioni vittoriosamente difese per sferrare un contrattacco decisivo e lasciando nelle mani dei loro avversari l’iniziativa tattica e strategica. Dopo aver analizzato la campagna del 1866 in Boemia, i francesi decisero di abbandonare le loro tattiche d’assalto im-piegate nel 1859 in Italia. La potenza di fuoco dei loro Chassepots convinse i comandi di Napoleone III, ed in particolare il maresciallo Adolphe Niel, ad equipaggiare ciascuna brigata con 1.000 tra picconi, pale e asce e ad addestrare gli uomini a scavare trincee profonde un metro in 25 minuti di lavoro48. “Così questo è il modo in cui i francesi manovrano, marciano verso le loro posizioni preparate e si attestano senza manovrare, senza usare il terreno, senza accorciare e allungare il loro fronte”49.
Sul campo di battaglia i prussiani intendevano muoversi a piccoli gruppi, mentre i francesi avrebbero raggruppato i propri battaglioni entro fortifica-
Giovanni Cerino-Badone98
zioni campali dalle quali saturare con il proprio continuo e preciso tiro le Kill Zones antistanti. Ma mentre il soldato prussiano era autorizzato a fare fuoco a volontà una volta giunto a contatto con il nemico, quello francese non poteva effettuare più di 5 tiri, dopo di che doveva attendere che un ufficiale verificasse l’effetto del fuoco e quindi attendere nuovi ordini sul da farsi, se riprendere il fuoco o effettuare una manovra. L’aspetto negativo era che i reparti francesi, anche quelli notoriamente più aggressivi come i reggimenti di zuavi o di Chasseurs, avrebbero atteso nelle trincee gli assalti del nemico, senza preoccuparsi di sviluppare a propria volta una credibile tattica di combattimento per la fanteria leggera. Mentre i prussiani distacca-vano sempre almeno 80 uomini in testa alle colonne d’assalto per scoprire la natura dello schieramento avversario, i francesi preferirono adattare la loro fanteria leggera allo schieramento principale allo scopo di sfruttare le qualità balistiche dello Chassepot, rimanendo così esposti ad aggiramenti anche alle brevi distanze: “le tattiche sono cambiate completamente dal 1866. Ora noi combattiamo alla maniera dei nativi algerini, per così dire, e preferiamo sparare alla distanza piuttosto che attaccare alla baionetta”50. Le manovre offensive erano ancora basate sulle colonne di battaglione, sei compagnie in-colonnate in ‘ordine serrato’. Tale massa di uomini contrasta con le più esili colonne prussiane, composte da singole compagnie di 250 uomini ciascuna, spesso suddivise in plotoni: un bersaglio più difficile da inquadrare rispetto alla controparte francese.
Nonostante tutto la risposta francese alle esperienze del 1866 avevano una loro ragione, ma ignoravano l’essenza delle tattiche di fuoco dell’eser-cito prussiano, ossia l’impiego di piccole unità di fanteria molto mobili che cercavano i fianchi del nemico per colpirlo con un tiro incrociato di fucile-ria. “Il segreto del nostro successo è nelle nostre gambe; la vittoria dipende dal marciare e dal manovrare”51. Questa volontà di muoversi sul campo di battaglia fu la differenza chiave tra i due eserciti. Sebbene i reggimenti francesi operassero occasionalmente delle offensive a livello tattico, questi lo facevano sempre a livello di battaglione. Questo modo di operare aveva funzionato bene contro le poco addestrate truppe austriache del 1859, ma sarebbe fallito miseramente, così come era accaduto nel 1866, contro la potenza di fuoco della fanteria e dell’artiglieria prussiana.
Moltke, al contrario, decise di mantenere in suo le tattiche impiegate con successo nel 1866 contro l’Austria e di continuare a far muovere la sua fanteria sul campo di battaglia52. Nel 1868 decise di alleggerire le colonne
Gli ultimi cento metri 99
d’assalto per inviare nelle prime linee un maggior numero di esploratori e di fanteria leggera in modo da coprire l’avanzata, rinforzare i fianchi, metterli in sicurezza ed evitare in tale modo di formare colonne più numerose di 250 uomini. I prussiani si addestrarono intensamente a scindere le colonne di battaglione in colonne di compagnia una volta iniziato il combattimen-to. La pressione sul nemico doveva essere costante e, dal momento che la ricomposizione delle compagnie durante le varie fasi degli scontri non era sempre possibile, si decise di formare sul momento compagnie ‘di forma-zione’ che avrebbero accolto presso di sé quei reparti separati dal resto della propria unità originaria. Infine, tutti gli ufficiali furono forniti di mappe del teatro delle operazioni francesi del 1870. Tutti questi elementi resero l’eser-cito prussiano del 1870 uno degli strumenti bellici più flessibili e mobili del XIX secolo, “una macchina intricata composta da tante piccole parti” che si riuniva a seconda delle circostanze53. Il comando Rechts und Links marschiert auf! divenne un incubo ricorrente per molti soldati francesi: significava che i plotoni prussiani stavano aggirando a destra e a sinistra l’immobile reparto avversario per accerchiarlo e chiuderlo in un cerchio di fuoco.
17:00, 18 agosto 1870, settore nordoccidentale del campodi battaglia di Gravelotte, villaggio di St.-Privat-la-Montagne
Gli storici che si occupano delle guerre del XIX secolo spiegano le gravi perdite subite dagli eserciti del periodo con l’aumento della gittata delle armi impiegate. Nella battaglia di Gravelotte i francesi contarono qualcosa come 5.237 morti, 14.430 feriti e 493 dispersi, contro i 1.146 morti, 6.709 feriti e 4.420 dispersi dei prussiani54. L’agente di distruzione principale fu l’aumentata cadenza di tiro delle armi individuali. Anche se il soldato fran-cese veniva in qualche modo addestrato ai tiri dalla lunga distanza, questi, per le ragioni che abbiamo già analizzato nel caso delle battaglie del 1859, non poteva avere gli effetti che i teorici, e gli storici attuali, desideravano55. Se ne accorsero gli stessi ‘bersagli’, ossia i soldati prussiani, che il pericolo degli Chassepots non risiedeva tanto nella gittata quanto nella loro superiore cadenza di tiro: “quando i francesi, nel 1870, ci salutavano con colpi tira-ti da 2.000 passi [circa 750 m, N.d.A.]56 di distanza, questo in un primo momento ci spaventava, e presto eravamo colti dal desiderio di restituire il complimento. Alcune persone sostengono, dimenticandosi completamente
Giovanni Cerino-Badone100
delle nostre vecchie tattiche, che è necessario adottare il principio di fare fuoco dalle lunghe distanze. Ma se esaminiamo la materia con maggiore freddezza, allora dobbiamo ammettere che se i francesi ci infastidivano con i loro lunghi tiri tra gli 800 e i 1.500 passi [300 e 560 m, N.d.A.], in realtà essi ci procuravano pochi danni”57.
I prussiani si erano impadroniti nella mattinata del villaggio di S.te-Ma-rie-aux-Chênes ed ora potevano minacciare l’estremità del fianco destro francese, ancorato al paese di St-Privat-la-Montagne, a circa 3.000 metri di distanza verso ovest. Il celebre attacco del 1° e del 2° Corpo della Guar-dia Prussiana, effettuato alle cinque pomeridiane, sarebbe stato annientato già nei campi adiacenti Ste-Marie-aux-Chênes, se prendiamo per buone le prestazioni teoriche delle armi della fanteria francese. Ma i prussiani ebbe-ro il tempo di schierare i loro uomini nelle basi di partenza per l’attacco e muovere in avanti: le linee di difesa avanzate francesi erano di 2.000 metri. Le colonne d’assalto della Guardia, pur tra gravi perdite, superarono varie linee di resistenza francesi e giunsero a 300 metri dalle prime case di St-Privat ancora in condizioni di combattere. Nonostante sia stato spesso de-
Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville, Il cimitero di St.-Privat, 18 agosto 1870, 1881.
Gli ultimi cento metri 101
scritto come una sorta di spalto naturale, il terreno tra St-Privat e Ste-Marie è interrotto da muretti, siepi e da almeno due avvallamenti che, secondo i rapporti francesi, permisero agli attaccanti di spingersi molto vicino alla linea di massima resistenza attestata poco ad ovest del paese. In effetti queste ondulazioni permettono il defilamento, e di conseguenza la sopravvivenza, ad un grande numero di uomini. Si tenga quindi conto che i soldati francesi erano addestrati ad aprire il fuoco a 400 metri, fatto che permise agli attac-canti di avvicinarsi e di spingere a fondo il loro attacco58. Le perdite, gravi e decisive, avvennero in questi ultimi 300 metri. Ma davanti ai prussiani non c’erano reparti armati con fucili ad avancarica, bensì truppa equipaggiata con moderni fucili a retrocarica i quali aprirono un fuoco rapidissimo. Le colonne di compagnia avanzarono ancora per qualche decina di metri, riu-scirono sanguinosamente ad arrivare sino a 150 metri dalla linea di massima resistenza del nemico, dopo di che la quantità di proiettili scagliata dai di-fensori rese impossibile ogni progressione59. Eppure, nonostante la distanza ridotta, il nemico sembrava invisibile agli attaccanti. Le teste dei tiratori ed i loro berretti furono le uniche percezioni dirette che i prussiani ebbero dei loro avversari, oltre al micidiale tiro di fucileria al quale erano sottoposti. A quel punto la potenza di fuoco degli Chassepots disintegrò i reparti avversari che si erano avventurati nelle Kill Zones davanti al villaggio. I soldati, im-pazziti di terrore come era avvenuto agli austriaci nel 1866, fuggirono nelle retrovie mentre 8.000 tra ufficiali e soldati agonizzavano al suolo60. Tutto era avvenuto in meno di un’ora di combattimento.
Il campo di battaglia del fucile pluricolpo
Nella seconda metà del XIX secolo apparvero fucili a ripetizione semiau-tomatici, alimentati da un caricatore che conteneva a seconda dei modelli 5 o 10 cartucce. Le altre grandi novità furono l’invenzione della polvere in-fume61, ottenuta dal chimico francese Paul Marie Eugène Vielle, e la mitra-gliatrice. Quest’arma è stata definita dal maggior generale J.C. Fuller come “il concentrato della fanteria”. Con questa definizione intendeva sottolinea-re il fatto che un solo uomo era dotato della potenza di fuoco che in pre-cedenza era stata di quaranta. Ma la mitragliatrice era una cosa ben diversa dal rappresentare solo l’equivalente di un certo numero di fanti concentrati in uno spazio ridottissimo. Il soldato, per quanto ben addestrato, ben ar-
Giovanni Cerino-Badone102
mato, risoluto e pronto ad uccidere, rimane un agente di morte erratico nel senso che, a meno che la sua attenzione non sia indirizzata verso un preciso bersaglio da un ordine del suo superiore, egli sceglierà il proprio bersaglio secondo scelte logiche, od illogiche, del tutto personali o dettate dalla situa-zione contingente (maggiore o minore distanza dalla propria posizione, sen-sazione di pericolosità, aspetto, armamento, grado ecc.). I soldati aprono e cessano il fuoco individualmente, sono distratti dai bersagli stessi che reagi-scono al tiro, dalle ferite del compagno, cedono alla paura o all’esaltazione, sparano troppo alto o troppo in basso con troppa frequenza. Ecco perché nel XVIII secolo gli eserciti europei insistevano giornate intere nelle piazze d’armi per addestrare i propri uomini al fuoco di plotone per salve. In realtà questo continuo esercizio manuale serviva, anche se gli ufficiali del periodo non potevano saperlo, a far reagire i soldati coinvolti in scontri a fuoco con una sorta di ‘pilota automatico’: in altre parole gli uomini imbracciavano le proprie armi e iniziavano il combattimento senza riflessione cosciente. Il continuo addestramento al tiro, con la sequenza di caricamento e sparo, condizionava i soldati a manovrare il fucile in loro dotazione e a sparare in automatico al primo ordine ricevuto in modo tale che continuassero a fare fuoco anche nella situazione di combattimento più caotica e nell’impossi-bilità di udire chiaramente gli ordini, il rullare del tamburo o lo squillare di una tromba62.
Il risultato fu che un reggimento dell’epoca di Federico II di Prussia, di Napoleone I ed anche delle armate francesi o austriaca a Solferino nel 1859 era decisamente molto più pericoloso da avvicinare rispetto ad un reggimento del 1914. Infatti i vantaggi tecnologici delle armi pluricolpo in loro possesso erano vanificati dalla dispersione dei soldati, con conseguente mancanza del controllo dei tiri e la scarsa efficacia del fuoco di fucileria. La mitragliatrice sembrava aver restituito al comandante di reggimento la possibilità di infliggere numerose e simultanee ferite con un solo coman-do. Ma la comparsa della mitragliatrice significò anche ben altro. La sua caratteristica principale consiste di essere una macchina, uno strumento di morte ad alta tecnologia simile ad un tornio di precisione o ad una pressa. Il tiro continuo con una cadenza di seicento colpi al minuto non aveva tanto disciplinato l’atto di uccisione, quanto piuttosto lo aveva meccanizzato e industrializzato. Il mitragliere infatti doveva solo esercitare una pressione sul grilletto e l’arma avrebbe iniziato a sgranare colpo su colpo ricavando ener-gia da se stessa con il rinculo, ed esigendo solo un continuo rifornimento
Gli ultimi cento metri 103
di materia prima e una ridotta manutenzione per poter operare durante un intero turno di lavoro, come una pressa meccanica.
La tattica della colonna, così polare in Germania, alla fine del XIX secolo subì un primo grosso colpo con i resoconti provenienti dal Sud Africa. Du-rante la guerra angloboera del 1899-1902 gli irregolari boeri, armati di fu-cile Mauser, decimarono sistematicamente le truppe inglesi che attaccavano nelle formazioni di plotoni a colonna copiata dai tedeschi63. In realtà i primi rapporti enfatizzarono a dismisura le capacità di tiro dei boeri i quali, tutto meno che tiratori scelti per natura, sconfissero i regolari inglesi bloccando le loro azioni offensive concentrando il proprio volume di fuoco negli ultimi 300 metri. Le umiliazioni patite dagli inglesi sui campi di battaglia sudafri-cani convinsero molti stati maggiori ad abbandonare la tattica dell’ordine chiuso. Già nel 1902 i giornali militari tedeschi e gli archivi del loro stato maggiore erano pieni di articoli che mettevano in guardia dai pericoli del-l’avanzata in ordine chiuso contro un nemico armato con moderni fucili a ripetizione. L’alternativa era quella di adottare una tattica simile a quella dei boeri, dove piccoli gruppi di fuoco si aprivano pazientemente un varco verso le linee avversarie sfruttando gli appigli tattici che il terreno consentiva loro di volta in volta. Nel 1902 furono fatte esperienze sui campi di manovra, ma l’interesse, almeno da parte tedesca, di voler imitare i boeri venne meno. Si era scoperto infatti che era difficile, se non impossibile, per un comandante di plotone controllare i suoi 80 uomini sparsi su oltre 300 m di fronte, alme-no in un periodo storico nel quale erano assenti le comunicazioni radio.
Nel 1904 la tattica ad ordine aperto tornò alla ribalta in seguito ai reso-conti che giungevano dal fronte russo-giapponese. I giapponesi, che dagli anni Settanta avevano affidato la formazione dei propri ufficiali a consiglieri militari tedeschi, avevano sconfitto l’esercito dello zar in Manciuria. No-nostante le gravi perdite subite (279.725 uomini morti o feriti in un anno e mezzo di combattimenti) sembrava che le tattiche di assalto in colonna fossero state la chiave della vittoria nipponica. Alcuni osservatori notarono però che le colonne giapponesi furono presto sostituite da formazioni più aperte, con maggiore spazio tra i soldati e maggiore libertà per i plotoni e le squadre di muoversi in modo autonomo64.
Le fotografie degli eserciti dei primi anni del XX secolo, ed in particolare quelle del 1914, ci possono aiutare a ricostruire la realtà della guerra. Sono testimonianze preziose dal momento che vanno al di là dei regolamenti uffi-ciali. Tutte le foto ci mostrano uomini stretti nei ranghi, in masse compatte,
Giovanni Cerino-Badone104
spesso spalla a spalla. Forse stanno cercando, come suona un detto tedesco, di “sentire la stoffa” del proprio vicino, uno dei modi che hanno gli uomini di farsi coraggio di fronte al fuoco. Lunghe baionette sono fissate ai fucili, giberne ed equipaggiamenti di vario genere sono fissati a cinghie lungo tutto il corpo rendendo i movimenti impacciati, mentre i corpi sono rivestiti da uniformi in stoffa grossolana. I mesi iniziali della prima guerra mondiale segnarono la fine di due secoli di storia per quanto riguarda il modo di com-battere della fanteria per la quale, sempre meno logicamente, si pensava che la migliore difesa, anche contro le armi da fuoco, fossero l’addestramento e la disciplina. Le foto dimostrano che su larga scala non si seguivano i rego-lamenti tattici che in tutti gli eserciti, a partire dal 1905, fissavano i canoni della dispersione. Nell’esercito tedesco i regolamenti del 190665 prevedeva-no, nel caso in cui l’artiglieria non avesse raggiunto il suo obiettivo di far tacere mitraglieri e fucilieri nemici, di scindere la più piccola unità tattica, il plotone di 80 uomini, in mezzi plotoni o squadre singole destinate a correre in avanti di copertura in copertura. A 400 o 500 metri dal nemico le truppe più avanzate si sarebbero fermate e, disposte su un’unica linea, avrebbero iniziato a sparare. La fanteria che seguiva le truppe d’attacco più avanzate si sarebbe a sua volta unita a questa linea, riempiendo gli spazi vuoti per as-sicurare che il maggior numero di fucili possibile facesse fuoco sul nemico. L’obiettivo dei fucili era quello di ottenere la superiorità di fuoco – facendo abbassare la testa al nemico, ostacolando così la sua capacità di restituire un fuoco efficace. Raggiunto questo la fanteria avrebbe approfittato della tem-poranea paralisi dell’avversario e lo avrebbe colpito a fondo con un assalto alla baionetta. Era questa una visione condivisa da tutti gli eserciti dell’Eu-ropa continentale, Russia, Austria, Francia e Gran Bretagna. Era un fatto acquisito che un’elevata potenza di fuoco comportasse forti perdite, ma si credeva anche che la disponibilità ad accettare forti perdite avrebbe condot-to alla vittoria. Nei primi anni del XX secolo si riteneva che la guerra del futuro sarebbe stata molto cruenta, con perdite dell’ordine delle centinaia di migliaia di uomini. La sola guerra franco-prussiana del 1870-71 aveva contato qualcosa come 872.981 soldati persi in combattimento, dei quali 167.079 morti in combattimento e 231.000 feriti. Ciò che non si poteva immaginare era la durata del conflitto. Quello scoppiato nel 1914, infatti, non sarebbe terminato che verso la fine del 1918.
Nelle prime battaglie della Grande Guerra dobbiamo immaginare la fan-teria all’attacco in masse compatte per prendere d’assalto le posizioni nemi-
Gli ultimi cento metri 105
che, tenute da una fanteria altrettanto densamente ammassata, eventual-mente attestata dietro una difesa improvvisata, con un’artiglieria da campa-gna dispiegata all’aperto in posizione ravvicinata rispetto alla linea del fuoco per lanciare salve direttamente a supporto della fanteria impegnata. Nessun esercito aveva però previsto procedure e né era in possesso dell’equipag-giamento necessario per correggere il fuoco dei cannoni una volta iniziato il combattimento. Le comunicazioni si realizzavano con bandiere, segnali manuali o con suoni. La regolazione del tiro dell’artiglieria era quasi sempre effettuata nell’arco della visuale dell’occhio umano.
Le battaglie del 1914, quella della Marna così come quella di Tannen-berg, assomigliano molto a quelle napoleoniche di cento anni prima, con la differenza che la fanteria soccombeva invece di resistere al fuoco e che i fronti si estendevano su ampiezze cento volte superiori. Anche la durata del-le battaglie aumentò, da un giorno o due ad una settimana o ancora di più. I risultati comunque furono approssimativamente simili: perdite notevoli, sia in termini assoluti che in proporzione al numero dei soldati coinvolti66.
Prime ore del mattino, 23 agosto 1914, linea del Canale Mons-Condé nei pressi di Mons, Belgio
La battaglia di Mons fu la prima grande operazione che coinvolse la Bri-tish Expeditionary Force (BEF) durante la prima guerra mondiale. Questo scontro fece parte dell’operazione nota come battaglia delle Frontiere, in cui gli alleati dell’Intesa si scontrarono con i tedeschi a cavallo dei confi-ni di Francia, Belgio e Germania. Nella località di Mons l’esercito inglese aveva ricevuto l’ordine di mantenere la linea del Canale Mons-Condé, che congiungeva le città di Mons e di Condé-sur-l’Escaut e che serviva preva-lentemente per il trasporto del carbone, opponendosi all’avanzata della 1. Armee tedesca. Il corpo di spedizione britannico era all’altezza del compito. L’esercito inglese, unico in Europa, era esclusivamente una forza regolare composta da soldati di professione, veterani di numerosi conflitti scoppiati all’interno dell’impero britannico. Molti di loro avevano quindi combattuto anni prima la guerra angloboera ed avevano sperimentato in prima perso-na la potenza di fuoco che un soldato armato di fucile a ripetizione era in grado di sviluppare in battaglia. Avevano così imparato a temere il fuoco della fanteria e a rendersi conto della necessità di scavare buche profonde
Giovanni Cerino-Badone106
per sfuggire al fuoco. Ricevuto l’ordine di tenere la linea del canale, sin dalla mattina del 23 agosto i britannici si erano solidamente trincerati sulle rive del corso d’acqua.
I tedeschi, che, numericamente superiori, combattevano con sei divisio-ni contro quattro, non erano preparati alla tempesta di fuoco che investì i loro ranghi. “L’impressione più diffusa tra i tedeschi era di trovarsi di fronte un nemico invisibile”67, nascosto dietro zolle di terra appena rigirata, ma più in profondità di quanto francesi e belgi non facessero in altri settori del fronte. Sui fiumi Tugela e Modder, sull’insanguinato Spion Kop, i boeri ave-vano insegnato alla fanteria inglese le regole della guerra moderna e quanto costasse caro attaccare truppa trincerata dotata di armi pluricolpo. Il fucile inglese Short Magazine Lee-Enfield, con i suoi dieci colpi a ripetizione, era un’arma superiore al Mauser tedesco e i soldati britannici erano meglio ad-destrati al tiro, dal momento che i buoni risultati in poligono di tiro erano premiati con un aumento di paga e una fornitura di munizioni supplemen-tari per conquistare il premio durante il tempo libero. Un ufficiale del Gre-nadier Regiment (2. Brandenburgisches) n. 12, il capitano Bloem, scoprì che i britannici si erano attestati lungo il canale ed “avevano trasformato ogni casa, ogni muro in una piccola fortezza; sicuramente il frutto di conoscenze che esperti soldati avevano accumulato in decine di guerre coloniali”. Il 23 agosto la sua compagnia entrò nelle Kill Zones inglesi, ed il pericolo si ma-nifestò immediatamente: “appena passammo il limite del bosco una raffica di pallottole fischiò sfiorandomi e andando a conficcarsi negli alberi alle mie spalle. Cinque o sei grida accanto a me, cinque o sei dei miei ragazzi in grigio crollarono nell’erba [...]. Il fuoco sembrava provenire da lontano e un po’ spostato a sinistra [...]. Era come se procedessimo su un campo di parata [...] lontano di fronte un suono martellante, poi una pausa, poi un martellamento più rapido: mitragliatrici!”68. I soldati che stavano combat-tendo contro i Grenadieren del Brandeburgo erano soldati del 1st Battalion del Queen’s Own Royal West Kent Regiment ed erano i loro fucili, piuttosto che le mitragliatrici – 2 in tutto il reggimento – che causarono le perdite. Alla fine della giornata il reparto tedesco era completamente a pezzi. Oltre 500 uomini erano stati uccisi o feriti, compresi tre dei quattro comandanti di compagnia del battaglione di Bloem. Tutte le unità tedesche impegnate soffrirono analoghe perdite e il fronte inglese non era stato sfondato. Le per-dite inglesi furono di 1.600 uomini tra morti, feriti e dispersi. I tedeschi ne persero almeno 5.000 durante quella sanguinosa giornata di agosto.
Gli ultimi cento metri 107
A fine ottobre 1914 la grande offensiva tedesca contro la Francia era finita, e si era trattato di una sconfitta con costi umani enormi, soprattutto nei corpi di volontari, in particolare in quei reparti formati da studenti uni-versitari e di liceo inizialmente esentati per poter completare gli studi. Oggi presso il cimitero di guerra di Langemark, dietro ad un cancello decorato con gli stemmi di tutte le università tedesche, giacciono in una fossa comu-ne i corpi di 25.000 studenti soldati. Dominano questa distesa di morti dal vicino cimitero di Vadslo le sculture di Käthe Kollwitz, anche lei una madre in lutto del 1914, con due genitori che piangono il loro figlio caduto. È il simbolo del dolore di decine di migliaia di famiglie tedesche per i quali la battaglia di Ypres (21 ottobre – 22 novembre 1914) è solo il Kindermord bei Ypern, il massacro degli innocenti di Ypres, tramonto della speranza di una guerra breve, facile e gloriosa. Fu l’inizio invece di un conflitto di logora-mento e dell’anonima morte di massa.
Conclusioni
L’esperienza bellica del periodo preso in esame dimostra, in tutta la sua crudezza, quale sia stato il vero agente di distruzione: la potenza di fuoco, espressa in termini di celerità di tiro e volume di fuoco, piuttosto che con la qualità del tiro e la gittata. Potremmo aggiungere, almeno sino al 1870, la manovra e la potenza di fuoco, ma appare evidente che il volto della batta-glia prevedeva combattimenti a breve distanza, con truppe decise a colpire duramente il nemico con il proprio fuoco, e quindi assestare il colpo decisi-vo e vittorioso con un fulmineo assalto. Gli ultimi cento metri diventavano dunque decisivi per le sorti dei combattimenti.
Le armi da fuoco individuali prodotte dopo la prima guerra mondiale non a caso sono armi automatiche dotate di un serbatoio di colpi sempre più capace. Gli americani, ad esempio, furono i primi ad adottare per le proprie forze armate un fucile semiautomatico, l’M-1 Garand, in grado di impiegare i gas di scarico delle munizioni sparate per ricaricare l’arma senza la necessità di un intervento umano sulle leve dell’otturatore. Il caricatore conteneva 8 colpi e possedeva una portata utile di tiro di circa 500 m. Il nuovo fucile adottato dall’esercito americano nel 1965 per le operazioni in Vietnam, l’M-16, fu dotato di un caricatore con 20 colpi, mentre la gittata rimase sostanzialmente simile a quella del modello precedente. Nel 1969
Giovanni Cerino-Badone108
l’M-16 divenne l’arma base dell’U.S. Army, negli anni Novanta le sue carat-teristiche tecniche e balistiche furono migliorate, portando le capacità del caricatore a 32 colpi e la gittata utile a 600 m. Ma sia il Garand che l’M-16 non sono fucili impiegati come armi di precisione, bensì per la loro capacità di saturare rapidamente il bersaglio, o l’area dove si pensa il bersaglio sia collocato, con una raffica di proiettili tirati ad una distanza ridotta. Se le gittate utili delle armi contemporanee sono aumentate, le distanze effettive di ingaggio non sono molto cambiate da quelle di Solferino nel 1859, ed in alcuni specifici casi si sono ridotte. Nella seconda guerra mondiale e nella guerra di Corea i combattimenti avvennero normalmente entro i 100 m. In Vietnam, nelle Falkland nel 1982 e nei recenti conflitti in Afghanistan e Iraq tale distanza è stata inferiore anche del 50%, distanze che risulterebbero famigliari alle truppe del XVIII secolo.
L’esperienza del campo di battaglia dimostra che, a dispetto dell’arma-mento (avancarica, avancarica a canna rigata, retrocarica, semiautomatico, automatico a ripetizione, automatico a raffica), il combattimento di fanteria è sempre avvenuto a distanza sempre molto ridotta.
Gli ultimi cento metri 109
NOTE 1 C. Clausewitz (von), Vom Kriege, vol. I, Ferdinand Dümmler, Berlin 1832, pp. 84-5. 2 Ivi, pp. 282-3. 3 Questo paradigma storiografico è stato messo in crisi dai seguenti lavori: P. Griffith, Battle Tactics
of the American Civil War, The Crowood Press, Ramsbury 1987; E.J. Hess, The Rifle Musket in Civil War Combat. Reality and Myth, University Press of Kansas, Lawrence 2008; G. Cerino Badone, San Martino 1859. Analisi di una battaglia, in atti del convegno 150° anniversario II Guerra di Indipendenza, Convegno Nazionale Commissione Italiana di Storia Militare, Roma 5-6 novembre 2009, Roma 2010, pp. 179-222.
4 Sulle caratteristiche del fucile inglese del XVIII secolo cfr. E. Goldstein – S. Mowbray, The Brown Bess. An identification Guide and Illustrated Study of Britain’s Most Famous Musket, Andrew Mow-bray Publishers, Woonsocket 2010.
5 Cfr. N.A. Roberts, J.W Brown, B. Hammett, P.D.F. Kingston, A detailed Study of the Effectiveness and Capabilities of 18th Century Musketry on the Battlefield, in «Journal of Conflict Archaeology» (Glasgow), vol. 4, n. 1-2, 2008 , pp. 1-21. Per le ferite che queste armi erano in grado di infliggere e come potevano essere curate nel periodo compreso tra il 1700 ed il 1850 si rimanda al completo M. Crumplin, Men of Steel. Surgery in the Napoleonic Wars, Quiller Press, Wykey 2007.
6 Cfr. B.P. Hughes, Firepower. Weapons Effectiveness on the battlefield, 1630-1850, Spellmount, London 1974, pp. 27-9.
7 Cfr. J. Keegan, Il Volto della Battaglia, Il Saggiatore, Milano 2001 [ed. or. The Face of Battle, Jonathan Cape, London 1976], pp. 245-6.
8 Cfr. C. Calamandrei, Meccanismi di accensione. Storia illustrata dell’acciarino dal serpentino alla retrocarica, Editoriale Olimpia, Sesto Fiorentino 2003, pp. 199-232.
9 La migliore ricostruzione degli avvenimenti è in M. Adkin, Gettysburg Companion. A Guide to the Most Famous Battle of the Civil War, Stackpole Books, Mechanisburg 2008.
10 La Kill Zone [zona di uccisione] è un’area del campo di battaglia ben definita e relativamente limitata, di cui l’esempio più noto e meglio comprensibile è fornito dalla ‘terra di nessuno’ della guerra di trincea. La profondità della Kill Zone è determinata dalla portata effettiva dell’arma impiegata.
11 Il fucile a canna rigata Lorenz M 1854/I fu equipaggiato con l’alzo fisso. Cfr. E. Gabriel, Die Hand- und Faustfeuerwaffen der habsburgischen Heere, Österreichischer Bundesverlag, Wien 1990, pp. 87-92, 296-7.
12 Le più moderne armi di fanteria e i più moderni metodi di addestramento del XXI secolo tengo-no in considerazione questo dato di fatto. La maggior parte degli eserciti NATO esercita i propri uomini su una distanza di sparo di 200 metri, mentre solo gli svizzeri si esercitano a 300 metri. Rapporti dal campo di battaglia, anche recenti, confermano questo aspetto. Durante la seconda guerra di Indocina la tipica distanza di combattimento era al di sotto dei 300 metri, mentre alle Falkland nel 1982 il primo combattimento terrestre, Goose Green (28-29 maggio), fu ingaggiato ad una distanza inferiore ai 50 metri. Cfr. R.H. Scales, Firepower in limited war, Presidio Press, Novato 1997, pp. 77, 200.
Giovanni Cerino-Badone110
13 Cfr. ad esempio R. Luraghi, Storia della Guerra Civile Americana, Einaudi, Torino 1966, p. 241, dove si attribuiscono al fucile rigato Springfield mod. 1860 qualità balistiche del tutto esagerate: “micidiale a 600 metri, poteva ancora uccidere a più di un chilometro”.
14 Griffith, Battle Tactics cit., pp. 145-50. Gli studi di Earl J. Hess hanno abbassato la distanza di ingaggio nel corso della guerra civile americana ad una media di 84 metri. Cfr. Hess, The Rifle Musket cit., pp. 107-15. Le ricognizioni sui campi di battaglia di Solferino e San Martino hanno confermato le ridotte distanze di ingaggio, non superiori ai 150 metri. Cfr. il recente M. Borelli, Solferino e San Martino. I residuati raccontano le battaglie, Nordpress edizioni, Chiari 2009.
15 C. Rüstow, Die neueren gezogenen Infanteriegewehre. Ihre wahre Leistunsfähigkeit und die Mittel, dieselbe zu sichern, Verlag Zernin, Darmstat-Leipzig 1862, p. 15. Cäsar Rüstow, autore del libro in questione, era il fratello minore di Friedrich Wilhelm Rüstow, capo di stato maggiore dell’Esercito Meridionale nel 1860 e a sua volta noto scrittore di argomenti storico-militari. Cfr. M. Herwegh, Guillaume Rüstow, un grand soldat, un grand Charactere, Éditions V. Attinger, Paris 1935.
16 Testimonianza di Ferdinando Berninzone citata in La battaglia di Solferino e San Martino vissuta dagli italiani, a cura di C. Cipolla e M. Bertaiola, FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 241-2.
17 Testimonianza di Marchionni Torello citata ivi, p. 372.18 Testimonianza di Emilio Iacòli citata ivi, p. 238.19 Testimonianza di Enrico Crema citata ivi, p. 351.20 Risulta quanto meno sospetta a questo punto la constatazione fatta da un medico francese, tale
dott. Bertherand, che a San Martino molti prigionieri austriaci presentavano sul torace ferite da arma bianca, in particolare di baionetta, Lettere mediche sull’armata d’Italia del dottor Bertherand, a cura di A. Omodei, C.A. Calderini, R. Griffini, in «Annali Universali di Medicina» (Milano), CLXXII, s. IV, vol. XXXVI, aprile-giugno 1860, p. 623.
21 G. Wawro, The Franco-Prussian War. The German Conquest of France in 1870-1871, Cambridge University Press, Cambridge 2003, p. 21.
22 I dati del 1895 indicano che nell’esercito austriaco il 22% delle reclute non era in grado di leggere e scrivere, mentre in Germania tale quota scendeva allo 0,2%. Cfr. G.E. Rothenberg, L’esercito di Francesco Giuseppe, LEG, Gorizia 2004, p. 218.
23 Sulle esercitazioni effettuate in tale periodo cfr. Moltke’s Tactical Problems from 1858 to 1882, a cura di K. von Donat, W.H. Allen & Co., London 1894.
24 Wawro, The Franco-Prussian War cit., p. 43.25 Nonostante la pretesa segretezza, lo Zündnadelgewehr M/41 era già descritto nei manuali del-
l’epoca e il suo utilizzo venne riportato anche in rapporti a stampa ben prima dello scoppio della guerra danese del 1864. Cfr. J. Schmoelzl, Ergänzungs-Waffenlehre oder die Feuerwaffen der Neuzeit, J.G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1851, pp. 24-8. La presenza di queste armi di nuova generazione non sfuggì neanche alle missioni militari statunitensi. Cfr. Military Commission to Europe, Report of Major Alfred Mordecai of the Ordnance Department, George W. Bowman, Washington 1861, pp. 159-60; G.B. McClellan, The Armies of Europe, J.B. Lippincott, Philadelphia 1861, pp. 76-7.
26 Tutti questi concetti furono inseriti nel volume di G. von Kessel, Die Ausbildung des Preussischen Infanterie-bataillons im praktischen Dienst, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1863.
Gli ultimi cento metri 111
27 Cfr. R.M. Citino, The German Way of War. From the Thirty Years’ War to the Third Reich, Univer-sity Press of Kansas, Lawrence 2005, pp. 142-73.
28 La collina di Chlum è alta 290 m e domina di 50 m la piana sulla quale sorge il villaggio di Rosbertiz. Il fianco del rilievo è caratterizzato da un pendio molto dolce e totalmente aperto, ideale per organizzare sulla sua sommità una posizione difensiva, cosa che gli austriaci prima e i prussiani poi fecero.
29 Tale divisione, comandata dal tenente generale Hiller von Gärtringen, era composta dalle seguen-ti unità: 1a Brigata, 1. Garde Regiment, 3. Garde Regiment; 2a Brigata, 2. Garde Regiment, Garde-Füsilier-Regiment, Garde-Jäger-Bataillon, Garde-Husaren-Regiment, 4. Batterie. Cfr. Q. Barry, The Road to Königgrätz. Helmuth von Moltke and the Austro-Prussian War 1866, Helion & Company, Solihull 2009, p. 484.
30 L’IR 52 apparteneva alla Brigata Benedek del III Corpo: Feld-Jäger-Bataillon n. 1, IR 52 Erzherzog Franz Carl, IR 78 Sokcevics. Cfr. Barry, The Road to Königgrätz cit., p. 489. Le perdite del reggimento furono 40 morti e 959 feriti (33,5%). Cfr. Anonimo, Geschichte de k. und k. 52. Linien-Infanterie-Regiments, Erzherzog Franz Carl, Aus der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1871, pp. 595-7.
31 La Brigata Prohaska (III Corpo d’Armata) era composta dai seguenti reparti: Grenz-Inf. Re-giment n. 13, 4° Btg/IR 55 Gondrecourt, 4° Btg./IR 56 Gorizutti, Jäger Bataillon n. 33, Jäger Bataillon n. 34. Cfr. Barry, The Road to Königgrätz cit., p. 489.
32 Groß Generalstab, Der Feldzug von 1866 in Deutschland (d’ora in avanti: Relazione Ufficiale Prussiana 1866), vol. II, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1867, p. 377. Si noti che l’attacco fu sostenuto e respinto praticamente da due sole compagnie, la 1a e la 4a del 2. Garde Regiment. Le perdite complessive dell’unità austriaca furono tutto sommato contenute a soli 248 uomini. Relazione Ufficiale Prussiana 1866, vol. II, Appendice E, p. 3.
33 Nel villaggio erano presenti la 4a e la 9a compagnia del 1° btg e il 2° btg del 1. Garde Regiment; la 9a, 10a, 11a e 12a compagnia del 2. Garde Regiment; la 2a compagnia del 3. Garde Regiment; il 3° btg. del Garde-Füsilier-Regiment. Relazione Ufficiale Prussiana 1866, vol. II, pp. 379-80.
34 Ivi, p. 319.35 Barry, The Road to Königgrätz cit., p. 361.36 La Brigata Jonak (VI Corpo d’Armata) era composta dai seguenti reparti: Feld-Jäger-Bataillon n.
6, IR 20 Prinz von Preussen, IR 60 Wasa. Ivi, p. 490.37 La Brigata Rosenzweig (VI Corpo d’Armata) era composta dai seguenti reparti: Feld-Jäger-
Bataillon n. 17, IR 4 Hoch-und-Deutschmeister, IR 55 Gondrecout. Ibid.38 Le perdite per la Brigata Jonak e Rosenzweig furono rispettivamente di 1.767 (25%) e 1.448
uomini (20,7%). Relazione Ufficiale Prussiana 1866, vol. II, Appendice E, p. 3.39 Tale divisione lamentò alla fine della battaglia la perdita di 38 ufficiali e 1.022 uomini (8,8%).
Ivi, Appendice C, p. 9.40 Ivi, Appendice E, p. 3.41 Anonimo, Für uns gibt es kein Kämpfen mehr, unter den bestehenden Verhältnissen müssen wir es ein
“Schlachten” nennen”. C. Morawetz, Rückblicke auf unsere Taktik auf dem nördlichen Kriegsschau-platze 1866 - nebs einigen Andeutungen zu Änderungen unserer taktischen Grundformen, in «Öster-reichische militärische Zeitschrift» (Vienna), vol. III, 1867, pp. 321-3, nota a fondo pagina.
Giovanni Cerino-Badone112
42 Per una valutazione dell’impatto psicologico delle tattiche prussiane cfr. L. Auspitz, Zur Taktik des Hinterladers, in «Österreichische militärische Zeitschrift» (Vienna), vol. IV, 1867, pp. 191-3.
43 Nonostante l’esaltazione che tale campagna ancora trova nella storiografia militare italiana – in particolare cfr. U. Zaniboni Ferino, Bezzecca 1866. La campagna garibaldina dall’Adda al Garda, Museo trentino del Risorgimento e della lotta per la libertà, Trento 1966 – un’analisi più accurata dei fatti racconta una storia ben diversa. Le truppe austriache del maggior generale Franz Kuhn von Kuhnenfeld, in tutto 17.000 effettivi dispiegati lungo il saliente trentino dallo Stelvio sino alla Valsugana, in un mese permisero a Garibaldi e ai suoi volontari di progredire di appena 20 km dalla linea di confine sino a Bezzecca, limite della sua avanzata verso Trento, pagando a carissimo prezzo ogni scatto in avanti. Il rapporto delle perdite subite ed inflitte fu sempre a vantaggio au-striaco: a Monte Suello, il 3 luglio, le perdite furono di 6:1, a Vezzo il giorno dopo di 4:1. Infine il 21 luglio a Bezzecca avvenne la battaglia di arresto decisiva. Spacciata in seguito come l’unica vittoria campale italiana nella guerra del 1866, il Corpo Volontari subì in realtà un rovescio tattico impressionante al termine del quale i garibaldini lamentarono la perdita di 1.450 uomini (9,6%) contro appena 207 perdite (1,6%) austriache, con una proporzione di 14:1. Non stupisce affatto che dopo una batosta simile, pur rimanendo padrone del campo di battaglia, Garibaldi abbando-nasse ogni progetto di rapida avanzata verso Trento e che fosse ben lieto, il 9 agosto, di firmare il famoso “Obbedisco” che gli imponeva la ritirata dal saliente trentino. Date tali premesse anche la 15a Divisione Medici (9.530 effettivi e 18 pezzi d’artiglieria), inviata in Valsugana per tentare l’occupazione di Trento da est, optò per una avanzata quanto meno prudente, data l’efficienza in combattimento dimostrata sino ad allora dalle forze austriache. A parte alcuni passaggi della Relazione Ufficiale Austriaca la storia operativa della campagna trentina del 1866 rimane sostan-zialmente ancora da scrivere. Cfr. Relazione Ufficiale Austriaca 1866, vol. V, pp. 1-71.
44 Cfr. W.W. Greener, Modern Breech-loaders. Sporting and Military, Cassel, Petter, and Galpin, London 1871, pp. 181-4. L’arma era oggetto di costanti attenzioni in Germania: H. Meineke, Das Chassepot-Gewehr der französischen Infanterie, Eduard Zernin, Darmstadt-Leipzig 1867. Il re di Prussia Guglielmo I era molto sensibile riguardo alle prestazioni dell’arma della fanteria francese, rinforzando il suo pessimismo circa la capacità della sua fanteria di battere il nemico sul campo di battaglia. Uno degli osservatori prussiani in Francia, il maggiore Alfred von Waldersee, fu pregato da Moltke in persona di limitare gli elogi nei confronti dello Chassepot in quanto “il re reagisce male a tali rapporti”. Wawro, The Franco-Prussian War cit., p. 56.
45 Cfr. Effet des projectiles Chassepot, in «Revue Militaire Suisse» (Losanna), XII, 1867, pp. 520-1.
46 Cfr. W. Witte, Die gezogenen Feldgeschütze C/61, C/64 und C/64/67, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1867.
47 Sulla tattica delle artiglierie prussiane nel 1870 cfr. E. Schmedes, Die Taktik der Preussen beim Ausbruche des Feldzuges 1870 und ihre Änderung im Laufe desselben, in «Österreichische militäri-sche Zeitschrift» (Vienna), vol. IV, 1871, pp. 4-11, 19-21. Si veda inoltre: E. Hoffbauer, The Ger-man Artillery in the Battles near Metz, Henry S. King & Co., London 1874; B. Strange, Artillery Retrospect of the last Great War, 1870, Middleton & Dawson, Quebec 1874; G. Rouquerol, L’Ar-tillerie dans la Bataille du 18 Aout, Berger-Levrault et C.ie, Paris-Nancy 1906. Per la controparte francese cfr. G. Erb, L’Artillerie dans les Batailles de Metz 14-16-18 août 1870, Librairie Militaire R. Chapelot et C.ie, Paris 1906.
Gli ultimi cento metri 113
48 Vennero stampati e distribuiti anche degli studi di fortificazione campale destinati agli ufficiali di compagnia: C. Roguet, L’officier d’Infanterie en Campagne. Fortification, petite guerre, Libraire Militaire de J. Dumaine, Paris 1869. Scritto originariamente nel 1846 e chiaramente destinato alle truppe operanti in Algeria, il libro di Roguet nel 1869 divenne di estrema attualità anche per forze metropolitane, dati i cambiamenti tattici in corso. Roguet era uno degli aiutanti di campo di Napoleone III.
49 Wawro, The Franco-Prussian War cit., p. 56.50 Ivi, p. 55. Il regolamento tattico francese era quello adottato il 16 marzo 1869, in sostituzione
di quello del 17 aprile 1862, decisamente più aggressivo. Ministere de la Guerre, Règlement du 16 Mars 1869 sur le Manœuvres de l’Infanterie, Librairie Militaire de J. Dumaine, Paris 1870. Sulla percezione che gli avversari prussiani avevano dei francesi cfr. F.K.N. von Preußen, L’art de combattre l’armée française, E. Dentu – J. Dumaine, Paris (s.d. ma 1870).
51 Schmedes, Die Taktik der Preussen cit., pp. 194-6.52 Il regolamento prussiano del 1863 fu leggermente modificato nel 1868: Colonel van Kessel [J.
Campe van Kessel], Manœuvres et Tactique de l’Infanterie Prussienne, A Mertend et Fils, Bruxelles 1868; A. von Witzleben, Heerwesen und Infanteriedienst der Königlich Preussischen Armee, Verlag von A. Bath, Berlin 1868, pp. 79-203.
53 Wawro, The Franco-Prussian War cit., p. 56.54 La battaglia di Gravelotte è stata la battaglia decisiva della guerra del 1870-71, oscurata tuttavia
da quella di Sedan nell’immaginario popolare e storiografico in quanto in questo scontro fu catturato lo stesso Napoleone III. Non a caso nel 1914 lo stato maggiore statunitense decise di curare una monografia a cura di Harry Bell sui rapporti, le memorie e le impressioni dal cam-po dei soldati prussiani che combatterono a Gravelotte. Le monografie ad essa dedicate sono comunque poche e datate. Per il seguente articolo, a parte il solito Wawro (The Franco-Prussian War cit., pp. 169-85) sono stati utilizzati i seguenti testi: H. Bell, St. Privat. German Sources, Staff College Press, Fort Leavenworth 1914; H. Bonnal, La Manœuvre de Saint-Privat, 18 juillet – 18 août 1870, 2 voll., Librairie Militaire R. Chapelot et C.ie, Paris 1904; Section historique de l’État Major de l’Armée, La Guerre de 1870-71 (d’ora in avanti: Relazione Ufficiale Francese 1870), vol. III, Librairie Militaire R. Chapelot et C.ie, Paris 1905; Groß Generalstab, La Guerre Fran-co-allemande de 1870-71 (d’ora in avanti: Relazione Ufficiale Prussiana 1870, qui nell’edizione in francese), parte I, vol. II, Ernst Siegfried Mittler und Sohn – J. Dumaine Librairie Militaire, Berlin-Paris, 1875, pp. 641-865;
55 Lo Chassepot è pur sempre un fucile che impiega munizioni a polvere nera. Affermare che in combattimento fosse efficace a circa un chilometro di distanza equivale ad equipararlo in termini di prestazioni balistiche ad un contemporaneo fucile di precisione quale l’M40, il che è a tutti gli effetti una grossa sciocchezza. In questo errore cade pressoché l’intera storiografia della guerra franco-prussiana. Si veda ad esempio Wawro, The Franco-Prussian War cit., p. 52. L’equivoco di fondo è sempre il solito, ossia considerare le capacità teoriche di un’arma direttamente applicabili al campo di battaglia, senza verificare le dottrine di impiego e l’addestramento dei soldati. I rego-lamenti francesi del periodo prevedevano l’apertura del fuoco di plotone tra i 200 e i 400 metri dal bersaglio, tra i 200 e i 500 metri per la fanteria leggera. Règlement du 16 mars 1869 cit., pp. 239-41.
Giovanni Cerino-Badone114
56 Il passo è da intendere come Fuß, di più difficile definizione. Tra il 1755 ed il 1815 era impiegato l’Alte Maße und Gewichte il cui Fuß era di 31,38 cm. Dopo il 1816 il Fuß fu ricalcolato in 37,66 cm. Cfr. C. Noback – F. Noback, Vollständiges Tasehenbuch der Münz- Maass- und Gewichts- Verhältnisse, der Staatspapiere, des Wechsel- und Bankwesens und der Usanzen aller Länder und Handelsplätze, vol. I, F.A. Brockhaus, Leipzig 1851, pp. 113-4.
57 A. Boguslawski (von), Tactical Deductions from the War of 1870-71, George A. Spooner, Lea-venworth 1891, p. 198.
58 Cfr. Relazione Ufficiale Francese 1870, vol. III, pp. 421-3.59 Cfr. Bell, St. Privat cit., p. 16.60 Cfr. Relazione Ufficiale Prussiana 1870, parte I, vol. II, Appendice XXIV, pp. 188-90.61 Nel 1884 il chimico francese Paul Marie Eugène Vieille, attraverso la gelatinizzazione della nitro-
cellulosa con una miscela di etere ed alcool, ottenne un nuovo tipo di polvere da sparo, completa-mente differente dalla polvere nera, chiamata polvere B (in francese Poudre B). Il nuovo composto era un esplosivo di tipo propellente che sviluppava una energia tre volte superiore alla precedente, producendo nel contempo fumi di combustione molto ridotti (da cui l’appellativo di infume).
62 Le dinamiche di assimilazione di un ciclo intenso di addestramento e il suo effetto sui soldati sono descritti in D. Grossman, On Combat. Psicologia e fisiologia del combattimento in guerra e in pace, Edizioni Libreria Militare, Milano 2009, pp. 93-9; Id., On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Back Bay Books, New York 1996, pp. 18-22.
63 Per una storia complessiva del conflitto sudafricano rimane sempre valido il classico testo di T. Pakenham, La Guerra Anglo-Boera. L’ultima grande avventura dell’Impero Britannico: la conquista dell’Africa australe, Rizzoli, Milano 1982. Per gli aspetti operativi della guerra e la realtà dei combat-timenti cfr. B. Nasson, The South African War 1899-1902, Arnold, London 1999; M.A. Ramsay, Command and Cohesion. The Citizen Soldier and Minor Tactics in the British Army 1870-1918, Prae-ger, Westport 2002. Il conflitto africano causò notevole interesse, in quanto era il primo che vedeva contrapposte tra loro truppe ‘bianche’ che operavano secondo schemi europei. Il Kriegsgeschichtli-che Abteilung [Ufficio Storico Militare] tedesco produsse una propria relazione successivamente tra-dotta in inglese: Groß Generalstab, The War in South Africa, 2 voll., John Murray, London 1904.
64 Sul dibattito scaturito dall’esperienza della guerra russo-giapponese cfr. B.I. Gudmundsson, Sturmtruppen. Origini e Tattiche, LEG, Gorizia 2005, pp. 103-4; F. Beretta, L’Esperienza inutile. I conflitti anglo-boero e russo-giapponese e l’impreparazione italiana alla guerra di trincea, Prospettiva Editrice, Roma 2008.
65 Le ragioni storiche che portarono al Regolamento del 1906 sono descritte in Freytag-Loringho-ven, Das Exerzier-Reglement für die Infanterie vom 29. Mai 1906 Kriegsgeschichtlich erläutert, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Berlin 1907. Una discussione di natura tecnico-tattica si ritro-va in M.F. De Pardieu – M.C. Fletcher, A Critical Study of German Tactics and of the new German Regulations, United States Cavalry Association, Fort Leavenworth 1912.
66 Due studi interessanti che propongono questa prospettiva sono: J. Keegan, La Prima Guer-ra Mondiale. Una storia politico-militare, Carocci, Roma 2001, pp. 188-90; D.E. Showalter, Tannenberg. Clash of Empires, 1914, Potomac Books, Dulles 2004.
67 Keegan, La Prima Guerra Mondiale cit., p. 118.68 Le citazioni sono tratte da ivi, p. 119.