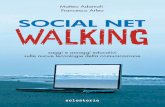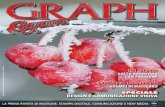Fenomeni di modulazione nelle sequenze complimento-risposta, 2008, in La comunicazione parlata, a...
Transcript of Fenomeni di modulazione nelle sequenze complimento-risposta, 2008, in La comunicazione parlata, a...
Società di Linguistica Italiana Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata
La comunicazione parlata
Atti del congresso internazionale Napoli, 23-25 febbraio 2006
Tomo II
a cura di M. Pettorino, A. Giannini, M. Vallone, R. Savy
Liguori Editore
Questa opera è protetta dalla Legge sul diritto d�autore (Legge n. 633/1941: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l633_41.html). Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla citazione, alla riproduzione in qualsiasi forma, all�uso delle illustrazioni, delle tabelle e del materiale software a corredo, alla trasmissione radiofonica o televisiva, alla registrazione analogica o digitale, alla pubblicazione e diffusione attraverso la rete Internet sono riservati, anche nel caso di utilizzo parziale. La riproduzione di questa opera, anche se parziale o in copia digitale, è ammessa solo ed esclusivamente nei limiti stabiliti dalla Legge ed è soggetta all�autorizzazione scritta dell�Editore. La violazione delle norme comporta le sanzioni previste dalla legge. Il regolamento per l�uso dei contenuti e dei servizi presenti sul sito della Casa Editrice Liguori è disponibile al seguente indirizzo: http://www.liguori.it/politiche_contatti/default.asp?c=legal L�utilizzo in questa pubblicazione di denominazioni generiche, nomi commerciali e marchi registrati, anche se non specificamente identificati, non implica che tali denominazioni o marchi non siano protetti dalle relative leggi o regolamenti. Liguori Editore - I 80123 Napoli http://www.liguori.it/ © 2008 by Liguori Editore, S.r.l. Tutti i diritti sono riservati Prima edizione italiana Febbraio 2008 Pettorino, Massimo (a cura di): La comunicazione parlata. Atti del congresso internazionale. Napoli, 23-25 febbraio 2006 - Tomo II/ Massimo Pettorino, Antonella Giannini, Marianna Vallone, Renata Savy (a cura di) Napoli : Liguori, 2008 ISBN-13 978 - 88 - 207 - 4022 - 1 1.Comunicazione parlata 2. Linguistica I. Titolo . Aggiornamenti: 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
FENOMENI DI MODULAZIONE NELLE SEQUENZE COMPLIMENTO-RISPOSTA
Giovanna Alfonzetti
1. Introduzione
I complimenti, poco studiati in italiano, sono atti la cui forza illocutoria presenta una miscela di ingredienti in base alla quale possono essere assegnati sia alla classe degli espressivi-comportativi che a quella dei verdettivi. Nel complimento, infatti, il parlante esprime ammirazione nei confronti del desti-natario, che viene dunque valutato positivamente per mezzo di termini espri-menti valori (cfr. Alfonzetti in stampa a).
Nei complimenti, inoltre, si verifica sistematicamente la sovrapposizione tra indicatori illocutori e indicatori di specificazione affettiva (Sbisà 1992, 371): le espressioni di carattere valutativo, oltre ad indicare che si sta com-piendo l�atto di complimentarsi, indicano anche l�affetto positivo qual è ri-chiesto dalle condizioni di sincerità, che nel caso dei complimenti specificano ammirazione e approvazione come emozioni esperite dal parlante (Norrick 1980, 296).
Ciò suggerisce una prospettiva sinora poco seguita nello studio dei com-plimenti: analizzarli cioè nell�ambito della comunicazione emotiva e, in parti-colare, in relazione ai fenomeni di modulazione dell�intensità affettiva e alle connessioni tra questi e la forza illocutoria (Sbisà 2001).
Per comunicazione emotiva si intende la segnalazione strategica e inten-zionale di informazioni affettive attraverso l�uso appreso culturalmente e me-diato cognitivamente di segnali verbali e non verbali. Essa presuppone una capacità emotiva grazie alla quale i parlanti sono in grado di produrre e inter-pretare le espressioni di affetto e anche di modulare intenzionalmente e in modi molto sottili l�intensità delle loro enunciazioni, in direzione sia del raf-forzamento che dell�attenuazione (cfr. Arndt e Janney 1991; Caffi e Janney 1994). Naturalmente il grado di intensità con cui si decide di produrre un atto linguistico dipende da molteplici fattori. E tuttavia, su un piano più generale, si pone una questione interessante che chiama in causa anche la relazione tra strategie di modulazione e principi di cortesia e cioè: è possibile individuare atti linguistici che vengano tipicamente sentiti come portatori di effetti da mi-tigare o viceversa da rafforzare?
Qui si cercherà di stabilire in particolare, sulla base di un corpus di par-lato spontaneo, se la tendenza prevalente nei complimenti in italiano sia verso l�attenuazione o il rafforzamento.
922 GIOVANNA ALFONZETTI
Prima di esporre i risultati dell�analisi, si discuteranno brevemente le principali posizioni sulla questione appena posta.
Per chi come Fraser (1980) concepisce la mitigazione come strategia an-ticipatrice mirante a ridurre i soli effetti sgradevoli che l�atto linguistico ha sul destinatario, si può mitigare una critica, una richiesta o una cattiva notizia ma non le congratulazioni o i complimenti, perché questi atti non comportano ef-fetti negativi.
Altri studiosi, invece, ritengono che sia possibile e spesso doveroso in-debolire anche atti i cui effetti siano positivi per l�interlocutore: secondo Caffi (1990, 184), ad esempio, �anche un semplice complimento può risultare ag-gressivo per l�interlocutore, invasivo del suo �territorio��1.
Pure secondo Holmes (1984) è possibile indebolire o rafforzare qualsiasi atto linguistico, ma il significato affettivo delle due strategie di modulazione sarà diverso a seconda del tipo di atto cui si applica: l�attenuazione di atti che comportano effetti indesiderati e il rafforzamento di atti positivi aumentereb-bero la solidarietà con il destinatario; di contro, indebolire atti positivi, come ad es. i complimenti, aumenterebbe la distanza interpersonale tanto quanto rafforzare atti negativi, quali critiche o richieste.
Analoga opinione sostengono Janney e Arndt (1992, 35-37), che hanno il merito di sottolineare l�importanza del contesto culturale: nelle culture che in-coraggiano la manifestazione di emotive displays, come ad esempio quella americana o italiana, la regola generale prevede che i messaggi negativi (atti di disaccordo, critiche, rifiuti, etc.) debbano essere sufficientemente indeboli-ti, per non essere interpretati come aggressivi o ostili, mentre i messaggi posi-tivi (atti di accordo, congratulazioni, complimenti, etc.) � debbano invece es-sere sufficientemente intensificati, per non essere interpretati come insinceri o ironici. Nel produrli i parlanti tenderanno dunque ad amplificarne l�effetto po-sitivo, mostrando maggiore assertività e coinvolgimento del normale sia al li-vello linguistico che paralinguistico e cinesico2.
1 Parole in cui affiora la visione dei complimenti come atti che minacciano la faccia ne-
gativa del destinatario, riconducibile principalmente a Brown e Levinson (1987) (cfr. Alfonzet-ti in stampa b). Forse è il caso di ricordare che la loro ben nota teoria della cortesia verbale � con l�estrema importanza assegnata ai concetti di Face Threatening Act e di faccia e cortesia negative � spiega la attenzione quasi esclusiva che gli studiosi hanno rivolto alle strategie di mitigazione piuttosto che a quelle di rafforzamento (cfr. Holmes, 1984 e Held, 1989).
2 Anche secondo Held (1989, 173) le strategie di �maximization� svolgono un ruolo im-portante nella cortesia positiva e di conseguenza �all those speech acts which serve to recognize and support alter [...] should be regularly strengthened�.
FENOMENI DI MODULAZIONE NELLE SEQUENZE COMPLIMENTO-RISPOSTA 923
2. Risultati dell�analisi
L�analisi qui condotta conferma decisamente la posizione di Janney e Arndt (1992): i complimenti nel nostro corpus si presentano per lo più come atti modulati e la tendenza nettamente prevalente è verso la intensificazione a vari livelli. Qui si esporranno le modalità che ricorrono con maggiore fre-quenza nel corpus.
I complimenti tendono ad essere pronunciati con qualità della voce ed espressioni del volto amichevoli o affettuose e sono spesso accompagnati da sorrisi aperti e sguardi diretti e prolungati3, tutti indici di maggiore assertività e coinvolgimento e di affetto positivo, che enfatizzano la valutazione espressa a livello linguistico nel complimento (Arndt e Janney, 1985).
Anche un�espressione del volto come quella di D., che nel turno 10 di (1) spalanca la bocca e gli occhi in segno di stupita ammirazione, concorre in-dubbiamente a intensificare la forza del complimento, insieme ad altri mezzi che ricorrono nella sequenza � quali ripetizioni, superlativi, l�avverbio vera-mente etc. � che verranno menzionati più avanti4: (1) Pranzo da una cugina (256)
((un nipote del marito di B, la ringrazia per il biglietto di auguri natalizi che B e il marito gli avevano inviato qualche giorno prima))
1 Bf come va? eh? 2 Dm io bene 3 Bf mm? 4 Dm ah comunque io/per il biglietto d�auguri è il più bello che ho mai visto 5 Bf ma va! [l�hai visto? 6 Dm [no anzi ora devo chiamare a papà perché vi vuole ringraziare [è veramente bellissimo 7 Bf [carino ((sorride)) D. l�ha ideato 8 Dm bellissimo 9 Bf ah? vero? 10 Dm bellissimo! ero così ero ((apre la bocca e spalanca gli occhi)) bellissimo!
divertente! ((pausa)) 11 Am grazie veramente
3 Espressioni del volto e qualità della voce fanno parte degli evaluation devices proposti
da Caffi e Janney (1994) per l�analisi della comunicazione emotiva. Questa categoria include tutti i tipi di scelte verbali e non verbali che consentono di inferire l�atteggiamento valutativo positivo o negativo del parlante nei confronti dell�argomento o dell�interlocutore.
4 Negli esempi riportati, A indica sempre il parlante che fa il complimento, B il destinata-rio. Il sesso dei parlanti viene notato dalla lettera f (femminile) o m (maschile) seguente.
924 GIOVANNA ALFONZETTI
Questa sequenza complessa esemplifica un modello ricorrente nel cor-pus: la tendenza del parlante a rafforzare con vari mezzi il complimento e quella contraria ad attenuarlo da parte di chi lo riceve. Si assiste pertanto a una sorta di negoziazione dell�ammontare della lode, regolata dal Principio della Cortesia di Leech (1983): la Massima dell�Approvazione induce infatti a massimizzare la lode dell�altro, mentre la Massima della Modestia a minimiz-zare la lode di se stessi. Al complimento di A nel turno 4 (1) � intensificato dal superlativo relativo (è il più bello che ho mai visto) � B reagisce con un disaccordo parziale. Si ha quindi nella seconda parte del turno 6 (1) una replica del complimento, anch�essa rafforzata dal superlativo assoluto e dall�avverbio veramente. Nel turno 7 (1) B risponde con un accordo attenuato dall�uso di un termine valutativo più debole (carino) di quello usato da A (bellissimo), accompagnato da un sorriso e seguito nello stesso turno dal tra-sferimento sul marito del merito di aver ideato il biglietto di auguri. A replica nuovamente il complimento nel turno 8 (1), ripetendo l�aggettivo usato prece-dentemente (bellissimo) e suscitando come reazione una richiesta di conferma nel turno 9 (1). Segue nel turno 10 (1) ovviamente un�ulteriore replica del complimento, che viene ripetuto per ben 3 volte: le prime due con lo stesso aggettivo (bellissimo) e la terza con l�aggettivo divertente, ripetizioni che vengono a loro volta rafforzate, come si è detto, dall�espressione del volto. Segue il silenzio di B � quasi una tacita accettazione del complimento dopo tale insistenza da parte di A � e quindi il ringraziamento di questi per il bi-glietto ricevuto, che pone fine alla sequenza.
Al livello prosodico, il complimento può essere intensificato sia aumen-tando il volume della voce sia invece abbassandolo, specie se ciò è concomi-tante al gesto di avvicinarsi, sorridere e parlare sottovoce all�orecchio del de-stinatario, indici che nella dimensione del coinvolgimento servono a segnalare maggiore intimità, come si può osservare in (2):
(2) A una riunione di lavoro (154)
((tutti sono seduti attorno al tavolo. T entra e va a sedersi accanto a G))
1 Gf io ero venuta alle nove meno cinque non c�era nessuno e sono andata nella
stanza a fare alcune cose e poi ho fatto tardi 2 Tm ((non risponde)) ((pausa)) 3 Tm ((sottovoce mentre si china verso G sorridendole)) sei molto elegante oggi 4 Gf sì::? grazie! ((sorride)) 5 Tf ((sorride))
FENOMENI DI MODULAZIONE NELLE SEQUENZE COMPLIMENTO-RISPOSTA 925
Frequente è l�intonazione enfatica sui termini che esprimono valori se-mantici positivi e, ancora più frequente, l�allungamento fonologico5, come in (3). Si tratta di un altro esempio da cui emerge la tendenza del parlante a raf-forzare il complimento � e non solo al livello prosodico: si noti la costruzione sintattica marcata, l�avverbio veramente e, nella seconda parte del turno, una affermazione la cui implicatura avvalora il complimento, anzi può considerar-si essa stessa un complimento implicito (sei tanto cresciuto che non ti avevo nemmeno riconosciuto) � e quella invece del destinatario a mitigarlo, reagen-do con un accordo attenuato dall�uso dell�avverbio abbastanza6:
(3) Tra docente e alunno (34)
((A incontra per strada un suo ex-alunno)) 1 Af cia::o! [come stai? ((lo bacia)) 2 Bm [buongiorno professoressa 3 Af come ti sei fatto gra::nde! verame::nte non ti avevo riconosciuto da lonta-
no vedevo qualcuno che mi sorrideva 4 Bm ((sorridendo compiaciuto e imbarazzato)) abbastanza grande 5 Af come va? la scuola? [...]
A livello sintattico, mezzi frequenti di intensificazione del complimento
sono le costruzioni marcate (es. (4)) e la domanda retorica (es. (5)), che senza dubbio amplifica la forza dell�affermazione trasmessa (cfr. Caffi, 1990 e Holmes, 1984):
(4) Dall�estetista (233)
((A sta facendo un massaggio a B))
1 Cf che carino questo cosino che hai in testa 2 Gf ti piace? questo me l�ha regalato M. 3 Cf è troppo bellino! [...]
(5) Al master (185)
((durante una pausa, B è in piedi davanti alla collega, A, che è invece seduta))
1 Af lo sai che hai un bel posteriore? 2 Bf sì lo so me lo dicono tutti è il mio punto forte
5 Caffi e Janney (1994) lo includono tra i quantity devices della comunicazione emotiva,
che comprendono tutte le scelte di intensificazione e attenuazione di quantità, misura, grado, durata, etc. di un dato fenomeno linguistico.
6 Si tratta di un elemento attenuativo appartenente alla categoria etichettata come hedges da Fraser (1980) e Holmes (1984) e come bushes (cioè propositional hedges) da Caffi (1999).
926 GIOVANNA ALFONZETTI
Va inoltre ricordato l�uso di interiezioni (es. (6)) (cfr. Holmes, 1984) e soprattutto del nome proprio del destinatario in funzione allocutiva, che può precedere (es. (7)) o seguire il complimento (es. (8)). Si tratta, com�è noto, di un mezzo codificato dalla retorica per creare coinvolgimento (Caffi, 1992), specie se come spesso succede nel corpus si accompagna ad altri segni di af-fetto positivo, quali intonazione enfatica, voce amichevole, sorrisi, sguardi di-retti, etc.:
(6) Pranzo tra parenti (235)
1 Bf ah! carini questi orecchini sono 2 Gf questo mi piace di più 3 Sf questi me li sono regalati io due anni fa 4 Bf ah:::! sono un amore
(7) Compleanno di un�amica (70)
((A entra in cucina dove si trova S, la padrona di casa))
1 Af S. sei stata superba! hai superato ogni limite 2 Sf va be::ne! grazie! ((tono condiscendente)) 3 Af mi hai fatto emoziona/sei commovente come dice mia figlia ((ride)) 4 Sf ((sorride))
(8) Cena tra amici (66)
1 Rf che bellino quel lume M.! 2 Mf quello l�ho preso a Como 3 Rf che belli::no!
Il rafforzamento si manifesta inoltre in scelte lessicali che consentono
di inferire un atteggiamento valutativo fortemente positivo nei confronti dell�oggetto del complimento7 e quindi soprattutto nell�uso di aggettivi valutativi iperbolici � quali ad es. superba (es. (7)) splendidi e favoloso (es. (9)), stupendo, geniale, delizioso, meraviglioso, squisito etc. � di superla-tivi (es. (9)), ma anche di diminutivi (es. (8)) o di altri termini affettivamente connotati:
(9) Al Master (188)
((in attesa che inizi la lezione due corsiste parlano del più e del meno)) 1 Rf hai dei capelli splendidi! hanno un colore non bello ma favoloso 2 Mf ((sorride)) finché durano! perché quelli bianchi stanno spuntando
7 Cfr. la classe degli evaluation devices di Caffi e Janney (1994).
FENOMENI DI MODULAZIONE NELLE SEQUENZE COMPLIMENTO-RISPOSTA 927
3 Rf ma che dici?! sono bellissimi 4 Mf grazie ((sorridendo))
Molto frequente è inoltre l�uso di avverbi di quantità (es. (10)) o di gra-
do8 (es. (11)) che intensificano aggettivi, verbi o altri avverbi9:
(10) In un negozio di abbigliamento (24) ((una cliente si sta guardando allo specchio mentre prova un tailleur; un�altra cliente la osserva e quindi le rivolge la parola))
1 Af questo tailleur è molto bello! le sta molto bene 2 Bf grazie! (11) Seduta di laurea (110)
((la candidata è spagnola, A è la correlatrice))
1 Af intanto mi compiaccio del suo italiano [che è estremamente fluente
2 Bf [grazie e l�uso di avverbi modali che hanno a che fare con il contenuto di verità di quanto viene affermato10 � quali davvero, veramente, etc. � e che occorrono o nello stesso turno del complimento, come ad es. in (12): (12) Visita a una amica (287)
1 Bf se si può comprare perché ora pare che sia in vendita ... [allora la cucina si deve rifare tutta 2 Mf [sì ce lo diceva ieri sera D certo poi ve la fate:: 3 Bf questa era tal quale 4 Mf sì 5 Bf però sapendo questa vicenda [(...........) 6 Mf [eh certo ... sì ... carina molto carina ... ve-
ramente
8 Per la distinzione tra avverbi di quantità e di grado cfr. Lonzi, 1991. 9 Holmes (1984) li include nella categoria dei content-oriented boosters e Caffi e Janney
(1994) in quella dei quantity devices. 10 Holmes (1984) li include negli speaker-oriented boosters. Held (1989, 200) usa la ca-
tegoria di affirmative modal particles.
928 GIOVANNA ALFONZETTI
oppure in un turno successivo, soprattutto dopo reazioni in cui il destinatario contesta la sincerità/verità del complimento o ne chiede conferma. Così come accade nei casi di rafforzamento dello speaker�s commitment descritti da Sbi-sà (2001, 1805), anche qui per fugare i dubbi manifestati dal destinatario, il parlante cerca di aumentare la credibilità e la pretesa di validità della propria enunciazione11, rafforzando il suo impegno verso quanto asserito nel compli-mento, come si può chiaramente osservare in (13):
(13) Cena tra amici (252)
((dopo cena i padroni di casa mostrano l�album con le fotografie del loro matri-monio, avvenuto molti anni prima))
1 Gf ((guardando le fotografie)) M. ma tu non sei cambiata tanto! 2 Sf no M. no 3 Mf sì non sono cambiata! ((sorridendo con amarezza)) 4 Gf no te lo giu::ro! verame::nte!
La modulazione rafforzativa nei complimenti non è dunque necessaria-
mente co-estensiva di un unico turno, ma al contrario spesso si attua su più turni della sequenza. Questo lo dimostra ancor più chiaramente la modalità di rafforzamento più frequente nei complimenti e cioè la ripetizione (cfr. Holmes, 1984 e Caffi, 1990). Insistere, ripetendo o riformulando uno stesso atto linguistico, viene visto da Sbisà (2001, 1808) come un modo per intensificare il desiderio del parlante di raggiungere un certo scopo, di elicita-re cioè una certa reazione da parte del destinatario. E in effetti nel corpus sono molti i casi in cui questi accetta il complimento, ringraziando, sorridendo o manifestando il suo accordo, solo dopo l�insistenza del parlante nel ripeterlo una o più volte: (cfr. gli ess. (1) e (9) riportati sopra).
Il complimento viene spesso replicato o in uno stesso turno, come in (14), dove troviamo ben tre ripetizioni disposte in ordine di intensità crescen-te:
(14) A casa di un�amica (279)
((B fa visitare a M la sua casa))
1 Bf ((escono)) il terrazzo 2 Mf che be:::llo! ma è troppo carino! .... belli::ssimo!
11 Cfr. gli evidentiality devices di Caffi e Janney (1994).
FENOMENI DI MODULAZIONE NELLE SEQUENZE COMPLIMENTO-RISPOSTA 929
oppure, altrettanto spesso, viene ripetuto in uno o più turni successivi, dopo la reazione del destinatario, soprattutto dopo una richiesta di conferma (es. (15)) ma anche dopo un ringraziamento (es. (16)), un accordo attenuato (es. (17)) o un disaccordo (es. (18))12:
(15) A cena tra amici (306)
((prima di prendere posto a tavola, U guarda le foto appese alle pareti))
1 Cf queste sono tutte le foto che loro mandano come:: auguri del nuovo anno ((pausa mentre U continua a guardare le foto)) 2 Cf tutte queste foto che vedi qua 3 Um son bellissime! 4 Bf vero? ... eh? 5 Um accidenti! ma sono di una bellezza proprio
(16) A cena tra amici (22)
((prima della cena, dopo i saluti, A si rivolge alla figlia dei padroni di casa))
1 Af sono molto carini questi capelli [ti stanno bene 2 Bf [grazie! 3 Af molto carini!
(17) Colleghi al ristorante (115)
1 Am Ti trovo benissimo, G. 2 Bf Sì, in effetti sto bene 3 Am Sei bellissima [cerca di conservarlo questo 4 Bf [grazie ((sorridendo))
(18) Tra fidanzati (180)
1 Am ma sei bellissima amore! 2 Bf ma mi hai guardato bene? ormai! 3 Am no sei bellissima!
Va inoltre notato che non di rado a rafforzare il complimento ripetendolo
è un terzo co-partecipante (es. (19)); poiché in questi casi il complimento ripetuto funziona anche come atto di accordo nei confronti del complimento del primo parlante, esso si presenta a sua volta intensificato rispetto a
12 Sulla analisi delle risposte ai complimenti, cfr. Alfonzetti (2005).
930 GIOVANNA ALFONZETTI
quest�ultimo, cioè come optimal agreement, così come prevede l�organizza-zione delle preferenze (cfr. Pomerantz, 1984):
(19) A cena tra amici (272)
1 Af buona! 2 Cf questa torta è buonissima 3 Af buonissima! ((pausa)) 4 Af c�è marmellata 5 Cf e mandorle ((pausa)) 6 Cf ma lei:: lei l�ha fatta! [che mi chiedi a me? 7 Af [buonissima!
Ciò avvalora una interpretazione non solo sequenziale ma anche riformu-
lativa della modulazione: in tutti questi casi viene infatti rafforzato un com-plimento che ha già avuto luogo, sia da parte dello stesso parlante sia da parte di un altro co-partecipante. La modulazione insomma si avvicina molto ai meccanismi di repair, presentandosi come autoriformulazione o, talvolta, co-me eteroriformulazione (Caffi, 1990, 172), di cui un chiaro esempio è quello riportato in (20):
(20) Tra amici
((A ha al collo una collana che le è stata regalata da un gruppo di amici, inclusi A e C))
1 Am guardate com�è bella stasera B 2 Cf ma B è sempre bella! 3 Bf sono bella grazie al vostro contributo
Il carattere sequenziale e riformulativo della modulazione si evince an-
che da un�altra modalità di intensificazione dei complimenti: l�uso di verbi o formule performative che indicano esplicitamente la forza illocutoria (cfr. Caffi, 1990 e Holmes, 1984). I casi più interessanti sono quelli in cui il par-lante ricorre a tale mezzo dopo che un primo complimento, di solito implicito, non viene recepito o è deliberatamente ignorato, tanto da rendere necessario ribadire senza possibilità di equivoci il tipo di atto compiuto, come succede nell�esempio (21): (21) Colleghi al ristorante (116)
FENOMENI DI MODULAZIONE NELLE SEQUENZE COMPLIMENTO-RISPOSTA 931
1 Am comunque tu saresti dovuta essere associata già da qualche anno 2 Bf ma io non mi sono mai lamentata di essere ricercatrice 3 Am ma io volevo farti un complimento 4 Bf ((sorride))
3. Conclusioni
L�analisi qui condotta mostra che in italiano prevale decisamente la ten-denza a intensificare i complimenti, che possono pertanto considerarsi suppor-tive positive messages, caratterizzati in molti casi da cue redundancy (Arndt e Janney, 1985): nella maggior parte dei complimenti sono presenti segnali e-motivi ai diversi livelli � prosodico, cinesico e linguistico � che si confermano a vicenda. I complimenti, infatti, come si è visto, vengono spesso accompa-gnati da sorrisi aperti e sguardi intensi e diretti, vengono pronunciati con tona-lità della voce amichevoli e affettuose e contengono espressioni valutative di segno fortemente positivo, etc. Tale ridondanza è di per sé un ulteriore indice di intensificazione. Come infatti osservano Wiener e Mehrabian (1968, 79), �in the case of redundancy among channels [...] the individual message in each channel is augmented: that is, a dimension of intensity of experience is also communicated�.
Lavorando con dati di parlato spontaneo, diventa evidente la necessità di adottare una concezione sequenziale e riformulativa della modulazione (cfr. Caffi, 1990), cioè di estendere l�unità interessata dai fenomeni di modulazione al di là del singolo atto del parlante, sino a comprendere la risposta del desti-natario, le repliche del complimento, le reazioni successive ed eventuali inter-venti di altri co-partecipanti, che possono essi stessi contribuire a modificare l�intensità dell�enunciazione.
La modulazione si dispiega infatti sulla intera sequenza complimento-risposta agendo in due direzioni opposte ma complementari dal punto di vista del principio della cortesia e delle sue massime (Leech, 1983): in direzione generalmente rafforzativa nei complimenti, in conformità alla sotto-massima che prevede di massimizzare la lode dell�altro; in direzione attenuativa invece nelle risposte del destinatario. Posto di fronte al conflitto tra massima della modestia (che prevede di minimizzare la lode di sé e quindi dissentire dal complimento) e massima dell�accordo (che prevede invece di massimizzare l�accordo con l�autore del complimento), il destinatario si orienta verso rispo-ste intermedie tra disaccordo radicale e accordo pieno (cfr. Alfonzetti 2005), cercando di ridurre in vari modi sia linguistici che non linguistici (litoti, hedges, smorfie di dubbio e diniego, etc.) l�ammontare della lode a lui rivolta, e mostrando quindi di nutrire riserve sulla realtà o validità di quanto asserito dal parlante nel complimento.
932 GIOVANNA ALFONZETTI
Ne risultano sequenze lunghe, complesse e articolate, co-costruite da più partecipanti, da cui emerge la natura intrinsecamente scenografica e contrat-tuale dell�interazione (Caffi, 1990) e la stretta interdipendenza tra strategie di mitigazione e rafforzamento. Come infatti osserva Held (1989), in contrasto con la tendenza prevalente ad identificare la cortesia verbale soltanto con stra-tegie di mitigazione, queste ultime vanno invece considerate in connessione con le strategie di rafforzamento, in quanto la cortesia si realizza nella reci-procità tra parlante e destinatario e si dispiega nell�ordine sequenziale della conversazione.
Bibliografia
Alfonzetti G., 2005, I complimenti in italiano: analisi delle risposte. In Kor-zen I. (a cura di), Lingua, cultura e intercultura: l�italiano e le altre lin-gue. Atti dell�VIII Congresso SILFI, (Copenhagen, 22-26 giugno 2004), «Copenhagen Studies in Language», 31, 59-72.
Alfonzetti G., in stampa a., I complimenti nella conversazione: criteri e pro-blemi di categorizzazione, in Atti del XXIV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Aberystwyth 1-6 agosto 2004), Tübingen, Niemeyer.
Alfonzetti G., in stampa b., I complimenti e la cortesia verbale, «Le Forme e la Storia».
Arndt H. e Janney R. W., 1985, Politeness Revisited: Cross-modal Supportive Strategies, «IRAL (International Review of Applied Linguistics in Lan-guage Teaching)», 23, 281-300.
Arndt H. e Janney R.W., 1991, Verbal, Prosodic and Kinesic Emotive Contrasts in Speech, «Journal of Pragmatics», 15, 521-549.
Brown P. e Levinson S.C., 1987, Politeness. Some Universal in Language Usage, Cambridge, Cambridge University Press.
Caffi C., 1990, Modulazione, mitigazione, litote, in Conte M.E., Giacalone Ramat A. e Ramat P. (a cura di), Dimensioni della linguistica, Milano, Franco Angeli, 169-199.
Caffi C., 1999, On mitigation, «Journal of Pragmatics», 31, 880-909. Caffi C. e Janney R.W., 1994, Toward a Pragmatics of Emotive
Communication, «Journal of Pragmatics», 22, 325-73. Fraser B., 1980, Conversational Mitigation, «Journal of Pragmatics», 4,
341-350. Holmes J., 1984, Modifying Illocutionary Force, «Journal of Pragmatics», 8,
345-365. Held G., 1989, On the Role of Maximization in Verbal Politeness,
«Multilingua», 8, 167-206.
FENOMENI DI MODULAZIONE NELLE SEQUENZE COMPLIMENTO-RISPOSTA 933
Janney R. W. e Horst A., 1992, Intracultural Tact Versus Intercultural Tact, in Watts R.J., Ide S. e Ehlich K. (a cura di), Politeness in Language. Studies in its History, Theory and Practice, Berlin-New York, Mouton de Gruyter, 21-41.
Leech G., 1983, Principles of Pragmatics, New York, Longman. Lonzi L., 1991, Il sintagma avverbiale, in Renzi L. e Salvi G. (a cura di),
Grande grammatica italiana di consultazione, vol. II, Bologna, il Mulino, 341-412.
Norrick N. R., 1980, The Speech Act of Complimenting, in Hovdhaugen E. (a cura di), The Nordic Languages and Modern Linguistics, Oslo, Universitetsforlaget, 296-304.
Pomerantz A., 1984, Agreeing and Disagreeing with Assessments: Some Features of Preferred/Dispreferred Turn Shapes, in Atkinson J.M. e Heritage J. (a cura di), Structures of Social Action. Studies in Conversation Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 57-101.
Sbisà M., 1992, Atti linguistici ed espressioni di affetto, in Gobber G. (a cura di), La linguistica pragmatica. Atti del XXIV Congresso della So-cietà di Linguistica Italiana, Roma, Bulzoni, 353-378.
Sbisà M., 2001, Illocutionary Force and Degrees of Strength in Language Use, «Journal of Pragmatics», 33, 1791-1814.
Wiener M. e Mehrabian A., 1968, Language within Language: Immediacy, a Channel in Verbal Communication, New York, Appleton, Century-Crofts.
Informazioni sull�autore
Giovanna Alfonzetti Università di Catania. Email: