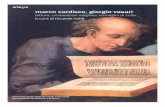I disegni di architettura e di urbanistica del fondo farnesiano nell’Archivio di Stato di Napoli.
Due mausolei del suburbio orientale di Roma. Problemi di ratio e ipotesi ricostruttive
Transcript of Due mausolei del suburbio orientale di Roma. Problemi di ratio e ipotesi ricostruttive
97
Monumenta, Atti del Convegno di Studi (Monte Porzio Catone, 25 ottobre 2008) a cura di M. Valenti (Tusculana - Quaderni del Museo di Monte Porzio Catone, 3), Frascati 2009 - pp. 11-26
poter stabilire l’applicazione di un’ipotetica ra-tio (modulo). Saranno esaminati due mausolei del suburbio orientale di Roma, situati lungo la via Casilina (fig. 1): uno circolare (mauso-leo di Via dell’Aquila Reale), l’altro a pianta quadrata con tamburo circolare (mausoleo di Publio Valerio Prisco).
Mausoleo anonimo in via dell’Aquila Reale
Il piccolo mausoleo circolare situato in via dell’Aquila Reale è stato messo in luce nel 1962, in seguito a lavori di sbancamento per la costruzione di un condominio, al km 10,54 della via Casilina: i risultati sono stati pubbli-cati da L. Quilici3.
Il mausoleo, a pianta circolare, ha il dia-metro di m 8,80. Poggia su una fondazione in blocchi parallelepipedi di tufo di diverse quali-tà, disposti per taglio, alti cm 56 circa e lunghi cm 140-150 circa, con gli angoli smussati per
Due mausolei del suburbio orientale di Roma: problemi di ratio
Francesco Di JorioSapienza. Università di Roma
Il concetto di schema geometrico è stato definito da A. Choisy come “una figura geometrica che consente di tracciare le
linee fondamentali del progetto”1. Tale for-mulazione tuttavia non è presente in Vitruvio (o almeno non è espressa in modo preciso), anche se nell’antichità abbiamo una serie di rappresentazioni che attestano l’impiego di schemi geometrici. In realtà allo stato attuale degli studi ancora non si è giunti a una precisa comprensione della problematica ed esistono due scuole di pensiero2: una che riprende i si-stemi modulari (unità di misura); l’altra, inve-ce, l’applicazione delle figure geometriche (ad es. triangolo pitagorico di 3:4:5 e figure deri-vate).
Questo lavoro ha lo scopo di determinare, per una particolare tipologia di monumenti, l’esistenza di rapporti proporzionali e impo-stare un sistema di proporzioni tra i differenti elementi che costituiscono l’edificio, così da
Fig. 1 - Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell’agro romano, f 25 scala 1 a 10000
Due mausolei del suburbio orientale di Roma: problemi di ratio Francesca Di Jorio
98
permetterne una maggiore adesione (fig. 2).Le giunture dei blocchi del primo filare non
cadono perfettamente al centro dei blocchi del filare inferiore. Il corpo superiore è in blocchi di travertino disposti, alternativamente, per te-sta e per taglio, alti cm 60 circa.
Al di sopra è scandito da una base in traver-tino modanata costituita da un plinto alto circa cm 10, un toro e da una gola dritta. I blocchi che costituiscono la cornice sono 22 e hanno una profondità di cm 90-92 e una lunghezza che varia dai cm 80 ai cm 240: delle grappe di ferro a coda di rondine, lunghe cm 14 circa uniscono i vari blocchi. Su questa cornice si impostano, sul lato ovest, altri tre blocchi di travertino con la stessa disposizione di quelli sottostanti, profondi circa cm 524. Quilici vide anche, nell’intradosso della cornice, un blocco che presumibilmente potrebbe far parte della camera sepolcrale5.
Dallo studio di Quilici non si ricavano al-
FondazionePrimo filare
BaseSecondo
filareDiam. maus.
cm 53p.r. 1,79
cm 62p.r. 2,09
cm 41p.r. 1,38
cm 60p.r. 2,02
m 8,80p.r. 29,72
Fig. 2 - Mausoleo Via dell’Aquila Reale, foto (da Quilici 1974, Autore)
Tabella 1: Misure mausoleo (p.r. = piedi romani).
cunr indicazione circa le eventuali sostruzioni interne che il mausoleo poteva avere.
Mausoleo via dell’Aquila Reale: ipotesi ricostruttive
Quel che è visibile del mausoleo è una parte della fondazione, il primo filare di travertino, la base e tre blocchi del filare superiore, tutto per un’altezza complessiva di circa m 2,13; mentre l’anello esterno è di m 8,80 di diametro.
L’unica ipotesi ricostruttiva finora proposta è stata avanzata da Quilici6 (fig. 3). (…)
Foto mausoleo (Quilici 1974)
Foto mausoleo (autore)
Monumenta I mausolei romani, tra commemorazione funebre e propaganda celebrativa Tusculana 3
99
Mausoleo Cilindro: diam./
altezza cons. Ratio (modulo)
Via Appia 19/2 m
p.r. 64,18/6,759:1
Curiatii 17,50/3 m
p.r. 59,12/10,13 6:1
Horatii 28/1 m
p.r. 94,59/3,37 28:1
Casal Rotondo 26,50/8,70 m
p.r. 89,52/29,393:1
Via Appia 28,60/4,50 m
p.r. 96,62/15,206:1
Via Appia 30,80/7 m
p.r. 104,05/23,64 4:1
Torraccio 15/10 m
p.r. 50,67/33,781:1
Frascati 27,15/7 m
p.r. 91,72/23,644:1
Torrione 41/9 m
p.r 138,51/30,404:1
Lucilii 34,91/4,50 m
p.r. 117,93/15,207:1
Via Flaminia 16,80/1,60 mp.r. 56,75/5,40
10:1
Per quanto riguarda il tumulo di terra so-prastante, è accettabile il rapporto di 4:1 sta-bilito anche per il mausoleo di Valerio Prisco (v. oltre). Non è possibile avanzare nessuna ipotesi sulla presenza dei muri di sostruzione, all’interno del Mausoleo. Però si può dedur-re che, data l’altezza di circa m 3 del tamburo circolare, non fosse necessario alcun muro di contenimento interno per alleggerire il peso della struttura.
In ultima analisi il mausoleo anonimo di via dell’Aquila Reale doveva poggiare su una
La ricostruzione proposta invece in questo lavoro tiene conto della ratio che gli architetti romani avrebbero potuto applicare nel rappor-to tra lunghezza e altezza. A questo proposito può essere utile confrontare i dati disponibili di altri mausolei a pianta circolare del subur-bio di Roma7.
Cilindro: diametro/altezza
Tumulo: diametro/altezza
Ratio
m 8,80/2,96p.r. 30/10
m 8,80/2,20p.r. 30/7
3:14:1
Fig. 3 - Mausoleo Via dell’Aquila Reale - piante (da Quilici 1974)
Tabella 2: confronti con mausolei del suburbio di Roma
Tabella 3: Misure mausoleo via dell’Aquila Reale
Pianta e alzato (Quilici 1974)
In questo caso, come si osserva dalla tabella 2, il rapporto tra diametro/altezza varia note-volmente e la difficoltà nasce proprio dal fat-to che non si possono istituire confronti con mausolei che hanno un diametro di circa 8-10 m, visto che molti sono stati completamente distrutti e di alcuni ne rimane solo la platea di fondazione.
Non si possono prendere come termine di confronto i mausolei elencati nella tabella 2, in quanto le misure sono minimo il dop-pio di quelle che si hanno per la tomba di via dell’Aquila Reale.
Il problema della ricostruzione potrebbe essere risolto solo pensando che il mausoleo in questione, data l’altezza di circa m 1,63 e la larghezza di m 8,80, possa rientrare nel tipo di edifico funerario diffuso intorno alla metà del I secolo a.C. e caratterizzato da un basamento relativamente basso, un alto tumulo e dal’as-senza della camera sepolcrale all’interno.
Purtroppo nessun mausoleo considerato mi ha permesso di ottenere dati certi sull’effettiva altezza del tumulo. Per questo mausoleo è pos-sibile così impostare le seguenti proporzioni:
Due mausolei del suburbio orientale di Roma: problemi di ratio Francesca Di Jorio
100
tre l’impiego del travertino non è un elemento caratterizzante. Per cui si può facilmente pro-porre una datazione tardo-repubblicana o pri-mo augustea.
Mausoleo di Valerio Prisco
Il Mausoleo di Valerio Prisco fu indivi-duato nel 192810: di esso venne messa in luce solamente la platea di fondazione. In seguito a continui rinvenimenti di materiale archeolo-gico sporadico nella zona, la Regia Soprinten-denza alle Antichità decise di promuovere un intervento di scavo più approfondito, che ebbe luogo nel 1931. Non si hanno altre notizie re-lative al sepolcro almeno fino al 1959, quando per le sue particolari caratteristiche fu citato da L. Crema, nel volume dedicato all’architet-tura romana11.
Fino a quel periodo non si conosceva il personaggio legato al mausoleo. Nel 1966 A. Degrassi studiò un’iscrizione ritrovata in zona circa dieci anni prima, la cui segnalazione alla Soprintendenza Archeologica di Roma era stata però taciuta. Così in base ai dati ricava-ti dall’epigrafe la tomba fu attribuita a Publio Valerio Prisco12. L’ultimo lavoro risale al 1974 ed è stato fatto da L. Quilici13, poi gli scarsis-simi resti del mausoleo furono definitivamente interrati per la costruzione di un edificio.
L’edificio che sorgeva a circa m 75 dalla via
platea di fondazione in blocchi di tufo di varia qualità di circa cm 53 di altezza. Su questa si imposta un solo filare di blocchi di travertino alti circa 60 cm. Segue poi la base modanata in travertino e su di essa cinque filari di blocchi, sempre di travertino. Su questi si innestava poi il tumulo di terra alto circa m 2,20 (fig. 4).
Per quel che concerne la decorazione archi-tettonica, il mausoleo era provvisto di una base in travertino8 che si articola su un plinto leg-germente avanzato, e su una gola rovescia. La curva esterna ha l’altezza pari alla metà della curva interna, mentre quest’ultima risulta es-sere metà dell’altezza complessiva della base ed ha un profilo quasi rettilineo nella parte superiore.
Tale caratteristica è dovuta al fatto che do-veva sostenere parte del peso dei blocchi di travertino. Il tipo di modanatura a gola rove-scia comincia a diffondersi intorno al III seco-lo a.C., ma solo tra il III ed il II a.C. verrà im-piegata come elemento nei podi e nelle basi9.
In conclusione è possibile accettare l’ipotesi di Quilici, anche se nella ricostruzione propo-sta in questo studio l’altezza del tamburo cir-colare è comunque maggiore. Questo mauso-leo ha comunque un diametro minore rispetto a quelli considerati; il profilo della base non aggiunge nulla di nuovo, tenuto conto che il tipo di modanatura rientra in quelle diffuse dal periodo medio-repubblicano in poi, inol-
Fig. 4 - Ricostruzione mausoleo Via dell’Aquila Reale (Autore)
Monumenta I mausolei romani, tra commemorazione funebre e propaganda celebrativa Tusculana 3
101
Casilina14 era completamente devastato: rima-neva solamente la fondazione a pianta quadra-ta di m 16,30 circa di lato che presentava al suo interno un vuoto circolare di circa m 12 di diametro. Lungo i lati perimetrali furono tro-vate tre tombe coperte con grosse tegole15 (fig. 5). Sembravano far parte invece dalla struttura del mausoleo16 i quattro frammenti ritrovati, compreso anche un pezzo appartenente al co-ronamento della trabeazione del sepolcro.
le cui fondazioni giungevano alla profondità di circa m 2,35 rispetto al piano di calpestio. Questa presentava al centro la cavità circolare attraversata da due muri di fondazione, spessi m 1,80 circa, che si intersecavano tra loro ad angolo retto: gli spazi vuoti a forma di archi ciechi furono ricoperti, al momento della co-struzione del sepolcro, con la terra di risulta. Quasi al centro del mausoleo, nel punto dove si intersecavano i muri di fondazione, a circa 10 cm di profondità rispetto al piano della platea, fu rinvenuta la piccola parte di un pa-vimento a mosaico a tesse bianche e nere in parte restaurato con elementi in cotto17.
Furono poi rinvenuti altri quattro elementi architettonici in marmo appartenenti al podio e al tamburo circolare del mausoleo18.
Lungo le pareti N, E ed O della platea di fondazione furono poi individuate le tombe messe in luce fin dal precedente intervento. Quelle situate a N ed E erano lunghe da m 1,50 a m 2 e furono rinvenute già violate e di-strutte: i corpi in esse deposti erano orientati uno verso N e l’altro verso O; la tomba ad E era lunga circa m 2 ed il corpo era rivolto verso N. Quest’ultima fu quella che ha restituito un cospicuo corredo funerario19.
Il monumento sepolcrale era corredato di un’epigrafe, incisa su un blocco di marmo lu-nense, di cui una parte fu già vista intorno alla metà del ‘700 e pubblicata nel CIL20. Il resto dell’iscrizione venne ritrovato nel 1957 ed il compito di integrarla con quella precedente e studiarla fu affidato ad A. Degrassi nel 1966 da J. Coste21 (fig. 6).
Attualmente ciò che rimane del mausoleo è stato interrato per la costruzione di un palaz-
Fig. 5 - Painta mausoleo P. Valrio Prisco (da Stefani 1931)
Fig. 6 - Epigrafe mausoleo P. Valerio Prisco (da Degrassi 1967-1968, Quilici 1974)
Nel 1931 fu di nuovo necessario un secon-do intervento, causa i continui ritrovamenti di materiale sporadico nella proprietà privata, e la direzione dello scavo fu affidata a E. Ste-fani. In questa occasione le strutture furono descritte in modo più dettagliato.
Venne messa di nuovo in evidenza la pla-tea del sepolcro, orientata perfettamente a N,
Due mausolei del suburbio orientale di Roma: problemi di ratio Francesca Di Jorio
102
zo, mentre il blocco di marmo con l’iscrizione studiata da Degrassi di trova all’interno del giardino della proprietà Sbardella.
Mausoleo di Valerio Prisco: ipotesi ricostruttive
Nessuna ricostruzione è mai stata proposta per il mausoleo di Publio Valerio Prisco. Per formulare una nuova ipotesi si devono pren-dere in considerazione esclusivamente gli uni-ci dati oggettiti disponibili, che sono:
In base a questi raffronti si è cercato di de-terminare se esistevano dei rapporti razionali per stabilire un sistema di proporzioni tra i differenti elementi che costituivano l’edificio, in modo che le loro dimensioni siano definite con numeri interi o frazioni semplici (un mez-zo, un quarto, ecc…). Sì è così ricavata una ra-tio o modulo che, nonostante delle accettabili variazioni, può comunque soddisfare i canoni sopra esposti.
Infatti, esaminando la colonna Ratio della tabella, possiamo vedere come nel podio dei mausolei considerati il rapporto tra lunghezza/altezza sia di 2:1 o di 4:1, comunque un mul-tiplo di due: da quel che si è potuto ricavare questo rapporto sembra essere una costante.
Per il mausoleo di Publio Valerio Prisco, non avendo altri termini di paragone, si deve necessariamente proporre una ricostruzione basata su questi rapporti proporzionali – che sembrano tuttavia accettabili –, e occorre prendere come riferimento, visto che le misure in un certo qual modo si avvicinano, il modulo ricavato per tomba degli Arruntii.
Considerata perciò la ratio di 4:1 per il po-dio quadrato e 2:1 per il tamburo circolare, basta applicare tali misure a quelle in nostro
Podio: lunghezza
Corpo cilindrico: diametro
Muri interni larghezza
m16,30 p.r. 55,06
m 12p.r. 40,54
m 1,80p.r. 6,08
Mausoleo Podio: Lungh./alt.
Cilindro: diam./alt.
Ratio (modulo) Podio/cilindro
Tomba di Priscilla m 20,82/2,72p.r. 70,33/9,125
m 19/5p.r. 64/16
7:1/3:1
Tomba dei Servilii m 11,10/5,18p.r. 37,50/17,50
n. d. 2:1
Torre Selce m 21,75/4p.r. 73,5/13,5
m 21/11p.r. 71/37
5:1/2:1
Torraccio m 10,37x10,12/4,19p.r. 35x(34,18)/14
n. d. 5:2
Tomba Arruntii m 12,59/3,20p.r. 42,5/10,625
m 11,70/5,50p.r. 39,5/18,5
4:1/2:1
Via Tiburtina m 5,90/2,70p.r. 20/9
m 6p.r. 20
2:1
Tor Lupara m 10,73/1,95p.r. 36/6
n. d. 6:1
Tabella 4: misure mausoleo
Tabella 5: confronti tra alcuni mausolei del suburbio di Roma
Questo mausoleo rientra nella tipologia delle tombe a tumulo, caratterizzate però da un basamento sottostante quadrato o rettan-golare. Si possono pertanto istituire i seguenti confronti con una serie di mausolei del su-burbio di Roma22, come viene indicato nella tabella:
Monumenta I mausolei romani, tra commemorazione funebre e propaganda celebrativa Tusculana 3
103
Podio: Lungh./alt.
Cilindro: diam./alt.
Ratio Podio/cilindro
m 16,30/8,15piedi 55/28
m 12/6 piedi 41/20
4:1/2:1
Muri ortogonali: spessore
Spicchi: raggio
Cilindro: altezza
Ratio (modulo)Cilindro/alt. muri sostr.
m 1,80piedi 6
m 4,55piedi 15
m 12/4,14piedi 41/14
1:1
Diametro (corda)
lunghezza
Freccia (altezza)
Ratio (modulo)Tumulo
lungh/alt.
m 12piedi 41
m 3piedi 10
4:1
possesso per calcolare l’altezza del podio e del tamburo:
ducibile, visto che in questa tipologia di tombe non si è conservata. Possiamo però tentare an-che qui una ipotesi.
Erano utilizzate tre tipi di coperture, che riprendono poi l’impostazione geometrica dell’arco, e sono: a sesto pieno, acuto e ribas-sato; poi si riscontra anche la forma tronco-conica. Escludendo la forma a sesto acuto, che prevede un’altezza notevolmente maggiore del diametro di base e quella a sesto pieno che prevede pari altezza, rimangono quella a sesto ribassato e la forma tronco-conica.
L’arco a sesto ribassato ha il centro che cade al di sotto della corda e la freccia risulta minore rispetto alla metà della corda23. Questo risolve i problemi di statica che invece si presentano
Tabella 6: mausoleo Valerio Prisco ratio 4:1/2:1
Tabella 6: mausoleo Valerio Prisco ratio 4:1/2:1
Tabella 7: misure muri di sostruzione, spicchi e rapporto con l’altezza del tamburo.
Una ulteriore considerazione si può propor-re esaminando i muri di fondazione ortogonali del mausoleo circoscritti dalla cavità circolare. La planimetria mostra come la fondazione ri-sulti divisa così in quattro spicchi. Da questa considerazione si ricava un altro dato:
Dalla tabella 7 notiamo che il raggio degli spicchi è di piedi 15 e si avvicina molto, come misura, all’altezza del tamburo circolare, come proposto nelle tabelle precedenti.
Abbiamo così individuato una ratio di 1:1 per quanto riguarda il rapporto altezza tambu-ro circolare/muri interni di sostruzione.
La terra che riempie gli spicchi, compresa quella che svolge la funzione di tumulo, sot-topone la struttura ad una forte sollecitazione anzi, anche la stessa terra, con il mutare delle condizioni atmosferiche è soggetta a delle no-tevoli variazioni di consistenza: dunque è accet-tabile un eguale rapporto tra l’altezza del tam-buro circolare e muri di contenimento interni.
È importante precisare che le misure espresse fin qui non tengono in considerazio-ne il soprastante tumulo di terra che fungeva da camera sepolcrale, almeno nei mausolei che non ne avessero una all’interno del basamento. L’altezza del tumulo e l’eventuale forma a pi-ramide o a arco ribassato non è facilmente de-
nelle soluzioni precedentemente scartate.Si può presumere, pertanto, che nella pro-
gettazione si sia tenuto conto anche qui di una ratio di 4:1 tra lunghezza del tumulo e altezza.
In ultima analisi il mausoleo di Publio Va-lerio Prisco doveva essere composto secondo il consueto schema tripartito di questo tipo di tombe: un basamento quadrato di m 16,30 di lato ed alto, a seconda della ratio presa in con-siderazione, circa 4 o 8 m; il tamburo circolare del diam. di m 12 e alto circa m 4. Il tumulo di terra poteva essere a forma tronco-conica oppure ad arco ribassato ed alto circa m 3. All’interno del cilindro i muri di contenimen-
Due mausolei del suburbio orientale di Roma: problemi di ratio Francesca Di Jorio
104
to ortogonali, spessi circa m 1,80, erano alti quanto il tamburo stesso (fig. 7).
Nelle indagini di scavo non è stata rinvenu-ta la camera sepolcrale e, considerato anche il pessimo stato di conservazione in cui si trovava al momento della scoperta, non è possibile for-mulare alcuna ipotesi in merito. Tuttavia pos-siamo ritenere per certo che l’urna con le ceneri si trovasse nel soprastante tumulo di terra.
Il pavimento a mosaico con tessere bian-che e nere ritrovato nei pressi di uno dei muri ortogonali e poi le tombe – con il loro pove-ro corredo funerario - messe in luce sul limi-te stesso della platea di fondazione, attestano solo che la zona era ancora frequentata nel tar-do III secolo d.C.
Mausoleo di Valerio Prisco: elementi architettonici
Appartenevano alla decorazione del mau-soleo i blocchi di marmo lunense rinvenuti nel
corso delle campagne di scavo: quelli che vide-ro sia Stefani che Quilici24 (fig. 8).
I dati di scavo in nostro possesso e l’osserva-zione dei materiali fanno presupporre che tutti i pezzi appartengono alla decorazione esterna del tamburo circolare.
Il podio quadrato era sicuramente rivestito in marmo o travertino. La funzione del podio, in questa particolare tipologia, serviva esclu-sivamente per sopraelevare il tamburo che poi rappresentava la tomba vera e propria25. Il tamburo circolare era movimentato da questo rivestimento in marmo lunense composto da uno zoccolo, un campo liscio e modanato in alto, in cui si alternavano una serie di lesene.
Solo Stefani ha tentato una ricomposizione grafica dei blocchi di marmo del basamento re-lativo al tamburo26 e, allo stato attuale, sembra l’unica accettabile. In questa sede, integrando i dati precedenti con quelli acquisiti, si tenterà un’ipotesi ricostruttiva anche dei blocchi.
Considerando solamente sei blocchi, ovve-
Fig. 7 - Ricostruzione mausoleo P. Valerio Prisco (Autore)
Monumenta I mausolei romani, tra commemorazione funebre e propaganda celebrativa Tusculana 3
105
ro quelli che compongono il basamento, essi raggiungono una lunghezza complessiva di m 7,60 (piedi 26); approssimativamente la lun-ghezza della circonferenza è di m 37,68 (piedi 127), per cui si conserva circa un quinto della decorazione esterna in marmo.
La lunghezza dei blocchi varia da cm 66 a m 1,79 circa27. Scartando il blocco da cm 66, possiamo ricavare la lunghezza media dei re-stanti cinque blocchi, che è pari a m 1,38 (pie-di 5).
Dividendo la misura della circonferenza per la media dei blocchi (in piedi) otteniamo il risultato di 25, che dovrebbe corrispondere al numero complessivo del blocchi utilizzati per rivestire il tamburo circolare.
Considerando poi la larghezza di una lese-na, pari a cm 53 (piedi 2 circa), possiamo ri-tenere che ogni blocco fosse movimentato da una lesena e che la distanza tra di esse fosse di circa m 1,38 (piedi 5). Per cui il basamento
del tamburo circolare era movimentato da 25 lesene larghe cm 53 e sporgenti di circa cm 6 (fig. 9).
Fig. 8 - Decorazione architettonica (da Stefani 1931, Quilici 1974)
Fig. 9 - Decorazione esterna tamburo circolare mausoleo P. Valrio Prisco (da Stefani 1931 rielaborata autore)
Disegni blocchi decorazioni mausoleo (Stefani 1931)
Foto blocchi decorazioni mausoleo (Quilici 1974)
L’impiego del marmo lunense, la semplicità delle modanature del frammento di architrave e anche il motivo della lesena sporgente, non
Due mausolei del suburbio orientale di Roma: problemi di ratio Francesca Di Jorio
106
permettono di poterli inquadrare stilistica-mente in un periodo preciso. L’unica conside-razione che si può fare è che le lesene sporgen-ti non si ritrovano nei mausolei del suburbio di Roma, e dunque questa potrebbe essere una particolarità della decorazione esterna del mausoleo di Valerio Prisco.
Per quel che riguarda la datazione del mau-soleo, Stefani dice testualmente che: “Per la forma del sepolcro e per la sobrietà delle mo-danature ritengo, infine, che l’età di esso non debba discendere oltre i primi decenni del II secolo.”28
Il tipo di mausolei a tumulo su un alto po-dio ha un periodo di diffusione, almeno nel suburbio, che va dalla seconda metà del I sec. a.C. fino a circa il I secolo d.C. Dopo questo arco di tempo non troviamo nei dintorni di Roma queste tombe; esse si diffondono però intorno al I d.C. nel resto dell’Italia e alcuni esempi si trovano anche nelle Province roma-ne29. Quanto esposto dunque non concorda con la cronologia proposta da Stefani.
Del personaggio in questione non si cono-sce altro che l’iscrizione; Degrassi comunque, in base a tutte le risultanze, data l’epigrafe non oltre la metà del II secolo d.C.30
Conclusioni
In questo sede si è cercato di evidenziare le problematiche e le difficoltà che stanno alla base delle restituzioni grafiche degli alzati.
Come rilevato, nel corso della storia degli studi che hanno interessato i mausolei31, non esiste ancora tutt’oggi una trattazione com-pleta su questa tipologia, che prenda in con-siderazione anche una eventuale ricostruzione grafica dell’elevato.
L’unica fonte antica, Vitruvio, non affronta la questione degli edifici funerari. Tuttavia il problema della ricostruzione grafica degli al-zati, dunque, rimane. In tal senso ci sono degli studi nei quali si cerca di ricavare, partendo sempre dal testo di Vitruvio e poi da esem-pi conservati, dei rapporti proporzionali, ma
questi riguardano o singole parti di un edificio o elementi strutturali32.
Nel caso specifico del mausoleo di Publio Valerio Prisco la situazione è ancora più com-plessa, poiché di questa tomba non si conserva praticamente nulla, se non la pianta della fon-dazione: così il problema della ricostruzione grafica investe tutta la struttura. Non esisten-do esempi simili a quello esaminato, si posso-no ricercare confronti e accostamenti, ma solo con mausolei che possono avere delle “affini-tà”, come ad esempio il mausoleo di Canosa e la tomba degli Arruntii. Il modulo di 4:1 e 2:1 determinato per la ricostruzione del podio quadrangolare e del cilindro (senza contare il tumulo di terra) è stato ricavato solo operando degli “accostamenti” con tombe che possono avere le dimensioni simile a quelle del mau-soleo preso in esame. C’è anche la possibilità che oltre al coronamento la tomba di Valerio Prisco avesse anche una merlatura superiore, come accennato, visto che esempi simili sono documentati nel suburbio di Roma.
Inoltre, contrariamente a Stefani, Degrassi e Crema che datano il mausoleo al II secolo d.C. – grazie all’iscrizione - che è il solo ele-mento datante - Von Esberg33 ritiene invece che P. Valerio Prisco possa aver “riutilizzato” una tomba costruita un secolo prima circa, applicando successivamente l’epigrafe. Come detto in precedenza il modello è comunque uno sviluppo in senso architettonico delle tre parti in cui è diviso un tumulo, per cui credo che si possano accettare tutte e due le ipotesi proposte
Per il mausoleo a pianta circolare l’unico problema che si pone in effetti è la ricostruzio-ne del tumulo di terra. Per questo si è proposto in questa sede di utilizzare un modulo di 2:1, ricavato da un passo di Vitruvio34. Esso, anche se è riferito alla copertura dei templi circolari, potrebbe comunque essere accettato come pri-ma ipotesi per un tentativo di ricostruzione.
In ultima analisi i problemi che rimango-no insoluti allo stato attuale riguardano, per il mausoleo di Valerio Prisco, principalmente la
Monumenta I mausolei romani, tra commemorazione funebre e propaganda celebrativa Tusculana 3
107
ricostruzione dell’intera struttura; mentre per il mausoleo di Via dell’Aquila Reale ritengo che non si possa aggiungere più di quanto
fatto, visto che le conclusioni a cui si è giunti fanno collocare entrambe le tombe in un arco cronologico ben determinato.
Note
1 Choisy 1898-1899, p. 313.2 Gros 1976, pp. 699-704; per una trattazione sulle varie interpretazioni, cfr. Barresi 1990, pp. 251-285. 3 Quilici 1974, pp. 743-744. Il mausoleo, situato all’interno di un cortile condominiale, si trova a una quota più bassa (m 5 ca.) rispetto al piano stradale di via Dell’Aquila Reale e a una quota ancora più bassa rispetto a quello dell’attuale via Casilina.4 Quilici 1974, p. 743.5 Quilici 1974, p. 743, nota 4.6 Quilici 1974, p. 744, fig. 1698.7 Cfr. Eisner 1986, pp. 54-56, 61, 69-70, 77, 90, 97, 124.8 Shoe 1965, tav. LI, 4; Quilici 1974, p. 704.9 Shoe 1965, p. 32.10 Degrassi 1967-1968, p. 16: come rilevava Coste l’indica-zione del km IX della Casilina data da Stefani nel 1931 era imprecisa, in quanto la proprietà privata in cui è stato fatto il rinvenimento si estendeva dal km 11 al km 12,500 circa. Errore dovuto al fatto che il conteggio dei km era stato effet-tuato iniziando da Porta Maggiore e non dal Campidoglio, con uno scarto di circa 3 km. 11 Crema 1959, p. 248: “[…] I resti di un sepolcro al nono chilometro della via Casilina (antica Labicana) sembrano in-dicare la sovrapposizione di un corpo circolare marmoreo su una crepedine di peperino quadrata di calcestruzzo, rivestita anch’essa di marmo […]”.12 Degrassi 1967-1968, pp. 15-25; Quilici 1974, p. 705, fig. 1580.13 Quilici 1974, pp. 704-705.14 Quilici 1974, p. 704.15 Paribeni 1928, pp. 349-350: due erano sprovviste di cor-redo funerario, mentre una sola conteneva un disco di bronzo di cm 7,30 di diametro; una piccola lucerna con un bollo; una statuetta fittile di Venere alta cm 18,5 ed un bronzo di Au-reliano.16 Stefani 1931, pp. 506-507, fig. 1; Quilici 1974, p. 705, fig. 1578.17 Stefani 1931, p. 508, figg. 2-3 18 Stefani 1931, p. 507, p. 509, fig. 4.19 Paribeni 1928, p. 350; Quilici 1974, p. 704: ai piedi del-lo scheletro furono rinvenuti uno specchio di bronzo con i frammenti di un altro; due piccole borchiette con un forellino al centro, una lucerna priva di ansa con sul fondo impressa la scritta FORTIS; una statuina fittile di cm 18 circa, con argilla di impasto giallo, raffigurante una Venere Cnidia e un bron-zetto dell’età di Aureliano. Le tombe erano dunque posteriori al mausoleo. L’intero corredo funebre ritrovato apparteneva ad una donna.20 CIL VI, 3654, citata da Degrassi 1967-1968, p. 18; cfr. anche AE, 1974, n. 226
21 Degrassi 1967-1968, pp. 18-19; Quilici 1974, p. 704, nota 8; pag. 705, fig. 1580. 22 Per le tombe prese come confronto v. Eisner 1986.23 Giuliani 1990, p. 71, fig. 3.1424 Stefani 1931, p. 506 fig. 1 a-d; 509, fig. 4 b-d; Quilici 1974, p. 705, figg. 1577-1579. 25 von Hesberg 1992, pp. ?26 Stefani 1931, p. 507, fig. 1, e; Quilici 1974, p. 705, fig. 1575.27 Ne diamo le misure per comodità: m 1,23 (piedi 4); m 1,05 (piedi 4); m 1,32 (piedi 4); 1,55 (piedi 5); m 1,79 (piedi 6); cm 66 (piedi 2).28 Stefani 1931, p. 509.29 Eisner 1986, pp. 213-219; von Hesberg 1994, pp. 113-134.30 Degrassi 1967-1968, p. 25.31 L. Crema nel 1959, ha messo in rilievo la mancanza di una trattazione completa sullo sviluppo architettonico dei mausolei. 32 Mi riferisco a tutti gli studi che riguardano la ricerca di moduli proporzionali da applicare agli edifici a pianta com-plessa, ai templi, oppure a singoli elementi funzionali di una struttura. Per un primo inquadramento del problema cfr. Geertman 1984, pp. 53-62 su Vitruvio ed i rapporti nume-rici; Wilson Jones 1989, pp. 106-151; per una trattazione generale sull’applicazione di alcuni schemi geometrici che riguardano però i templi dell’Italia centrale Barresi 1990, citato a nota 2. 33 von Hesberg, pp. 130-131.34 Vitruvio IV,8,3.
Abbreviazioni Bibliografiche
Barresi P. 1990: Schemi geometrici nei templi dell ’Italia cen-trale, in ArchCl XLII, pp. 251-285Choisy 1898-1899: ?Crema L. 1959: L’architettura romana, Torino.Degrassi A. 1967-1968: Il sepolcro di Publio Valerio Prisco, in MemAL 13, 1967-1968, pp. 15-25.Eisner M. 1986: Zur Typologie der Grabbauten im Suburbium Roms (RM. Suppl. 26), MainzGeertman H. 1984: Vitruvio e i rapporti numerici, in BA-Besch 59, pp. 53-61.Giuliani C.F. 1990: ?Gros M. 1976: ?Messineo G. 1991: La via Flaminia, RomaParibeni R. 1928: Via Casilina antica via Labicana, in NSc 1928, pp. 349-350 .Quilici L. 1974: Collatia (Forma Italiae, Regio I, 10), Roma.Shoe L.T. 1965: Etruscan and Repubblican Roman Mouldings (MAAR XXVIII), RomaStefani E. 1931: Scoperta di un antico sepolcro sulla via Casi-
Due mausolei del suburbio orientale di Roma: problemi di ratio Francesca Di Jorio
108
lina, in NSc 1931, pp. 506-509.von Hesberg H.1994: Monumenta. I sepolcri romani e la loro architettura, Milano
Wilson Jones M. 1989: Principles of Design in Roman Archi-tecture. The Settings out of Centralised Buidings, in PBSR LVII, pp. 106-151.