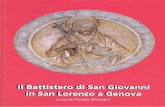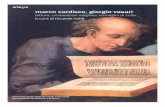Osservazioni sull’industria litica di Maddalena di Muccia (Neolitico antico).
Ipotesi interpretative sull’industria litica del Monte S. Vittoria - Neoneli (Or)
Transcript of Ipotesi interpretative sull’industria litica del Monte S. Vittoria - Neoneli (Or)
Atti del 5° Convegno internazionale (Pau, Italia, 27-29 Giugno 2008)
L’ossidiana del Monte Arci nel Mediterraneo
Nuovi apporti sulla diffusione, sui sistemi di produzione e sulla loro cronologia
a cura diCarlo Lugliè
Comune di Pau
Comune di Pau, Paese dell’OssidianaVia S. Giorgio, 17 - 09090 Pau ORTel. 0783 939002 - Fax 0783 939282 [email protected]
© NURVia Amsicora, 27 - 09091 Ales ORTel. e Fax 0783 [email protected]
Il progetto grafico è di Luigi Manias. Il testo è composto da Diego Dessì delle Nuove Grafiche Puddu con Adobe In design in Optima Linotype di Herman Zapf nei corpi 11, 10 e 9; per la copertina nei corpi 30, 22, 18, 14, 12. Stampato in offset dalle Nuove Grafiche Puddu su carta Favini Aralda avorio opaca da 100 g con PH neutro per l’interno e su cartoncino Symbol Freelife Gloss P.W. BC Fedrigoni da 300 g per la copertina. Allestimento in brossura a filo refe e plastificazione della copertina a cura delle Nuove Grafiche Puddu di Ortacesus.
L’ossidiana del Monte Arci nel Mediterraneo : nuovi apporti sulla diffusione, sui sistemi di produ-zione e sulla loro cronologia : Atti del 5. Convegno internazionale, Pau, Italia, 27-29 Giugno 2008. / a cura di Carlo Lugliè. - Ales : Nur, 2010. - 380 p. : ill. ; 24 cm.
736.280945944OSSIDIANA - Monte Arci - Congressi - Pau - 2008.
Prima edizione 26 febbraio 2010
ISBN 978-88-96837-00-9
Regione Autonomadella Sardegna
Provincia diOristano
Ipotesi interpretative sull’industria litica del Monte S. Vittoria - Neoneli (Or)
L’ossidianadelMonteArcinelMediterraneo.Nuovi apporti sulladiffusione, suisistemidiproduzioneesullalorocronologia,Atti del 5° Convegno internazionale (Pau, Italia, 27-29 Giugno 2008), a cura di C. Lugliè. NUR, Ales, 2010
1 Dipartimento di Storia, Università di Sassari. [email protected] Dipartimento di Biologia ed Evoluzione, Università di Ferrara - Paleoworking. [email protected]
Cinzia Loi1, Vittorio Brizzi2
RiassuntoLostudiosiriferisceadun’analisimacroscopicadellefratturedaimpattoriscon-tratesuunpiccolocampionedicuspidiinossidianarinvenutenelsitoneoliticodiS.Vittoria,individuatoall’internodell’oasifaunisticadiAssai,nelterritoriodiNeoneli(Or).L’industriainquestione,dicuifannoparteanchenumerosiraschia-toiconevidenti traccedi ritocco,è statapresa inesamedaunpuntodivistafunzionale; alcuni di questi reperti sono stati riprodotti, immanicati in aste difrecciaescagliati,indiversesessioni,sucarcassediselvagginapercompararelefratturerisultanti.Inquestomodoèstatopossibileattribuireall’impattolamag-giorpartedelle traccepresenti.Ciòsuggerisceun’ipotetica interpretazionedelsito,identificabilecomeaccampamentotemporaneodicacciatoriincuivenivaoperatoildepezzamentoprimariodellaselvagginaabbattutaconarcoefrecce,peragevolarneiltrasportoversoilvillaggio.Lamorfologiadelterritorio,alcuneconsiderazionilegatealladinamicavenatoriaelasuaubicazione,inun’areaan-coraoggiriccadifaunaungulataautoctona,potrebberosuffragarequestaipotesi.
AbstractThisarticlewillshowhowobsidianmacroscopicweartracesanalysisonalittleassemblageofarrowpointsexcavatedfromtheNeolithicsiteofS.Vittoria,intheAssaiwildlifeoasisintheNeoneliterritory(Or),canbeemployedtoexplorethedestinationofthesite.Thankstoexperimentalarchaeologyandfunctionalanalysis on these remains, assembled in arrow and shootwith bow to boarcarcasses,inseveralsessions,authorshypothesizedatemporaryhuntingdres-sing site foraquickbutcheryoperations,before returning to thevillage.Theterritorymorphology,itslocalization,withacontemporaryrichautochthonousfaunaandsomebehavioralaspectsonthehuntingpracticecouldconfirmthishypothesis.
C. Loi e V. Brizzi236
IntroduzioneIl presente lavoro muove dall’analisi macroscopica delle fratture da impatto riscontrate su un campione di cuspidi in ossidiana rinvenute nell’insediamento neolitico di S. Vittoria. Il sito, ubicato al confine tra i territori comunali di Neoneli e Nughedu S. Vittoria, nel Barigadu −re-gione storico-geografica che si estende nella parte centrale della Sarde-gna (293,94 Kmq)− occupa la sommità di un vasto pianoro dai versanti precipiti (817 m s.l.m.) dal quale si domina gran parte dell’altopiano di Abbasanta e, verso E, i rilievi del Mandrolisai. La località ricade all’in-terno dell’oasi faunistica di Assai (Figura 1).
L’ambiente, in un’area compresa nel raggio di due km, è caratterizzato da un paesaggio di alta collina con quote comprese fra i 601 e gli 800 m s.l.m.Dal punto di vista geologico tale ambito è occupato dai graniti del Pa-leozoico1; le forme del rilievo si presentano a tratti aspre e si diver-sificano in relazione alla distribuzione delle diverse facies litologiche. L’elevata rocciosità che contraddistingue tale paesaggio rappresenta un forte limite all’utilizzo di questi terreni. Il substrato del Monte S. Vittoria è costituito anch’esso da rocce granitiche su cui poggiano però suoli ignimbritici. Anche le distanze dal corso d’acqua non sono brevissime; il più vicino è il Riu Tintinnu, distante oltre 500 metri.Le prospezioni di superficie - effettuate sul terreno da chi scrive (Loi cds a) - hanno permesso di individuare diverse fasi di frequentazione, in un
Fig. 1: Il monte di S.Vittoria, Neoneli (Or).
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 237
arco cronologico molto ampio, il cui limite inferiore sembra collocabile alla metà del IV millennio a.C., nel Neolitico Recente (cultura di Ozieri) cui seguono testimonianze delle fasi iniziali dell’Eneolitico (culture di Filigosa e Abealzu). Non sono attestate le fasi finali dell’Eneolitico e le diverse fasi dell’età del Bronzo. Secondo il Barreca (1978: 245), sul Monte S. Vittoria vi sarebbe stato un insediamento di età punica. Tutta-via, sulla base di quanto documentato inloco ed in assenza di dati di scavo, si preferisce tenere sospesa la valutazione dello studioso e inter-pretare le rovine presenti nel sito come ciò che resta dell’insediamento giudicale diSancteVictoriedeMontesancto, documentato nel Conda-ghe di S. Maria di Bonarcado (Besta1982).Allo stato attuale delle ricerche non è emerso alcun elemento che do-cumenti, nella zona circoscritta attorno al nostro sito, l’esistenza di altri insediamenti di epoca preistorica.Un dolmen è stato individuato in località Nole, a circa tre km in direzio-ne S del sito in esame (Loi cds b). Nella stessa località si trovano i resti dell’omonimo nuraghe e di un villaggio ad esso pertinente. Sempre in direzione S, a poco più di due km dal nostro insediamento, sulla sommi-tà del monte Olisezzo, si trovano i resti di un secondo nuraghe.La stazione di S. Vittoria si collega tipologicamente a quelle di Sas Con-cas de Cavizze, Esiricoro, Sedda Sa Figu, Punta Cannasin territorio di Austis (Nieddu 2003: 76). Tuttavia, la scarsità delle informazioni edite ad esse inerenti non agevola l’individuazione di precisi confronti per la peculiare struttura e organizzazione del sito di S. Vittoria.
1. Analisi territorialeA questo punto la domanda che ci si pone è quale fosse la natura di que-sto sito (accampamento stagionale finalizzato alla caccia o insediamen-to permanente) e quali fattori (economico-ambientale, strategico-difen-sivo) possono aver indotto il gruppo umano di S. Vittoria a stanziarvisi.Non si dispone di dati di scavo: tuttavia, sulla base dei confronti con siti coevi e sulla base dei dati direttamente desumibili dallo studio territo-riale e di quelli raccolti sul campo si possono avanzare alcune ipotesi interpretative, che null’altro vogliono essere se non ipotesi di lavoro in vista di future verifiche.Il raffronto tra il sito di S. Vittoria e quelli ad esso coevi ne fa emergere le sue peculiarità. Ricordiamo, infatti, che gli insediamenti del Neolitico Recente isolano risultano ubicati, di preferenza, in aree pianeggianti o modestamente elevate, denotano una economia legata in prevalen-za all’agricoltura e godono della prossimità di un corso d’acqua (Melis 2003: 86).
C. Loi e V. Brizzi238
Lo stesso avviene anche nel restante territorio del Barigadu, all’interno del quale sono stati individuati altri 59 siti riferibili all’età prenuragica (Loi cds c). In questa regione, infatti, si è rilevato che nella maggioranza dei casi le testimonianze relative a possibili aree abitative si localizzano a breve distanza dalle necropoli ed in zone modestamente elevate per le quali si potrebbe ipotizzare un’attività di sussistenza mista. L’analisi del rapporto degli stanziamenti con l’idrografia, seppure riferita alla situa-zione attuale del reticolo idrografico −che tuttavia si suppone non molto dissimile da quella antica−, evidenzia come oltre il 70% di essi avesse un corso d’acqua ad una distanza inferiore ai 300 metri. Per quanto con-cerne le relazioni fra i siti si rileva come la distanza media che separa un complesso a domus de janas da un insediamento abitativo è di circa 800 metri.Caratteristica dell’insediamento di S. Vittoria è invece, come già detto, la posizione elevata, che consente un grande dominio visivo dei territori circostanti. Ancora, l’ambiente sul quale insiste il sito è roccioso, poco adatto all’agricoltura. Inoltre è assai interessante notare come non vi sia un corso d’acqua nelle immediate vicinanze. Altro elemento degno di rilievo è l’assenza di sepolture riferibili a questo insediamento.I caratteri generali del sistema ambientale in cui esso gravita denota-no, come già detto, un criterio di scelta topografica orientato verso il dominio visivo del territorio e fanno supporre che, da un punto di vi-sta economico, il ruolo di maggior interesse fosse attribuito alla caccia, considerato che le possibilità di utilizzo agricolo e per il pascolo di questi suoli sono quasi inesistenti. Tale ambiente, infatti, che immaginia-mo non dovesse essere troppo differente dall’habitatche riscontriamo ancora oggi nella zona, assicurò ai cacciatori che lo frequentavano pe-riodicamente, o vi risiedevano, un’ampia scelta tra le prede cacciabili: prime fra tutte, le specie boschive come il cinghiale, il muflone ed il cervo (Wilkens2003).
2. Il materialeLe indagini di superficie, volte in primo luogo allo studio e alla ridefi-nizione delle fasi di vita dell’insediamento di S. Vittoria, hanno resti-tuito numerosi elementi di industria litica in ossidiana costituita sia da elementi su lama che su scheggia. Gli strumenti sono rappresentati da grattatoi, raschiatoi e da numerose punte di freccia (Figura 2).L’area di raccolta dei reperti, di estensione ridotta, si concentra in corri-spondenza del settore centrale del pianoro.2.1AnalisidellecuspidiDal materiale litico rinvenuto a S. Vittoria, è stato enucleato un cam-
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 239
pione di nove cuspidi. Esse mostrano una serie di danneggiamenti più o meno significativi nella parte distale e alcune presentano fratture nel codolo e nelle spalle. Per quanto riguarda le dimensioni e il peso, la lunghezza va dai 18 ai 35 mm, mentre la loro massa varia dai due ai quattro grammi.I dati riferiti alla “lunghezza presunta” derivano da considerazioni di tipo balistico-strutturale. La tipologia rappresentata è la cuspide bi-facciale peduncolata con spalle più o meno pronunciate (in un solo caso, cuspide 4b, sono abbastanza evidenti tracce di “alette”, ma non si esclude che anche altre potessero avere questa conformazione). Anche la lunghezza dei codoli è dedotta da un punto di vista strutturale, me-diamente come ¼ dell’intera lunghezza della punta. L’intero sviluppo della punta (nei casi in cui risulti priva dell’estremità) è calcolato gra-ficamente facendo convergere i prolungamenti dei bordi esterni della cuspide, tenendo conto di un profilo rettilineo o sub excurvato (Tabella 1). Le armature esaminate presentano sezione lenticolare o piano con-vesse. Il ritocco è piatto ed invadente, in un caso (6b) seriale ed obliquo.
Fig. 2: Il campione di cuspidi in esame.
C. Loi e V. Brizzi240
2.2LedimensionielemasseIl campione esaminato è composto da cuspidi di modeste dimensioni. Sottoponendo, pur con le dovute cautele, le caratteristiche topologiche e metriche di esse ad un processo di reverseengineering, si potrebbe giungere con ragionevole certezza alla conclusione che tali armature fossero parte di un proiettile comunque leggero. Secondo le leggi della balistica del sistema arco-freccia (interna e esterna), infatti, una freccia ben bilanciata, in grado cioè di muoversi verso il bersaglio in modo non erratico e dissipando la minore energia possibile, dovrebbe avere il baricentro statico spostato in avanti rispetto al suo centro geometrico di una percentuale variabile dal 6 al 16%1 (Brizzi 2006). Più la massa in punta è alta, maggiori sono la stabilità in volo, la penetrazione nel bersaglio e minore superficie stabilizzante (impennaggio) è necessaria. Conseguentemente, una freccia armata da una cuspide con caratteristi-che analoghe al nostro campione dovrebbe avere una massa compresa tra i 20 e i 25 grammi (considerando una media tra i pesi specifici delle diverse essenze impiegabili per l’asta e le altre componenti, penne, le-ganti ed incollaggi).La variabile incognita, procedendo in questa modellizzazione, è co-munque relativa alla lunghezza della freccia. Tale dato può essere de-sunto per sommi capi dalle misure antropometriche, ancorché nei suoi termini minimi (un arciere non può tendere una freccia più corta del suo allungo fisiologico, definito dalla distanza tra la mano che regge l’arco con il braccio completamente teso e il punto di aggancio della corda, nei pressi del volto, con l’arco alla sua massima trazione). Dall’altezza media dei paleosardi, desunta dai ritrovamenti funerari (Germanà 1995), si può ragionevolmente ipotizzare una minima lunghezza di freccia in-torno ai 66–68 cm. Questa sommaria ricostruzione comunque ci può comunicare informazioni interessanti: la bassa sezione d’urto appare
1 Per la nostra analisi, è stata utilizzata la “Carta Geologica d’Italia”.
Cuspide Lunghezza origine Lunghezza presunta4b 35 405b 31 406b 25 307b 28 328b 23 359b 20 391d 21 344d 18 408c 20 38
Tabella 1: Lunghezze presunte del campione
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 241
inequivocabile2 e le dimensioni dei codoli (massima larghezza sei mm, massimo spessore tre mm), confermano l’uso di frecce sottili e leggere. Tutte informazioni utili a ipotizzare un sistema balistico dedicato a sca-gliare frecce leggere (per mantenere traiettorie tese) con archi poco forti, e conseguentemente cacce di gruppo basate su sistemi definiti come svantaggio e inseguimento (Churchill 1993: 11–21).
3. Le tracce d’uso macroscopicheRicordiamo che le tracce d’uso riscontrabili sugli strumenti litici sono fonda-mentalmente di due tipi: le tracce di abrasione e le tracce di affaticamento.Le tracce di abrasione sono proprie della deformazione della superficie del manufatto in ragione di politura, appiattimento, striatura, ma non cor-rispondono ad una modificazione della forma fisica macroscopica (Buc-kley 1981: 469-471).Le tracce di affaticamento corrispondono invece a vere e proprie rotture, apprezzabili a occhio nudo, che si verificano quando la resistenza mec-canica del materiale costituente il manufatto viene vinta da una forza di impatto. Queste ultime sono diagnostiche della meccanica delle fratture dei solidi di struttura omogenea sottoposti a carico statico o dinamico3.Nel presente studio, a causa delle modalità di rinvenimento, verranno considerate soltanto le tracce di affaticamento4 (Figura 3).Da un punto di vista topologico le tracce di affaticamento si dividono in fratture longitudinali, laterali (burination), basali e trasverse; dal punto di vista meccanico, invece, vengono classificate in funzione del modo in cui inizia la frattura (initiation) e del modo in cui essa termina (termina-tion). Si avranno così le Conefracture e le Bendingfracture.Le Conefracture sono originate da una forza applicata in un’area rela-tivamente modesta. Tali fratture si generano in prossimità del punto di applicazione della forza stessa. Non sono sempre connesse alla funzio-ne propria del proiettile.2 La valutazione, nell’ambito della balistica terminale, della letalità della ferita è funzione dell’or-gano vitale colpito e dalla profondità del canale di taglio. asua volta,la larghezza del canale di taglio -e quindi della letalità della ferita- è vincolata all’angolo frontale della cuspide e al rapporto tra il perimetro della cuspide/circonferenza dell’asta e l’area di impatto/sezione d’urto che la arma, che deve essere non inferiore a 1 (perché l’asta, trascinata dalla cuspide, sia libera di penetrare senza particolari attriti) e meglio se superiore a 2. La totale superficie della ferita, dal punto di vista dell’efficacia, è parametrizzabile rispetto al selvatico in funzione del periodo dell’anno e dello spessore della pelle e dalla larghezza della cavità toracica ove risiedono gli organi vitali (Friis-Hansen 1990; Perco 1988; 1989; Landini 1990).3 Per carico statico si intendono le fratture generate soprattutto per pressione (ritocco a pressione) mentre per carico dinamico si intendono le fratture a percussione. La percussione morbida rientra, talvolta, nel campo del “carico statico” (Cotterell e Kamminga 1987; 1990).4 Nella classificazione delle tracce di affaticamento il sistema seguito è quello definito dal Ho Ho Committee (Ho Ho Committe Nomenclature 1979). La terminologia si è mantenuta in lingua ingle-se, per evitare confusioni di traduzione.
C. Loi e V. Brizzi242
Le Bendingfracture si generano, invece, su una superficie più ampia. Il punto di applicazione della forza è distante dalla frattura stessa.Entrambe, sulla base della loro forma e terminazione, si articolano in sei specie diverse.Le tracce, siano esse di abrasione che di affaticamento, si presentano spesso associate e vengono osservate in varie combinazioni dipendenti dalle modalità d’uso dello strumento, dalla consistenza del materiale e dalle sue proprietà meccaniche, dal tipo di sollecitazioni e dalla loro durata. Le cuspidi e i frammenti di cuspide rinvenuti nel sito, di lun-ghezza e massa variabile, presentano ognuna tracce per affaticamento. Lo studio del materiale rivela che tutti i tipi di macro-fratture sono va-riazioni sul tema della “Bendingfracture” e della “Snapfracture”. La spiegazione di questa uniformità è basata sui limiti fisici dell’innesco e forma della frattura specifica (Cotterell e Kamminga 1979; Keeley e Lawrence 1979; Tsirk 1979).
4. Le fratture riscontrate sul campioneSono state considerate diagnostiche le StepTerminatingBending frac-ture,leSpin-offfracturebifaccialieleSpin-offfracturemonofaccialidi lunghezza superiore al millimetro, le fratture derivanti da burination e le featherTerminatingBendingfracturedistali (Tabelle 2-3; Figura 4).La cuspide 4b, triangolare, a spalle pronunciate, mostra una confi-gurazione asimmetrica dovuta, con ogni probabilità, ad una frattura dell’aletta destra per collisione trasversale, immediatamente successiva all’impatto. Tale frattura è stata generata, con ogni probabilità, da una
Fig. 3: Classificazione delle macro fratture per impatto (da Fisher et al. 1984).
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 243
Fratture rilevatearea distale area mesiale area prossimale
4b Feather T., burination Cone F.Cone + spin-off
unifacciale (1<Sp<2 mm)
5bBending F. + spin-off
bifacciale (2<Sp<3 mm)Cone + spin-off
unifacciale (1<Sp<2 mm)Snap Feather.
6b Crushing + cone, Step T. Cone F. Snap + Step
7bFeather T., Crushing, Bending F. + spin-off
bifacciale (1<Sp<2 mm)Cone F. Snap T.
8b Snap - Cone
9b Feather T., Crushing, Step T.Cone + spin-off
unifacciale (1<Sp<2 mm)Step T. Cone
1dStep T.
Crushing- Snap + Step T.
4dFeather + crushing
burinationStep T. Cone F.
8c Bending F. + spin-off unifacciale (1<Sp<2 mm)
- Step T.
Sintesi dei risultati osservativi
cusp
idi
Cone fracture Bending fracture Spin-off fracture
Bur
in
(lon
gitu
d.)
feat
her
snap
hing
e
Step
monofacciali bifacciali
fino a 1 mm
oltre 1 mm
4b X X X X5b X X X6b X X XX7b X X8b X X X9b X X1d XX4d X X8c X X X
Tabella 2: Tipologia di frattura macroscopica sull’intero campione di S.Vittoria (Ho Ho Committee Nomenclature 1979)
Tabella 3: Fratture attribuite alle cuspidi
C. Loi e V. Brizzi244
forza con vettore opposto al moto verso il bersaglio (Bendingfracture). Si osservano, inoltre, due piccoli conoidi sulla faccia opposta (Spinoff unifacciale). La punta, priva di un frammento di circa 6 mm, presenta una frattura longitudinale evidente nella forma di un canale (fluting) di discreta entità. Questa frattura è diagnostica per l’impatto (Dockall 1997: 326-327; Ahler 1971: 85-86; Ahler e McMillan 1976: 166), come pure gli spin off sull’aletta destra. Rientra nella casistica delle fratture “Ben-dinginitiation”, con propagazione lungo la superficie. E’ anche definita come “FeatherTerminatingBendingfracture”(Fisher et al. 1984).Il mar-gine destro presenta un’ulteriore frattura laterale lunga 18 mm; secondo la terminologia adottata è definibile come “Burination”, corrispondente ad una rimozione macroscopica di materiale sul bordo dell’utensile che in un altro contesto privo di altri indicatori potrebbe essere confusa con la tecniqueducoupdeburin(Tixier 1974: 9). Anch’essa risulta diagno-stica per l’impatto.La cuspide 5b, triangolare con spalle e bordo excurvato, presenta il co-dolo fratturato da una Snapfracture molto comune negli impatti a breve distanza e nelle situazioni di caccia reale (anche se non propriamente definibile come diagnostico, secondo la letteratura). Presenta un dan-neggiamento nel vertice distale caratterizzato da una Bendingfracture cui corrispondono, sia nella stessa faccia che in quella opposta, delle fratture a cono interpretabili come Spin-offbifacciali. Secondo i criteri diagnostici, questo caratterizza un impatto certo.La cuspide 6b, di forma ogivale, biconvessa, priva di spalle, è caratte-rizzata da un ritocco bifacciale piatto e coprente che sul lato sinistro mostra una tendenza alla serialità. Danneggiata nella punta, presen-
Fig. 4: Ripartizione percentuale dei tipi di frattura sul campione.
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 245
ta evidenti “crushing” e StepTerminatingBendingfracture di modesta entità. Il codolo, fratturato, presenta una serie di indicatori di impatto (Snap+StepTerminatingBendingfracture).La cuspide 7b è piano convessa, triangolare, con spalle asimmetriche (la sinistra risulta danneggiata). Ritoccata grossolanamente sulla faccia dorsale presenta, nell’estremità distale, una FeatherTerminatingBendingfracture di 4 mm, un evidente crushing e una frattura conoide sul lato destro della faccia dorsale. Il codolo mostra, invece, una Snapfracture (non diagnostica).La cuspide 8b, biconvessa, con spalle accennate simmetriche, lacunosa del primo terzo distale, mostra una troncatura snap non diagnostica. Il codolo è rettangolare, con lesioni (FeatherTerminatingBendingfracture).La cuspide 9b, biconvessa, con alette accentuate simmetriche, mostra evidenti segni di ritocco-ravvivamento. Su entrambe le facce sono pre-senti StepTerminatingBendingfracturediagnostiche.Il codolo, frattura-to, presenta una ulteriore StepTerminatingBendingfractureprecedente ad una ulteriore frattura trasversale(ConeFracture). Nel bordo destro è evidente una frattura combinata Bending+spinoff unifacciale −di lun-ghezza compresa tra 1-2 mm− che, data la lunghezza del manufatto, può considerarsi diagnostica per l’impatto (Fischer et al.1984: 24).La cuspide 1d è lacunosa sia dell’estremità distale che del codolo. La sezione è piano convessa e la punta mostra evidenti StepTerminatingBending fracturediagnostiche.La frattura del codolo è anch’essa una StepTerminatingBendingfracture. Entrambe le fratture riscontrate, risul-tano diagnostiche per l’impatto.La cuspide 4d, tronca per circa due quinti, presenta un ritocco di rav-vivamento ortogonale all’asse (evidenzia la caratteristica di “tranciante trasverso”). Sul bordo sono presenti innumerevoli piccole StepTermi-natingBendingfracturesdiagnostiche ma, soprattutto, mostra una buri-nation sul lato sinistro. Il codolo è fratturato da una incipiente FeatherTerminatingBendingfracture.La cuspide 8c è di piccole dimensioni, piano convessa. Sul dorso pre-senta una Bendingfracture con corrispondente Spinoff unifacciale nella parte ventrale, di lunghezza superiore al millimetro, quindi diagnostica per l’impatto. Il codolo è troncato da una StepTerminatingBendingfrac-ture.
5. La sperimentazioneI dati emersi dall’analisi funzionale macroscopica sono stati integrati con alcune nuove determinazioni scaturite da una sperimentazione ba-listica incentrata sul campione selezionato di punte di freccia. La com-
C. Loi e V. Brizzi246
pletezza dei dati disponibili, derivati dall’analisi territoriale e da quel-la sperimentale, ci indurrà quindi ad avanzare alcune considerazioni sul sito in esame che pensiamo saranno utili per alimentare il dibattito sull’uso del territorio nelle diverse fasi della preistoria.La sperimentazione balistica su carcasse o su bersagli succedanei effet-tuata dagli studiosi negli anni passati, evidenzia un limite irrevocabile. Esso consiste nel non aver considerato la differenza sostanziale delle conseguenze di impatto e post-impatto (macroscopiche e microscopi-che) −riscontrabili sia sul proiettile che sui tessuti− effettuando tiri ver-so carcasse piuttosto che su selvaggina viva, sia sul proiettile stesso sia nell’azione sui tessuti. Infatti, l’impatto è strettamente influenzato dai parametri dinamici. Il post-impatto è la fase in cui la cuspide continua ad agire all’interno della cavità corporea grazie al movimento del selvatico (urti dell’asta della freccia conficcata contro ostacoli naturali) e quindi prosegue nella sua azione lesiva (Odell e Cowan 1986: 202). Inoltre, nella fase di recupero del selvatico, postmortem, tutte le azioni di tra-sporto della carcassa e dei possibili tentativi di rimozione della freccia dal corpo da parte del cacciatore producono tracce di affaticamento e abrasione sulla cuspide ben diverse da quelle proprie delle forze agenti in seguito al moto rettilineo del proiettile che coglie il bersaglio.La differenza tra un impatto su bersaglio vitale rispetto a quello su una carcassa oppure su uno artificiale, in molti casi può quindi inficiare la validità dell’esperimento, nel momento in cui le fratture generate speri-mentalmente vanno a raffrontarsi con il record archeologico.La permanenza del proiettile o di parte di esso nella cavità della fe-rita nei momenti successivi all’impatto, determina sulla superficie del proiettile tracce d’uso complesse, diverse da quelle riscontrabili in una sperimentazione su carcasse inanimate, verso cui vengano indirizzati proiettili reiterati.Un altro limite della sperimentazione balistica riguarda la mancanza di dati derivanti da tiri effettuati da breve e brevissima distanza (situazione verosimile in ambito venatorio, ove il cacciatore, appostato, scaglia la sua freccia alla preda “guidata” nei pressi dal battitore o dall’eventuale ausiliario). In tali condizioni, le componenti vibrazionali della freccia modificano di buona misura le forze agenti sulla cuspide nell’istante dell’impatto. Le tracce risultanti sono tali da complicare enormemente il pattern conseguente.Al fine di colmare tale lacuna, dopo aver riprodotto −utilizzando la stessa materia prima (ossidiana del gruppo SC-Pau)− il campione litico in esame ed averlo immanicato in aste di freccia5 secondo i protocolli
5 Uno degli elementi critici esaminati è stato il sistema di interfaccia tra asta e cuspide. La criticità
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 247
descritti ed adottati da altri sperimentatori (Fisher et al. 1984; Odell e Cowan 1986), sono state effettuate due sessioni di sperimentazione bali-stica. Le frecce, infatti, scoccate con archi di forza variabile6 su carcassa di cinghiale7, sono state scagliate a media distanza (prima sessione) −al fine di poter comparare i dati ottenuti con i risultati pubblicati dagli autori citati− e da brevissime distanze8 (seconda sessione). Ai risultati di queste prove ottenute da situazioni di tiro statiche abbiamo assommato ulteriori dati derivanti da osservazioni post-uso raccolte in situazioni di caccia reale al cervo ed al cinghiale9. Qui sono state considerate anche le lesioni derivate da movimenti post-impatto della cuspide conficcata nel corpo del selvatico (i movimenti del selvatico colpito in fuga con la cuspide o tutta la freccia conficcata) e post-mortem (derivanti dal trasporto della carcassa da parte dei cacciatori e prima della depezza-tura o provocati dai tentativi di estrazione della freccia per agevolare il trasporto della carcassa).La decisione di effettuare tiri anche da brevissima distanza (d < 3 m) soddisfa la necessità di verificare le tracce di impatto sulle cuspidi, de-rivanti dalle forze che si generano in questa particolare fase della traiet-toria (accelerazione iniziale). L’impatto a breve distanza è ben diverso da un punto di vista dinamico da quello che avviene nei tiri a distanza superiore, usuali nella caccia di appostamento e incontro (10 < d < 25 m) (Churchill 1993: 11-21). A tale maggiore distanza la freccia risulta stabilizzata nel suo moto rettilineo grazie all’effetto dell’impennaggio; la traiettoria si rettifica ed i moti trans-assiali della freccia si riducono notevolmente.L’impatto provocato da un tiro a breve distanza risulta così caratterizza-
dipende dalla solidità della giunzione tra le componenti, ed in questo caso è stato adottato un sistema che prevede una connessione a “V” nell’asta, ed un mastice composto da resina di pino, ocra e cera d’api nelle proporzioni 60%-20%-20%. L’asta, nella parte terminale dell’interfaccia, è stata rinforzata con tendine di bovino. Infine, estrema attenzione è stata posta nell’uniformare tale interfaccia su tutti i campioni per limitare il più possibile la variabilità del risultato a fronte di una non costante solidità strutturale.6 Archi ricostruiti da 45 a 79 libbre di forza (200,2-351,4N), e frecce di massa compresa tra 35 e 60 grammi, con velocità di uscita tra 45 e 70 m/sec.7 Le carcasse di cinghiale sono state utilizzate in condizioni antecedenti al rigormortis e posiziona-te in modo da avere le articolazioni esposte e contratte.8 E’ evidente come la sperimentazione in “situazione reale di caccia” produca in sé l’insieme di cause che generano l’intero pattern “per affaticamento”, comprese le evidenze riscontrate nei tiri a brevissima distanza. Lo scopo della sessione è stato quello di isolare il fenomeno per acquisirne i dati specifici. Potendo disporre di ulteriori dati, l’osservazione delle fratture dovute alla sperimen-tazione a breve distanza assumerebbe un significato statistico più determinante.9 I dati provenienti dalle sperimentazioni in caccia sono stati raccolti ed elaborati dal 2002 al 2006 nel corso di esperimenti patrocinati da NBEF (National Bowhunting Educational Foundation) e coordinati da uno degli autori nell’ambito del progetto T.I.P.S. in collaborazione con il network dell’associazione Paleoworking. I risultati qui indicati si riferiscono alle sole frecce armate con cuspidi in ossidiana fissate direttamente all’asta (prive di foreshaft).
C. Loi e V. Brizzi248
to da un pattern di forze complesso. Il moto della freccia è la risultante di due componenti: l’accelerazione lungo la linea di avanzamento e le accelerazioni trasversali della freccia intorno ai suoi punti nodali. Que-ste ultime sono causate dal movimento delle dita che rilasciano la corda (nell’istante in cui la freccia inizia ad accelerare verso il bersaglio) e dal disassamento tra piano virtuale di scorrimento della corda e la linea di mira che congiunge l’occhio dell’arciere con il centro del bersaglio, prodotto dallo spessore dell’impugnatura dell’arco. E’ il fenomeno noto come “paradosso dell’arciere”(Kooi 1981; Brizzi e Ferraro 1992: 198-204; Kooi e Bergman 1997; Brizzi 2008).Una freccia che impatta a breve distanza quindi scarica energia vibra-zionale trasversale lungo tutto il canale della ferita, ed essa è di entità veramente notevole10; il fenomeno moltiplica la probabilità di rotture per flessione (BendingeSnapfracture) sulla cuspide simili a quelle otte-nute durante il lavoro sull’utensile durante la sua realizzazione e ad altre fratture ritenute accidentali (cadute e calpestio) e definite “non propria-mente diagnostiche” in letteratura (Fisheret al. 1984).I risultati dei test effettuati sulla carcassa a distanza 20 m (prima ses-sione), soprattutto per ciò che riguarda le fratture “diagnostiche”, sono compatibili con quelli delle sperimentazioni di Odell e Cowan (1986) e quelli di Fisher, Vemming Hansen e Rasmussen(1982). Tuttavia, il dato più interessante è quello relativo alla differenza tra i risultati ottenuti dal-la sperimentazione eseguita su carcassa a distanza media (20 m) e quelli ottenuti dalla sperimentazione eseguita a brevissima distanza (seconda sessione) e da situazioni di caccia reale, ove le fratture Snap appaiono almeno cinque volte più frequenti soprattutto nella porzione prossimale del codolo. Il risultato della sperimentazione (Tabella 4) evidenzia una sostanziale conferma dei dati osservati nel campione in esame, consi-derando l’integrazione dei dati sperimentali provenienti da tiri a brevis-sima distanza e di quelli derivanti dalla caccia reale, in cui le fratture Snap accompagnano quattro cuspidi su nove.L’aver constatato che nell’insieme dei reperti litici di S.Vittoria, oltre al campione esaminato, un alto numero di frammenti di cuspide mostra
10 L’asta della freccia durante il suo moto “libero” vibra intorno ai suoi due punti nodali, posti a un sesto della lunghezza dell’asta, ai suoi estremi. Questo moto, nei primi metri della traiettoria e ri-spetto al bersaglio, è prossimo ai 150 piedi al secondo (50 m/sec) e oltre di velocità; trasversalmen-te le due estremità della freccia si muovono a 50 piedi al secondo (16 m/sec) in un moto oscillatorio sul piano orizzontale, e rispetto all’asse dell’asta a 3000 rotazioni al minuto. All’impatto, il punto nodale principale (anteriore) diventa l’interfaccia di contatto tra asta e bersaglio; la componente della velocità, rispetto al moto lineare, conseguentemente diventa uguale a zero in un attimo rapi-dissimo, e buona parte dell’energia cinetica dei moti vibrazionali liberi si trasferisce istantaneamen-te all’interno del canale della ferita (attraverso movimenti trasversali) enfatizzando la probabilità di snapfracture,indipendentemente dall’orientamento spaziale della cuspide all’impatto.
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 249
Tabe
lla 4
: Il c
ampi
one
sper
imen
tale
esa
min
ato.
“D
” le
frat
ture
rite
nute
dia
gnos
tiche
in le
ttera
tura
Sint
esi d
ei r
isul
tati
spe
rim
enta
li
Tipo
logi
a be
rsag
lioD
ista
nza
di t
iro
(m)
Num
ero
di im
patt
i To
tali
(N)
Con
e fr
actu
reB
endi
ng fr
actu
reSp
in-o
ff fr
actu
re
N.
%
Bur
in
(lon
gitu
d.)
feat
her
snap
hing
eSt
epm
onof
acci
ali
bifa
ccia
li
Fino
a 1
m
mO
ltre
1
mm
N.
%N
.%
N.
%N
.%
N.
%N
.%
N.
%N
.%
Cin
ghia
le
(car
cass
a)2,
552
713
,82
3,8
2751
,913
255
9,6
2140
,416
30,8
1325
1325
Cin
ghia
le
(car
cass
a)20
465
12,2
12,
216
34,8
24,
32
4,3
1839
,113
28,3
919
,68
17,4
Cin
ghia
le
(cac
cia)
10-3
512
413
11,5
54
5947
,626
2116
12,9
6451
,631
2537
29,8
3125
Cer
vo
(cac
cia)
22-3
032
413
,92
6,3
1340
,67
21,8
515
,614
43,8
721
,98
259
28,1
DIA
GN
OST
ICH
ED
DD
D
C. Loi e V. Brizzi250
evidenti fratture Snap, ci permette di allargare l’osservazione all’intero repertorio litico. Tale dato ci suggerisce l’opportunità di includere tali tipi di lesione tra gli indici diagnostici, essendo esse parte integrante e diretta conseguenza dell’evento venatorio. Infatti, la sperimentazione non ha considerato, almeno fino ad oggi, eventi esterni al “semplice” impatto con una carcassa inanimata da media distanza. Viene da sé che anche l’analisi microscopica (tracce di abrasione) dovrebbe tener conto di questi fattori.Queste circostanze sperimentali, sommate, definiscono quindi, secon-do noi, una ulteriore cornice di riferimento alla sperimentazione. Alle fratture propriamente diagnostiche per l’impatto (Spinoff su due facce della cuspide, e StepTerminatingBendingfracture) sono state associati altri tipi di fratture che, in combinazione con le precedenti, possono individuare un modello di riferimento per ulteriori e più approfonditi studi.
6. ConclusioniIn primo luogo il rinvenimento delle cuspidi associate alla presenza di un discreto numero di raschiatoi ci suggerisce un sito preposto alla ma-cellazione (butchering).Le cuspidi sono fratturate in modo “definitivo”, nel senso che difficil-mente avrebbero potuto essere ritoccate ulteriormente e riutilizzate. Il sito presenta un classico assemblaggio di “resti della caccia”: raschiatoi e punte esauste, abbandonati perché non più ravvivabili. Le punte po-trebbero anche essere state lasciate all’interno delle parti anatomiche scartate. La maggior parte di esse, infatti, presenta fratture distali (al pe-duncolo).Il numero delle cuspidi e la loro variabilità stilistico-tecnologica sugge-risce la partecipazione di un cospicuo numero di cacciatori, organizzati in cacce strutturate e coordinate in un discreto lasso di tempo; l’alta in-cidenza di fratture Snap testimonia la probabilità di tiri effettuati a breve e brevissima distanza, come pure potrebbe indicare un lungo trasporto della carcassa con le frecce ancora conficcate.Le cuspidi sono di piccole dimensioni: la loro forma fa ipotizzare un uso su frecce leggere (m < 25 grammi) e quindi scagliate da archi non particolarmente forti. Questo suggerisce cacce di gruppo, organizzate in modo da spingere gli animali verso cacciatori appostati, che porta facilmente a tiri a breve distanza e molte frecce scagliate sulla preda. Una cuspide di queste dimensioni è insufficiente a provocare emorragie mortali e risolutive, ma più cuspidi ottengono il risultato voluto.La corrispondenza delle frequenze delle fratture ottenute con la speri-
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 251
mentazione indica che le sollecitazioni che hanno subito le frecce del campione all’interno della carcassa (postmortem) possono derivare da situazioni di caccia ravvisabili nella battuta(driving-ambushing)esvan-taggio, in cui le occasioni di tiro a breve distanza sono più probabili, naturalmente facilitate dalla morfologia del territorio.La collocazione del sito, in posizione dominante in un’area ricca di selvaggina ungulata, potrebbe anche suggerire la scelta di un luogo “difeso” naturalmente per le operazioni di depezzatura preliminare e grossolana, per consentire un più agevole trasporto della carne verso l’insediamento di origine del nucleo dei cacciatori.Il monte di S. Vittoria potrebbe quindi rappresentare un insediamento temporaneo ad orizzonti liberi, consentendo la visione a lunga distanza di eventuali contendenti in avvicinamento.
C. Loi e V. Brizzi252
Riferimenti bibliografici
aHLer,s.A. 1971 Projectile point form and function at Rodden Shelter, Missouri.
MissouriArchaeologicalSociety,ResearchSeries8. Columbia, MO: Missouri Archaeological Society.
aHLer,s.A., and McMiLLan, R.B. 1976 Material culture at Rodgers Shelter: A Reflection of Past Human Ac-
tivities, in W.R. Wood and R.B.Mcmillan, eds., Prehistoricmanandhis environments.A case study in theOzark highland: 163-199.New York: Academic Press.
Barreca, F. 1978 LaSardegnafeniciaepunica. Sassari: Chiarella.Besta, E. 1982 IlCondaghediSantaMariadiBonarcado, a cura di M. Virdis. Ori-
stano: S’Alvure.Brizzi, V. 2006 La Cuspide di Tabina 1,Antrocom,OnlineJournalofAnthropology.
URL http://www.antrocom.net/mod-subjects-printpage-pageid-21-scope-all.htm
Brizzi, V. 2008 Il paradosso dell’Arciere rivisitato, Arcosophia 7: 7-13.Brizzi,v.eFerraro,e. 1991 Manualeditiroconl’arco. Milano: FIARC.BuckLey,d.H. 1981 Surfaceeffectsinadhesion,friction,wearandlubrication. Tribology
Series 5. New York: Elsevier Scientific Publishing Company.cHurcHiLL,s.e. 1993 Weapon technology, prey size selection, and hunting methods in
modern hunter-gatherers: implications for hunting in the Palaeoli-thic and Mesolithic, in G.L. Peterkin, H.M. Bricker and P.A. Mellars, eds., HuntingandanimalexploitationintheLaterPalaeolithicandMesolithicofEurasia: 11-24. Archaeological Papers of the Ameri-can Anthropological Association 4.
cottereLL,B.andkaMMinGa,J. 1979 The mechanics of flaking, in B. Hayden, ed., Lithicuse-wearanaly-
sis: 97-112.New York: Academic Press.cottereLL,B.andkaMMinGa,J. 1987 The formation of flakes, AmericanAntiquity52,4:675-708. 1990 Mechanics of pre-industrial technology. Cambridge: Cambridge
University Press.dockaLL,J.E. 1997 Wear traces and projectile impact: A review of the experimental
and archaeological Evidence, JournalofFieldArchaeology 24, 3: 321-331.
Ipotesiinterpretativesull’industrialiticadelMonteS.Vittoria-Neoneli(Or) 253
FiscHer,a.,veMMinGHansen,P.andrasMussen,P. 1984 Macro and micro wear traces on lithic projectile points, Journalof
DanishArchaeology3: 19-46.Friis-Hansen, J. 1990 Mesolithic cutting arrows: functional analysis of arrows used in the
hunting of large game, Antiquity 64: 494-5.GerManà, F. 1995 L’uomoinSardegnadalPaleoliticoall’EtàNuragica. Sassari: Carlo
Delfino Editore.HoHonoMencLaturecoMMittee 1979 The Ho Ho classification and nomenclature committee report, in B.
Hayden, ed., Lithicuse-wearanalysis: 133-135. New York: Acade-mic Press.
keeLey, L.H. e Lawrence,H. 1979 Experimentaldeterminationofstonetooluses:amicrowearanaly-
sis. Prehistoric Archaeology and Ecology Series. Chicago: Universi-ty of Chicago Press.
kooi,B.w. 1981 On the mechanics of the bow and arrow. Journal of Engineering
Mathematics 15:119-145.kooi,B.w.eBerGMan,c.a.1997.An approach to the study of ancient archery
using mathematical modelling, Antiquity 71: 124-134.Landini, R. 1990 Ilcapriolo. Bologna: Calderini.Loi, C. cds a. TestimonianzearcheologichenelterritoriodelcomunediNeoneli. cds b. Modelli di insediamento nel territorio del Barigadu, in Convegno
Nazionale Giovani Archeologi (Sassari 2006). cds c. Testimonianze prenuragiche nel Barigadu, in Atti 2° Convegno “Fe-
derico Halbherr” per i giovani archeologi (Roma 2008).MeLis, M.G. 2003 Aspetti insediativi nel Sulcis tra Neolitico ed Eneolitico: il territorio
di Villaperuccio, in StudiinOnorediErcoleContu: 83-95. Sassari: Editrice Democratica Sarda.
nieddu, M.R. 2003 Monumenti prenuragici sul Foglio 207 III NO (Salto di Lochele), in
StudiinOnorediErcoleContu: 73-81. Sassari: Editrice Democrati-ca Sarda.
odeLL,G.H.e cowan,F. 1986 Experiments with spears and arrows on animal targets, Journalof
FieldArchaeology13: 195-212.Perco, F. 1988 Ungulati. Firenze: Lorenzini. 1989 Ilcervo. Firenze: Olimpia.
C. Loi e V. Brizzi254
tiXier,J. 1974 Glossary for the description of stone tools, with special reference to
the Epipaleolithic of the Maghreb.NewsletterofLithicTechnologySpecialPublication1. San Antonio: The Center for Archaeological Research, University of Texas.
tsirk,a. 1979 Regarding Fracture Initiations, in B. Hayden ed., Lithic use-wear
analysis: 83-96.New York: Academic Press.wiLkens, B. 2003 La Fauna sarda durante l’Olocene: le conoscenze attuali, Sardinia,
CorsicaetBalearesantiqvae, InternationalJournalofArchaeology 1: 181-197.
























![[Traduzione di] Georges Bataille, La vittoria militare e la bancarotta della morale che maledice, in Symbolica e theorica. Contributi, a cura di Paolo Gregoretti, Trieste, E.U.T.,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63419e3216b404e89c032a14/traduzione-di-georges-bataille-la-vittoria-militare-e-la-bancarotta-della-morale.jpg)