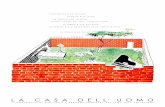Giuseppe Ciracì: la ricerca del sacro attraverso il disegno dell'uomo
Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione europea. Nuovi...
Transcript of Diritti dell'uomo e libertà economiche fondamentali nell'ordinamento dell'Unione europea. Nuovi...
Diritti dell’uomo e libertà economiche fon-damentali nell’ordinamento dell’Unione eu-ropea: nuovi equilibri?
di ROBERTO MASTROIANNI *
SOMMARIO: I. Premessa. — II. Libertà e diritti, entrambi “fondamentali” nella giurisprudenzadella Corte di giustizia. — III. L’interazione tra diritti e libertà fondamentali nella giurispru-denza in tema di mercato interno. — IV. Segue: i frutti del bilanciamento nell’ottica dellaCorte. — V. Il bilanciamento nei Trattati e nella legislazione secondaria. — VI. Segue: alcuniesempi di bilanciamento nel testo delle direttive. — VII. Conclusioni.
I. Scopo della presente riflessione è l’analisi, alla luce del nuovoart. 6 TUE come modificato dal Trattato di Lisbona e dunque della“promozione” della Carta dei diritti fondamentali nel novero dellefonti primarie dell’ordinamento dell’Unione, del rapporto intercor-rente tra diritti fondamentali e libertà economiche garantite daiTrattati 1.
Com’è noto, si tratta di una questione antica, che accompagna dasempre lo sviluppo dell’integrazione europea 2 e che in concreto si
* Testo rivisto e corredato di note della Relazione presentata al XVConvegbnoSIDI Laprotezione dei diritti fondamentali: arta dei diritti UEe standard internazionali (Bologna, 10-11giugno 2011): L’A. ringrazia i dr. Luigi Della Corte e Adriano Maffeo per il loro preziosocontributo in sede di ricerca del materiale e revisione del testo.
1 Per una visione d’insieme dell’impatto del Trattato di Lisbona sulla tutela dei dirittifondamentali nell’ordinamento dell’Unione europea cfr. i contributi di L. DANIELE, N. PARISI, A.GRANELLI, A. BULTRINI, S. AMADEO e P.L. SIMONE. pubblicati in questa Rivista, 2008, p. 645 ss.,nonché J. RIDEAU, La protection des droits fondamentaux dans l’Union europèenne. Perspectivesouvertes par le Traité de Lisbonne, in Rev. aff. eur., 2007, p. 185 ss.; I. PERNICE, The Treaty ofLisbon and Fundamental Rights, in S. GRILLER, J. ZILLER (eds.), Eu Constitutionalism without aConstitutional Treaty?, Wien/New York, 2010, p. 235 ss.; I. PINGEL, Les références a la Charte desdroit fondamentaux dans le Traité établissant une Union européenne, in Mélanges en l’honneurdu professeur Philippe Manin, Paris, 2010, p. 795 ss.; M. CARTABIA, I diritti fondamentali inEuropa dopo Lisbona: verso nuovi equilibri?, in Giorn. dir. amm., 2010, p. 221 ss.
2 C. KOMBOS, Fundamental Rights and Fundamental Freedoms: A Symbiosis on the Basisof Subsidiarity, in Eur. Public Law, 2006, p. 433; S. HENNETTE-VAUCHEZ, Les droits fondamentauxà Luxembourg. Droit et politique dans la determination des contours de l’office du juge, inMélanges Manin, cit., p. 775 ss.; N NIC SHUIBHNE, Margins of appreciation: national values,Fundamental Rights and Ec Free Movement Law, in European Law Rev., 2009, p. 230 ss.
Il Diritto dell’Unione Europea - 2/2011
presenta con diverse sfaccettature coinvolgendo il legislatore del-l’Unione, quello nazionale, i giudici interni e, soprattutto, la Corte digiustizia. Se molto è cambiato da quando negli anni sessanta il sig.Erich Stauder 3 si lamentava della violazione del suo diritto allaprivacy — a suo parere provocata da una decisione della Commis-sione che imponeva di divulgare il suo nome per accedere ad alcunivantaggi sociali — o da quando, qualche anno dopo, la sig.ra Lise-lotte Hauer 4 protestava per gli effetti che i regolamenti comunitarivolti alla instaurazione del mercato interno dei prodotti agricoliproducevano sui suoi diritti di proprietà e di iniziativa privata, laquantità e l’importanza degli interventi dell’Unione in settori legatial cuore della sovranità statale comportano che sia tutt’altro che rarorinvenire ancora oggi, nelle pronunce della Corte, la questione deli-catissima del bilanciamento tra le libertà economiche e diritti fon-damentali.
In questa sede non si intende ripercorrere questo cammino 5, nécadere nella tentazione di dare giudizi su vere o presunte “preva-lenze” degli uni sulle altre o viceversa. Si eviterà, quindi, una rico-struzione “rigida”, tendente a porre in evidenza la contrapposizionetra i detti valori, per tentarne una più ampia, che sottolinei evalorizzi la condizione di sostanziale equilibrio di cui libertà e dirittifondamentali godono nell’ordinamento dell’Unione.
II. In avvio di discorso, va tenuto in debito conto il ruolo che lelibertà fondamentali del mercato interno rivestono nell’ordinamentodell’Unione. É appena il caso di ricordare che le c.d. quattro libertàsono l’essenza stessa del mercato interno (art. 26 TFUE), la cuiinstaurazione è a sua volta tra i principali obiettivi del Trattato (art.3, comma 3, TUE). Il mercato interno può concretamente realizzarsisoltanto se ai fattori produttivi è consentito di circolare senza inde-bite restrizioni provocate da norme o prassi nazionali 6. Quanto alla
3 Corte giust. 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, in Racc., p. 419.4 Corte giust. 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, in Racc., p. 3727.5 Per una ricostruzione d’insieme sono ancora attuali le valutazioni di G. STROZZI, La
tutela dei diritti fondamentali tra diritto comunitario e ordinamento degli Stati membri, in Scrittidegli allievi in memoria di Giuseppe Barile, 1995, p. 579 ss.; sia consentito inoltre il rinvio a R.MASTROIANNI , Il contributo della Carta europea alla tutela dei diritti fondamentali nell’ordina-mento comunitario, in Cass. Pen., 2002, p. 261 ss. Per gli sviluppi più recenti si vedano L.DANIELE, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e Trattato di Lisbona, in Liber FaustoPocar, Milano, 2009, p. 235 ss. e L.S. ROSSI, How Fundamental Are Fundamental Principles?Primacy of the EU Law, Principles of National Constitutions and Fundamental Rights afterLisbon, ivi, p. 801 ss.
6 Cfr. V. SKOURIS, Fundamental Rights and Fundamental Freedoms: The Challenge ofStriking a Delicate Balance, in Eur. Rev. Business Law, 2006, p. 225. L’importanza della libera
Dottrina320
Corte di giustizia, questa non svolgerebbe in pieno il suo ruolo digarante del rispetto del diritto dell’Unione, attribuito oggi dall’art.19, comma 2, TUE, se non tenesse in debita considerazione leesigenze di integrazione in sede di interpretazione ed applicazionedelle regole dei Trattati 7. É stata la Corte, infatti, a riconoscereefficacia diretta alle disposizioni che tutelano le libertà del mercatointerno, nonché ad inserire nel divieto di restrizioni anche le misurestatali non discriminatorie — risultato in verità non scontato allaluce del testo del Trattato — nonché le regole poste da statuti diassociazioni 8 e da negozi conclusi tra privati 9. In breve, nell’otticadella Corte di giustizia le libertà del mercato interno sono talmente“fondamentali” per le esigenze di integrazione da non consentirel’applicazione di alcuna regola de minimis nello scrutinio delle re-strizioni statali alla libera circolazione 10, e da essere qualificatecome “norme imperative” ai fini della valutazione di clausole con-trattuali 11. Se è vero che lo stesso Trattato consente agli Statimembri l’adozione di misure in deroga ai divieti di restrizioni allelibertà del mercato interno, è noto che nella giurisprudenza dellaCorte le disposizioni in questione sono interpretate ed applicate inmaniera restrittiva 12.
È altrettanto evidente che, allo stato attuale dell’integrazione,anche i diritti fondamentali dell’uomo ed il loro rispetto rivestono un
circolazione dei fattori produttivi per il buon funzionamento del mercato interno è sistema-ticamente e fermamente ribadita dalla Corte di giustizia: ex multis, cfr. Corte giust. 29 aprile2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01, Orfanopoulos c. Land Baden-Württemerg, in Racc., p.I-5257, punto 62 e ss.
7 A. TIZZANO, Qualche riflessione sul contributo della Corte di giustizia allo sviluppo delsistema comunitario, in questa Rivista, 2009, p. 141 ss.
8 Circa l’incidenza delle regole poste da statuti di associazioni e regolamenti, è suffi-ciente far riferimento ad alcune pronunce della Corte di giustizia in tema di sport: Corte giust.15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, in Racc., p. I-04921; 18 luglio 2006, causaC-519/04, Meca-Medina e Majcen, ivi, p. I-6991; 16 marzo 2010, causa C-325/08, Bernard, nonancora pubblicata.
9 Corte giust. 6 giugno 2000, causa C-281/98, Angonese, in Racc. , p. I-413910 Ad esempio, in Corte giust. 1º aprile 2008, causa C-212/06, Gov. Comunità francese e
Gov. Vallone c. Gov. Fiammingo (in Racc., p. I-1683), al punto 52, si legge: «[p]er quantoriguarda l’argomento del Governo fiammingo volto a sostenere che detta normativa, comun-que, avrebbe un’incidenza marginale sulla libertà di circolazione, in considerazione dell’esi-guità dell’importo delle prestazioni di cui è causa e del numero di persone interessate, èsufficiente osservare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, gli articoli delTrattato relativi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitalicostituiscono norme fondamentali per la Comunità e che è vietato ogni ostacolo a questalibertà, anche se di minore importanza». In tal senso anche 13 dicembre 1989, causa C-49/89,Corsica Ferries, in Racc., p. I-4441, punto 8 e 10 febbraio 2000, causa C-169/98, Commissionec. Francia, ivi, p. I-1049, punto 46.
11 Corte giust. 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarket, in Racc., p. 181.12 Per un approccio d’insieme cfr. C. BARNARD, Substantive Law of the European Union,
III ed., Oxford, 2010, p. 460 ss.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 321
ruolo basilare nell’ordinamento dell’Unione. Se in un primo mo-mento, con l’intento di affermare e difendere l’autonomia del si-stema comunitario rispetto agli ordinamenti nazionali, la Corte digiustizia aveva dichiarato la propria incompetenza a vagliare lacompatibilità delle norme comunitarie con le Costituzioni degli Statimembri 13, ben presto, una volta “internalizzato” il meccanismo diprotezione, il suo atteggiamento è mutato in favore di una tutelaintensa dei diritti. Testimoniano tale tendenza le sentenze Stauder 14
e Internationale Handelsgesellschaft 15, in cui la Corte ha ribadito lasua intenzione di assolvere alla funzione di tutela dei diritti fonda-mentali, sia pure nei limiti della loro compatibilità con la struttura ele finalità della Comunità, individuando il fondamento del propriointervento nei principi generali del diritto, intesi, sebbene rilevatisulla base delle tradizioni costituzionali comuni ai vari Stati mem-bri 16 e dei trattati internazionali che li vincolano, quale fonteautonoma del diritto comunitario.
È noto che, successivamente, questo approccio ha ottenutopieno riconoscimento nel diritto primario dell’Unione, nel quale sirinviene oggi che tra i valori fondanti dell’Unione rientra a pienotitolo il principio del “rispetto dei diritti umani” (art. 2 TUE). L’art.6 TUE, a sua volta, enuncia le varie fonti (la Carta dei dirittifondamentali, i principi generali del diritto tratti dalle tradizionicostituzionali comuni e dalla CEDU, in prospettiva la stessa CEDUcome fonte “interna” dell’ordinamento a seguito dell’adesione) dallequali si ricavano i diritti umani vincolanti l’Unione.
Quanto alla giurisprudenza della Corte, può ritenersi che ad oggiil momento più alto del suo percorso si sia raggiunto nella sentenzaKadi 17, del 3 novembre 2008, in cui essa sembra voler attribuire aidiritti fondamentali un ruolo apicale, tale da poter fungere da argine
13 Corte giust. 4 febbraio 1959, causa 1/58, Stork, in Racc., 1958/59, p. 41.14 Corte giust. 12 novembre 1969, Stauder, causa 29/69, in Racc., p. 419.15 Corte giust. 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, in
Racc., p. 1170.16 Corte giust. 14 maggio 1974, Nold, causa 4/73, in Racc., p. 491. Cfr. A. TIZZANO, La
Corte di giustizia delle Comunità europee e i diritti nazionali, in questa Rivista, 2005, p. 839 ss17 Corte giust. 3 novembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al
Barakaat International Foundation, in Racc., p. I-6351. Per commenti v. M. BENLOLO-CARABOT, LaCJCE et la protection des valeurs fondamentales de l’ordre juridique communautaire, in Rev.mar-ché commun Union europ., 2009 p. 380 ss.; M. BEULAY, Les arrêts Kadi et Al Barakaat Interna-tional Foundation. Raffirmation par la Cour de justice de l’autonomie de l’ordre juridiquecommunautaire vis-à-vis du droit international, in Rev.marché commun Union europ., 2009 p.32 ; J.-P. JACQUÉ, Primauté du droit international versus protection des droits fondamentaux, inRev. trim. droit europ., 2009, p. 161 ss.; O. POLLICINO, V. SCIARABBA, Lotta al terrorismo, diritti eprincipi fondamentali, rapporti tra ordinamenti: un importante capitolo della giurisprudenza″costituzionale″ europea, in Dir. pubbl. comp. europeo, 2009, p.159 ss.
Dottrina322
anche rispetto alle conseguenze prodotte dall’applicazione di dispo-sizioni del Trattato: essa ha infatti sostenuto che gli artt. 307 CE(oggi 351 TFUE) e 297 CE (oggi 347 TFUE), se possono in linea diprincipio «consentire deroghe al diritto primario», tuttavia «nonpossono essere intese nel senso che autorizzano una deroga aiprincipi di libertà, di democrazia nonché di rispetto dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali sanciti dall’art. 6, n. 1, TUEquale fondamento dell’Unione. L’art. 307 CE — continua la Corte —non potrebbe in alcun caso consentire di mettere in discussione iprincipi che fanno parte dei fondamenti stessi dell’ordinamentogiuridico comunitario, tra i quali quello della tutela dei diritti fon-damentali, che include il controllo, ad opera del giudice comunita-rio, della legittimità degli atti comunitari quanto alla loro confor-mità a tali diritti fondamentali» 18.
Anche in questo caso, peraltro, è utile effettuare alcune precisa-zioni in merito all’effettiva portata dei diritti fondamentali garantitidall’ordinamento dell’Unione. In effetti, anche nella prassi succes-siva all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte ha ricono-sciuto che, a determinate condizioni, sono consentite restrizioni allelibertà fondamentali tutelate dall’ordinamento dell’Unione: ad esem-pio, nella sentenza Alassini, con riferimento al diritto alla tutelagiurisdizionale, la Corte ha affermato che anche «i diritti fondamen-tali non si configurano come prerogative assolute, ma possonosoggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effetti-vamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura dicui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, unintervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanzastessa dei diritti così garantiti» 19. La medesima soluzione si rinvieneall’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea 20.
18 Sentenza Kadi, cit., punti 303 e 304.19 Corte giust. 18 marzo 2010, cause riunite C-317-320/08, Alassini e a, non ancora
pubblicata in Racc., punto 63. V. anche, rispetto al principio di tutela della proprietà, Trib. UE
17 febbraio 2011, causa T-386/07, FIFA c. Commissione, non ancora pubblicata in Racc., punto139.
20 La disposizione della Carta citata nel testo riconosce, infatti, che possano essereapportate limitazioni all’esercizio dei diritti ivi elencati, purché tali limitazioni siano previstedalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principiodi proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generalericonosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Per un’appli-cazione recente di questa disposizione nella giurisprudenza del giudice dell’Unione cfr. Cortegiust. 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Schecke e Eifert, non ancorapubblicata, punti 43 ss., in cui la Corte, all’esito di un’operazione di bilanciamento tra leesigenze di trasparenza nella pubblicazione di informazioni sulle persone fisiche beneficiariedei fondi FEOGA e FEASR, da un lato, e del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali,
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 323
Ciò non deve tuttavia sorprendere: non solo perché il medesimoapproccio, con l’eccezione dei diritti ritenuti assoluti, è proprioanche della giurisprudenza della Corte di Strasburgo 21, ma ancheperché non costituisce certo una novità l’esigenza di contempera-mento ed armonizzazione di diritti fondamentali con altri interessigenerali, riconosciuti dall’ordinamento di riferimento come essen-ziali per la sua stessa sopravvivenza. Nella sentenza sul falso inbilancio 22, ad esempio, relativa ad un caso di successione di leggipenali nel tempo, la Corte si è dimostrata pronta a sacrificare ildiritto (pur riconosciuto come fondamentale) dell’applicazione re-troattiva della lex mitior sull’altare della primauté del diritto del-l’Unione. Si tratta, in definitiva, di un modo in cui un ordinamentotenta di “difendersi”, per così dire, allo scopo di garantire il raggiun-gimento di alcuni fini ritenuti essenziali. Questo è il caso anchedell’ordinamento dell’Unione europea, che trae una delle sue prin-cipali ragion d’essere, una delle sue “caratteristiche specifiche”, nellagaranzia di alcune libertà fondamentali che solo con uno sguardosuperficiale si possono ancora qualificare come meramente “di mer-cato”. La garanzia del loro rispetto è essenziale per la tenuta stessadell’ordinamento, ma deve ovviamente fare i conti con le esigenze ditutela dei diritti fondamentali. Il contemperamento di queste esi-genze non può non essere compito, in ultima analisi, delle Corti, inparticolare della Corte di giustizia, la quale a sua volta, come dimo-strato dalle conclusioni raggiunte in Laval 23 e Rüffert 24, apparerispettosa delle scelte di bilanciamento effettuate dal legislatoredell’Unione.
Ora, è vero che, in assenza di un “catalogo di diritti” di riferi-mento, la Corte è apparsa disporre di un’amplissima libertà nell’in-dividuazione dei diritti fondamentali e dei loro confini. Secondo
dall’altro, dichiara l’invalidità degli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento (CE) delConsiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune,come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, ed ilregolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazionedel regolamento (CE) n. 1290/2005
21 Per un esempio, si segnala Corte EDU 21 novembre 2001, Fogarty c. Regno Unito, inRecueil des arrêts et décisions, 2001, XI, par. 33. In merito alla individuazione, anche nell’or-dinamento dell’Unione, di diritti fondamentali “assoluti”, in quanto tali non suscettibili dideroghe, v. A. TANCREDI, L’emersione dei diritti fondamentali “assoluti” nella giurisprudenzacomunitaria, in Riv. dir. int., 2006, p. 644.
22 Corte giust. 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi ealtri, in Racc., p. I-3565, punto 72.
23 Corte giust. 18 dicembre 2007, causa C-341/05, Laval und Partneri, in Racc., p.I-11767.
24 Corte giust. 3 aprile 2008, causa C-346/06, Rüffert, in Racc., p. I-1989.
Dottrina324
alcuni autori 25 in alcune occasioni la Corte ha dimostrato pocaattenzione alla tutela dei diritti sociali, privilegiando una letturavolta alla maggiore tutela delle libertà di mercato. Di certo, quelloche si può dire è che la Corte ha talvolta svolto una ricostruzione deidiritti in maniera che appare (quanto meno all’esterno) frettolosa,senza un’indagine accurata, in particolare quando ha inteso ricor-rere alla categoria delle “tradizioni costituzionali comuni” per laricostruzione di un nuovo diritto fondamentale 26. Più in generale, lacritica da molti avanzata 27 è che la Corte abbia scelto di volta involta in maniera strumentale la “better law” per il raggiungimentodel suo scopo principale di difesa delle caratteristiche proprie del-l’ordinamento dell’Unione europea 28. Ciò appare ulteriormente di-mostrato dalla circostanza che, anche laddove siano in gioco dirittifondamentali, nelle sentenze della Corte il percorso è agevole se siintende accertare la presenza di una restrizione alle libertà econo-miche fondamentali, molto più arduo se si tratta di giustificarne unarestrizione. È tuttavia da chiedersi se sia lecito aspettarsi un cam-biamento dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel sensoche la Corte potrebbe deviare dal suo percorso tradizionale e nonsostenere, quando sono coinvolti i diritti fondamentali, che le dero-ghe alle libertà del mercato interno debbono essere interpretaterestrittivamente (v. infra, par. 6).
III. L’analisi delle pronunce relative al funzionamento del mer-cato interno dimostra che la Corte, sia pure ricorrendo, per i motiviche si diranno più avanti, ad un meccanismo di tutela indiretta e, percosì dire, incidentale, è pervenuta al riconoscimento ed alla tutela di
25 Cfr. in tal senso di recente F. SORRENTINO, I diritti fondamentali in Europa dopo Lisbona(considerazioni preliminari), in Corr. giur., 2010, p. 145 ss. Ma la critica viene da lontano: v. ades. J. COPPEL, A. O’NEILL, The European Court of Justice: Taking rights seriously?, in CommonMarket Law Rev., 1992, p. 669 ss.
26 Ad esempio, per l’applicazione della lex mitior in caso di successione nel tempo dileggi penali, nella sentenza Berlusconi, cit., l’unico riferimento normativo è una disposizionedel codice penale italiano. Cfr. A. BIONDI, R. MASTROIANNI, Comment to case C-387/02, Berlusconiand others, in Common Market Law Rev., 2006, p. 553 ss.
27 V. G. GAJA, Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamentocomunitario, in Riv. dir. int., 1988, p. 574 ss.
28 Va certo aggiunto in proposito che più di recente la costante citazione della CEDU edella giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha reso molto meno “imprevedibili” i risultatifinali, elemento che non potrà non rinforzarsi grazie alla presenza di un catalogo tutto“interno” dei diritti fondamentali. In merito all’applicazione diretta della Carta di Nizza siveda, tra le pronunce più recenti, Corte giust. 14 ottobre 2010, causa C-243/09, Fu§, nonancora pubblicata in Racc., punto 66, mentre per una citazione “congiunta” della Carta e dellaCEDU con riferimento al medesimo diritto fondamentale (rispetto della vita privata e familiare)si veda tra le altre Corte giust. 22 novembre 2010, causa C-145/09, Tsakouridis, non ancorapubblicata nella Racc., punto 52.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 325
numerosi diritti fondamentali tra i quali, a titolo esemplificativo, lalibertà di espressione e di informazione 29, la libertà di circolazionee di associazione 30, la non discriminazione in ragione del sesso 31 ela libertà di religione 32. Più in dettaglio, appare utile, ai nostri fini,valutare la crescente attenzione dimostrata dalla Corte per la prote-zione dei diritti fondamentali nella sua giurisprudenza relativa allalibera circolazione dei servizi. A partire dal caso ERT 33 del 1991,attraverso la pronuncia Carpenter 34 del 2002 (ma passaggi altret-tanto significativi si rinvengono in materia di circolazione dellemerci, come nel caso delle sentenze Schmidberger 35 e Karner 36), finoad arrivare alla sentenza Omega 37 dell’ottobre 2004 e più di recentealle decisioni in tema di azioni collettive dei lavoratori del 2007 38, laCorte ha infatti tentato di rinvenire un giusto equilibrio tra esigenzedi tutela che, nella fattispecie portata alla sua attenzione, apparivanocontrastanti, quali, da un lato, la protezione dei diritti umani e,dall’altro, il rispetto della libertà di prestazione dei servizi. In questocontesto, le pronunce della Corte possono a grandi linee esserericondotte a due tipologie di casi.
I — Nella prima, in cui figura ad esempio la citata sentenza ERT,i diritti dell’uomo vengono in rilievo come limiti alla possibilità degliStati membri di impedire o ostacolare, in applicazione di una dellederoghe previste dal Trattato, una libertà economica fondamentale.La loro protezione è qui incidentale e funzionale alla libertà econo-mica in questione, nella specie la libertà di prestazione dei servizi,nei confronti dell’invocazione di poteri residui pure riconosciuti agliStati membri dai Trattati. In base a tale impostazione, alla luce deldiritto fondamentale della libertà di informazione, tratto dall’art. 10CEDU (ed oggi dall’art. 11 della Carta), la Corte di giustizia haritenuto di poter sindacare le misure adottate dallo Stato greco atutela del monopolio riconosciuto ad un’emittente televisiva pub-blica. I diritti dell’uomo, dunque, vengono in tal modo in rilievocome limite aggiuntivo imposto agli Stati nell’esercizio della facoltà
29 Corte giust. 25 luglio 1991, causa C-288/89, Gouda, in Racc., p. I-4007; 5 ottobre 1994,causa C-23/93, TV 10, ivi, I-4795.
30 Corte giust. 8 ottobre 1974, causa 18/74, Syndacat général, in Racc., p. 933; 28 ottobre1975, causa 36/75, Rutili, ivi, 1219; 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, ivi, p. 4097.
31 Corte giust. 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne, in Racc., p. 365.32 Corte giust. 27 ottobre 1976, causa 130/75, Prais, in Racc., p. 1589.33 Corte giust. 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, in Racc., p. I-2925.34 Corte giust. 11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter, in Racc., p. I-6279.35 Corte giust. 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, in Racc., p. I-5659.36 Corte giust. 25 marzo 2004, causa C-71/02, Karner, in Racc., p. I-3025.37 Corte giust. 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega, in Racc., p. I-9609.38 Sentenze Laval e Viking Lines, cit.
Dottrina326
loro riconosciuta di apporre restrizioni alle libertà fondamentaligarantite dal Trattato.
Allo stesso modo, sia pure con un percorso in parte diverso, laCorte ha ritenuto contrario all’art. 49 CE (oggi art. 56 TFUE) ilprovvedimento di espulsione per mancato rinnovo del visto dellasig.ra Carpenter, cittadina filippina e coniuge di un prestatore diservizi comunitario. E ciò perché il provvedimento rappresentavaun’ingerenza all’esercizio del diritto al rispetto della vita familiarenon proporzionata all’obiettivo di salvaguardia dell’ordine pubblicoe della pubblica sicurezza 39.
A questo filone giurisprudenziale possono essere in parte acco-munate le sentenze, particolarmente numerose, in cui i diritti fon-damentali trovano riconoscimento come parametro di legittimità delcomportamento del legislatore nazionale anche in tutti gli altri casiin cui questo si muova nel cono d’ombra (di certo sempre più ampio,ma non totalizzante come sembrano sostenere alcune pronunce deinostri giudici 40 e parte della dottrina) del diritto dell’Unione, come
39 Sentenza Carpenter, cit., della quale è utile riprodurre i punti 40 — 45: « (...) si deverilevare che uno Stato membro può addurre motivi di interesse generale al fine di giustificareuna misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera prestazione dei servizi soloqualora tale misura sia conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto(v., in questo senso, Corte giust. 18 giugno 1991, causa C-260/89, Ert, Racc., p. I-2925, punto43, e 26 giugno 1997, causa C-368/95, Familiapress, Racc., p. I-3689, punto 24). La decisionedi espellere la sig.ra Carpenter costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto del sig.Carpenter al rispetto della sua vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione per lasalvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre1950 (in prosieguo: la «Convenzione»), il quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondola giurisprudenza costante della Corte, riaffermata inoltre nel preambolo dell’Atto unicoeuropeo e dall’art. 6, n. 2, TUE, sono tutelati nell’ordinamento giuridico comunitario. Benchéla Convenzione non garantisca, a favore di uno straniero, alcun diritto ad entrare o risiederenel territorio di un paese determinato, l’esclusione di una persona da un paese in cui vivonoi suoi congiunti può rappresentare un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare cometutelato dall’art. 8, n. 1, della Convenzione. Una simile ingerenza viola la Convenzione a menoche essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso articolo, cioè a meno che essanon sia «prevista dalla legge», dettata da uno o più scopi legittimi ai sensi della disposizionecitata e «necessaria, in una società democratica», cioè giustificata da un bisogno socialeimperativo e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito (v., in particolare, CorteEDU 2 agosto 2001, Boultif c. Suisse, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, § 39, 41 e 46). Ladecisione di espellere la sig.ra Carpenter presa in circostanze quali quelle di cui alla causaprincipale non rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, cioè, da un lato, il dirittodel sig. Carpenter al rispetto della sua vita familiare e, dall’altro, la salvaguardia dell’ordinepubblico e della pubblica sicurezza. (...) Conseguentemente, la decisione di espellere la sig.raCarpenter costituisce un’ingerenza non proporzionata allo scopo perseguito». Per un com-mento cfr. E. SPAVENTA, From Gebhard to Carpenter: Towards a (non) economic constitution, inCommon Market Law Rev., 1004, p. 767 ss.
40 Per alcuni esempi di questo approccio non corretto si vedano Cass civ., I sez., 22settembre 2008, n. 23934 , in materia di patronimico; Cass. civ., III sez., 2 febbraio 2010, n.2352 del, in materia di “danno alla professionalità”; Cons. Stato 2marzo 2010, n. 1220 , inmateria di espropriazione di pubblica utilità.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 327
ad esempio qualora si tratti di dare attuazione a direttive dell’Unioneo comunque a disciplinare una materia da queste coperta 41.
II — Nella seconda categoria, in cui rientra tra gli altri la citatasentenza Omega, la protezione dei diritti umani è invece più tradi-zionalmente promossa dagli Stati membri come “scudo” nei con-fronti dell’applicazione delle disposizioni del Trattato che proteg-gono le libertà del mercato interno. In altri termini, accertatal’esistenza della restrizione alla libertà in discorso, la Corte valuta sequesta possa essere giustificata dall’esigenza di proteggere un dirittofondamentale.
A questo proposito, la sentenza Omega è interessante per diversimotivi. In primo luogo, essa specifica che «l’ordinamento comuni-tario è diretto innegabilmente ad assicurare il rispetto della dignitàumana quale principio generale del diritto», e chiarisce anche che atale proposito non ha alcun rilievo la circostanza che «in Germaniail principio del rispetto della dignità umana benefici di uno statusparticolare in quanto diritto fondamentale autonomo» 42. Inoltre, intale pronuncia la Corte afferma esplicitamente che «poiché il ri-spetto dei diritti fondamentali si impone sia alla Comunità che aisuoi Stati membri, la tutela di tali diritti rappresenta un legittimointeresse che giustifica, in linea di principio, una limitazione degliobblighi imposti dal diritto comunitario, ancorché derivanti da unalibertà fondamentale garantita dal Trattato quale la libera presta-zione dei servizi» 43.
Ampio è poi il margine di valutazione del giudice nazionalequanto alla necessità e proporzionalità della misura restrittiva ri-spetto al fine perseguito. La sussistenza di tali condizioni non èesclusa per il solo fatto che uno Stato membro ha scelto un regimedi tutela diverso da quello di un altro Stato membro 44. Significativoè in proposito il passaggio in cui la Corte ricorda che «secondo ilgiudice del rinvio il divieto di sfruttamento commerciale di giochiche comportano la simulazione di atti di violenza contro persone, inparticolare la rappresentazione di omicidi, corrisponde al livello ditutela della dignità umana che la Costituzione nazionale ha intesoassicurare sul territorio della Repubblica federale di Germania» 45. È
41 Cfr. Corte giust. 13 luglio 1989, causa C-5/88, Wachauf, in Racc., p. 2609, nonché,nella copiosa giurisprudenza successiva, ord. 26 marzo 2009, causa C-535/08, Pignataro, ivi, p.I-50.
42 Sentenza Omega, cit., punto 34.43 Sentenza Omega, cit., punto 35.44 Sentenza Omega, cit., punti 37 e 38.45 Sentenza Omega, cit., punto 39.
Dottrina328
un esplicito rimando alla percezione che del diritto fondamentale siha nello specifico Stato membro, in particolare quanto alla natura ealla portata di tale diritto, laddove, come nel caso di specie, nonesiste negli Stati membri un’identica sensibilità, un comune sentireriguardo tale diritto fondamentale 46.
Scorrendo le pronunce che rientrano in questa categoria, si puòin definitiva notare che la Corte di giustizia non ha mai tracciato unagerarchia netta tra diritti umani e libertà fondamentali, ricono-scendo sempre la possibilità che, nel rispetto del principio di pro-porzionalità 47, gli uni e gli altri incontrino deroghe e limiti nelrispetto di altri interessi parimenti meritevoli di tutela, da identifi-carsi di volta in volta 48. Ad ogni modo, il bilanciamento di interessiconfliggenti — tecnica tipica, peraltro, delle Corti costituzionali —nel contesto di pronunce pregiudiziali è stato realizzato spessomediante il rinvio al giudice nazionale della valutazione ultima delcaso di specie: rinvio a volte più formale che reale, preoccupandosila Corte di giustizia di fornire una serie di indicazioni capaci dilimitare, se non ad eliminare del tutto, il raggio d’azione del giudicenazionale nella soluzione del caso concreto 49 .
Dai menzionati filoni giurisprudenziali emerge un dato, menoappariscente ma estremamente interessante ai fini di questa inda-gine: in diversi casi, è proprio l’invocazione delle libertà del mercatointerno a veicolare, per così dire, il rispetto dei diritti fondamentali.Nessun contrasto, dunque, piuttosto una “sinergia” tra libertà ediritti, i quali insieme contribuiscono a raggiungere risultati utili siaai fini del buon funzionamento del mercato e dunque dell’integra-
46 Va infine evidenziato che nel caso Omega (sentenza cit., punti 32 e 36) la misurarestrittiva della libera circolazione dei servizi viene giustificata non in base alla tutela delladignità umana come motivo autonomo di giustificazione, ma pur sempre in base all’eccezionedell’ordine pubblico minacciato dall’attività economica contraria alla dignità umana secondola concezione prevalente nell’opinione pubblica tedesca; il medesimo approccio, nel contestodella disciplina della cittadinanza europea e dei suoi rapporti con le esigenze di tutela deivalori costituzionali nazionali, cfr. la più recente Corte giust. 22 dicembre 2010, causaC-208/09, Sayn-Wittgenstein, non ancora pubblicata in Racc. Sempre seguendo il medesimopercorso, ma facendo leva, questa volta, sulle deroghe pretorie dei motivi imperativi diinteresse generale, la Corte, nella pronuncia Arblade, è giunta a giustificare restrizioni allalibera prestazione di servizi consistenti nell’obbligo imposto dallo Stato membro ospitanteall’impresa — che distacchi lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizio — di teneredocumenti sociali e di lavoro sebbene sia già soggetta, nello Stato di stabilimento, ad obblighiequiparabili. Per tale via, ancora indirettamente, è stata, quindi, offerta tutela ai diritti socialidei lavoratori (Corte giust. 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, Arblade e a,in Racc., p. I-8453, punto 51)..
47 V. le Conclusioni dell’AG Trstenjak del 14 aprile 2010 nella causa C-271/08, Commis-sione c. Germania, non ancora pubblicate.
48 In questo senso anche M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione europea,cit., p. 42 ss.
49 Si veda per tutte la sentenza Viking Line, cit., punti 80 e ss.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 329
zione europea, sia a quelli della tutela piena dei diritti. In tale otticapossono essere riconsiderate le sentenze in materia televisiva deglianni ottanta, in cui l’esercizio della libera prestazione dei servizi infattispecie transfrontaliere è visto dalla Corte come espressione deldiritto, tutelato dall’art. 10 CEDU, di diffondere informazioni senzaconsiderazioni di frontiera, nonché la citata sentenza Carpenter, conla quale, tramite il riconoscimento della contrarietà all’art. 49 TCE(ora 56 TFUE) del provvedimento di espulsione comminato per ilmancato rinnovo del permesso di soggiorno ad una cittadina filip-pina, coniuge di un prestatore di servizi comunitario, la Corte ha,indirettamente, tutelato il diritto fondamentale dell’unione familiare(oggi riconosciuto agli artt. 7 e 33 della Carta) 50. Lo stesso afflato diprotezione dell’unione familiare è possibile cogliere nella pronunciaZhu e Chen 51 in cui la Corte ha riconosciuto la possibilità per unminore, cittadino di uno Stato membro, e per il suo genitore,cittadino di uno Stato terzo, che ne abbia la custodia, di beneficiaredella libertà di circolazione per spostarsi all’interno della Comunitàed ottenere un permesso di residenza di lungo termine in un altroStato membro. Così, ancora, nella nutrita saga delle sentenze rela-tive alle prestazioni sanitarie in Paesi diversi da quello in cui si èiscritti ad un regime di assistenza sanitaria (da Kohll 52e Decker 53 aVanbraekel 54, ad Elchinov 55): la Corte, facendo leva sul diritto aricevere servizi medici o oculistici in un altro Stato membro, hariconosciuto ai cittadini comunitari la possibilità di ottenere dalloStato membro in cui sono stabiliti il rimborso delle spese sostenuteper prestazioni sanitarie rese da una struttura ospedaliera di un altroStato membro, qualora i tempi di attesa per ottenere la medesimaprestazione nello Stato di stabilimento, tenuto conto della situazioneclinica e della possibile evoluzione della malattia, fossero eccessivi.
Se si tiene da parte per il momento quest’ultimo elemento, deveessere riconosciuto che ciò che accomuna le categorie prima citate èla tendenza a tutelare i diritti fondamentali in modo “implicito edindiretto”, come una deroga alle libertà fondamentali previste dal
50 È stato efficacemente dimostrato che l’attenzione verso la tutela della vita familiaresi rinviene da tempo nella giurisprudenza della Corte: cfr. S. NINIATTI, Il diritto alla vita familiareall’esame della Corte di Giustizia, in M. CARTABIA, I diritti in azione, cit., 239 ss. Corte giust. 25luglio 2008, causa C-127/08, Metock, in Racc., p. I-6241 né è una recente dimostrazione, cosìcome, nel contesto — divenuto oggi davvero amplissimo — della cittadinanza europea, Cortegiust. 8 marzo 2011, causa C-34/09, Ruiz Zambrano, non ancora pubblicata.
51 19 ottobre 2004, causa C-200/02, in Racc., I-9925.52 Corte giust. 28 aprile 1998, causa C-158/96, in Racc., I-01931.53 Corte giust. 28 aprile 1998, causa C-120/95, in Racc., I-1831.54 Corte giust. 12 giugno 2001, causa C-368/98, in Racc., I-5363.55 Corte giust. 5 ottobre 2010, causa C-173/09, non ancora pubblicata.
Dottrina330
Trattato. Prescindendo per ora dai singoli risultati, quanto ora dettonon comporta, quanto meno in linea di principio, ipotizzare unaminore attenzione per i diritti fondamentali rispetto alle libertàfondamentali o addirittura una collocazione di quest’ultimi in posi-zione di inferiorità (dal punto di vista del rango normativo) rispettoalle libertà del Trattato 56: è la “struttura” del meccanismo di appli-cazione delle regole sulle libertà fondamentali sul mercato interno, edunque in definitiva i limiti apposti dal Trattato alle competenzedell’Unione, a richiedere alla Corte un percorso argomentativo cheparte dall’accertamento della presenza o meno, in un determinatointervento statale, di una restrizione delle libertà del Trattato, perpoi chiedersi se detta restrizione possa essere giustificata in quantofinalizzata a tutelare valori o diritti fondamentali 57.
Né appare giustificato ipotizzare una minore attenzione allatutela di diritti fondamentali nell’ambito dell’ordinamento del-l’Unione rispetto a sistemi internazionali quali quello della CEDU:un’analisi attenta potrebbe facilmente smentire questo assunto. Daun lato, infatti, la Carta dei diritti fondamentali, all’art. 52, par. 1, èchiarissima nel precisare che «laddove la presente Carta contengadiritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europeaper la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferitidalla suddetta convenzione» 58. Resta fermo tuttavia che, come lastessa CEDU non solo consente, ma anzi promuove, «la presentedisposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda unaprotezione più estesa». Dall’altro, nel sistema della CEDU non sirinvengono diritti quali, ad esempio, il diritto alla protezione dellasalute che, come dimostra la giurisprudenza citata nonché la suainclusione nella Carta dei diritti fondamentali, trovano invece tutelanell’ordinamento dell’Unione. Non è, quindi, azzardata l’afferma-zione secondo cui, quanto meno dal punto di vista dell’ampiezza del
56 Per un esame circa la collocazione dei principi fondamentali nell’ambito dell’ordi-namento UE, v. Corte giust. causa C-294/83, Parti ecologiste “Les Verts” c. Parlamento europeo,in Racc., p. I-1017. In tema di impugnazione di atti dell’Unione diversi dai regolamenti perviolazione dei diritti fondamentali cfr. Corte giust. 27 febbraio 2007, causa C-355/04 P, Segi ea., ivi,p. I-1657. Per una collocazione di principi fondamentali e norme del Trattato come fontidi pari grado v. anche T. TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, 2ª ed., Oxford, 2006, nonchéK. LENAERTS — J.A. GUTIÉRREZ-FONS, The Constitutional Allocation of Powers and General Princi-ples of EU Law, in Common Market Law Rev., 2010, p. 1269 ss.
57 In questo senso V. SKOURIS, Fundamental Rights and Fundamental Freedoms, cit. p.237. V. anche più in generale B. DE WITTE, Non-market values in internal market legislation, inN NIC SHUIBHNE (ed.), Regulating the internal market, Cheltenham, 2006, p. 68.
58 Per una recente applicazione di questa regola cfr. la sentenza 5 ottobre 2010, causaC-400/10 PPU, J.McB, non ancora pubblicata.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 331
novero dei diritti fondamentali tutelati, il sistema dell’Unione offremaggiori garanzie rispetto al sistema CEDU 59.
IV. (Segue). Come è stato esattamente segnalato 60, la questionedel come conciliare le esigenze di funzionamento delle libertà fon-damentali garantite dai Trattati e la tutela dei diritti dell’uomo èrelativamente recente: in un primo momento, il problema dell’inte-razione tra le due categorie concerneva soprattutto gli atti secondarie la loro compatibilità con i diritti fondamentali. Ma la valorizza-zione operata dalla Corte delle quattro libertà ha inevitabilmenteportato alcuni nodi al pettine.
In particolare, se è vero che la Corte, seppur indirettamente, hada tempo messo in funzione un meccanismo di tutela dei dirittifondamentali nell’ordinamento dell’Unione, tuttavia la stessa, primadel citato caso Schmidberger 61, non si era mai spinta in un’analisi“aperta” ed approfondita del rapporto intercorrente tra quest’ultimie le libertà fondamentali. Nel caso citato, la questione pregiudizialesottoposta alla Corte era, in buona sostanza, se la libera circolazionedelle merci garantita dal Trattato imponesse ad uno Stato membrodi garantire il libero accesso alle principali vie di comunicazione e setale obbligo prevalesse sui diritti fondamentali, quali la libertà diespressione e la libertà di riunione (garantiti nell’ordinamento del-l’Unione in quanto tratti dagli artt. 10 e 11 della CEDU) dei manife-stanti consistente, in pratica, nella chiusura dell’autostrada del Bren-nero.
Orbene, per la prima volta, i giudici di Lussemburgo, pur utiliz-zando l’inevitabile percorso libertà (libera circolazione delle merci)/eccezione (diritti fondamentali), non si sono accontentati di unatutela indiretta — attraverso il prisma delle deroghe previste dalTrattato — ma si sono spinti apertamente in una disamina dellarelazione intercorrente tra diritti e libertà fondamentali, rilevandoche se, da un lato, la libera circolazione delle merci rappresentacertamente uno dei principi fondamentali nel sistema del Trattato,dall’altro — a talune condizioni — può subire restrizioni 62. Allo
59 Cfr. in tal senso P. MENGOZZI, Les caractéristique spécifiques de l’Union européenne dansla perspective de son adhésion à la CEDH, in questa Rivista, 2010, p. 231 ss.
60 J. P. JACQUÉ, Vers une nouvelle étape dans la protection des droits fondamentaux dansl’Union européenne in La France, l’Europe et le monde; mélanges en l’honneur de Jean Charpen-tier, Parigi, 2009, p. 345 ss.
61 Per un’analisi del caso v., A. BIONDI, Free Trade, a Mountain Road and the Right toProtest: European Economic Freedoms and Fundamental Individual Rights, in European Hu-man Rights Law Rev., 2004, pp. 51 ss.;
62 Sentenza Schmidberger, cit. punto 78.
Dottrina332
stesso modo, però, anche i diritti fondamentali, spesso invocati asostegno delle restrizioni alle libertà fondamentali, sono soggetti aderoghe, ove giustificate da un bisogno sociale imperativo e propor-zionate al fine legittimo perseguito 63. Sulla scorta di tale ragiona-mento, la Corte perviene, quindi, ad ammettere l’incidenza direttadei diritti fondamentali sul godimento di una delle libertà ricono-sciute dal Trattato 64, definendo come «necessario» il bilanciamentotra valori (libertà e diritti), cui è riconosciuta una posizione parite-tica.
Un contrasto diretto tra diritti fondamentali e libertà economi-che si rinviene anche nel citato caso Omega, nel quale interagiscono,da un lato, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazionedelle merci e, dall’altro, la tutela della dignità umana, riconosciutadalla Carta fondamentale tedesca come un diritto fondamentale. Inquesto caso, tuttavia, la Corte, pur effettuando un bilanciamento tralibertà economiche e diritti fondamentali, non approfondisce ildiscorso avviato con la pronuncia Schmidberger e, attraverso la“conversione” in principio di un diritto riconosciuto come fonda-mentale dalla Carta costituzionale di un solo ordinamento nazio-nale, ammette, ricorrendo alla clausola dell’ordine pubblico, unarestrizione alle libertà economiche 65.
Ad ogni modo, le pronunce Schmidberger ed Omega possonoessere accomunate per contenere entrambe un bilanciamento, più omeno diretto, tra libertà e diritti, apparentemente in contrasto traloro, a vantaggio di quest’ultimi 66. Lo stesso risultato non si rag-giunge, invece, nelle ormai celebri pronunce Viking Line 67 e Laval un
63 In tal senso v. anche Corte giust. 26 giugno 1997, causa C-386/95, Familiapress, inRacc.,p. I-3689, punto 26.
64 Sulla scorta di quanto evidenziato, in dottrina è stato affermata la creazione di unanuova ipotesi di deroga alla libera circolazione delle merci, autonoma e distinta tanto dallederoghe espresse previste dal Trattato quanto dalle esigenze imperative attinenti all’interessepubblico. In tal senso, v. C. BROWN, Case C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Tran-sporte und Planzüge v. Austria, in Common Market Law Rev., 2003, p. 1499 ss.; R. AGERBEEK,Freedom of Expression and Free Movement in the Brenner Corridor: the Schmidberger Case, inEuropean Law Rev., 2004, p. 255 ss.; in senso contrario, cfr. F. G. JACOBS, Human Rights in theEuropean Union: the Role of the Court of Justice, in European Law Rev., 2001, p. 331 ss.,secondo cui, invece, la protezione dei diritti fondamentali andrebbe esaminata «as part of thepublic policy derogation under the Treaty».
65 In dottrina vi è chi ha criticato tale scelta della Corte definendo «un’occasione persa»la pronuncia in esame. V. A. TANCREDI, L’emersione dei diritti fondamentali, cit., p. 646. È appenail caso di ricordare che il nuovo testo del TUE cita espressamente, all’art. 2, la tutela delladignità umana come uno dei valori fondanti l’Unione.
66 J. MORIJN, Balancing Fundamental Rights and Common Market Freedoms in UnionLaw: Schmidberger and Omega in the Light of the European Constitution, in European LawJournal, 2006, p. 15 ss.
67 Corte giust. 11 dicembre 2007, causa C-438/05, Viking Line,cit..
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 333
Partneri 68. Noti sono i fatti dai quali originano le pronunce, ealtrettanto noto è che — in entrambe le decisioni — viene sostan-zialmente preclusa la possibilità, riconosciuta in Schmidberger, diuna restrizione alle libertà del Trattato (nella fattispecie, liberacircolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento) effettuata sullabase di un configgente diritto fondamentale (segnatamente, la tuteladei diritti dei lavoratori ed il diritto di sciopero, riconosciuti dagliartt. 27 e 28 della Carta) 69. Sarebbe però un errore considerarequeste due sentenze come una “deviazione” rispetto alla sua tenden-ziale e progressiva apertura nei confronti della tutela dei diritti“sociali” che aveva trovato riconoscimento in Schmidberger. È benecosì evidenziare alcuni passaggi di entrambe le sentenze che mo-strano come anche in queste pronunce si sia realizzato, in continuitàrispetto a Schmidberger ed Omega, un bilanciamento tra tutela deidiritti fondamentali ed esercizio delle libertà economiche. Ed infatti,nella sentenza Viking si legge con chiarezza come il perseguimentodi finalità sia economiche che sociali all’interno dell’ordinamentodell’Unione, siano considerati obbiettivi necessariamente di impor-tanza paritetica 70, ed anzi inscindibili 71. L’azione collettiva a tuteladei lavoratori di uno Stato non viene affatto considerata, di per sé,una limitazione alla libertà di stabilimento: è tale, nell’opinione dellaCorte, solo un’azione collettiva che impedisca ad un’impresa difornire i suoi servizi dopo il trasferimento all’estero 72, in violazionedel principio generale di non discriminazione.
A questo proposito, nelle sue conclusioni, l’Avvocato generalePoiares-Maduro rilevava come «l’ordinamento economico» europeoè solidamente fondato su un contratto sociale «incorporato nelTrattato»: e che per questo «i lavoratori in tutta Europa devonoaccettare le ricorrenti conseguenze negative connesse alla creazionedi una ricchezza crescente da parte del mercato comune» in cambiod’un generale miglioramento delle loro condizioni di vita e di la-voro 73. Altrettanto afferma la Corte quando ribadisce che «la Co-munità non ha soltanto una finalità economica ma anche una fina-lità sociale» e che la libera circolazione delle merci, delle persone,
68 Citata supra, nota 23.69 Per un esame complessivo di entrambi i casi v. C. BARNARD, Viking and Laval: An
Introduction, in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2007-2008, pp. 463 e ss70 Sentenza Viking, cit., punto 7971 Cfr. le conclusioni dell’Avvocato generale Poiares-Maduro del 23 maggio 2007,
Viking, in Racc., I-10779, punto 23.72 Ibidem, punto 67.73 Ibidem, punto 59.
Dottrina334
dei servizi e dei capitali «devono essere bilanciati con gli obiettiviperseguiti dalla politica sociale» 74.
Dunque, la causa del “bilanciamento sbilanciato” che si attribui-sce alla sentenza Viking appare essere non già la ricostruzione inastratto svolta dalla Corte del rapporto tra diritti sociali e libertàeconomiche, bensì l’assenza di un reale “contratto sociale europeo”che vedrebbe i lavoratori di un Paese non già scioperare a difesa delproprio posto di lavoro (che rischiano di perdere a causa di untrasferimento “vantaggioso” del datore di lavoro in un altro Statomembro), ma manifestare invece a sostegno di un generale miglio-ramento delle condizioni di lavoro nell’Unione (magari anche in quelPaese che gode proprio di una disciplina meno severa delle condi-zioni di lavoro!). Non è dunque il bilanciamento svolto dalla Corte adessere errato: è, piuttosto, il calarsi della ricostruzione del bilancia-mento in astratto nella realtà economica e sociale del mercato unico,al quale si richiede una maturità a tutt’oggi non realizzata, che larende “sbilanciata”.
Anche nella sentenza Laval si può leggere che l’azione dellaComunità comporta non soltanto la realizzazione di un mercatointerno ma anche di una politica sociale; la Corte, infatti, ribadisceche le libertà economiche «devono essere bilanciat[e] con gli obiet-tivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figurano in particolare[...] il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che con-senta la loro parificazione nel progresso, una protezione socialeadeguata e il dialogo sociale» 75. La Corte piuttosto afferma 76
(richiamando proprio i casi Schmidberger ed Omega) che l’eserciziodei diritti fondamentali (come quello di espressione e di riunione e ilrispetto della dignità umana) «non esula» dall’ambito applicativodelle disposizioni del Trattato; anzi, il loro esercizio deve essereconciliato con le esigenze relative alle libertà del Trattato, oltre cheessere conforme al principio di proporzionalità.
In Laval ad aver destato le maggiori perplessità non è certol’assenza di una valutazione paritetica tra l’esercizio delle libertà e latutela dei diritti quanto, piuttosto, la ricostruzione della legittimitàdella restrizione alla libertà economica, svolta attraverso un test diproporzionalità alquanto rigido, al punto da non lasciar ritenerel’ostacolo alle libertà (ossia il blocco del cantiere) giustificato alla
74 Sentenza Viking, cit., punto 79.75 Sentenza Laval, cit., punti 104 e 105.76 Ibidem, punti 89-97.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 335
luce dell’obbiettivo della protezione dei lavoratori 77. Ciononostante,è da sottolineare come, da parte della Corte, il diritto di scioperovenga pienamente inserito nell’ambito dei diritti riconosciuti dall’or-dinamento dell’Unione europea (anche attraverso un espresso ri-chiamo alla Carta dei diritti fondamentali). Il suo esercizio, tuttavia,viene funzionalizzato rispetto alla piena espressione delle libertàeconomiche che — come la Corte da tempo ripete — possono trovaresì deroghe, purché non si spingano al di là di ciò che è necessario perraggiungere la realizzazione di un obbiettivo legittimo compatibilecon il Trattato; e la Corte ribadisce (in un passaggio forse tropporapido 78) come tra questi siano ricompresi oltre a quelli economici,anche quelli sociali.
Tuttavia, in Laval forse più che in Viking, è dato riscontrare comela Corte abbia inteso affermare che le libertà del mercato nonpossono essere messe in discussione ogni volta che non portino adun esito auspicabile, o quando “dispiacciano”. Al di là di tale rico-struzione, si può, comunque, affermare che tanto in Viking quanto inLaval la tutela dei diritti fondamentali è stata ricondotta dalla Cortenel consueto schema di analisi fondato sul carattere di motivogiustificativo non scritto delle «ragioni imperative di interesse gene-rale» 79 e sulla giustificabilità in base alla applicazione del principiodi proporzionalità.
Conseguentemente, più che venire esclusa la configurabilità diuna parità gerarchica tra diritti e libertà in astratto (riscontrabileinvece in Schmidberger), è l’esercizio dei diritti fondamentali inrilievo nelle pronunce Viking e Laval (diritto di sciopero e diritto diespressione) che, in definitiva, appare funzionalizzato rispetto allelibertà del Trattato, ossia ritenuto ammissibile nei limiti dell’eserci-zio di quest’ultime.
Ad ogni modo, senza soffermarsi sulla correttezza di tale impo-stazione e dunque dei risultati raggiunti 80, ciò che appare utilerilevare ai fini della presente analisi è che, in tutte le pronunce citate,è comunque effettuato un bilanciamento tra diritti e libertà fonda-mentali, entrambi sempre ricostruiti “all’interno” delle disposizionidei Trattati, senza mai coinvolgere gli atti di diritto derivato. A
77 Ibidem, punti 107 e 108.78 Ibidem, p.to 10579 Cfr. la ricostruzione compiuta dall’Avvocato generale Trstenjak nelle citate conclu-
sioni del 14 aprile 2010 rese nella causa Commissione europea c. Repubblica federale diGermania, punto 181 ss.
80 Cfr., in tal senso: B. CARUSO, I diritti sociali fondamentali nell’ordinamento costituzio-nale europeo, in S. SCIARRA, B. CARUSO (a cura di), Il lavoro subordinato, Torino, 2006, pp. 707 ess.
Dottrina336
questo proposito è però da registrare una recente pronuncia 81, nellaquale la Corte sembra attribuire anche agli atti delle istituzioni (nellafattispecie, le direttive in materia di appalti pubblici) la capacità diesprimere elementi utili per il bilanciamento, qualora questi sianoda considerarsi come adottati in applicazione delle libertà economi-che fondamentali garantite dai Trattati. Nelle parole della Corte, “lanatura di diritto fondamentale del diritto di negoziazione collettivae la finalità sociale del TV-EUmw/VKA (la legge tedesca oggetto dianalisi nella causa: ndrintesa nella sua globalità non possono, inquanto tali, comportare l’automatico esonero delle amministrazionie aziende comunali datrici di lavoro dal rispetto degli obblighiimposti dalle direttive 92/50 e 2004/18, le quali danno attuazione allalibertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settoredegli appalti pubblici” (corsivo aggiunto).
Tale orientamento, nella sostanza, individua anche nel dirittoderivato delle disposizioni capaci di essere prese in considerazioneai fini del bilanciamento, insieme alle regole contenute dei Trat-tati 82. È presto per valutarne la solidità: di certo, se venisse confer-mato, si avrebbe come immediata conseguenza di un simile orien-tamento un allargamento considerevole del numero di disposizioniinteressate nel bilanciamento tra diritti e libertà.
V. Se la giurisprudenza della Corte è senz’altro il principalecampo di indagine per valutare le modalità ed i risultati dell’opera-zione di bilanciamento, va aggiunto che sia il testo dei Trattatiistitutivi, sia gli atti di diritto derivato, non sono certo ad essaestranei.
In questo diverso contesto, va in primo luogo evidenziato che iprimi articoli del Trattato sull’Unione europea fanno spesso riferi-mento ad obiettivi ulteriori rispetto a quelli tipici del mercato in-terno 83, anzi, in particolare dopo il Trattato di Lisbona, intendono ilprimo in maniera più “aggiornata”, come una complessa panoplia diesigenze ed interessi variegati 84. Quanto al Trattato sul funziona-
81 Corte giust. 15 luglio 2010, causa C-271/08, Commissione c. Repubblica federale diGermania, non ancora pubblicata.
82 Ibidem, punti 44-48.83 Il nuovo art. 2 TUE elenca una serie di valori fondanti dell’Unione, arricchendo la
lista in precedenza contenuta nel vecchio testo dell’art. 6, par.1, TUE.84 Cfr. art. 3, par. 3, TUE, ove l’obiettivo di instaurazione del mercato interno viene
accompagnato da una serie di corollari che fanno esplicito riferimento, inter alia, allo“sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabi-lità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla pienaoccupazione e al progresso sociale”.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 337
mento, questo si preoccupa di fissare precise indicazioni sulle mo-dalità di svolgimento dell’intervento normativo delle istituzioni qua-lora, nel facilitare la libera circolazione dei fattori produttivi, questoincida su interessi e valori fondamentali di diverso contenuto. Ilriferimento va, ad esempio, all’art. 114 TFUE (ex art. 95 TCE),dedicato alle misure di ravvicinamento delle legislazioni finalizzateall’instaurazione ed al funzionamento del mercato interno. In questadisposizione non solo si richiede al legislatore un livello di prote-zione elevato nelle proposte in materia di sanità, sicurezza, tuteladell’ambiente e dei consumatori, tutti valori ripresi anche nella Cartadei diritti fondamentali; in aggiunta, si codifica una proceduraspeciale che comporta, sotto il controllo della Commissione, l’even-tuale adozione o mantenimento, da parte degli Stati membri, dimisure derogatorie rispetto a quelle previste a regime dall’interventodi armonizzazione, se finalizzate alla tutela delle esigenze dell’art. 36(già art. 30 CE) o relative alla protezione dell’ambiente o dell’am-biente di lavoro 85. Inoltre, la tutela della salute viene ulteriormenterichiamata da una delle “clausole orizzontali” contenute nel TFUE:ai sensi dell’art. 168, par. 1, «nella definizione e nell’attuazione ditutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevatodi protezione della salute umana».
Inoltre, di estremo interesse ai fini di questa analisi è la circo-stanza che a questa azione di bilanciamento tra diritti e libertà nonsia affatto estranea l’opera del legislatore dell’Unione: come giusta-mente osservato dall’Avvocato generale Kokott nel caso Promusi-cae 86, è al legislatore che compete la definizione di “un primoequilibrio” 87 già all’interno di uno specifico atto normativo. In talsenso, un ruolo determinante è affidato anzitutto alla Commissione,chiamata per prima a misurare la compatibilità delle proposte legi-slative e di tutti i propri atti con i diritti fondamentali. Tale processodi verifica è stato affermato (e codificato) nel tempo attraversonumerosi atti non vincolanti (Comunicazioni) della Commissione:più precisamente, già a partire dal 2001, anno di proclamazionedella Carta di Nizza, quest’ultima ha affermato che ogni atto ed ogniproposta adottata dovesse divenire “oggetto di un controllo prelimi-nare” finalizzato alla valutazione della compatibilità con le disposi-zioni della Carta stessa 88 e che, qualora si fosse ravvisato “un nesso
85 Bisogna tuttavia riconoscere che questa procedura non sembra aver prodotto unaprassi significativa.
86 Corte giust. 29 gennaio 2009, causa C-275/06 Promusicae,.in Racc., p. I-271.87 Conclusioni dell’Avvocato generale Kokott del 18 luglio 2007, Promusicae, punto 56.88 V. la Communication on Application of the Charter of Fundamental Rights of the
Dottrina338
specifico” tra la proposta e i diritti fondamentali, dovesse essereespressa una “dichiarazione formale di compatibilità” mediantel’inserimento di uno o più considerando che sostanzialmente forma-lizzasse il rispetto della Carta dei diritti fondamentali. Tale opera-zione, che talora si concretizza nell’affermazione (contenuta neiconsiderando) di rispetto della Carta e, più spesso, con un rinvioespresso a specifici suoi articoli 89, è in realtà, frutto dell’opera divalutazione dell’incidenza rispetto ai diritti fondamentali — svoltadai servizi della Commissione nell’ambito della redazione della pro-posta (o di adozione) di un atto — e che spesso rimane confinatanegli atti preparatori.
Prima di svolgere un esame “sul campo” analizzando alcuni attie mostrando come in questi entri in gioco il bilanciamento tra dirittie libertà, appare utile ricordare brevemente i principali momentievolutivi della disciplina inerente all’esercizio della verifica dell’im-patto sui diritti fondamentali svolto dalla Commissione. A partire dal2005, la Commissione — che si era frattanto dotata di uno strumento
European Union, SEC (2001) 380/3, del 13 marzo 2001, disponibile all’indirizzo http://ec.europa-.eu/justice/doc_centre/rights/doc/sec0380_3_en1.pdf.
89 È la stessa Comunicazione sopra citata a fornire una formula standard da inserireall’interno d’un atto, qualora quest’ultimo abbia un collegamento coi diritti fondamentali, cosìche nell’atto si statuisca il formale rispetto della Carta: «This act respects the fundamental rightsand observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of theEuropean Union»; qualora poi un atto coinvolga specificamente un principio o una disposi-zione contenuta nella Carta, la formula può arricchirsi di un riferimento specifico, secondoquesto modello: «In particular, this [act] seeks to ensure full respect for [right XX] and/or topromote the application of [principle YY] / [Article XX and/or Article YY of the Charter ofFundamental Rights of the European Union] » (parentesi quadre del testo). È tuttavia da notarecome talvolta l’inserimento di tali formule nei considerando appaia piuttosto una clausola distile; in questo senso, a titolo di mero esempio, cfr. il Regolamento n. 1160/2005/CE delParlamento e del Consiglio del 6 luglio 2005 che modifica le disposizioni della convenzione diapplicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione gradualedei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al sistema d’informazioneSchengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti diimmatricolazione dei veicoli (in GUUE L 191del 22 luglio 200), ove si afferma in manieraapodittica, al cons. 15, che «Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva iprincipi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».In altri casi più recenti, invece, la valutazione appare più puntuale, come nel caso delRegolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’applicazionedi una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazionepersonale, in GUUE L 343 del 29 dicembre 2010, ove si legge, al Considerando n. 30, che “Ilpresente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dallaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente l’articolo 21, che vietaqualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore dellapelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o leconvinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad unaminoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. Leautorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti dovrebbero applicare il presenteregolamento nel rispetto di tali diritti e principi”.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 339
di verifica come l’analisi di impatto 90 per tutte le proposte daadottare (e in casi peculiari, per gli atti) — ha avuto modo dicodificare, attraverso la redazione di una ”metodologia per un con-trollo sistematico e rigoroso” del rispetto della Carta dei dirittifondamentali 91, le modalità attraverso cui monitorare il rispetto deidiritti dell’uomo. La Commissione in quella sede affermava che — alfine di «rafforzare e rendere più sistematico in concreto il controllo[sulla conformità] ai diritti fondamentali» — proprio all’internodella valutazione di impatto venisse offerto un sunto, il più completoe preciso possibile, dei vari effetti sui diritti individuali coinvoltidalla successiva adozione dell’atto 92. Va poi ricordato che anche ilParlamento europeo con la relazione Voggenhuber del 2007 93 sulrispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislativedella Commissione, poneva l’accento sulla necessità di un controlloancora più rigoroso in fase di proposta.
Anche per offrire risposta a queste istanze, nel gennaio del 2009la Commissione rendeva pubblica una relazione sul funzionamentodella metodologia per un controllo sistematico e rigoroso del ri-spetto della Carta dei diritti fondamentali 94. In questo documento,la Commissione esprimeva chiaramente la necessità di un migliora-mento della sua azione, attraverso un vero e proprio “incitamento a
90 Comunicazione della Commissione in materia di valutazione d’impatto, COM (2002)276, del 5 giugno 2002.
91 Comunicazione della Commissione su Il rispetto della Carta dei diritti fondamentalinelle proposte legislative della Commissione; metodologia per un controllo sistematico erigoroso, COM (2005) 172, del 27 aprile 2005.
92 Loc. cit., p. 12. È il caso di ricordare che l’impact assesment verte su tre categorie diimpatto: gli effetti si valutano sul piano sociale, politico ed economico, mentre si escludeespressamente che i diritti fondamentali costituiscano una quarta categoria di impatto (p. 19).Tale mancanza viene spesso contestata: cfr., in tal senso, la Relazione Voggenhuber sulrispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione, del12 febbraio 2007, punto 11. Le linee guida sull’impact assesment sono state oggetto di revisionenel 2009 — SEC(2009) 92. Qui chiaramente si legge come «certain fundamental rights areabsolute and cannot be limited or subject to derogation: others can only be limited orderogated from subject to a demonstration of necessity and, thereafter, proportionality» (par.3.1), e che «[a]ll Commission proposals have to be compatible with the EU Charter ofFundamental Rights, and the Commission has decided that impact assessments must take intoaccount the impacts of initiatives on fundamental rights as laid out in the Charter» (par. 8.3).In questo contesto va anche inserita l’istituzione nel 2007 di una Agenzia per i dirittifondamentali (Regolamento n. 168/2007/CE del Consiglio del 15 febbraio 2007, che istituiscel’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali., in GUUE L 53del 22 luglio 2007).Sull’Agenzia, in senso critico, cfr.: A. DEL GUERCIO, L’Agenzia europea per i diritti fondamentali:un’occasione perduta?, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, p. 136 ss.
93 La Relazione Voggenhuber sottolinea, al punto 7, anche l’esigenza di «un monito-raggio [..] sistematico e rigoroso dei diritti fondamentali [che] richiede non solo una sempliceverifica di eventuali errori [...] nel determinare il giusto equilibrio tra la libertà del singolo e leesigenze dell’interesse generale».
94 Relazione sul funzionamento pratico della metodologia per un controllo sistematico erigoroso del rispetto della Carta dei diritti fondamentali, COM(2009) 205, del 29 aprile 2009.
Dottrina340
pensare in termini di diritti fondamentali”, nonché a favorire la“cultura dei diritti fondamentali” all’interno della stessa attività diproposta e iniziativa legislativa 95. Un aspetto di questo documentomerita un’attenzione particolare. Nella relazione è ribadita l’inten-zione della Commissione — già affermata nella “metodologia” del2005 96 — di seguire il Parlamento e il Consiglio nell’iter di adozionedell’atto “nell’ottica del rispetto dei diritti fondamentali”: la Com-missione si riserva così il diritto di proporre un ricorso di annulla-mento, qualora ritenga l’atto in questione incompatibile con i dirittifondamentali quali tutelati nell’ordinamento dell’Unione 97. Talevolontà di controllo viene peraltro meglio delineata nella Relazionedel 2009 98, in cui la Commissione si riserva anche di procedere alritiro della propria proposta qualora, a sua parere, nell’iter di ado-zione dell’atto le altre istituzioni si siano discostate significativa-mente dalla proposta proprio in riferimento alla tutela dei dirittifondamentali, tanto da “stravolgere l’equilibrio” raggiunto all’in-terno dell’atto. Una posizione dunque di estrema rigidità, quanto-meno sul piano teorico, che potrebbe aprire scenari inediti, ma chelascia intendere come la Commissione ritenga di sentirsi “guar-diana” del rispetto della Carta dei diritti fondamentali anche neiconfronti dell’operato delle altre istituzioni nel corso delle procedurelegislative.
L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il cui art. 6 TUEattribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei Trattati, ha infinesollecitato la Commissione ad adottare una nuova Comunicazionecontenente la sua “strategia” per rendere il più possibile effettivinell’Unione i diritti fondamentali contenuti nella Carta, per quantoriguarda non solo le politiche interne ma anche la sua azioneesterna 99. In base alla Comunicazione, tutte le proposte legislativedella Commissione, ma anche gli atti delegati o di esecuzione, sonosottoposti nella fase di preparazione al controllo di compatibilità
95 Ibidem, p 9. È qui evidente come il testo riveli il suo valore “politico” più cherealmente programmatico: aldilà di questo però è chiaro come — anche in questo contesto —la Commissione abbia preferito non giungere ad una formalizzazione del processo di valuta-zione, e dunque di non codificare, il “meccanismo di bilanciamento”.
96 COM (2005) 172, p. 27 e ss.97 COM(2009) 205, cit., par. 3.4 «[I]l ricorso di annullamento rappresenta la strategia
migliore ove queste possano essere eliminate lasciando inalterato il resto dell’atto. Le dispo-sizioni lesive possono infatti essere cassate, lasciando inalterate le altre disposizioni dell’attolegislativo in grado di rappresentare un valido progresso cui la Commissione non intenderebberinunciare».
98 COM (2009) 205, cit.99 Comunicazione della Commissione “Strategia per un’attuazione effettiva della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, COM(2010) 573 def. del 19 ottobre 2010.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 341
con la Carta (“valutazione di impatto”) seguita da un gruppo diret-tivo della valutazione di impatto che riunisce i servizi interessatidella Commissione. È istituito inoltre un apposito comitato per lavalutazione d’impatto Impact Assessment Board, che fa capo alpresidente della Commissione, indipendente dai servizi competentiper l’elaborazione delle politiche, chiamato a verificare costante-mente gli aspetti relativi ai diritti fondamentali nei progetti divalutazione di impatto che gli vengono sottoposti dai servizi compe-tenti e a rilasciare, se necessario, un parere. Dopo la valutazione diimpatto, nella redazione finale del progetto di atto la Commissioneavvia il controllo della legalità verificando in particolare la suaconformità con la Carta. Si impegna dunque ad indicare con preci-sione, in appositi “considerando” della proposta 100, i diritti fonda-mentali sui quali quest’ultima si ripercuote, nonché le ragioni per lequali ritiene che le eventuali limitazioni apportate a un dirittofondamentale “non assoluto” siano giustificate in termini di neces-sità e proporzionalità. La Commissione si impegna altresì a repri-mere le condotte degli Stati membri nell’attuazione del diritto del-l’Unione non rispettose dei diritti fondamentali, avviandoprocedimenti di infrazione (par. 1.3.2 della Comunicazione). Essainoltre presenterà una relazione annuale sull’applicazione dellaCarta, anche sulla scorta dei dati forniti dall’Agenzia per i dirittifondamentali.
5. Segue: alcuni esempi di bilanciamento nel testo delle diret-tive — V. (Segue). L’azione di bilanciamento operata a monte dallegislatore si riflette dunque nel testo degli atti dell’Unione. Ciò puòessere facilmente riscontrato analizzando, ovviamente senza presun-zione di esaustività, alcune direttive in vigore.
a) Un primo ed emblematico esempio del bilanciamento tra
100 La Commissione sembra avvertire che, come prima evidenziato, la prassi sinoraseguita non abbia garantito una informazione sufficiente: al par. 1.1.3 della Comunicazione,rubricata “Considerando mirati”, si sostiene infatti che “le proposte che presentano un nessoparticolare con i diritti fondamentali devono contenere considerando specifici che ne spie-ghino la conformità con la Carta. I considerando hanno la funzione di spiegare il ragiona-mento alla base dell’adozione dell’atto e quindi consentono e agevolano l’eventuale controllogiurisdizionale della conformità con la Carta. Per questo occorre evitare qualsiasi banalizza-zione derivante dall’uso generalizzato di un considerando che si limiti a dichiarare la conformitàcon la Carta (corsivo aggiunto). L’ ’inserimento di un considerando non è una mera formalitàma serve a dimostrare il controllo approfondito della conformità della proposta con la Carta.I considerando che spiegano la conformità della proposta con la Carta si ritengono mirati seindicano con precisione i diritti fondamentali sui quali la proposta si ripercuote. Inoltre,saranno inseriti considerando specifici su misura per taluni diritti fondamentali se necessarioper chiarire la portata di una disposizione o le soluzioni trovate nella proposta per garantireche la limitazione di un diritto fondamentale si giustifica rispetto all’articolo 52 della Carta”.
Dottrina342
diritti e libertà nell’ambito della formazione degli atti normativi,riscontrabile in una materia che potremmo definire un crocevia,dove più diritti e più libertà si intersecano, è la direttiva sui servizi dimedia audiovisivi (c.d. SMAV) 101. Già dall’analisi della propostadella Commissione 102 è possibile osservare come questa non soloabbia tenuto conto delle disposizioni della Carta dei diritti fonda-mentali, ma abbia anche considerato la direttiva in quanto tale, purfondata sugli articoli del Trattato concernenti la liberalizzazione deiservizi nel mercato interno, come mirata a consolidare il rispetto deidiritti fondamentali 103, e in particolare del diritto alla libertà diespressione. L’impact assessment report redatto dai servizi dellaCommissione 104, partendo dalla necessità di una disciplina capaceal contempo di esprimere obiettivi di interesse generale e di lasciareaperta la libertà economica e libera la scelta dei consumatori (par4.2), tende esplicitamente a sottolineare come l’intervento normativocontenuto nella proposta sia capace di assicurare un alto livello ditutela dei diritti fondamentali 105 e realizzare un bilanciamento“equilibrato” tra istanze economiche e sociali.
Per esemplificare come tale bilanciamento operi in concretonell’ambito del testo finale della direttiva SMAV, è possibile farriferimento — seppur sinteticamente — a come essa risolva, da unlato, la questione dell’accesso agli eventi di maggior rilevanza e aic.d. “estratti di cronaca”, materia in cui si evidenzia il rapporto tral’esercizio di una libertà economica (acquisto in esclusiva di undiritto a trasmettere un evento) e la tutela del diritto ad essereinformati, e dall’altro, la delicata questione della “procedimentaliz-zazione” del ricorso a misure nazionali di salvaguardia nel caso diviolazione delle regole della direttiva e/o delle regole nazionali che,
101 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinatedisposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’eser-cizio delle attività televisive, in GUUE L 312del 18 dicembre 2007. La direttiva SMAV è oggicodificata nella direttiva 2010/13/UE (ivi, n. L 95). Per un commento al suo testo rinvio a R.MASTROIANNI, La direttiva sui servizi di media audiovisivi, Torino, 2009.
102 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica ladirettiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizionilegislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delleattività televisive, COM (2005) 646, del 15 dicembre 2005.
103 Ibidem, considerando n. 12. Anzi, è bene specificato che la Commissione ha “mo-dulato” la sua proposta orientandosi in base ai diritti fondamentali: soltanto laddove questiultimi siano messi in gioco, la Commissione ha ritenuto che la regolamentazione sia neces-saria (lasciando così che il resto della disciplina sia dettato attraverso co-regolamentazione edautoregolamentazione).
104 SEC (2005)1625, del 13 dicembre 2005.105 Si tratta, segnatamente, della «dignità umana, della protezione dei diritti (sic!) e dei
consumatori»
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 343
nel rispetto della medesima, abbiano adottato misure più severe diquelle previste a regime.
Quanto alla prima questione, la Commissione, all’interno dellasua proposta (considerando nn. 26 e 27), chiariva che i diritti ditrasmissione relativi a manifestazione di interesse generale «pos-sono essere acquistati da fornitori di servizi audiovisivi in esclusiva»ma che — al fine di tutelare la libertà fondamentale di essereinformati e per assicurare la promozione del pluralismo — «è op-portuno che i titolari di diritti esclusivi [...] concedano [...] il dirittodi utilizzare brevi estratti nei loro programmi d’informazione [...] acondizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie». Le esigenze dicontemperamento tra libertà del mercato e tutela del pluralismo edel diritto ad essere informati si ritrovano interamente ribadite neltesto della direttiva 106: l’art. 3 duodecies, comma 1, del testo finale(divenuto art. 15 del testo codificato) prevede che «ai fini dellarealizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilitanell’UE abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discri-minatorie, ad eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclu-siva» da altra emittente; tali estratti tuttavia sono (comma 3) libera-mente scelti, e non imposti agli altri fornitori. L’apertura allapossibilità di trasmettere brevi estratti non è però qui da conside-rarsi funzionale alla contendibilità del mercato dell’audiovisivo, di-retta cioè ai concorrenti di chi ha acquistato l’esclusiva: dietro lalibertà economica è invece racchiusa la preservazione del pluralismoinformativo e quindi la tutela del diritto ad essere informati degliutenti 107.
Come si accennava poc’anzi, altro aspetto significativo dellemodalità attraverso cui nella direttiva SMAV si siano realizzateforme di bilanciamento, è da individuarsi nell’ambito della “proce-dimentalizzazione” delle misure poste dagli Stati a allo scopo ditutelare esigenze primarie legate alla protezione dei diritti fonda-mentali. Come è noto, la direttiva SMAV, basata sull’home countrycontrol, rimette allo Stato membro nel quale un’emittente è stabilitail controllo sulle trasmissioni, le quali circolano poi liberamente nelterritorio dell’Unione. Gli Stati che ricevono la trasmissione non
106 Cfr. Direttiva 2007/65/CE, cit., considerando 38 e 39.107 Il medesimo approccio si rinviene nella procedura codificata all’art. 14 della direttiva
2010/13/UE in tema di diffusione in chiaro di “eventi maggiori”: la Commissione opera unoscrutinio delle misure adottate dagli Stati membri con le quali, limitando l’esercizio dei dirittiacquisiti dalle emittenti televisive ed allo scopo di tutelare il diritto all’informazione, si imponeloro una specifica modalità di trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per lasocietà. Si vedano in proposito Trib. UE 17 febbraio 2011, cause T-385/07, FIFA c. Commissionee T-55/08, UEFA c. Commissione, non ancora pubblicate in Racc.
Dottrina344
possono quindi svolgere un secondo controllo, assicurando anzi dinon porre ostacoli alla ritrasmissione nel loro territorio dei pro-grammi originari di altri Paesi membri. Tuttavia, a questa regolagenerale la direttiva appone due deroghe, consentendo allo Statomembro di destinazione di adottare misure restrittive nei confrontidella circolazione dei servizi televisivi. Ciò può avvenire, in primoluogo, qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altroStato membro violi “in maniera evidente, grave e seria” le regoledella direttiva in tema di tutela dei minori (articolo 27, paragrafo 1o 2) 108 o i divieti di incitamento all’odio (articolo 6) 109: è appena ilcaso di sottolineare che, in entrambi i casi, gli interessi che gli Statiintendono salvaguardare possono essere facilmente inquadrati nel-l’ambito della Carta dei diritti fondamentali (art. 24, in tema di tuteladei minori; art. 10, 11, 21 e 22 in tema di divieto di incitamentoal’odio). In secondo luogo, qualora un’emittente, per avvantaggiarsidi una disciplina meno severa, si stabilisca in uno Stato membro madestini comunque la propria programmazione — in tutto o in granparte — in un altro Stato membro, aggirandone la più severa disci-plina adottata dal secondo per la tutela di un “interesse pubblicogenerale” (c.d. abuso del diritto) 110.
In entrambi i casi la direttiva detta le regole che limitano ilpotere di reazione dello Stato membro di ricezione, attraverso unaprocedura articolata che si caratterizza dal coinvolgimento delloStato membro di stabilimento e della Commissione, la quale ultimaè chiamata a giudicare (ex post, nel primo caso, ex ante nel secondo)la correttezza delle misure adottate. In definitiva, ciò che il legisla-tore UE ha realizzato attraverso tale procedimentalizzazione è nien-t’altro che un’operazione di bilanciamento tra le esigenze di tuteladegli interessi fondamentali dello Stato di ricezione, da un lato, e lelibertà fondamentali, dall’altro, operazione realizzata attraverso uncontrollo della legittimità delle misure di salvaguardia statali affi-dato alla Commissione. È da notare come attraverso tale peculiare
108 «Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisivedelle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possanuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare pro-grammi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.Le misure di cui alparagrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico,mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altroaccorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano oascoltino normalmente tali programmi».
109 «Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovi-sivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contenganoalcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità».
110 Corte giust. 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV10, in Racc., p. I-04795.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 345
procedura la direttiva SMAV realizza anche una non banale erosionedel “monopolio” degli Stati membri circa le modalità di eserciziodelle misure stesse, ponendo la Commissione nella condizione divalutare l’opportunità e la proporzionalità della misura di salvaguar-dia e, in sostanza, di svolgere un ruolo fondamentale nella ricerca diun bilanciamento tra le esigenze del singolo Stato membro e leesigenze del mercato interno.
b) Un ulteriore esempio può essere rinvenuto nella direttiva2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’ener-gia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE 111, adottata dalConsiglio e dal Parlamento con base giuridica negli artt. 47, 55 e 95CE (oggi artt. 53, 62 e 114 TFUE). Ad essere “bilanciati”, in questocaso, sono le esigenze economiche del mercato interno (ed in parti-colare la libera prestazione dei servizi), insieme alla tutela dei con-sumatori (Carta dei diritti fondamentali, art. 38), da un lato, ed ildiritto dei proprietari delle reti di distribuzione dell’energia (ibidem,art. 17), dall’altro.
La finalità dell’intervento legislativo in esame, come risulta dalladirettiva stessa, è quello di realizzare «un mercato interno dell’ener-gia elettrica [...] completamente aperto» 112 in cui siano garantitecompetitività, sostenibilità e sicurezza dell’approvvigionamento 113.L’intento è, quindi, la realizzazione, attraverso l’utilizzo delle libertàgarantite dai Trattati, di quello che potrebbe essere definito il diritto“sociale” di approvvigionamento energetico.
Per il perseguimento di tale obiettivo, il legislatore europeo haritenuto di dover imporre la separazione della proprietà e dellagestione delle reti dalle attività di generazione e fornitura dell’ener-gia ritenendo che detta separazione potesse essere «un modo efficacee stabile per [...] garantire la sicurezza degli approvvigionamenti» 114
e l’accesso transfrontaliero di nuovi fornitori 115 a chiaro vantaggiosoprattutto dei consumatori “domestici” i quali, oltre a veder garan-tito l’accesso alla fornitura, dovrebbero beneficiare di costi inferiori
111 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009,relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva2003/54/CE, in GUUE L 211del 14 agosto 2009.
112 Cfr. Direttiva 2009/72/CE, cit., considerando 1 e 3.113 In tal sensi si esprime la Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e
al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, dal titolo Una politica energetica per l’Europa,COM (2007) 1 def., non pubblicata in GUUE, par. 3.1, in cui è ampiamente illustrato che unmercato competitivo, oltre a determinare una riduzione dei costi per i cittadini, è in grado diincentivare l’innovazione nell’approvvigionamento da nuove fonti di energia oltre allo sviluppodi nuove reti.
114 Cfr. Direttiva 2009/72/CE, considerando 11.115 Ibidem, considerando 8.
Dottrina346
e tariffe trasparenti. Il diritto di proprietà delle reti che, nella mag-gior parte degli Stati membri, è riscontrabile in capo ad impreseintegrate verticalmente, si mostra quindi suscettibile, come eviden-ziato anche nell’impact assessment report 116 di limitazioni, purchéproporzionate e necessarie, per la realizzazione di esigenze stretta-mente connesse al funzionamento del mercato 117.
Nell’individuazione delle modalità concrete attraverso cui realiz-zare tale separazione proprietaria, gli Stati membri, ai quali illegislatore comunitario concede una certa discrezionalità, dovrannocomunque salvaguardare, secondo quanto previsto dal considerando18, gli interessi degli azionisti delle imprese verticalmente inte-grate 118 tenute alla cessione di assets.
c) Di estremo interesse ai nostri fini è anche la c.d. direttiva“anti-riciclaggio” 119, adottata con base giuridica negli artt. 95 e 47,par. 2, CE (ora artt. 114 e 53 TFUE), dunque principalmente fina-lizzata a facilitare l’esercizio del diritto di stabilimento.
In questo caso, il bilanciamento è effettuato tra il diritto ad unricorso giurisdizionale effettivo e ad un giudice imparziale, nonché ildiritto alla presunzione di innocenza, sanciti dagli artt. 47 e 48 dellaCarta dei diritti fondamentali, da un lato, e la tutela della «stabilitàe [de]la reputazione del settore finanziario» 120 e, più in generale, ilbuon funzionamento del mercato interno, dall’altro. Il segno di taledelicata operazione può essere riscontrato non solo nel considerandon. 48, in cui è affermato l’intento di rispettare il dettato della Cartadei diritti fondamentali, quanto, piuttosto, nel considerando n. 20 incui si sostiene che «quando i liberi professionisti che forniscono
116 SEC(2007) 1179/2. Al par. 2.5 è chiarito che il rispetto del diritto fondamentale diproprietà, garantito costituzionalmente dalla pressoché totalità degli ordinamenti degli Statimembri e dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali in quanto i diritti fondamentali nonsono prerogative assolute ma necessitano di un bilanciamento che tenga conto della funzionedagli stessi svolta all’interno dell’ordinamento, è suscettibile di restrizioni purché proporzio-nate e necessarie all’esigenza pubblica perseguita.
117 La creazione di un mercato concorrenziale in cui le attività di generazione e didistribuzione dell’energia siano separate dalla gestione delle reti può determinare lo sviluppodi reti efficienti, con la consequenziale riduzione della dispersione energetica, l’incentivazionedell’approvvigionamento da fonti alternative, con evidente benefici per l’ambiente, ed unariduzione dei costi per i consumatori. Cfr. in tal senso: E. CIARALLI, I mercati europei dell’elet-tricità e del gas, in Mercato concorrenza regole, 2008, p. 179 e ss.
118 Il considerando 18 ipotizza la cessione diretta di azioni ovvero il frazionamento delleazioni dell’impresa integrata in azioni dell’impresa della rete ed azioni dell’impresa dellafornitura e generazione di energia.
119 Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005,relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi diattività criminose e di finanziamento del terrorismo, in GUUE L 309 del 25 novembre del2005..
120 Ibidem, considerando 1.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 347
consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllaticome ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica diun cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudizia-rio, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività lapresente direttiva imponesse loro l’obbligo di segnalare eventualioperazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrori-smo». Conseguentemente, è affermata la necessità che «la consu-lenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a menoche il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo» ovvero sia «fornita a scopo di rici-claggio o di finanziamento del terrorismo».
Al fine di meglio comprendere, però, l’attività di bilanciamentocompiuta dal legislatore, è utile analizzare l’iter procedimentale cheha portato all’adozione dell’atto. Da questo risulta infatti che ilParlamento europeo si era energicamente opposto 121 alla inizialeproposta elaborata dalla Commissione 122: mentre la Commissioneintendeva lasciare agli Stati membri la scelta se assoggettare gliavvocati ed i notai agli obblighi informativi previsti dalla direttivaprevedendo, in ogni caso, una deroga per le informazioni acquisite alfine di approntare la difesa di un cliente in un procedimento giudi-ziario, il Parlamento riteneva che agli Stati dovesse essere imposta laprevisione di una esenzione per avvocati e notai dagli obblighiinformativi della direttiva e, soprattutto, dovesse essere estesa ancheall’attività di consulenza.
Alla posizione di compromesso assunta dal Consiglio, nel sensodi riconoscere la possibilità per gli Stati di inserire tale derogaestendendone, però, l’ambito di applicazione anche alla consulenza,face seguito l’opposizione del Parlamento, secondo cui il testo nonrisultava perfettamente aderente ai principi generali del diritto del-l’Unione ricostruiti con riferimento alla CEDU. La soluzione propo-sta dal Consiglio, tuttavia, fu poi quella concretamente adottataanche perché, «i fatti dell’11 settembre negli Stati Uniti hannodrammaticamente modificato il punto di vista sulla questione per-ché, a partire da quella data, la direttiva sul riciclaggio di denaro èconsiderata parte integrante della lotta contro il terrorismo» 123.
Quanto affermato dimostra non solo l’attività di bilanciamento
121 Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2000, in GUUE C 121 del 24 aprile 2001.122 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 91/308, COM(1999) 352 def., del 4 luglio 1999.123 Relazione del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di
conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delladirettiva 91/308, del 5 novembre 2001 [PE-CONS 3654/2001 — C5-0496/2001 — 1999/0152(COD)].
Dottrina348
compiuta dal legislatore nella fase di formazione degli atti legislativima altresì come interessi meritevoli di essere comunque adeguata-mente tutelati, quali quello alla sicurezza, possano incidere nell’at-tività di ponderazione. Tale impostazione trova, tra l’altro, confortonella pronuncia della Corte di giustizia nel caso Ordre des barreauxfrancophones et germanophone 124 in cui, in sede di valutazione dellavalidità della direttiva rispetto ai diritti fondamentali, è chiaramenteaffermato che, l’esonero degli avvocati dagli obblighi di informa-zione imposti dalla direttiva 125 «è di natura tale da preservare ildiritto del cliente ad un equo processo» 126.
d) Gli esempi sono, comunque, molteplici. Tra questi meritauna citazione anche la direttiva 96/71/CE 127 in tema di distacco deilavoratori nella prestazione di servizi, divenuta particolarmente fa-mosa con le note sentenze Laval, Viking, Rüffert e Commissione c.Lussemburgo 128, con la quale il legislatore dell’Unione tenta unequilibrio tra la libertà di prestazione dei servizi delle imprese in unPaese diverso da quello di stabilimento, da un lato, e le fondamentaliesigenze di salvaguardia degli standard di tutela sociale, dall’al-tro 129: equilibrio che la stessa Corte di giustizia ha in sostanzaritenuto definitivo, tanto da respingere, nella sentenza Rüffert, ognitentativo di estensione della protezione dei lavoratori al di là del“nocciolo duro” contenuto in quell’atto normativo 130.
e) Per concludere, è il caso di evidenziare che l’attività dibilanciamento descritta non era estranea al legislatore — ed allaCorte — già prima dell’elaborazione della stessa Carta dei dirittifondamentali. A riprova di ciò, è sufficiente analizzare la direttiva92/100/CEE 131 (oggi sostituita dalla direttiva 2006/115/CE 132 che,
124 Corte giust. 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordre des barreaux francophones etgermanophone, in Racc., p. I-5305.
125 Nella specie si trattava della direttiva 91/308/CEE, come modificata dalla direttiva2001/97/CE.
126 Sentenza Ordre des barreaux francophones et germanophone, cit., punto 34.127 Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996
relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, in GUCE L 18 del21 gennaio 1997.
128 Corte giust. 19 giugno 2008, causa C-319/06, Commissione c. Lussemburgo, in Racc.,p. I-4323
129 Conclusioni Cruz Villalón presentate il 5 maggio 2010 nella causa C-515/08, Palhotae a., non ancora pubblicate in Raccolta.
130 M. FRANZEN, C. RICHTER, Case C-346/06, Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert, in his capacityas liquidator of Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG v. Land Niedersachsen, [2008] ECR I-1989,in Common Market Law Rev., 2010, p. 537 e ss.
131 Direttiva del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, ildiritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellet-tuale, in GUCE L 356 del 29 novembre 1992.
132 Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 349
sostanzialmente, ne ripropone la medesima disciplina) relativa aldiritto di noleggio, al diritto di prestito e taluni diritti connessi aldiritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
In tale atto, con base giuridica nelle disposizioni del Trattato intema di servizi e di ravvicinamento delle legislazioni, infatti, è statoeffettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali alla libertà diiniziativa economica ed alla tutela della proprietà intellettuale (oggitutelati dalla Carta dei diritti fondamentali agli artt. 16 e 17) con leesigenze di funzionamento del mercato interno e, in particolare, conla libera prestazione dei servizi (in particolare, quello di noleggio).Se, da un lato, è, infatti, riconosciuta la possibilità di sfruttamentoeconomico dell’opera protetta dal diritto d’autore, dall’altro, sulpresupposto che la vendita e la messa in circolazione dell’opera(recte: del supporto contenente l’opera letteraria o artistica) non«esaurisce» ogni diritto di sfruttamento economico (quale, ad esem-pio quello di rappresentazione pubblica dell’opera, di radiodiffu-sione o di locazione), il legislatore ha dettato particolari disposizionifinalizzate ad armonizzare la legislazione degli Stati membri inmateria di noleggio e prestito garantendo, come rilevato nel consi-derando n. 7, agli autori delle opere «livelli di reddito adeguati oltreal recupero degli investimenti effettuati per poter creare l’opera». Ilperseguimento di tale obiettivo, infatti, in assenza di una particolarelimitazione della possibilità di cedere a noleggio il supporto conte-nente l’opera senza il necessario consenso del titolare del diritto disfruttamento, sarebbe vanificato. L’evoluzione tecnologica e la faci-lità di riproduzione di opere contenute su supporti non facilmentedeteriorabili quali i compact disc, infatti, potrebbero consentire allocatario del supporto fonografico di ottenere una copia dell’operaad un costo notevolmente inferiore rispetto a quello di vendita conconseguente ed immediato nocumento per l’autore ed il produt-tore 133.
La soluzione raggiunta dal legislatore è stata successivamenteposta al vaglio della Corte di giustizia nel caso Metronome Mu-sik 134.Nel confermare la validità delle disposizioni della direttiva inmateria di diritto di noleggio, la Corte osservava come «le opereletterarie ed artistiche possono essere oggetto di uno sfruttamento
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto diautore in materia di proprietà intellettuale, in GUUE L 376 del 27 dicembre 2006.
133 Il rischio è adeguatamente illustrato dall’Avvocato generale Tesauro nelle conclu-sioni presentate il 22 gennaio 1998 nella causa C-200/96, Metronome Musik, punto 26, che fariferimento al c.d. fenomeno della vendita a prezzo di noleggio.
134 Corte giust. 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik, in Racc., p. I-1953.
Dottrina350
commerciale diverso dalla semplice vendita dei supporti materiali»,per cui la distinzione compiuta nella direttiva e la limitazione aparticolari condizioni dell’esercizio dell’attività di noleggio o di pre-stito pubblico dell’opera sono misure idonee a ridurre i rischi per gliautori di vedere riprodotta, a basso costo, la propria opera senzapoter ottenere una adeguata remunerazione. D’altronde, «non poteradeguatamente remunerare chi pone in essere investimenti econo-mici per la realizzazione dei prodotti fonografici» potrebbe avere«evidenti ripercussioni sull’attività di creazione di nuove opere»inducendo i produttori a «concentr[arsi] esclusivamente sugli inve-stimenti delle opere commerciali e dunque più lucrative, a scapitodel pluralismo culturale all’interno della Comunità» 135.
Sulla scorta di tale rilievo, la Corte affermava che il diritto allibero esercizio di un’attività professionale (quale quella di noleggio)si configura come un principio generale del diritto comunitario ma,tuttavia, «detti principi non si configurano come assoluti ma vannoconsiderati in relazione alla loro funzione sociale» con la conse-guenza che «possono essere apportate restrizioni a condizione chetali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interessegenerale perseguiti dalla Comunità europea e non costituiscano,rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inac-cettabile tale da ledere la sostanza dei diritti così garantiti» 136.
La Corte, quindi, con la citata pronuncia (il cui impianto risultaancora attuale, nonostante la stessa risalga a prima della proclama-zione della Carta), non ha fatto altro che ritenere corretto il bilan-ciamento compiuto dal legislatore che, per garantire un dirittofondamentale (tutela della proprietà intellettuale e della creazioneartistica, nonché, indirettamente, sebbene non espressamente ri-chiamato nella sentenza, il pluralismo culturale) ha ammesso “limi-tazioni” (per altro non assolute essendo comunque lasciata la pos-sibilità di concedere licenze per il noleggio ad un prezzo ritenutoequo rispetto allo scopo perseguito) alla libertà di circolazione dellemerci ed alla prestazione di servizi ed al sotteso diritto (anch’essofondamentale) di iniziativa economica.
VII. L’analisi condotta nelle pagine che precedono dimostracome, in linea di principio, l’azione dell’Unione, nel suo complesso,appare costantemente condizionata dall’esigenza di tutelare i diritti
135 Conclusioni dell’Avvocato generale Tesauro nella causa Metronome Musik, cit. punto26.
136 Sentenza Metronome Musik, cit., punto21.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 351
fondamentali. Qualora l’opera di bilanciamento venga operata dallegislatore, ad essa la Corte appare mostrare una certa deferenza,affidandosi a valutazioni che, in ultima analisi, non possono nonessere essenzialmente di tipo politico 137. Resta, tuttavia, da valutarese l’attività di bilanciamento tra libertà economiche e diritti fonda-mentali effettuata sia dalla Corte di giustizia, sia dalle istituzionipolitiche possa oggi presentarsi in maniera differente in conse-guenza dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
In primo luogo, è possibile ritenere che la “promozione” dellaCarta a fonte di pari grado rispetto ai Trattati, operata con il nuovotesto dell’art. 6 TUE, non provochi di per sé novità di rilievo rispettoal passato dal punto di vista della gerarchia delle fonti: anche primadell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, come precisato dallagiurisprudenza, i principi generali relativi ai diritti fondamentalierano da considerare a pieno titolo come “diritto primario” dell’or-dinamento dell’Unione. Il mantenimento del riferimento ai principigenerali nel testo dell’art. 6 TUE, all’ultimo comma — apparente-mente superfluo, se non contraddittorio, in un contesto oramaicaratterizzato da un elenco formale di diritti fondamentali — po-trebbe tuttavia spiegarsi come un’indicazione nel senso di conser-vare in capo alla Corte il ruolo di contribuire allo “sviluppo progres-sivo” del sistema, anche al di là delle prescrizioni della Carta.
In secondo luogo, ogni valutazione in merito all’incidenza delTrattato di Lisbona non può prescindere dalla difficoltà di effettuareuna netta distinzione concettuale tra diritti fondamentali e libertàeconomiche. Queste, infatti, alla luce del testo della Carta potreb-bero anche essere agevolmente ricostruite in termini di diritti fon-damentali 138. A ciò si aggiunga l’ulteriore rilievo che, con le modi-fiche attuate dal Trattato di Lisbona, la tutela dei dirittifondamentali si impone alla stregua degli altri obiettivi del Trattatoe, pertanto, ovviamente nel contesto delle competenze attribuite,tende ad imporsi come un obiettivo da perseguire ex se e non comeuna mera deroga ad una libertà del mercato interno.
137 Qualora il bilanciamento sia frutto dell’attività legislativa, infatti, permane in capoal giudice dell’Unione un margine di valutazione sia delle finalità di interesse generale inprincipio sottese alle misure in discorso, sia della loro idoneità per il perseguimento degliobiettivi indicati e dunque del sacrificio imposto alle libertà fondamentali. Spetta sempre algiudice dell’Unione svolgere lo scrutinio con riferimento alla idoneità e proporzionalità dellemisure nazionali adottate per dare attuazione alle misure comunitarie in questione. Vedi perentrambi gli aspetti Trib. UE 17 febbraio 2011, FIFA c. Commissione, cit., par. 125 ss.
138 In tal senso si può leggere, ad esempio, l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali,dedicata alla “libertà d’impresa”. Per una ricostruzione delle libertà economiche in termini didiritti fondamentali, v. V. SKOURIS, Fundamental Rights and Fundamental Freedoms, cit.,passim.
Dottrina352
Peraltro, le novità portate da Lisbona non si fermano qui: bastiporre mente al nuovo art. 3, par. 3, TUE, nel quale (e qui l’eco dellasentenza Laval è facilmente percettibile) l’obiettivo di instaurazionedel mercato interno si accompagna al perseguimento di obiettivi“intrinseci”, riferiti all’economia sociale di mercato che miri allapiena occupazione ed al progresso sociale, nonché all’elevato livellodi tutela dell’ambiente. Inoltre, l’art. 9 TFUE pone un vincolo di tipo“orizzontale”, richiedendo all’Unione di tener conto, nella defini-zione e nell’attuazione di tutte le sue politiche ed azioni, delleesigenze connesse ai diritti sociali ed alla salvaguardia della salute (elo stesso avviene, in base all’art. 11 TFUE, con riferimento alla tuteladell’ambiente). Non era difficile, dunque, attendersi una valorizza-zione di questi nuovi riferimenti subito dopo l’entrata in vigore delTrattato di Lisbona: ed infatti nelle citate Conclusioni dell’Avvocatogenerale Cruz Villalón rese nella causa C-515/08, Palhota e a., del 5maggio 2010, con riferimento alla tutela delle condizioni di lavoro, èaffermato che «qualora le condizioni di lavoro si presentino comemotivi imperativi d’interesse generale che giustificano una derogaalla libera prestazione dei servizi, esse non devono più essere inter-pretate restrittivamente. Nella misura in cui la protezione del lavo-ratore diventa un fattore meritevole di essere tutelato direttamentedai Trattati [v. art. 9 TFUE e 3, n. 3, TUE], non ci troviamo piùdinanzi ad una mera deroga ad una libertà, né, tantomeno, dinanziad una deroga non scritta e ricavata dalla giurisprudenza» 139. Indefinitiva, nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale (non seguitosino in fondo dalla Corte che, invece, sembra aver preferito unatteggiamento più prudente 140), sposa in pieno l’approccio Schmi-dberger, che si traduce nella ponderazione, fondata sul principio diproporzionalità, di valori in principio equivalenti per lo stesso ordi-namento dell’Unione. Da quanto affermato discende che la compo-sizione di un eventuale conflitto e la conseguente compressione delle
139 Conclusioni dell’Avvocato generale Villalón nella causa Palhota e a, cit., punto 53.140 Corte giust. 7 ottobre 2010, causa C-515/08, Palhota e a., non ancora pubblicata in
Racc. Sebbene la Corte pervenga alle medesime conclusioni suggerite dall’Avvocato generale,non passa inosservata l’assenza di un riferimento espresso alla Carta dei diritti fondamentalinonché la ricostruzione della tutela dei lavoratori come una esigenza imperativa di caratteregenerale idonea a giustificare una restrizione alla prestazione di servizi (cfr. punti 47-49).Probabilmente, nella specie, contrariamente alla sentenza di poco precedente resa nel casoCommissione c. Repubblica federale di Germania (causa C-271/08), cit., in cui, come suprarilevato, la Corte si è spinta sino al riconoscimento della idoneità di una fonte secondaria,qualora esplicazione di un diritto fondamentale riscontrabile nel Trattato, a derogare ad unalibertà fondamentale, è prevalso un atteggiamento di maggiore cautela rinviando a futurepronunce una più chiara definizione del rapporto tra diritti e libertà fondamentali alla luce diLisbona.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 353
libertà a vantaggio dei diritti (e viceversa) non potrà che muoveredall’analisi della idoneità 141 della necessità 142 e dell’adeguatezza alperseguimento dello scopo specifico.
Tale ricostruzione, come d’altronde rilevato dall’Avvocato gene-rale Trstenjak nelle citate Conclusioni del 14 aprile 2010 relative allacausa C-271/08 Commissione europea c. Repubblica federale di Ger-mania, rispetta l’art. 52, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali, aisensi del quale tutte le limitazioni all’esercizio dei diritti e dellelibertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge erispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, in appli-cazione del principio di proporzionalità, devono configurarsi comenecessarie ed effettivamente rispondenti alle finalità di interessegenerale riconosciute dall’Unione 143.
Ora, tirando le fila del discorso, è possibile concludere affer-mando che il bilanciamento tra diritti e libertà economiche non puòessere codificato in una regola o in un paradigma definito, richie-dendo piuttosto un’analisi da svolgersi caso per caso. Ciò detto, èpossibile immaginare che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbonaed il riconoscimento della Carta dei diritti fondamentali quale para-metro diretto di legittimità e di interpretazione delle fonti seconda-rie (ovviamente anche di quelle adottate prima della sua entrata invigore come fonte vincolante nell’ordinamento dell’Unione ovverodella sua stessa proclamazione), apra uno scenario in cui il ruolofondamentale sarà svolto dai giudici nazionali, eventualmente attra-verso lo strumento del rinvio pregiudiziale, non solo di interpreta-zione ma anche di validità, chiamati ad effettuare, in concreto, quelbilanciamento al quale si è ampiamente fatto riferimento.
Resta, tuttavia, da chiedersi se il giudice nazionale, che, inalcune recenti pronunce 144, ha dimostrato di tenere in considera-zione la Carta di Nizza, probabilmente anche oltre l’effettiva rile-vanza per la decisione delle questioni concrete sottoposte al suovaglio ed al di là dei confini dell’ordinamento dell’Unione 145, sia
141 Una misura restrittiva di una libertà è da ritenersi idonea al raggiungimento delloscopo qualora risponda «realmente» all’intento di raggiungerlo in modo «coerente e sistema-tico». Cfr. Corte giust. 17 novembre 2009, causa C-169/08, Presidente del Consiglio c. RegioneSardegna, in Racc., p. I-10821, punto 42.
142 Nella Corte giust. 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, in Racc., p. 2237, punto 21,la Corte sostiene che la misura potrà essere ritenuta necessaria qualora, tra una pluralità dimisure idonee al perseguimento dello scopo, «sia quella che impone l’onere minore perl’interesse o il bene giuridico colpito».
143 Conclusioni dell’Avvocato generale Trstenjak del 14 aprile 2010 nella causa C-271/08, Commissione europea c. Repubblica federale di Germania, cit., punto 189.
144 Cfr., ad esempio, Cass. civ. 2 febbraio 2010, n. 2352.145 Alcuni “paletti” relativamente alla delimitazione della sfera di competenza dell’or-
Dottrina354
sufficientemente pronto per il compimento di tale delicata opera-zione 146.
SUMMARY
In this paper the author examines the relationship between fundamen-tal rights and economic freedoms in the light of Article 6 TEU, in particularafter the Charter of Fundamental Rights of the European Union was givenbinding legal effect equal to the one of the Treaties.
The author underlines the fact that striking a balance between eco-nomic freedoms and fundamental rights is not a recent development inEuropean Union law; on the contrary, such a delicate question is oftenraised before the European Court of Justice since its earliest decisions.Never the less, the entry into force of the Lisbon Treaty, by recognizing theimportance of non economic values in the European Union, may suggestnew solutions to old problems.
The author distinguishes between two categories of ECJ decisions: inthe first one, the protection of fundamental rights prevails over measureswhich are adopted by Member States and are in breach of the economicfreedoms granted by the Treaties (ERT, Carpenter); on the other hand, theprotection of fundamental rights is used ’as a shield’ by Member States, inorder to justify restrictions to the economic freedoms guaranteed by theTreaty (Omega).
Furthermore, it also points out that the search for a balance betweeneconomic freedoms and fundamental rights is crucial not only in theprovisions of the Treaties themselves and in the decisions of the Court, butalso in the process of adoption of secondary European law. Some examplesare given by reference to directives adopted in different sectors fallingunder the competence of the EU.
dinamento dell’Unione si rinvengono già in Corte giust. 29 maggio 1997, causa C-299/95,Kremzow, in Racc., p. I-2629, e si ritrovano nella giurisprudenza più recente: cfr. ord. 6 ottobre2005, causa C-328/04, Vajnai, in Racc., p. I-8577; 3 ottobre 2008, causa C-287/08, Savia, ivi,p.I-1326; 26 marzo 2009, causa C-535/08, Pignataro, cit. Sul punto v. J.P. JACQUÉ, Vers unenouvelle étape dans la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, cit., p. 349.
146 Oltre alle decisioni citate supra, nota 41, ulteriori dubbi suscita T.A.R. Lazio, Sez. II
bis, 18 maggio 2010, n. 11984, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui si rinviene unriferimento confuso ed impreciso alla Carta dei diritti fondamentali ed alla sua rilevanza perl’ordinamento dell’Unione europea.
Diritto dell’uomo e libertà economiche fondamentali 355