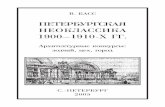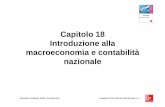Fondamentali di letteratura italiana - 1900
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Fondamentali di letteratura italiana - 1900
1
FONDAMENTALI DI LETTERATURA ITALIANA
di
Santoianni Miriam e Penati Limonta Carola
SOMMARIO LA SCAPIGLIATURA ............................................................................................................................................. 4
La Scapigliatura e il 6 febbraio, introduzione ......................................................................................................... 4
Emilio Praga ........................................................................................................................................................... 5
Preludio .............................................................................................................................................................. 5
Arrigo Boito ............................................................................................................................................................ 5
Dualismo ............................................................................................................................................................ 5
Lezione di anatomia ........................................................................................................................................... 5
Igino Ugo Tarchetti ................................................................................................................................................. 6
IL NATURALISMO FRANCESE .............................................................................................................................. 7
Emile Zola ............................................................................................................................................................... 7
Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale ............................................................................................ 7
IL VERISMO ........................................................................................................................................................ 7
Luigi Capuana ......................................................................................................................................................... 7
Scienza e forma letteraria: l'impersonalità ......................................................................................................... 7
Giovanni Verga ....................................................................................................................................................... 8
Impersonalità e regressione ............................................................................................................................... 8
L' "eclisse" dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato .................................................................... 8
L'impersonalità del narratore ............................................................................................................................. 8
Verga e Zola ....................................................................................................................................................... 8
Vita dei campi .................................................................................................................................................... 9
Rosso Malpelo .................................................................................................................................................... 9
Ciclo dei Vinti ................................................................................................................................................... 10
2
DECADENTISMO ............................................................................................................................................... 12
SIMBOLISMO .................................................................................................................................................... 13
Charles Baudelaire ............................................................................................................................................... 13
Fiori del male.................................................................................................................................................... 13
Paul Verlaine ........................................................................................................................................................ 14
Languore .......................................................................................................................................................... 14
Arte poetica ..................................................................................................................................................... 14
Arthur Rimbaud.................................................................................................................................................... 15
Vocali................................................................................................................................................................ 15
DECADENTISMO IN ITALIA ............................................................................................................................... 15
Gabriele D'Annunzio ............................................................................................................................................ 15
Il Piacere ........................................................................................................................................................... 16
Una fantasia «in bianco maggiore» ................................................................................................................. 16
Le Vergini delle Rocce ...................................................................................................................................... 16
Il programma politico del superuomo .............................................................................................................. 17
Le Laudi ............................................................................................................................................................ 17
Alcyone ................................................................................................................................................................ 17
La sera fiesolana ............................................................................................................................................... 17
La pioggia del pineto ........................................................................................................................................ 18
La prosa "notturna" .......................................................................................................................................... 18
Nella belletta .................................................................................................................................................... 19
Critica letteraria e Gabriele D'Annunzio ........................................................................................................... 19
GIOVANNI PASCOLI .............................................................................................................................................. 19
Myricae ............................................................................................................................................................ 20
I Canti di Castelvecchio .................................................................................................................................... 21
Il fanciullino ...................................................................................................................................................... 22
IL FUTURISMO .................................................................................................................................................. 23
Filippo Tommaso Marinetti .................................................................................................................................. 24
Manifesto del Futurismo .................................................................................................................................. 24
Manifesto tecnico della letteratura futurista ................................................................................................... 24
Zang tumb tuuum Adrianopoli 1912 ................................................................................................................ 25
Il futurismo in altri paesi ...................................................................................................................................... 25
Vladimir Majakovskij ........................................................................................................................................ 25
3
Italo Svevo ............................................................................................................................................................ 26
Le suggestioni culturali dell'opera di Svevo ...................................................................................................... 26
Una vita ............................................................................................................................................................ 27
Senilità ............................................................................................................................................................. 28
La coscienza di Zeno ......................................................................................................................................... 28
Le lettere a Jahier ............................................................................................................................................. 30
La profezia di un'apocalisse cosmica ................................................................................................................ 30
Luigi Pirandello ..................................................................................................................................................... 31
La poetica di Pirandello .................................................................................................................................... 31
L'umorismo ...................................................................................................................................................... 32
Il fu Mattia Pascal ............................................................................................................................................. 33
Ciaula scopre la luna ........................................................................................................................................ 34
Il treno ha fischiato .......................................................................................................................................... 35
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero .................................................................................................. 36
La trappola ....................................................................................................................................................... 36
Il teatro di Pirandello ........................................................................................................................................ 37
Sei personaggi in cerca di autore ..................................................................................................................... 37
Umberto Saba ...................................................................................................................................................... 38
Il Canzoniere .................................................................................................................................................... 39
ERMETISMO ..................................................................................................................................................... 41
Giuseppe Ungaretti .............................................................................................................................................. 41
L'Allegria ........................................................................................................................................................... 41
Veglia ............................................................................................................................................................... 42
Eugenio Montale .................................................................................................................................................. 43
Ossi di seppia ................................................................................................................................................... 43
Salvatore Quasimodo ........................................................................................................................................... 45
Acque e terre ................................................................................................................................................... 45
Giorno dopo giorno .......................................................................................................................................... 45
Alle fronde dei salici ......................................................................................................................................... 45
Italo Calvino ......................................................................................................................................................... 45
Il sentiero dei nidi di ragno ............................................................................................................................... 45
4
LA SCAPIGLIATURA È un gruppo di scrittori (non una scuola o un movimento organizzato) detti scapigliati che si
caratterizzano per uno stile di vita disordinato, ribelle e fuori dalle regole, dediti al consumo smoderato di alcool, senza un lavoro fisso e critici nei confronti della borghesia.
Si sviluppa negli anni 1860-70 (periodo della nascita dell'Unità) nel Nord d'Italia, soprattutto nelle città di Milano, Genova e Torino (il c.d. "triangolo industriale").
Il termine compare per la prima volta nel testo "La Scapigliatura e il 6 febbraio" di Cletto Arrighi per designare un gruppo di ribelli che vivevano in maniera disordinata ed eccentrica.
È un'"avanguardia mancata": non ha aperto nuovi orizzonti, ma è stata il punto di partenza da cui sono nate vere e proprie avanguardie. Avanguardia mancata poiché:
dal punto di vista dei contenuti: rappresenta una novità e ha un atteggiamento ribelle verso i valori della borghesia;
sul piano formale: la parola non rimanda ad altri significati, ma mantiene il suo originario uso delle regole (anche se connotava un modo d'essere da tutti disprezzato).
Caratteristiche: presenta atteggiamenti di
ambivalenza: posizione non chiara tra il vecchio / nuovo, bene / male (combattuti dal vecchio, ma attratti dal nuovo);
dualismo: tali artisti oscillano tra poli contrastanti fra loro, tra Ideale e Vero, bene e male,… .
Recupera i temi del Romanticismo (l'irrazionalità, il fantastico, il sogno, l'allucinazione, il soggettivismo, il male, l'infinito) e del Positivismo = movimento culturale (filosofico, letterario e scientifico) che subentra al Romanticismo, si sviluppa a partire dalla 1° metà del 1800, che ha una visione positiva della realtà ed un estrema fiducia nel progresso e nella scienza e nelle capacità dell'uomo di risolvere ogni problema e difficoltà con essi.
Micro saggio - La bohème parigina Il termine "Scapigliatura" designava il gruppo di scrittori milanesi anticonformisti, equivalente del termine bohème. "Bohémiens" significava zingari poiché si riteneva che questi nomadi venissero dalla Boemia.
La Scapigliatura e il 6 febbraio, introduzione Nel romanzo scritto dal milanese Cletto Arrighi, si fa riferimento alle "grandi città del mondo incivilito",
introducendo così un'esagerazione.
Descrizione degli scapigliati: persone spostate e ribelli di ogni ceto e condizione sociale appartenenti ad ambo i sessi (introduce una novità sulla parità di sesso), tra i 20 e i 35 anni e dediti alla letteratura, pittura e alla musica (eclettici —› più forme d'arte).
Sul piano formale, si attengono alle regole classiche della struttura poetica.
I termini consueti sono quelli riferiti all'incertezza, all'ambivalenza e alla mancanza di punti fermi.
5
Emilio Praga
Preludio Tratto da Penombre, di Emilio Praga, scritto nel novembre 1864.
Manifesto della Scapigliatura: il narratore deve rivelare il volto reale della vita, senza maschere e finzioni.
Struttura poesia: 8 strofe di 4 versi di rima alternata ABAB
Riferimento a Manzoni "nume" (v. 4) cioè pilastro del Romanticismo, "casto poeta" (v.13).
Il lessico è aulico e letterario, ma vi sono anche espressioni prosaiche; vi sono riferimenti alla religione "arca", patriarca, "Calvario", "Sudario", "litane", "martire", "peccati" e "tempio". Si evince un atteggiamento ambivalente di attrazione e repulsione verso la religione.
Vi sono i termini caratteristici della Scapigliatura come "noia", "nebbia", "malattia", "fango", "loto", "ignoto", "miseria". Si utilizza una sintassi semplice, per la maggior parte paratattica (le frasi sono della stessa lunghezza delle strofe), e vengono anche usate inversioni alla latina.
Tra le metafore, vi è "aquile al tempo di mutar le piume" fa riferimento alla condizione di debolezza di una generazione non in grado di volare. I versi sono scorrevoli e non sono presenti enjambement.
Sono presenti molte contrapposizioni tra "figli" e "padri" (v. 1), "nebbia" e "splendor" (v. 5), "antecristi" e "Cristi" (vv. 15-16), "nebbia" e "fango" (vv.1- 24), "o nemico lettor" e "fratello" (vv. 17-27), "noia" e "misera" (vv. 17-31), "cielo" e "loto" (v. 20), "martire" e "empio" (v. 21).
Riferimenti alla storia ebraica per trattare l'allontanamento dell'uomo ai valori religiosi; ad esempio, "vertice sacro" (v. 7), "patriarca" (v. 7), …
Il lettore è descritto come "nemico lettor" (v. 17) poiché il lettore è ostile nei confronti degli scapigliati.
Arrigo Boito
Dualismo Testo programmatico della Scapigliatura: tratta un carattere, infatti, del dualismo. È stato scritto da
Arrigo Boito, è parte integrante di "Libro dei versi".
Si parla di una forte contrapposizione, si è attratti dal bene e allo stesso modo dal male.
Lezione di anatomia Testo di Arrigo Boito composto da 14 strofe ognuna composta da quinari; il 1° e il 4° verso sono
sdrucciole "lugubre" e "riverbera". Ha rime ABCDBC.
Vicende: si sta effettuando un'autopsia fatta da un medico per istruire i presenti. La ragazza è un adolescente bionda e bella, è morta all'ospedale, denota le umili condizioni (ai tempi, i medici si recavano a casa per i nobili) ed è priva di una degna sepoltura. Sembra "pura e casta" con il suo "bianco volto", è "pia, dolce, purissima, fiore languente di poesia".
[5°str.] Ci si rivolge alla scienza che profanando il cadavere crede di scoprire altro, ma accresce i dubbi riguardo la sua esistenza. L'autore è critico: la scienza pur di arrivare a delle certezze non si cura delle persone e delle dignità.
[vv.34-36] Introduce l'immagine del medico che urla, con modi di fare bruschi e cita i medici del passato.
Mentre che il medico spiega nel modo più completo nozioni riguardanti il corpo umano, l'autore non può far almeno di pensare a quello che succederà alla testa del cadavere e ai sogni ("mille mondi aerei") della ragazza che non si sono potuti realizzare. Nella conclusione, la scienza diviene utile: ci rivela che quella ragazza così pura, casta ha al suo interno "un feto di trenta giorni".
Atteggiamento di ambivalenza: la scienza da un lato ha profanato il cadavere della giovane, dall'altro la vera natura della ragazza, non pura e non casta, e riesce a valutare i veri aspetti della realtà.
6
Igino Ugo Tarchetti È l'autore di "Fosca", romanzo scapigliato.
Vicende: Il protagonista, Giorgio, ufficiale dell'esercito è contesto tra due donne: Clara, donna bella e serena, con cui ha una relazione felice e gioiosa, e Fosca, bruttissima, isterica, dalla sensibilità acuta e patologica. Fosca è la cugina del colonnello comandante della guarnigione della piccola città dove Giorgio, come ufficiale, è destinato. A poco a poco Giorgio si sente attratto morbosamente da Fosca, non se ne può più liberare. La donna muore dopo una spaventosa notte d'amore con lui, e Giorgio è contaminato dalla malattia della donna.
Il narratore è autodiegetico, cioè coincide con il protagonista (1° persona).
Valore simbolico dei personaggi:
Fosca: donna fatale (nera capelli e scura), ricorda la "Natura dell'Islandese" di Leopardi, che ammalia l'uomo e lo conduce alla morte;
Clara: esprime bellezza, armonia e serenità. Il narratore può essere:
Autodiegetico: interno alle vicende, narra in prima persona, es. Divina Commedia;
Eterodiegetico: diverso rispetto ai personaggi (voce fuoricampo), narra in 3° persona e onnisciente, es. Promessi Sposi;
Omodiegetico: narratore esterno, diverso dal protagonista.
Sistema dei personaggi: rapporto tra i personaggi stessi. Ad es. nei Promessi Sposi, contrapposizione tra umili, potenti e mediatori; in Fosca, triangolo amoroso tra Giorgio, Clara e Fosca e il medico come mediatore. Giardino di Leopardi nello "Zibaldone" Giardino di "Fosca" di Tarchetti
Luogo dove "non trovi una pianticella sola in istato di sanità perfetta" e quasi "ben più deplorabile che un cemeterio".
Luogo "incantevole, così pieno di maestosa orribilità".
Sofferenza: attrae ed affascina; dolore: aspetto negativo della vita degli esseri viventi.
Ricco di piante, erbe e fiori che soffrono data la loro collocazione "troppo calda, … fresco, … luce, … ombra, … secco". I vegetali sono visti come essere viventi che "ammacchi, … stritoli, … spremi il sangue, … rompi, … uccidi".
Privo di aiuole, fiori, ma presenta "viali ampi e lunghissimi", "statue mutilate … cippi e basi di colonne sepolte in mezzo alle ellere". Il clima è umido ed ombroso e favorisce la fioritura delle viole in pieno agosto.
Coloro che arrecano alle piante sono una "donzelletta sensibile e gentile" e un "giardiniere saggio".
Non vi sono persone.
Gli animali presenti sono: api, formicai, bruchi, mosche, lumache e zanzare.
Vi sono "serpentelli d'acqua", "grosse lucertole" e "una specie di uccelli".
Soffia il vento che rompe i rami secchi degli alberi.
7
IL NATURALISMO FRANCESE Presenta alcune caratteristiche in comune ed alcune diversità con il verismo di Giovanni Verga e con
Luigi e Roberto Capuana.
Il termine si sviluppa in Francia a fine 1800 con l'obiettivo di essere una fedele riproduzione della realtà attraverso lo studio scientifico della società e dando maggior importanza alle classi più deboli.
S'inserisce nel contesto del Positivismo cioè il pensiero filosofico che valorizza la scienza, ha fiducia nel passato e nella sua capacità di risolvere ogni problema.
Caratteristiche:
Ottimismo che si traduce in fiducia nel poter cambiare la realtà;
dal punto di vista letterario si vuole affrontare la realtà su basi scientifiche per migliorare le condizioni delle classi subalterne.
Emile Zola Ritiene che lo scrittore deve osservare e studiare la realtà con rigore scientifico ed evidenziare i
meccanismi della regola.
Nel 1880, scrisse il saggio "Il romanzo sperimentale" in cui dichiara le caratteristiche di un romanzo che dev'essere il resoconto di un'esperienza scientifica applicata alle passioni e ai sentimenti dell'uomo.
È necessario ritrovare leggi universali che possano spiegare i comportamenti dell'uomo in modo da riuscire a migliorare la vita.
Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale Scritto di Emile Zola, dalla prefazione de "Il romanzo sperimentale".
Per scrivere un romanzo, Zola ritiene che si deve comportare da scrittore-analista: deve applicare il metodo scientifico e grazie ad esso, può risolvere tutti i problemi e migliorare la società. Il romanzo quindi è un'opera sociale, utile perciò alla collettività.
IL VERISMO È una tendenza letteraria di fine 1800, sviluppatosi negli ambienti milanesi con i principali esponenti furono Giovanni Verga e Luigi Capuana. Esso trova fondamento nel Naturalismo francese (negli ambienti socialisti-milanesi si erano tradotte le opere di Zola per leggerle).
Luigi Capuana Luigi Capuana, critico letterato del "Corriere della Sera" ritiene inauspicabile che non vi sia una distinzione netta tra arte e scienza e perciò ne rivendica l'autonomia. Apprezza da Zola la forma scientifica del romanzo, cioè il modo attraverso il quale il romanziere presenta i fatti: l'impersonalità (si limita a teorizzarla).
Scienza e forma letteraria: l'impersonalità È una recensione del romanzo i "Malavoglia" di Giovanni Verga, in cui esso anticipa il ciclo dei Vinti.
Capuana usa un tono polemico verso Zola: l'opera d'arte non può essere assimilata ad un concetto scientifico; la scienza può essere usata solo nella forma e si traduce in impersonalità.
Riporta alcuni esempi: il lettore è di fronte ai personaggi ed imparerà a conoscerli dal modo in cui essi "si soffiano il naso", perciò il narratore dev'essere in grado di eclissarsi. I personaggi devono essere descritti senza filtri, conformi alla realtà.
8
Giovanni Verga Giovanni Verga approva la posizione di Capuana e ritiene impropria l'associazione arte-scienza ed applica l'impersonalità concretamente.
Impersonalità e regressione È la prefazione al racconto del "L'amante di Gramigna" e si pone come risposta a Salvatore Farina. Verga
rivolgendosi a Farina lo presenta come un "documento umano" (v.2), espressione tipica del Naturalismo Francese.
"Lo ripeterò così come l'ho raccolto pei viottoli dei campi" (v. 4): l'autore scompare, non racconta; Verga prende i suoi racconti dal popolo e utilizza le stesse espressioni di chi rappresenta. Egli decide di raccontare le vicende "faccia a faccia col fatto nudo e schietto" (v. 6).
Fine: l'impersonalità non è un processo immediato che necessità di tempo per raggiungerla. L'opera sarà impersonale solo se essa non avrà punti di contatto con l'autore.
L' "eclisse" dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato Testo A) Giovanni Verga esprime una serie di dubbi sul fatto di riuscire effettivamente ad esprimere la
realtà al lettore e la difficoltà nel rappresentare i personaggi. All'inizio del romanzo, non occorre soffermarsi su ogni carattere, ma solo in modo sommativo facendo comprendere che essi sono pescatori di Aci Trezza.
Testo B) Verga ha evitato di inserire un profilo dei personaggi principali come Felice Cameroni suggerisce e mette in conto che il lettore si possa trovare in difficoltà e non comprenda.
Testo C) Verga dice a Cameroni che il suo obiettivo primario è quello di rappresentare la verità senza retorica e senza l'uso di artifizi. Il personaggio non deve avere una descrizione puntuale, ma il lettore deve riconoscere i comportamenti e i modi di fare dal "modo di soffiarsi il naso" (v. 11).
Testo E) Testo E) Verga, rivolgendosi al romanziere Rod, parla del suo progetto intitolato il ciclo dei Vinti e che è difficile rappresentare le classi più elevate. Egli anticipa che nella Duchessa rispetto ai Malavoglia (persone umili) sarà più difficile rappresentarle perché più forbite, meno immediati e spontanei.
L'impersonalità del narratore Emile Zola Giovanni Verga
IMPERSONALITÀ A PARTE SUBJECTI IMPERSONALITÀ A PARTE OBIECTI
Il narratore si pone dall'alto in modo distante rispetto a ciò che egli rappresenta.
Il narratore si cala nella realtà da rappresentare e si nasconde tra i personaggi.
«Nonostante la pulizia, un odore di cipolle cotte, stagnanti dal giorno prima, avvelenava l'aria calda.» da Germinal
Incipit Rosso Malpelo: i capelli rossi, per superstizione, denotavano i birboni.
Verga e Zola Zola Verga
Pensiero Naturalismo francese Verismo
Contesto di provenienza Realtà dinamica della Francia, dove si registra un forte sviluppo economico
Realtà arretrata e statica del Meridione d'Italia, in particolare della Sicilia
Ideologia La società è regolata da leggi spiegabili scientificamente
La società è regolata da rapporti di sopraffazione immutabili
Finalità della letteratura La letteratura ha funzione conoscitiva e la conoscenza può migliorare la società
La letteratura ha una funzione conoscitiva, ma non può modificare la realtà
Tecnica narrativa Impersonalità come distacco scientifico dalla materia analizzata; il narratore commenta le vicende
Impersonalità intesa come "eclisse" del narratore che non esprime giudizi e non dà spiegazioni
9
Vita dei campi Composta da Cavalleria rusticana, la Lupa, Jeli il pastore, Fantasticheria, l'amante di Gramigna, Guerra di Santi e Pentolaccia; essi rappresentano il mondo popolare, il conflitto fra l'individuo "diverso" e il contesto sociale che lo rifiuta ed espelle.
Rosso Malpelo
Novella appartenente a "Vita dei campi". Segna la svolta dell'adesione alla tendenza verista.
Tecniche:
Si usa lo straniamento cioè una tecnica narrativa che consente di far apparire un fatto normale come se fosse strano; es. dal punto di vista del minatore, il fatto normale che Malpelo cerchi il cadavere del padre appare come strano.
È presente anche lo straniamento rovesciato: da fatto strano lo si fa apparire come normale; es. il fatto strano che la madre e la sorella non si occupino del "birbone" appare normale.
Contenuto: Rosso Malpelo è il soprannome dato a un ragazzo con i capelli rossi, gli occhiacci grigi, un monellaccio che lavora in miniera per pochi tarì, meno di quelli per cui suo padre Misciu Besta perse la vita. Malpelo esca dalla cava il sabato per portare la misera paga settimanale alla madre; al lavoro maltratta l'asino grigio che a stento si regge in piedi e Ranocchio, ragazzo zoppo, che picchia per farlo abituare alla vita crudele; tale ragazzo a cui Malpelo vuole bene, poco dopo si ammalerà e morirà con la madre piangente accanto. Diversa sorte toccherà all'impavido che decide di imbattersi alla scoperta di una nuova via con gli arnesi del padre: non ritornerà mai più a casa e di lui si persero anche le ossa.
Narratore: il narratore non è onnisciente, nei confronti di Malpelo è disumano, ottuso e duro, privo di compassione tanto quanto i minatori della cava, il narratore non ha perciò la visione dell'uomo colto, ma si eclissa. Verga evita che il lettore si commuova perché vuole presentare la realtà così com'è.
Descrizione di Rosso Malpelo:
La "filosofia" di Rosso Malpelo è il pensiero con cui egli conduce la propria vita: resiste e sopporta le sofferenze e i soprusi che gli si presentano perciò per lui, è necessario attrezzarsi per superare gli ostacoli. Il suo pensiero è diverso da quello dei minatori che credendosi più furbi, lavorano il meno possibile perché secondo loro è meglio. Usando la violenza cerca di far abituare coloro che, per la loro condizione debole, sono destinati a soccombere.
Egli ha un buon rapporto con suo padre, mentre la madre prova totale disinteresse per il figlio. Il ragazzo va incontro alla morte rivivendo la sorte del padre portando con sé gli arnesi paterni in modo da sentirsi a lui più vicino.
Nutre affetto per l'asino grigio e Ranocchio, soggetti deboli sfruttati ed emarginati da tutti, li percuote e gli fa dispetti affinché si abituino agli ostacoli della vita.
Decide di morire nelle viscere della Terra per ricongiungersi al padre: normalmente, simboleggia il ritorno alle membra materne da cui si nasce e quindi si accosta alla madre, in questo caso lo si associa al padre.
10
Ciclo dei Vinti Verga traccia un quadro sociale, delineando tutte le classi sociali e narrando i «vinti»; per questo si
propone di scrivere 5 romanzi (rappresentanti ognuno un ceto sociale): I Malavoglia: popolo e i relativi bisogni; Mastro Don Gesualdo: borghesia di provincia; la Duchessa di Leyra: la borghesia; l'Onorevole Scipioni: ambizione politiche; l'Uomo di Lusso: tutte le ambizioni.
La Duchessa di Leyra non completato interamente, l'Onorevole Scipione e l'Uomo di Lusso nemmeno iniziati perché:
Verga è vecchio e privo di forze;
al Verismo stava subentrando il Decadentismo;
l'autore incontra numerose difficoltà a rappresentare le classi più elevate.
Il Ciclo dei Vinti rappresenta coloro che soccombono e falliscono; esprime pessimismo per cui il destino è immodificabile e l'uomo non può fare altro che accettarlo così com'è. La società si basa perciò su una continua lotta di classi in cui i più deboli sono destinati a soccombere.
I Malavoglia Si tratta di un romanzo corale cioè tutti i personaggi sono posti sullo stesso piano.
Intreccio: è la storia di una famiglia di pescatori siciliani, i Toscano, c.d. Malavoglia, che vivono ad Aci Trezza. Possiedono una barca chiamata la "Provvidenza" che consente loro di avere una vita tranquilla. Nel 1863, il giovane 'Ntoni, figlio di Bastianazzo e nipote di padron 'Ntoni, il vecchio patriarca deve partire per il servizio militare. Per questo, la famiglia si troverà in difficoltà e dovrà pagare un lavorante. S'aggiunge una cattiva annata per la pesca e il fatto che la figlia maggiore, Mena, ha bisogno di una dote per sposarsi. Padron 'Ntoni, per superare le difficoltà, compra a credito dell'usuraio Zio Crocifisso un carico di lupini per rivenderli in un porto vicino. La barca naufraga, Bastianazzo muore e il carico è perduto. Comincia da qui una lunga serie di sventure: la casa viene pignorata per via del debito contratto con l'usuraio; Luca, il secondo genito, muore nella battaglia di Lissa; la madre, Maruzza, è uccisa dal colera; la Provvidenza riparata dopo il naufragio, naufraga nuovamente. Il nucleo famigliare si disgrega: 'Ntoni, conosciuta la vita delle grandi città, non si adatta più alle fatiche e agli stenti; comincia a frequentare cattive compagnie, è coinvolto nel contrabbando e finisce per dare una coltellata alla guardia doganale che tra l'altro corteggiava la sorella minore, Lia. 'Ntoni ottiene una condanna attenuata, Lia ormai disonorata fugge e finisce in una casa di malaffare. Padron 'Ntoni, atterrato dalle sventure, muore in un ospedale. L'ultimo figlio, Alessi, riesce a riscattare la casa del Nespolo con la sorella Mena e decide di continuare il mestiere del nonno. 'Ntoni, uscito dalla prigione, s'allontana dalla famiglia per sempre.
Il sistema dei personaggi è bipolare: da un lato si contrappone la famiglia Toscano (che si distingue per i valori come famiglia, umiltà, …), dall'altro la comunità del villaggio (avidità ed egoismo).
Personaggi: non ce ne sono in particolare rilievo, alcuni sono più presenti come Padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni che rappresentano due mondi che si scontrano (antichità vs modernità). Il ragazzo è descritto con un'accezione negativa e perciò dovrà trasferirsi abbandonando il suo paese natio; mentre Padron 'Ntoni è definito come un "minchione" da parte della comunità del villaggio perché vuole saldare tutto il debito dei lupini (evince l'onestà del personaggio, ma è straniamento rovesciato), è coerente con l'eclisse dell'autore che non giudica e assume il punto di vista del villaggio rimanendo impersonale.
Tempo:
ciclico cioè lento con andamento circolare, tipico del mondo arcaico, legato alle tradizioni contadine e alle stagioni;
storico poiché vi sono tappe precise e va dal 1863 al 1878. I fatti caratterizzanti sono la battaglia di Lissa, il colera e l'arrivo della ferrovia.
11
Spazio:
esterno: visto negativamente, indica il male, il mistero ed è tutto quello al di fuori della Sicilia;
interno: limitato al villaggio di Aci Trezza, luogo noto e conosciuto. Vi è un ulteriore opposizione tra il villaggio di Aci Trezza (spazio esterno) e la casa del Nespolo (spazio interno, luogo dove si riunisce la famiglia, nido protettivo dal male esterno).
Linguaggio: si usa la lingua italiana, ma vi sono molte espressioni dialettali per le ingiurie, per i proverbi popolari e i modi di dire, perché Verga si vuole rivolgere a un pubblico ampio.
La conclusione non è a lieto fine: avviene il riscatto della Casa del Nespolo da parte di Alessi, in molti muoiono ('Ntoni e Lia). Verga dedica un ampio spazio all'addio definitivo del giovane 'Ntoni e minore spazio per la riappropriazione della casa del Nespolo.
I «vinti» e la «fiumana del progresso» Testo prefazione dei "Malavoglia" appartenente al ciclo dei Vinti.
Verga, con un atteggiamento pessimistico, inserisce delle considerazioni sul progresso: usa l'espressione «fiumana» per indicare il progresso perché ha un'accezione negativa ambivalente a quella positiva ed indica una forza violenta che trascina gli uomini e fa sì che i più deboli, i Vinti, siano sopraffatti.
Mastro Don Gesualdo Romanzo di Verga, facente parte del Ciclo dei Vinti, pubblicato nel 1889.
Protagonista: Mastro Don Gesualdo Motta (mastro: muratore; don: titolo attribuito a persone di potere in senso di riverenza, ai grandi proprietari terrieri e ai capimafia). Egli da una condizione umile aspira ad essere accolto nella società aristocratica perché con il duro lavoro negli anni è riuscito ad accumulare una quantità notevole di ricchezza e terreni. Il matrimonio con Bianca è combinato: la famiglia della donna è nobile, ma è in condizioni misere (ella è senza una dote adeguata), Gesualdo gode di notevoli ricchezze, ma è privo di titolo nobiliare. La figlia Isabella è nata da una relazione con il cugino (che ama e non può sposare ---> "vinta") e anch'essa ama il cugino Corrado, ma sarà costretta a sposare il Duca di Leyra. Isabella è stata abituata a vivere lontano da casa in un collegio di suore. Gesualdo ha una relazione con Diodata ("amata da Dio"), orfana, forse figlia illegittima, serva e sincera amante che non può sposare per mantenere la reputazione; con essa, avrà dei figli che non riconoscerà e vivrà una vita dura.
Gesualdo un uomo «vinto» su due fronti:
sul piano affettivo: Gesualdo ha sposato una nobile, Bianca Trao che non lo ama. Isabella, non riconoscendolo come genitore, ne sottolinea le condizioni umili. I propri fratelli lo odiano per il modo di arricchimento. —› Nessuno prova affetto e amore per lui.
sul piano sociale ed economico: ambisce ad entrare nel mondo aristocratico, ma non verrà accettato, nonostante accumula grandi ricchezze lavorando. Tale patrimonio ("roba") verrà dilapidato dalla figlia e dal genero.
Verga tratta di un ambiente borghese e aristocratico. Il narratore dei fatti è Mastro Don Gesualdo; non è un narratore onnisciente perché non da esaurienti informazioni riguardanti i personaggi, ma li descrive come se già lì conoscesse. Non è un romanzo corale, infatti la narrazione è focalizzata sul protagonista; è presente anche mediante il discorso indiretto libero per riportare i pensieri del protagonista.
Conclusione: Gesualdo dalla vita in campagna è costretto dalla figlia a trasferirsi a Palermo, vive isolato fino alla sua morte (di cancro allo stomaco) e il servo attende l'ora giusta per avvisare la figlia. (I servi non lo rispettano in quanto non nobile).
Verga mette in evidenza due modi di vedere la vita diversi, due "mondi inconciliabili": Gesualdo infaticabile lavoratore non si è mai concesso un lusso e comprende la fatica per guadagnare e si contrappone con l'aristocrazia che vive nel lusso con sprechi ed eccessi. «Il pesco non si innesta nell'ulivo» (Mastro Don Gesualdo, I Capitolo) sottolinea il distacco tra due mondi che non hanno più niente in comune.
12
La morte di Mastro Don Gesualdo Testo tratto da Mastro Don Gesualdo, scritto da Verga.
Isabella non va d'accordo con il marito, il duca di Leyra: il pallore del suo viso denota la tristezza, l'infelicità di vivere con un uomo non amato. Tiene la distanza dal "padre" che non è il padre genetico.
Il cocchiere, i servi, … trascorrono il tempo nell'ozio perché in gran numero, lavorano solo quando il duca si appresta ad uscire. Il duca non si cura degli sprechi del palazzo, i servi si prendono il gioco di lui, mentre Gesualdo controlla i suoi dipendenti.
Gesualdo chiuso in una stanza della casa della figlia rimpiange l'aperto dove è nato che lo rendeva felice. Si può distinguere uno spazio chiuso (la casa della figlia) e uno aperto (la campagna).
L'uomo dà consigli alla figlia e al genero, gli dice di non dilapidare i beni del suo patrimonio evitando di venderli, ma è consapevole che succederà poiché essi conducono una vita troppo lussuosa. Con "roba" indica i beni e il patrimonio di Gesualdo.
DECADENTISMO Origine del termine: si tratta di
un movimento letterario sorto in un dato ambiente, quello parigino negli anni 1870/80/90 (in contemporanea al Naturalismo francese) e con programmi, testi e tempi precisi. Nel 1883, Verlaine pubblica sulla rivista "le Chait Noir" Languore.
un modo di pensare / movimento culturale di ampie dimensioni che occupa un intero secolo, l'Ottocento (per poi proseguire nel primo Novecento).
In Francia il decadentismo assume il nome di "Simbolismo".
Elementi caratterizzanti:
rifiuto del Positivismo (si mette in dubbio la scienza e la fiducia nel progresso), vi è un'esaltazione dell'irrazionalità (misticheggiante); perciò la realtà non è conoscibile, bisogna superare la superficie delle cose per cogliere il mistero della vita. Gli strumenti sono tutte le condizioni della coscienza dell'uomo che hanno a che fare con le situazioni abnormi (sogno, incubo, malattia, allucinazioni, ...), solleticati dall'uso di droghe e alcool.
coincidenza tra io e il mondo, tra oggetto e soggetto che si confondono in un'unica unità, cioè la coscienza individuale si fonda su sé stessi e in un mondo misterioso.
stato di incoscienza (in questo periodo si scopre questa dimensione, infatti Sigmund Freud pubblicherà "l'interpretazione dei sogni"): fondamentale è tutto ciò che caratterizza ciascuno senza razionalità e che garantisce la scoperta di una realtà più vera.
Prevalgono tematiche negative, così come nel romanticismo; il decadentismo è un'estremizzazione del romanticismo, deriva dalla reazione dell'individuo che reagisce alla Rivoluzione Industriale, si genera perciò noia, tedio e crollo di certezze.
Nei testi decadentisti e simbolisti si fa largo uso di sinestesie (scambio di sensi).
Estetismo: il principio che regola la vita è il bello, non i valori morali che gli uomini comuni hanno. Vi è una stretta connessione con le arti, poiché si afferma che bisogna "fare della propria vita un'arte"; si crea perciò la c.d. regione del bello e dell'arte, principio basilare simile alla "religione della roba" di Verga.
Decadentismo e Romanticismo: Elementi di continuità
Lo sfondo socioeconomico è il medesimo: la società è sconvolta dagli sviluppi della Rivoluzione industriale che si affaccia con violenza.
L'individuo è in crisi: di fronte a lui, incombe una realtà misteriosa che minaccia di schiacciarlo.
Comune irrazionalismo, rifiuto della realtà e della fuga verso un "altrove" ideale e fantastico.
13
Differenze
Il Romanticismo tende verso uno slancio entusiastico, verso l'infinta espansione dell'io; il Decadentismo è contrassegnato da un senso di stanchezza, estenuazione, languore, smarrimento, presentimento di fine e di sfacelo, che induce a ripiegarsi nell'analisi della propria "malattia" e debolezza.
La letteratura del Romanticismo ha ambizioni costruttive e mira a grandi sintesi esaustive, vaste costruzioni concettuali e artistiche; il Decadentismo non punta alla totalità, ma al frammento, tende a opere brevi, dense, ama il frammento slegato da un tutto organico e nel frammento si concentra tutta l'energia poetica.
Decadentismo e Naturalismo: si tratta di movimenti letterari contemporanei che si sviluppano nel 1870/80/90. Gli scrittori decadenti patiscono le contraddizioni del sistema e i meccanismi di esclusione e di emarginazione e rifiutano la visione positivista del Naturalismo. Si tratta di tendenze mescolate fra di loro: aspetti decadenti sono ravvisabili in scrittori naturalisti e viceversa aspetti naturalistici sono presenti in quelli decadenti.
SIMBOLISMO Corrente poetica specifica del Decadentismo che si afferma in Francia nella seconda metà
dell'Ottocento. Con esso, si attua una rivoluzione poetica: la poesia è la rivelazione dell'essenza più profonda e misteriosa delle cose, non conoscibile con la logica e la razionalità.
Esso non è inteso in senso letterale, ma come simbolo di un concetto cioè si allude ad altri concetti; perciò si usa un linguaggio indefinito, evocativo e allusivo.
Goethe spiega la differenza tra:
allegoria: il fenomeno è trasformato in concetto, a sua volta trasformato in immagine completa, circoscritta e chiara (es. Selva: allegoria del peccato)
simbolo: trasforma il fenomeno in idea e a sua volta in immagine indeterminata, inaccessibile e inesprimibile cioè lascia nell'incertezza.
I maggiori autori sono Verlaine, Rimbaud e Mallarmé che si ispirano al maestro Charles Baudelaire che pubblica " I fiori del male".
Verlaine e Rimbaud ebbero una storia tra loro facendo scandalo; quando Rimbaud decise di lasciarlo, Verlaine lo sparò e per questo, venne arrestato.
Charles Baudelaire
Fiori del male È una raccolta di testi poetici scritta da Baudelaire.
È stata bollata per il titolo come un'opera scandalosa e oscena: il fiore dà l'idea di purezza, semplicità, gentilezza e bellezza quindi elementi positivi e si contrappone al male.
Ha una funzione evocativa, anticipa i poeti che mirano a sciogliere la poesia in musica (es. Verlaine) e i poeti "veggenti", tesi a decifrare la rete misteriosa di simboli che avvolge il reale (es. Rimbaud).
Corrispondenze È un testo programmatico del simbolismo francese, parte integrante dei "Fiori del male" di Baudelaire.
Usa un linguaggio evocativo ed allusivo. Usa sfumature, il discorso analogico e accostamenti di elementi lontani fra loro.
Secondo lui, la natura è un insieme di simboli misteriosi di cui si serve la poesia.
Inserisce numerosi riferimenti ai sensi. Sensazioni olfattive, visive e uditive come "i profumi e i colori e i suoni si rispondono" (vv.5 - 6) creando così corrispondenze. La realtà è misteriosa, inconoscibile e incerta e scopribile solo in condizioni di estasi e sogno.
14
Paul Verlaine
Languore Sonetto scritto da Verlaine, facente parte della rivista "Le Chait Noir".
Il titolo "Languore" attribuitogli dall'autore, dà l'idea del lasciarsi andare e non agire.
Si parla del termine "decadentisti" che la gente attribuisce con un'accezione negativa ai componenti del decadentismo, che però lo usano con vanto.
Contenuto: 1°strofa: Concetto di decadenza e il "guardar passar", caratteristica del decadentismo cioè l'inerzia e
la stanchezza 2°strofa: Si sottolinea il non volere agire dei decadentisti. 3°strofa: Riferimento a Batillo, nome di un mimo per indicare che tutto è finito e non c'è nessuna
fiducia nel futuro. 4°strofa: Quel che rimane è solo un poema, un vuoto da buttare alle fiamme, uno schiavo, un
qualcosa che consuma l'anima fino alla morte.
Parole chiave: solitudine, noia, tedio, fato (vuoto, vanità), decadenza, frivolo, fatuo.
Arte poetica È un testo poetico che racchiude un misto di preciso e impreciso ed esprime delle incertezze.
Secondo Verlaine, il verso è libero e non deve sottostare alle regole della Rima; la letteratura è un insieme di regole da rifiutare ed è composta da versi di sillabe dispari.
Contenuto: 1°strofa: Il verso impari costringe a passare al verso successivo, quindi è meglio evitarlo. 2°strofa: Le parole devono essere scelte con malizia, non devono essere né bianco né nero poiché il
colore è ricco di sfumature. 3°strofa: Rimanda a una serie di sensazioni visive ed uditive con l'espressione "fremito" (v. 10) e
"tepido" (v.11). 4°strofa: È necessario cercare le sfumature che rendono possibile l'unione con i sogni. L'"oboe" e il
"flauto" sono strumenti simili ma differenti (sfumatura). 5°strofa: Evita la battuta pungente, l'arguzia e il riso impuro perché sono come l'"aglio di bassa
cucina" (v.20) cioè hanno un odore, un puzzo pungente, e si contrappongono alla poesia pura ("Azzurro" (v.19)).
6°strofa: / 7°strofa: È necessario lasciare libera la Rima che ha tante colpe così come la lima cioè attività volta ad
applicare una serie di regole per revisione. 8°strofa: Richiama la musica del primo verso. 9°strofa: Inserisce sensazioni olfattive "menta e timo" (v. 35) accostandole al verso che non deve
sottostare alle regole della Rima.
15
Arthur Rimbaud
Vocali Scritto da Rimbaud e appartenente alla raccolta "Poesie".
È un sonetto in cui si usa un linguaggio analogico cioè la poesia si serve di immagini collegate logicamente tra loro in modo da rappresentare una realtà misteriosa, inconoscibile ed ignota.
Vi è il c.d. fonosimbolismo cioè i suoni che compongono le parole sono simboli.
Si fa riferimento alle vocali, ognuna delle quali rimanda a un colore: nero "corsetto villoso", "mosche lucenti", "ombra"
bianco "candori di vapori e di tende", "lance di ghiacciai superbi", "re (vestiti di) bianchi", "brividi di umbelle (baldacchini mossi dal vento)"
rosso, porpora "sangue sputato", "riso di labbra belle …"
verde "cicli", "vibrazioni divine", "pace dei pascoli seminati di animali", "pace di rughe … nelle ampie fronti studiose"
blu "l'Omega", "raggio violetto dei Suoi Occhi"
Al termine si tratta della morte richiamandola con l'Omega (ultima lettera dell'alfabeto greco, fine di un ciclo) e il "violetto", colore anch'essa alla morte.
DECADENTISMO IN ITALIA
Gabriele D'Annunzio Nato a Pescara in una famiglia borghese.
Iniziò la sua carriera da scrittore con "Primo Vere", un libretto di versi. Negli anni giovanili, D'Annunzio è influenzato da Carducci e Verga, poi aderirà all'estetismo, al mito del superuomo e al panismo.
Ha una produzione letteraria abbondante, si dedica a vari generi letterari e al teatro. Le sue più importanti opere sono:
Il Piacere l'estetismo romanzo
Le vergini delle rocce il mito del superuomo poesia
Alcyone (Laudi) musicalità e panismo
Notturno — prosa
Esperienze di vita di Gabriele D'Annunzio:
Beffa di Buccari: tra il 10/11 febbraio 1918 (fine guerra mondiale) nella baia di Buccari in Croazia, D'Annunzio con un motoscafo antisommergibile lascia tre bottiglie beffarde contenenti il testo della beffa (chiuse con il tappo di sughero e abbandonante sul luogo). ---> Egli non ha uno scontro diretto con il nemico, ma vuole beffarsi dell'avversario.
Volo su Vienna: il 9 agosto 1918 D'Annunzio che possedeva un piccolo aereo parte da San Pelagio (vicino Padova) per arrivare su Vienna dove lascia messaggi contro il nemico austriaco.
Marcia su Fiume: nel 1919, con alcuni volontari D'Annunzio occupa Fiume in segno di protesta perché l'Italia ha vinto la guerra, ma si tratta di una "vittoria mutilata". Nel 1920, lo stato italiano, con il trattato di Rapallo, lo costringerà a lasciare la città.
—› data la sua mania egocentrica e ama stupire, questi i suoi modi per partecipare alla guerra.
Orientamento ideologico e politico: divenne deputato dell’estrema destra provando disprezzo verso i principi democratici ed egualitari. Tre anni dopo, cambiò schieramento passando a quello di sinistra. Elaborò ideologie, slogan ed atteggiamenti fatti propri dal fascismo, ad esempio “Mare nostro”.
Stile di vita: ama l'arte, si circonda di lusso, ama far parlare di sé.
Scelte linguistiche: linguaggio aulico, ricercato, quasi sovrabbondante.
La sua visione della società è elitaria, al di sopra degli uomini comuni disprezzati perché mediocri. Prova disprezzo per la democrazia, il Parlamento.
16
Il Piacere Romanzo scritto nel 1889 da Gabriele D'Annunzio decadente e psicologico cioè evidenzia l'interiorità del
protagonista. Ha una trama scarna: eventi di poco rilievo, ma tratta le interiorità dei personaggi perché rimandano ad una realtà nascosta e misteriosa.
Contenuto: Andrea Sperelli, aristocratico ed esteta (ama circondarsi e vivere nel mondo dell'arte) che ha due relazioni sentimentali con:
Elena Muti: riferimento a Elena di Troia, donna ammaliatrice che attrae l'uomo e lo porta alla distruzione (simile alla femme fatal) —› color rosso;
Maria Ferres: rimanda alla Vergine Maria pura e casta —› color bianco. In un incontro in intimità immagina di trasferire le caratteristiche di Elena su Maria e la chiama con il nome dell'altra; entrambe lo lasceranno determinando in lui il c.d. fallimento amoroso.
Si fa largo uso dell'indiretto libero.
Una fantasia «in bianco maggiore»
Tratto dal "Piacere" di Gabriele D'Annunzio.
Il titolo fa riferimento sia ai colori "bianco" (sensazioni visive) sia a "maggiore" (sensazioni uditive).
Contenuto: Elena ha invitato Andrea ad attenderla in carrozza dinanzi al palazzo Barberini dove abita; Andrea, nell'attesa, fantastica su Maria. L'ambiente descritto accuratamente è notturno, splendente, caratterizzato dalla luna piena (plenilunio) e biancheggiante a causa della neve cioè rievocante la purezza e il candore. La vicenda del romanzo non segue un ordine logico-cronologico, ma viene spezzata da anacronie cioè salti nel tempo.
Lingua: aulica e ricercata.
Parole chiavi: immaginazione, immateriale, sogno.
Vi sono espressioni rimandanti al rito liturgico, come "Ave" e "Amen".
Pallore rimanda alla donna dello stilnovismo di Dante.
Vi sono colori come "bianchezza" (v. 37), "cerulea" (vv.14, 43), "zaffiro" (v.43) e "azzurro" (v. 52).
Le descrizioni che partono da un dato reale sono filtrate dall'immaginazione dell'autore. Il dettaglio dei capelli di Elena "nascosti in una fascia" (v.41) poi si "effondono … come un gran flutto oscuro" (v.56) e "le care labbra " (v. 55) sono attribuite a Maria.
Le Vergini delle Rocce Poesia scritta da Gabriele D'Annunzio.
Il titolo è ispirato dal capolavoro artistico di Leonardo Da Vinci in cui si rappresenta dettagliatamente un paesaggio (esposto al Louvre a Parigi) con animali e piante. D'Annunzio sceglie tale titolo perché prova interesse verso l'arte e perché tale opera esprime una concezione decadente a causa del castello maltenuto, decadente e isolato.
Contenuto: tratta di tre sorelle Montaga, figlie del principe Montaga, esponenti della nobiltà aristocratica borbonica. Claudio Cantelmo deve scegliere tra loro la sua futura sposa e originare con lei, un superuomo. Egli non raggiungerà l'obiettivo, il romanzo non avrà una vera e propria conclusione.
Mito del superuomo: il superuomo è un uomo che ha un disegno politico tale da riportare Roma ai fasti dopo la decadenza dell'Impero. D'Annunzio rimanda al pensiero di Frederich Nietzsche, filosofo tedesco autore di "Così parlò Zarathustra".
Il pensiero spirituale di Nietzsche si contrappone a quello di D'Annunzio che lo afferma in termini dittatoriali: il superuomo s'impone della società diventando dittatore.
17
Übermensch traduce in "superuomo" (violenza, sopraffazione), ma il termine corretto è "oltre l'uomo" (supera sé stesso, con una visione individualistica).
Il programma politico del superuomo D'Annunzio caratterizza il popolo trattando dell'"arroganza delle plebi" (v. 1), "malfattori" (v.4), cioè
prova un'accezione negativa verso di esso ed esprime la sua concezione politica elitaria (non democratica, ma oligarchica).
Usa uno stile colorito, passionale.
Contenuto: esalta l'Impero Romano, prova disprezzo verso il Regno d'Italia alla fine degli anni Ottanta in cui vi è una monarchia parlamentare. Gabriele D'Annunzio esplicita che non è necessario esaltare il suffragio universale, l'uguaglianza, affrettare la caduta del Re, l'avvento delle Repubbliche, modalità mediante il quale le plebi accedono al potere (democrazia); per lui, occorre difendere la bellezza.
Le Laudi Gabriele D'Annunzio imitando Verga scrive una raccolta poetica chiamandola le Laudi del Cielo, della
Terra e delll'Eroe composte da 7 libri intitolati con i nomi mitologici delle stelle che costituiscono la costellazione delle Pleiadi: Maia, Elettra, Merope, Asterope, Taigete e Celeno.
Tale progetto non sarà portato a termine: Taigete e Celeno non vennero nemmeno iniziati da D'Annunzio. Merope tratta dell'esaltazione della guerra italo-turca e raccoglie testi sull'impresa di Lidia. Asterope parla degli ideali bellici e nazionalisti e riguarda la Prima Guerra Mondiale. Alcyone è un diario scritto in Versilia tra giugno e settembre nel 1899 (periodo propizio al godimento dei sensi e all'amore).
Alcyone
La sera fiesolana
Poesia tratta dall'"Alcyone" e scritta da Gabriele D'Annunzio.
Contenuto: Oltre l'io lirico, si fa riferimento a una donna chiamata Ermione, descritta come una donna angelicata dello stilnovismo.
1°strofa: Intitolata "la natività della luna". Tratta della luna che sta per sorgere "distenda un velo" (v. 9); rimanda a un'immagine incerta, infatti la luna si presenta come una teofania cioè come se fosse una divinità che appare.
1° ripresa: La sera è rappresentata con il viso di una donna dove la pioggia si tace. 2°strofa: Intitolata "la pioggia di giugno" perché descrive la pioggia estiva; la primavera lascia il posto
all'estate, si usa un'immagine vaga e indefinita per cogliere il momento di trapasso. Traspare la musicalità della pioggia che cadendo sugli olivi, fieno, … produce suono. L'ulivo rimanda all'idea della pace poiché "fratello" e alla religiosità di San Francesco d'Assisi. Il verde che trascolora rimanda al pallore e alla santità.
2° ripresa: La sera è di nuovo personificata: si allude ai profumi che aleggiano nell'aria nelle sere calde di giugno.
Così parlò Zarathustra
Scritto da Frederich Nietzsche.
Contrario al conformismo della società borghese e alla razionalità scientifica.
Propone il c.d. spirito dionisiaco (derivante dalla cultura greca): energia ed entusiasmo che consente all'uomo di realizzare gli obiettivi superiori alla realtà. Si contrappone al c.d. spirito apollineo: razionalizzazione dei comportamenti dell'uomo; il cristianesimo (non agire, mediocrità) spinge l'affermarsi di tale spirito: l'uomo umile accetta il destino così com'è con un atteggiamento passivo.
Secondo Nietzsche, l'uomo deve tendere e superare sé stesso per realizzare oltre l'uomo, cioè spingersi oltre i propri limiti; non lo usa termini pratici o politici, ma lo interpreta spiritualmente in chiave individualistica.
18
3°strofa: Rimanda alla sensualità, all'erotismo e inserisce un messaggio amoroso: le colline sono paragonate a due labbra chiuse da un misterioso divieto che impedisce loro di parlare, ma esse sono ansiose di rilevare il messaggio; perciò vi è una funzione consolatrice: ogni sera l'anima le ama di un amore sempre più forte. Le fonti e i fiumi sono considerati sacri perché contribuiscono a creare un'atmosfera sensuale e ispiratrice dell'amore.
3° ripresa: Passaggio dalla sera alla notte rimanda alla morte. Ripresa (vv. 15-17; vv. 32-34; vv. 49-51): formata da un endecasillabo, un quinario oppure un settenario cioè un ipermetro (verso che supera la lunghezza) e un quinario.
Presenta numerose figure retoriche di suono, tipiche del decadentismo. Largo uso di enjambement.
Numerosi i riferimenti ai colori come "s'annera", "rosei", "cerule", "verde", biondo", "s'argenta", "trascolora", "perla"; ma anche quelli ai rumori come "silenzioso", "fruscio".
Traspare anche il panismo; vi sono espressioni come "rosei diti", "pini che giocano", "clivi e sorridenti".
La pioggia del pineto Poesia tratta dall'"Alcyone" e scritta da Gabriele D'Annunzio; costituita da 4 strofe, versi liberi (quinari, senari, settenari, ottonari, novenari e versi trisillabi come "lontane" (v.6)).
L'io lirico si rivolge a un interlocutore Ermione, donna stilnovista, usando un'imperativo come "taci" (v. 1) e "ascolta" (v.8).
Ricorre la musicalità: la pioggia sollecita l'immaginazione uditiva perché cadendo causa suoni diversi e sembra che il cicalio si faccia sordo a causa della rana: si usa una climax (crescente) e un anti-climax (decrescente).
Vi è anche il panismo (dal greco, "pos" cioè tutto): l'uomo diviene un tutt'uno con il mondo vegetale; alcune espressioni sono "volti silvani" (vv. 20-21), "spirito silvestre" e "arborea vita" (vv. 53-55), "fatta virente" (v.100), "vita … aulente" (vv. 102-103), "palpebre … tra l'erbe" (vv. 105-106), "denti … come mandorla acerbe" (vv. 108-110), "volti silvani" (vv.116-117).
Ieri e oggi richiamano a un gioco di parole così come io e tu.
Parole chiave: sogno, ecstasy, favola che richiamano una realtà misteriosa.
Molte sono le anafore come "piove", "su", "che", che richiamano ancora la musicalità.
La prosa "notturna" Prosa moderna scritta da D’Annunzio e tratta da "Notturno". È una serie di annotazioni e appunti e
rappresenta l'ultima produzione letteraria di D'Annunzio: presenta caratteristiche proprie, ma coesistono con elementi decadenti.
Si riscontrano immagini frammentate, analogiche e numerose sensazioni uditive che egli avverte perché esse coincidono con un periodo di malattia e sofferenza: a causa di un distacco di una retina dovuta ad un incidente in aereo, è costretto a stare bendato, al buio. (tale disturbo si protrarrà a lungo, infatti nella casa della Prioria egli aveva tendaggi pesanti per impedire il passaggio della luce). L'importanza di tali è costatabile da una serie di imperativi "sento" e "ascolto".
Vi sono numerose onomatopee come "chioccolio", "ronzio" e "ticchettio".
Stile: secco, non particolarmente articolato, nervoso (simile all'altro brano).
Contenuto: 1° parte: inserisce immagini reali che circondano il poeta: sia voci umane, sia una serie di dettagli
riguardanti il luogo in cui egli si trova, Venezia, come "battello", "bassa marea" e "remo". 2° parte:
inserisce una serie di immagini surreali che hanno a che fare con la sofferenza. Dato il problema visivo, egli vede le figure violacee. Es. afferma di vedere l'immagine di un fiore con il gambo che s'allunga (figura strana e cupa)
come altri testi, come ad esempio in "Vocali" di Rimbaud, si usano i colori per rimandare a sensazioni cupe (nero e violetto).
Vi sono impressioni illogiche sollecitate dai sensi simili ad allucinazioni.
19
Nella belletta Tratto dall'Alcyone di Gabriele D'Annunzio. Il tema trattato è la morte.
Non celebra il vitalismo panico (non si adora la natura e ci si confonde con essa), ma l'uomo avvicinandosi ad essa, cade in un profondo silenzio solenne e terribile così come la morte.
Gli oggetti verso cui il poeta volge la propria attenzione sono i giunchi e la palude; i primi sono paragonati a "persiche mezze", "rose passe", "miele guasto" (vv. 3-4) e quindi alla morte. La palude invece è descritta come un "fiore lutulento" (vv. 5-6) cotto dal sole d'agosto.
Critica letteraria e Gabriele D'Annunzio D'Annunzio è indicato come un "cattivo maestro" anche se il suo modo d'essere e di fare ha goduto
interesse nel pubblico.
Recentemente, a prescindere dai temi, è stato ampiamente rivalutato poiché è stato in grado di influenzare numerosi poeti del Novecento (Montale e Ungheretti) sul piano formale (lessico, metrica, …). Ad es., a livello sintattico, vi è l'uso dello stile nominale (assenza del verbo), ricorso alle onomatopee/assonanze/rime imperfette di lunghezza variabile) e l'uso dell'ipermetro.
GIOVANNI PASCOLI Era un piccolo borghese rurale di condizione abbastanza agiata appartenente a una famiglia patriarcale
molto numerosa (10 figli).
Fu sconvolto dalla morte del padre Ruggero ucciso a fucilate. A causa di questa perdita si crearono una serie di difficoltà economiche per cui si trasferirono e il fratello maggiore, Giacomo assunse un ruolo paterno. Seguirono una serie di lutti: quello della madre, della sorella e i due fratelli Luigi e Giacomo.
Orientamento ideologico e politico: negli anni universitari egli subì l’ideologia anarco – socialista che proprio allora si diffondevano. Dal socialismo divenne socialista umanitario cioè crede che nella società vi debba solidarietà, la bontà, l’amore, la fraternità tra gli uomini. In ogni caso Pascoli celebra il nucleo familiare che si raccoglie entro la piccola proprietà: tale legame si allarga fino ad inglobare l’intera nazione. Per lui, l’italiano che si è costretto al lasciare il suolo della patria è come colui che viene strappato dal « nido››. —› nazionalismo pascoliano. Partecipò attivamente a varie manifestazioni contro il governo per cui fu arrestato e trascorse alcuni mesi in carcere, un esperienza che lo fece distaccare dalla politica militante. Successivamente espletò numerosi discorsi pubblici tra i quali è famoso "La grande proletaria si è mossa".
Stile di vita: conduce una vita umile, casta, modesta, esprime un carattere schivo ed appartato (nel contesto familiare). Non ebbe relazioni amorose poiché conduceva una vita forzatamente casta; riteneva l'amore come proibito, misterioso, da contemplare con palpiti e tremori. Aveva un'idea della famiglia sacra, centrale ed estremamente protettiva.
Scelte linguistiche: linguaggio comune con il ricorso di termini specifici come "tamerici", "prunalbo" (Novembre) e "puffini".
Pascoli ricevette una formazione classica presso un collegio; per questioni economiche lo abbandonò, ma grazia al professore continuò l'università.
Dopo gli studi, iniziò la sua carriera da insegnante liceale a Matera dove (negli anni Ottanta) lo raggiunsero le due sorelle Ida e Mariù costituendo finalmente un «nido» familiare verso cui egli provava un morboso attaccamento, così come verso i morti che lo avevano "tradito".
Le sorelle verso cui provava affetto, assolvono per lui, un ruolo materno a tal punto che, il matrimonio di Ida fu sentito come un tradimento per cui manifestò depressione.
Riteneva D'Annunzio il "fratello minore e maggiore", ma in realtà era due persone completamente differenti tra loro, li accumunava l'uso del discorso analogico e del simbolismo.
Il suo carattere è tormentato, turbato e morboso.
Divenne poi, professore universitario a Bologna, a Messina, per poi trasferirsi a Castelvecchio e continuare l'insegnamento a Bologna, luogo dove egli morì.
20
Pascoli ha una visione frammentaria, spezzata, misteriosa della realtà che lo circonda, fa spesso uso di fonosimbolismo e linguaggio analogico (la poesia si serve di immagini collegate logicamente tra loro in modo da rappresentare una realtà misteriosa, inconoscibile ed ignota).
Pascoli non ha una visione ottimistica della realtà, ma è inquieta, cupa, pessimista, piena di dolore, vista come un ingenuo fanciullino (senza logica e ragionamenti) —› visione decadente per cogliere le corrispondenze e i simboli.
Myricae Raccolta di poesie scritta da Giovanni Pascoli. Il titolo è una citazione virgiliana, tratta dall'inizio della IV Bucolica, in cui il poeta latino proclama l'intenzione di innalzare il tono del suo canto, poiché «non omnes arbusta iuvant, humilesque myricae» (a non tutti piacciono gli arbusti e le umili tamerici).
Pascoli usa questo titolo perché predilige temi umili così come le tamerici (piante selvatiche impregnate dalla salsedine).
I puffini dell'Adriatico Sonetto facente parte di Myricae e scritta da Pascoli.
Parla dei puffini, volatili visti e sentiti da Pascoli.
Occasione di stesura: Paolucci, aveva pubblicato il canto degli uccelli, nella quale si descrive la voce dei puffini, uccelli marini diffusi nell'Adriatico, verso così «meravigliosamente simile alla voce umana».
Contenuto:
1° parte: prevalgono i suoni molto aperti come "parlano" e "alba"
2° parte: introduce un paragone tra marinai e puffini: il verso dei puffini sembra il vociare dei marinai calmo, fioco.
Linguaggio: ellittico (spesso in assenza di soggetto e verbo, in alcuni casi a fine frase).
Uso del fonosimbolismo per far riferimento al verso degli uccelli: simbolismo affidato a un suono.
Gli uccelli in passato avevano una funzione oracolare perciò Pascoli ha interesse verso tali animali.
Novembre Tratto da "Myricae", scritto da Giovanni Pascoli. Le strofe sono composte da 3 endecasillabe e un
quinario.
Dà al lettore un messaggio di morte, inoltre ricorre alla poesia pura (messaggio implicito che il lettore deve percepire) in modo da riuscire a penetrare all'interno delle cose.
Contenuto:
1° strofa: impressione di una primavera improvvisa (in Novembre cade l'estate di San Martino). Accostamento di Pascoli del biancospino a un'idea amara, anche se soggettivamente non è così.
2° strofa: inizio con "ma" in modo da ribaltare la situazione differente rispetto a quanto prospettato finora nella poesia.
3° strofa: accostamento tra la finta estate e il ricordo dei defunti quindi l'incombenza dell'idea della morte, unica certezza della vita umana.
Tra 1° e 3° strofa è possibile identificare una notevole differenza: inizia con il sole, aria, limpidezza si conclude con la morte.
Descrizione paesaggio: evoca sensazioni diverse rispetto a quelle oggettive; è un modo per descrivere un'altra realtà diversa da quella prospettata.
Contrapposizione tra primavera- vita e autunno- morte. Presenti figure di luce, colore e profumo.
21
L'assiuolo Sonetto di Pascoli, tratto da "Myricae" e scritta da Pascoli.
Il titolo rimanda all'assiuolo, un uccello notturno, simile a un gufo.
Struttura: 2 strofe costituite da 2 quartine, l'ultimo verso è «chiù» monosillabico.
Inizio con un'interrogativa indiretta: "Dov'è la luna?" poiché la luna non è ancora visibile.
Descrive un luogo indeterminato, incerto che si connota con nubi nere, e dall'arrivo dei lampi. I campi sono indicati genericamente come luoghi lontani.
Numerose suggestioni: rimanda a un mondo cupo, incerto e d'incerta posizione.
Contenuto:
1° parte: atmosfera di quiete e pace, di luce. Presenza della vocale A, quindi di suoni piani e dolci.
2° parte: atmosfera di inquietudine, dolore, sofferenza. Prevalenza di doppie, suoni aspri.
3° parte: presenza del monosillabo chiù, rimanda al verso dell'assiuolo.
4° parte: riferimenti alle stelle, mare, cullare quindi a immagini dolci, rimandanti all' immagine infantile del neonato nelle braccia della madre (nido, protezione, conforto).
5° parte: atmosfera di dolore a causa del grido.
6° parte: atmosfera cupa, conclusione con la morte, cui segue il chiù dell'assiuolo.
X (dieci) Agosto Poesia meno riuscita perché meno spontanea, decadente e meno caratteristica, scritta da Pascoli e
tratta da "Myricae". Composta da 6 quartine di decasillabi e novenari alternati, schema fisso delle rime; le strofe riflettono una simmetria (simmetrie: v. 1 - v. 6, v. 2 - v. 4, v. 3 - v. 5).
Pascoli rievoca la tragedia personale, la morte del padre, avvenuta il giorno di San Lorenzo, il 10 agosto.
Il cielo sembra "lontano", distante perché non sembra partecipare alla tragedia che accede sulla terra: una rondine tornando nel suo nido è stata uccisa e quindi è decisa la sorte dei piccoli che la attendono nel nido (morte). Il cielo è quindi, in netta antitesi con la terra, descritta come un' "atomo opaco del Male", cioè la parte infinitesimale espressione del Male.
Esprime valori cristiani, infatti compare "perdono".
Vi sono immagini frammentarie, incerte.
Tema: dolore, male e morte ("singulto", "pianto di morte")
Dall'argine Sonetto di Pascoli, tratto da "Myricae" e scritta da Pascoli.
Sono presenti sensazioni visive come "ala orma ombra", "fumo", "sole", ma anche sensazioni uditive rimandanti a "campani", "strilli della calandra".
Inserisce gli uccelli come simbolo oracolare.
I Canti di Castelvecchio Scritti da Giovanni Pascoli, considerati da lui stesso, la prefazione di «Myricae››.
Castelvecchio è il luogo dove Pascoli si trasferisce con Mariù dopo il matrimonio dell'altra sorella Ida.
Occasione: Pascoli scrive in una nota che furono scritti in occasione del concepimento di Dante Gabriele Giovanni, figlio del suo amico Gabriele Briganti, nel 1903.
22
Il gelsomino notturno Poesia scritta da Pascoli e inserita successivamente nei Canti di Castelvecchio; ha 6 quartine di novenari
a rime alternate (schema fisso).
Occasione: per le nozze dell'amico Gabriele Briganti.
Il titolo "gelsomino notturno" riprende un particolare tipo di pianta dai colori bianchi che si schiude all'imbrunire. Allude alla prima notte d'amore della giovane coppia e al concepimento del piccolo Dante Gabriele Giovanni.
Temi: "nido familiare" con il termine "Chioccetta". —› raro caso di visione positiva in mazzo a una realtà negativa: i pulcini seguono la madre.
Punto di vista dell'autore: egli osserva dall'esterno come se fosse escluso e lontano. Inoltre egli ha una visione tormentata, non serena del sesso che descrive con "petali gualciti" e "fragole rosse".
Linguaggio: allusivo, magico e simbolico per creare una suggestiva atmosfera notturna.
Il fanciullino Saggio che raccoglie una serie di poesie, scritto da Giovanni Pascoli.
Il poeta coincide col fanciullo che sopravvive al fondo di ogni uomo: un fanciullo che vede tutte le cose «come per la prima volta››, con ingenuo stupore e meraviglia, come dovette vederle il primo uomo all'alba della creazione. Di conseguenza egli attribuisce alle cose un nome alle cose dato che si trova in un «mondo novello›› usa una «novella parola››.
Una poetica decadente Pascoli afferma che dentro ognuno vi è un fanciullino che esprime sentimenti e stati d'animo diversi;
infatti due voci dentro di noi "temono sperano godono piangono" (v.4). Man mano che cresciamo diventando adulti, dentro di noi rimane quest'anima da fanciullino che come un campanellino ci fa ricordare d'essere così. Secondo lui, tutti l'hanno, ma non tutti ne sono consapevoli perché non sono abbastanza sensibili per vederlo; eppure i segni della sua presenza sono semplici e umili.
Pascoli descrive le caratteristiche del fanciullino:
Ha paura del buio in cui vede "l'ombra di fantasmi" (v.16);
Parla ad esseri inanimati come alle "bestie, agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle" (v.15);
Si fa guidare dall'immaginazione.
È spontaneo, semplice, umile, ingenuo nei comportamenti non sempre filtrati dalla ragione.
Visione dell'amore del fanciullino: puro, casto, tra fratello e sorella, nell'ambito della famiglia.
Anche in chi non ha fede, il fanciullino la mantiene accesa con la propria ingenuità (è meno portato al ragionamento e si pone meno domande).
Parla sempre senza fermarsi mai, fa perdere tempo a causa della sua tendenza ad immaginare. Osserva stupendosi di cose di cui gli adulti non si accorgono più; egli "scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose" (vv. 31-32), creando così delle corrispondenze. Inventa nomi alle cose e associa suoni per descriverle.
L'uomo è così intento nelle sue attività che non si accorge del fanciullino che tutti hanno; tale consapevolezza e sensibilità in Pascoli è creatasi perché nella sua infanzia egli ha vissuto molti dolori. Per lui, è necessario cogliere il profondo, quasi segreto per gli altri, conosciuto dal fanciullino —› Mito dell'infanzia e del primitivo, caratteristiche del Romanticismo e presenti in Giacomo Leopardi.
Per egli, la poesia ha un utilità morale e sociale: essa non dev'essere definita, delimitata da qualche aggettivo, infatti ritiene che non per forza i versi belli e degni devono essere rappresentati con elementi straordinari e rari (come le piante esotiche), ma si può far poesia semplicemente con la "pimpinella" (pianta selvatica).
Inserisce riferimenti a Virgilio che "cantò per cantare" per indicare che la poesia debba essere pura, priva di fine morale ed etico che autonomamente il lettore deve percepire, poiché il poeta deve essere vate (come D'Annunzio); infatti nelle Georgiche, il lettore coglie la pace, la serenità date dall'assenza delle
23
guerre non perché Virgilio abbia trattato di tali sensazioni, ma perché ha raccontato le guerre. In questa maniera Pascoli critica fortemente D'Annunzio.
Stabilisce una graduatoria «professore», «banchiere», «contadino» e «operaio» che veicola una visione della società conservatrice, borghese e prevalentemente rurale, in cui le altre attività economiche sono di minor importanza.
Micro saggio - Il «fanciullino» e il superuomo: due miti complementari Contiene riflessioni riguardanti il fanciullino e il superuomo, miti antitetici (contrapposti fra loro): il
fanciullino si caratterizza per l'ingenuità, espressa anche mediante il diminutivo -ino, mentre il superuomo è sensuale, forte, arrogante, per indicarlo si usa un superlativo super.
Essi sono anche miti complementari perché diverse espressioni / manifestazioni dovute al medesimo contesto storico di difficoltà (fine 1800 - inizio 1900): il fanciullino si rifugia nel passato, mentre il superuomo guarda il futuro; entrambi esprimono una situazione di incertezza, difficoltà e smarrimento caratterizzante il Romanticismo.
Carlo Salinari descrive efficacemente tali miti come «lì la lussuria e qui l’innocenza, lì la violenza e qui la mansuetudine, lì il tono esaltato e qui la voce smorzata, lì gli oggetti e i paesaggi più esotici e strani, qui gli oggetti e i paesaggi di tutti i giorni, lì il lusso e qui la povertà, lì il dominio e qui la sofferenza».
IL FUTURISMO Movimento artistico - letterario che copre diversi ambiti: pittura, scultura, teatro, moda, musica, … per
ognuno di essi si scrisse un manifesto; nasce il 20 febbraio 1909 con il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti. Presenta una straordinaria abbondanza di manifesti programmatici (gli intellettuali volevano dichiarare le regole del movimento a cui appartenevano).
S'esprime un programma di rivolta contro la cultura del passato e tutti gli istituti del sapere tradizionale («noi vogliano distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie››).
Elementi caratterizzanti legati alla moderna realtà industriale e al mito della macchina: velocità, dinamismo, sfrenato attivismo ed energia —› non vi è l'intento di valorizzare la scienza e la razionalità, invece è uno slancio irrazionale che coglie gli aspetti materici.
È un'avanguardia letteraria: avanguardia termine militare per indicare il gruppo di soldati davanti, esposti a maggiori rischi; dal punto di vista letterario indica una rottura con il passato, una spinta verso il futuro. Diverso da Scapigliatura che è un avanguardia mancata con il quale s'introdusse un nuovo modo di fare letteratura.
Il movimento respinge violentemente ed esasperatamente ogni forma esistente di organizzazione politica e sindacale così come il parlamentarismo, il socialismo e il femminismo, similmente all'ideologia nazionalista e militarista che celebra la guerra come «sola igiene del mondo››.
Prova disprezzo verso la letteratura precedente basata sui valori da loro disprezzati.
L'impatto verso il lettore è originale e provocatorio.
Similmente alla Scapigliatura, presenta un atteggiamento di ambivalenza tra il vecchio e il nuovo e una forte tendenza verso il futuro.
Diverso dal Positivismo che presenta invece l'esaltazione del progresso e della scienza.
24
Filippo Tommaso Marinetti
Manifesto del Futurismo Manifesto programmatico futurista scritto da Filippo Tommaso Marinetti, pubblicato sul quotidiano
parigino "Le Figaro". Scritto per punti come se fossero vere e proprie regole da seguire.
Descrizione del futurista: un soggetto che ama il pericolo, coraggioso, audace e ribelle. Essi come i fascisti glorificano la guerra, il militarismo, il patriottismo e sono caratterizzati dall'azione e non dall'immobilismo pensoso, dall'estasi e dal sonno dei periodi precedenti.
Per "bellezza" si intende quella delle velocità cioè delle automobili, diversa da quella di D'Annunzio —› è molto meglio un'automobile da corsa che la Vittoria di Samotracia (simbolo dell'arte classica, bellissima statua in marmo).
Si costata uno spirito di ribellione verso i simboli del passato quali musei, biblioteche, accademie …
Vi sono numerosi riferimenti al paesaggio che sta cambiando come conseguenza della Rivoluzione industriale (ponti, fabbriche, ciminiere, …), elementi poi ripresi da opere d'arte.
Manifesto tecnico della letteratura futurista Manifesto futurista anch'esso scritto da Filippo Tommaso Marinetti che come gli altri è redatto per
punti. Affermazioni fatte nel 1912 circa un secolo fa (essendo un'avanguardia provoca disorientamento).
È contrario a Verlaine che proponeva le sfumature (decadentismo).
Similmente al decadentismo, si usa il discorso analogico cioè accostamento di realtà diverse e lontanissime tra loro in grado di creare accostamenti e per ricercare significati impalpabili, spirituali e metafisici; perciò le analogie non devono essere banali e immediate, ma devono essere profonde.
Sempre per questo motivo, si fa largo uso del sostantivo-doppio come ad. es. donna-golfo, di sinestesie e onomatopee.
La sintassi non deve essere complessa, ma bisogna distruggerla abolendo l'aggettivo, l'avverbio e usando i verbi all'infinito. Inoltre si rifiuta la struttura per creare un maximum di disordine —› "Parole in libertà!" e si dispongono «i sostantivi a caso, come nascono››.
Di rilievo è inoltre la forma grafica, la quale con un segno concretamente visibile è destinata a riprodurre impressioni acustiche o tattili.
Si rifiuta anche la punteggiatura.
È necessario introdurre nel testo tre elementi finora trascurati: il rumore (manifestazione del dinamismo degli oggetti), il peso (facoltà di volo degli oggetti) e l'odore (facoltà di sparpagliamento degli oggetti).
Rimando al contesto: la velocità area ha mutato la situazione; gli aerei fatti in legno era usati per la ricognizione, non per i bombardamenti.
Come in Pascoli, vi sono categorie d'immagini: si può fare poesia con immagini semplici (es. tamerici).
All'io lirico, scrittore saggio e razionale, bisogna accostare l'ossessione lirica della materia, ad. es. è più appassionante un pezzo di legno o di ferro rispetto a un sorriso di una donna.
Riferimenti alla novità come il pianoforte meccanico e il cinematografo.
Alla psicologia umana si sostituisce quella intuitiva.
Odio verso i musei, biblioteche, accademie, … simbolo del passato.
25
Zang tumb tuuum Adrianopoli 1912
Bombardamento Testo futurista scritto e pubblicato nel 1914 da Filippo Tommaso Marinetti e facente parte di "Zang tumb
tuuum Adrianopoli 1912". Descrive la guerra del 1912 tra Bulgaria e Turchia combattuta ad Adrianopoli.
Presenta i verbi all'infinito, numerose parole distanziate graficamente sia orizzontalmente che verticalmente scritte con diversi caratteri di stampa, abbondanti vocali A e E ed è privo di punteggiatura.
Vi è la ripetizione della parole "vampe" per indicare dei bagliori improvvisi.
Numerose sono le onomatopee.
Graficamente le parole sono collocate in disordine nello spazio, distanziate orizzontalmente e verticalmente.
Contrariamente da quanto previsto nei manifesti del futurismo, presenta aggettivi come "rapido" e "aperti", e avverbi come "giù giù in fondo" e "dovunque".
Il futurismo in altri paesi L'avanguardia futurista si sviluppa anche in altri paesi europei, compresa la Russia dove rimane sostanzialmente uguale, ma si presenteranno differenze sul piano formale e dei contenuti (es. no glorificazione della guerra, ma condanna della guerra in quanto tale).
Vladimir Majakovskij
La guerra è dichiarata Poesia futurista composta nel luglio 1914 da Vladimir Majakovskij. Essa fa riferimento allo scoppio della
Prima Guerra Mondiale.
Traspare un'opinione negativa dell'autore.
Si descrive un paesaggio di sangue e si condanna la guerra.
La guerra è evocata attraverso immagini analogiche come "il veleno del sangue" (v.7) e "tuoni degli obici" (v.8) richiamano una situazione di dolore dove innescare una rivoluzione.
BOMBARDAMENTO LA GUERRA È DICHIARATA
Medesima corrente letteraria, il futurismo, ma ambienti diversi: Francia - Russia
Medesimo periodo storico tra il 1912 - 1914, ma vi sono riferimenti a due guerre diverse tra loro.
Filippo Tommaso Marinetti Vladimir Majakovskij
Privo di punteggiatura Presenza di punteggiatura quali segni come «, ››, ! , ,
Sintassi distrutta, verso libero e suddiviso in strofe Sintassi normale (tradizionale)
Spazi ampi tra le parole sia orizzontalmente che verticalmente Suddivisione in 7 strofe di 4 versi ognuna (quartine)
Presenza di numerose personificazioni come: "cannone ghigliazzante" v. 18 - "mitragliatrici strillare" v. 14
Glorificazione e acclamazione della guerra Opinione negativa della guerra
Privo di tali riferimenti; s'occupa della sola descrizione della guerra
Ricco di riferimenti a luoghi civili e quotidiani come "piazza" (v.3), "caffè" (v.5), "Reno" (v.7) e "Roma" (v.8) e a persone come "generali" (v.13), "fanti" (v.16) e "strilloni" (v.25)
26
Italo Svevo Pseudonimo di Aron Hector Schmitz: egli vuole sottolineare le sue origini cioè la madre italiana ("Italo") e
padre austriaco appartenente alla dinastia di Svevia ("Svevo"), di origine ebraica.
Nasce il 19 dicembre 1861 a Trieste, città di confine appartenente al territorio austriaco e vi convivono culture differenti (italiana, slava e austriaca) e importante città commerciale.
Appartiene a un'agiata famiglia borghese (imprenditoriale); il padre è un commerciante di vetrami, figlio di un funzionario imperiale austriaco di origine ebraica e la madre è anch'essa di famiglia ebraica.
Non è uno scrittore puro, infatti diversamente dagli altri (che sono aristocratici, vivono di rendita) egli intraprende gli studi commerciali in Germania (dove imparò il tedesco) per volontà del padre; nel tempo libero data la sua aspirazione letteraria s'occupa della scrittura: iniziò con testi drammatici che rimasero per il momento nei suoi cassetti.
Collaborò con il giornale "L'indipendente" di orientamento liberal - nazionale e irredentista scrivendo articoli letterari e teatrali.
Dato un investimento industriale sbagliato, il padre fallì perciò la famiglia visse in condizioni di ristrettezza economica. Per necessità divenne dirigente di banca (per 19 anni).
Un fatto rilevante della sua vita fu il matrimonio con la cugina molto più giovane, Livia Veneziani, figlia di industriale proprietario di una fabbrica di vernici da cui ebbe una figlia Letizia. Egli divenne dirigente industriale e uomo d'affari e si recò per questo in Francia e in Inghilterra. Essendo che essa venne messa sotto sequestro si dedica all'attività letteraria.
Intanto scrisse le sue opere Una vita e Senilità che non ebbero successo perché rimasero inosservate (né una parola di biasimo né una di lode a tal punto che avrebbe preferito il biasimo).
Data la delusione, definisce la "letteratura cosa inutile e dannosa" cioè esprime la propria concezione borghese e cerca di trovare una giustificazione per abbandonare la letteratura (ha bisogno di giustificarsi verso gli altri), ma sarà la vera passione della sua vita.
Critico verso il marxismo che studiò accuratamente, venne influenzato dal socialismo.
L'incontro con James Joyce: tra i due si crea un'amicizia duratura e si scambiano i reciproci testi letterari. Joyce, alla lettura dei suoi romanzi, lo incoraggia a tal punto che lo induce nel proseguire la sua attività letteraria —› infatti successivamente scrisse la Coscienza di Zeno, romanzo il quale riscosse numerosi apprezzamenti prima in Francia, poi in tutta Europa.
L'incontro con la psicoanalisi (1908-1910): a causa del cognato che aveva sostenuto una serie di terapie a Vienna con Freud, Svevo venne a conoscenza delle teorie psicoanalitiche che condivideva intimamente.
Morirà a causa di un incidente d'auto presso Treviso a causa delle ferite riportate.
Le suggestioni culturali dell'opera di Svevo Interessi di Svevo sono di varia natura: filosofia, scienza e letteratura.
Schopenhauer: filosofo tedesco, che riteneva che l'uomo non ha libertà di scelta, è destinato alla rinuncia e alla contemplazione —› pessimismo radicale
Nietzsche: tedesco che critica la società borghese come negativa: si tratta di una società meschina e rinunciataria a causa del cristianesimo che ha reso l'uomo passivo.
Darwin: scienziato autore della teoria evoluzionistica per cui solo i più forti (cioè quelli con le caratteristiche migliori riescono a sopravvivere); non è la volontà a determinare l'evoluzione della specie, ma si tratta di caratteristiche indipendenti dalla volontà. —› "selezione naturale" e "lotta per la vita".
Freud: psicanalisi come disciplina scientifica —› attenzione verso ciò che è irrazionale come il sogno.
Zola (Naturalismo francese): descrizione degli ambienti presenti in buona parte in "Una Vita", meno in "Senilità" e scompare in "Coscienza di Zeno".
27
Una vita Romanzo pubblicato a spese dell'autore Italo Svevo nel 1892. Il titolo originario era "Un inetto", ma la
casa editrice, Vram, lo cambiò in "Una vita" per renderlo più neutro. —› suscitò scarsa attenzione nella critica e nel pubblico.
Non è un romanzo realistico poiché non si tratta di importanti fatti e vicende, ma è un romanzo psicologico poiché si mette in risalto la psicologia dei personaggi.
Rappresenta la figura dell'inetto cioè di un soggetto incapace, fallito, arrendevole, insicuro, incerto che si limita a contemplare, non osa e non ama il rischio —› spunti autobiografici a Svevo poiché egli si sentiva un'incapace alla vita.
Personaggi:
Alfonso Nitti: inetto, semplice impiegato di banca che ha la possibilità di fare un salto sociale sposandosi con Annetta;
Macario: giovane brillante e sicuro di sé, amichevole e fraterno, artista inconscio, intelligente e furbo.
Contenuto: Alfonso Nitti, giovane intellettuale con aspirazioni letterarie, lascia il paese natale, dove vive con la madre, e si trasferisce a Trieste, trovando un avvilente impiego come bancario. Un giorno viene invitato a casa del banchiere Maller, e qui conosce Macario, un giovane sicuro di sé con cui Alfonso fa amicizia, e Annetta, figlia di Maller con la quale Alfonso inizia una relazione. Sul punto di sposarla però, fugge, così da poter cambiare vita, e torna al paese d'origine, dove la madre, già gravemente malata, muore. Alfonso torna quindi a Trieste, e decide di vivere una vita di contemplazione, lontano dalle passioni. Tuttavia, alla scoperta che Annetta si è fidanzata con Macario, Alfonso si sente ferito e cerca in tutti i modi di ritornare alla situazione precedente, ma non solo fallisce in questo proposito, bensì riesce persino ad aggravare ulteriormente la situazione. Quando, in seguito all'ennesimo equivoco con la famiglia Maller, si trova a dover sfidare a duello il fratello di Annetta sceglie di suicidarsi (esalando gas) e di porre così fine alla sua vita di disadattato.
Le ali del gabbiano Facente parte di "Una vita" di Italo Svevo.
Narrato in 3° persona, con focalizzazione interna su Alfonso Nitti di cui prevale il punto di vista. Il narratore è etero diegetico: scelta funzionale a rappresentare l'inattendibilità di Zeno.
Caratteristiche complementari di Alfonso e Macario: parlando di sé stesso, Alfonso si presenta come una persona docile e aggiunge "tanto piccolo e insignificante" ≠ Macario che accanto a lui si trova bene: per mettere in luce la sua forza ha bisogno di una persona debole. Nella vicenda, Alfonso è prudente, agitato e insicuro, mentre Macario è ostentato e coraggioso e tende a deriderlo (vuole affrontare il vento burrascoso).
Conquista della solida salute: concetto che si ripropone più volte in Italo Svevo (nella Coscienza di Zeno in riferimento alla salute di Augusta, in Vita in merito allo stato di salute di Alfonso). La salute è intesa in maniera ampia, non legata alla sola malattia.
Discorso sulle ali dei gabbiani: Alfonso invita Macario ad osservare il volo dei gabbiani e a notare come sono fatti, struttura fisica per pescare e mangiare; lo invita ad osservare il volo in picchiata dei gabbiani per prendere i pesci —› Chi ha gli strumenti per pescare può farlo, mentre chi non li ha è destinato a guardare.
Contrapposizione tra contemplatori e lottatori (da Schopenhauer) Contemplatori: Alfonso non possiede gli strumenti, né può acquisirli Lottatori: Macario ha gli strumenti per prevalere sui più deboli All'uomo, non è dato scegliere: o si è lottatori o contemplatori —› concezione pessimista. Solo chi lotta sopravvive (Darwin).
Cultura giudicata negativamente da Macario (esprime mentalità borghese): Alfonso ne approfitta per parlare del cervello; Macario sfrutta l'occasione per deriderlo dicendo lui che passa il tempo a studiare ovvero a "nutrire il cervello"; difatti Alfonso scrive testi in prosa e se ne vergogna.
28
Senilità Secondo romanzo di Italo Svevo, pubblicato nel 1898.
Titolo: senilità non come anzianità in senso anagrafico, ma indica una particolare condizione di inettitudine ovvero l'essere inadeguati alla vita e agli ostacoli.
Personaggi:
Emilio Brentani: protagonista, lavora come impiegato in una compagnia di assicurazioni;
Stefani Balli: antagonista;
Angiolina: amante di Emilio, persona esuberante, volgare, cinica con una vita sentimentale movimentata;
Amalia: sorella di Emilio, nonostante non sia vecchia è scialba, vive solo per occuparsi del fratello (non ha rapporti con il mondo esterno) e si lascerà morire per amore di Stefano.
Contenuto: Emilio vive con la sorella Amalia la quale si limita principalmente ad accudirlo. Emilio conosce Angiolina, di cui s'innamora, e trascura la sorella e l'amico. Stefano non crede nell'amore, e cerca di convincere Emilio a divertirsi con Angiolina, che ha una pessima fama a Trieste, mentre Emilio apre il cuore a questa donna la quale inizia a mostrare un certo interesse per un ombrellaio e per lo stesso Stefano Balli. Nell'incipit del romanzo, l'accordo desiderato dal Brentani era quello di un legame senza impegni. Stefano, dal canto suo, comincia a frequentare casa Brentani con maggiore assiduità; Amalia finisce per innamorarsene. Emilio, geloso della sorella, allontana Stefano, mentre Amalia s'ammala fino a morire. Emilio smette di frequentare Angiolina, pur amandola, e si allontana da Stefano Balli; poco dopo la donna fugge con un altro uomo. Il romanzo si conclude con un'immagine significativa: anni dopo, nel ricordo, Emilio vede le due donne idealizzate secondo i propri desideri e fuse in una singola persona, con l'aspetto dell'amata e il carattere della sorella.
Il ritratto dell'inetto Incipit "in medias res" ovvero inizio al centro della storia. Suscita nel lettore maggior interesse, ma anche
maggiore difficoltà di comprensione.
Emilio Brentani finge di non essere interessato; in realtà s'innamorerà di Angiolina. Alla fine della storia con lei, egli afferma di tornare alla senilità ovvero l'uomo ha 35 anni, si rende conto di aver trascurato amore, carriera, lavoro.
Narrazione in terza persona (vv. 1-6): giudizio del narratore in merito al rapporto di Emilio con Angiolina. "la famiglia? Egli vuole lasciare da parte i pericoli…". Come Alessandro Manzoni, il narratore usa degli aggettivi per esprimere il proprio giudizio es. "impiegatuccio di poca importanza" riferendosi a Emilio.
La coscienza di Zeno Terzo romanzo di Italo Svevo. Pubblicato 25 anni dopo Senilità, nel 1923 (scoppio 1° guerra mondiale).
È un romanzo d'analisi poiché si concentra sull'introspezione psicologica del protagonista.
Nella prefazione del libro il sedicente psicoanalista Dottor S dichiara di voler pubblicare "per vendetta" alcune memorie, redatte in forma autobiografica di un suo paziente, Zeno Cosini, che si è sottratto alla cura. Gli appunti dell'ex-paziente costituiscono il contenuto del libro.
Svevo sceglie alcune esperienze significative della sua vita e le affronta in un capitolo, non in ordine cronologico. Es. vizio del fumo —› capitolo: Il fumo
Abbandona la narrativa tradizionale, introduce il c.d. tempo misto, contaminazione tra futuro e passato.
Il narratore è autodiegetico: corrisponde al personaggio di Zeno Cosini —› scelta funzionale per rendere Zeno un personaggio inattendibile esterno, guida il lettore, lo condiziona, svela menzogne e provoca incertezza nel lettore.
Zeno rappresenta la figura dell'inetto come una persona che fugge dai problemi, non trova una soluzione, non determinato, non sicuro di sé, ma diverso rispetto ad Alfonso ed Emilio assume una connotazione positiva: l'inetto è una persona più consapevole rispetto alla media del mondo borghese e ritiene che i principi borghesi siano inutili (e servano solo ad illudersi).
29
ostentata sicurezza dei borghesi vs dubbio di Zeno Cosini
Capitoli: 1. Prefazione e preambolo 2. Il fumo 3. La morte di mio padre 4. La storia del mio matrimonio 5. La moglie e l'amante 6. Storia di un'associazione commerciale 7. Psicoanalisi
Il fumo: tratta della sua malattia del fumo, narrando fatti che coprono tutta la sua vita. Oltre all'inettitudine, il suo grande problema è il vizio del fumo, del quale non riesce a liberarsi. Il protagonista, infatti, ricorda di aver iniziato a fumare già nell'adolescenza a causa del rapporto conflittuale con il padre. A quest'ultimo rubava inizialmente soldi per comprare le sigarette e in seguito, dopo essere stato scoperto, raccoglieva i sigari fumati a metà sparsi per casa. Nonostante più volte si sia riproposto di smettere, non vi riesce e per questo si sente frustrato. I tentativi si moltiplicano, e anche gli sforzi, ma il problema non viene risolto. Ogni volta che prova a smettere di fumare, Zeno decide di fumare un'«ultima sigaretta» (U.S.) e di annotare la data di questa. Dopo numerosi fallimenti Zeno si rende conto che fumare "ultime sigarette" è per lui un'esperienza piacevolissima, in quanto quelle assumono ogni volta un sapore diverso, causato dalla coscienza che dopo quelle non potrà fumarne più. Zeno indica inoltre il vizio del fumo come causa dei cambiamenti repentini di facoltà universitaria (passa numerose volte dalla facoltà di chimica a quella di giurisprudenza). La morte di mio padre: Zeno rievoca il rapporto conflittuale con suo padre concentrandosi sui suoi ultimi giorni di vita. Si tratta di una relazione ostacolata dall'incomprensione e dai silenzi. Il padre non ha alcuna stima del figlio, tanto che, per sfiducia, affida l'azienda commerciale di famiglia a un amministratore esterno, l'Olivi. A sua volta il figlio, che si ritiene superiore per intelletto e cultura, non stima il padre e sfugge ai suoi tentativi di parlare di argomenti profondi. Quando il figlio è al suo capezzale, il padre (ormai incosciente) lo colpisce con la mano. Zeno non riuscirà mai a capire il significato di quel gesto: uno schiaffo assestato allo scopo di punirlo o soltanto una reazione inconscia del padre ammalato? L'interrogativo produce un dubbio che accompagnerà il protagonista fino all'ultimo dei suoi giorni. Alla fine Zeno preferisce ricordare il padre come era sempre stato: "io divenuto il più debole e lui il più forte". La storia del mio matrimonio: Il protagonista conosce tre sorelle, le figlie di Giovanni Malfenti, con il quale Zeno ha stretto rapporto di lavoro e per il quale nutre profonda stima, al punto che lo vedrà come una figura paterna dopo la morte del padre. La più attraente delle figlie è la primogenita (Ada), a cui il protagonista fa la corte. Il suo sentimento però non è ricambiato, perché ella lo considera troppo diverso da lei e incapace di cambiare, oltre che già promessa sposa a Guido un uomo profondo (che lei ama). Anche dopo il rifiuto, Zeno è sempre attratto dalla sua bellezza esteriore ed interiore. Tuttavia, ormai deciso a chiedere in sposa una delle sorelle Malfenti, si dichiara ad Alberta che ugualmente lo respinge. Egli finisce quindi per sposare Augusta, la terza delle sorelle Malfenti (quella che meno gli piaceva e che aveva assicurato alle altre sorelle di non sposare mai). Nonostante questo, il protagonista arriverà a nutrire per la moglie un amore sincero, anche se ciò non gli impedirà di stringere una relazione con un'amante, Carla. Augusta costituisce nel romanzo una figura femminile dolce e tenera, che si prodiga per il proprio marito. In lei Zeno trova la figura materna che cercava e un conforto sicuro mancatogli nell'infanzia.
La salute "malata" di Augusta Augusta, la moglie, non è stata propriamente scelta da Zeno, anche se nel testo afferma che scopre
l'amore verso Augusta (v.3), ma in realtà dopo aver invitato prima Ada, poi Alberta che rifiutarono. —› Zeno è alla ricerca di una figura femminile che abbia certezze e che possa rimediare alle sue incertezze.
Augusta gode di una solida salute, invece il padre convinto di aver sconfitto la propria malattia non ne soffre più. La donna è precisa, organizzatrice, mentre il padre è distratto che per non dimenticarsi tutto annota su un libretto.
Zeno patisce gli sguardi dei medici perché essi sono convinti di guarire il paziente, ma egli ritiene che rimangano malati come prima. I medici della sua vita, assumono una figura autoritaria capace di giudicarlo senza conoscere la sua vita e patirlo.
30
"La salute non analizza sé stessa": affermazione di Zeno Cosini che fa riferimento ai meccanismi di psicoanalisi di Freud. Indica che il sano non ha la necessità di analizzarsi perché privo di malattie, mentre il non sano deve trovare le cause, i sintomi della propria malattia.
Psicoanalisi Contenuto: Zeno Cosini parla della sua condizione "malata": dopo 6 mesi di psicanalisi in maniera
assidua, Zeno si sente "squilibrato e malato" (v. 11) —› decide di abbandonare la terapia. Il dottore dicendogli di essere guarito, lo ha illuso ingiustamente ("sciocca illusione" (v. 23), "trucco buono" (v.23)). Zeno tratta poi del passato, della sua infanzia: il fumo non gli faceva male e solo quando se ne sarebbe convinto sarebbe diventato per lui innocuo. Passa alla trattazione del matrimonio e della scelta della moglie, per poi continuare con i rapporti con Guido Speier, uomo scelto da Ada e con il quale creò un'associazione commerciale. Zeno parla di Olivi, amministratore dei suoi beni, che è lontano, mentre lui è a Trieste, è solo e la guerra tra Austria e Italia è scoppiata. Alla fine, Zeno si auto convince d'avere una salute solida, perfetta per la sua età inoltrata e dichiara la volontà di rifare tutto ciò che ha fatto nella sua vita. Egli ha scoperto che la "vita attuale è inquinata alle radici" e che rendersene conto è segno di salute, non di malattia.
Le lettere a Jahier Valerio Jahier è un letterato italiano residente a Parigi e grande ammiratore di Svevo.
Italo Svevo è entrato a contatto con la psicoanalisi di Freud a causa del cognato. Egli non riconosce alla psicoanalisi un valore terapeutico, ma ritiene che essa sia uno strumento narrativo grazie al quale cogliere gli aspetti più nascosti della vita dell'uomo.
La profezia di un'apocalisse cosmica Compare l'evento relativo alla 1° guerra mondiale. Italo Svevo ne è influenzato: tratta di "ordigni" (v. 29),
"gas velenosi" (v. 30), "esplosivi" (v. 32), …
L'uomo e l'intera civiltà sono visti in maniera negativa, così come gli alberi e le bestie, poiché inquinano l'aria e occupano spazio utile; si consente la sopravvivenza anche ai più deboli i quali sarebbero destinati a soccombere. Le macchine, definite "gli ordigni", "prospereranno malattie ed ammalati" (vv. 27-28). L'"esplosione enorme" (v. 35) causerà la trasformazione della terra in una nebulosa e girerà errando nei cieli, non vi saranno più parassiti e malattie. Zeno lo giudica un evento positivo perché in grado di cancellare i parassiti e le malattie presenti sulla terra.
Rivalutazione della figura dell'inetto, diverso rispetto a "Una vita" e "Senilità": Italo Svevo prova simpatia verso l'inetto poiché le certezze del mondo borghese non sono tali e l'inetto ne è consapevole.
31
Luigi Pirandello
Nasce a Girgenti (Agrigento) nel 1867; appartiene a una famiglia agiata di condizione borghese. Il padre dirigeva alcune miniere di zolfo prese in affitto.
Compie studi classici, dopo aver lasciato l'Università di Palermo e poi quella di Roma a causa di un contrasto con un professore, si laurea all'Università di Bonn con una tesi su Suoni e sviluppo di suoni del dialetto di Girgenti e diventa professore universitario.
L'esperienza in Germania lo mise in contatto con la cultura tedesca e con gli autori romantici che influenzarono le sue opere e le sue teorie riguardanti l'umorismo.
Dal 1892, grazie ad un assegno del padre, si stabilì a Roma, dedicandosi interamente alla letteratura; proprio lì conobbe Luigi Capuana.
Scrisse il romanzo L'esclusa e una raccolta di racconti Amori senza amore.
Nel 1894 sposa a Girgenti Maria Antonietta Portulano con cui ebbe 3 figli e torna a vivere a Roma.
Nel 1903, un tracollo finanziario genera in famiglia una crisi profonda, non soltanto economica. La moglie, infatti, inizia a soffrire di disturbi psichici (gelosia) e sarà curata in casa per 15 anni prima di essere internata in una casa di cura dal marito.
La sua vita fu segnata dalla declassazione cioè dal passaggio da una vita di agio borghese ad una condizione borghese che provocò disagi economici e frustrazioni.
A causa di tale situazione, tra il 1904 e il 1915, iniziò una fitta produzione di novelle e romanzi e anche con l'industria cinematografica.
Egli sentiva la società come una "trappola": in tante novelle rappresentò il grigiore soffocante della vita piccolo borghese, provò rancore e insofferenza verso la società in cui l'uomo si dibatte invano.
Raccolse in vari volumi tutte le novelle e ottenne un buon successo con il pubblico, ma poca attenzione nella critica.
Egli aderì al partito fascista iscrivendosi dopo il delitto di Matteotti; ottenne appoggi da parte del regime che finanziò in modo consistente l'esperienza teatrale. Egli aveva una visione ambigua del fascismo: da un lato lo vedeva come una garanzia di ordine, dall'altro gli sembrava un'affermazione di una genuina energia vitale che spazzava via le forme fasulle e soffocanti della vita sociale dell'Italia postunitaria.
Negli ultimi anni lo scrittore seguì la pubblicazione organica delle sue opere in numerosi volumi.
Nel 1934 vince il premio Nobel per la Letteratura, a consacrazione della sua fama mondiale.
Nel 1936 muore a Roma.
La poetica di Pirandello A differenza di altri autori, i temi di fondo della poetica pirandelliana sono gli stessi per tutta la sua
attività letteraria; egli si dedica a diversi generi, rimanendo però coerente con i suoi temi.
I temi principali sono:
la contrapposizione tra apparenza e la realtà,
lo sfaccendarsi della verità cioè sostenere che esistono tante realtà quante sono le persone che pensano di aver la verità,
l'assurdità della condizione dell'uomo che è prigioniero della condizione economica / lavorativa e della famiglia.
Il primo romanzo è "L'esclusa" (1893) il quale tratta di una donna che viene ingiustamente condannata per adulterio, cacciata di casa e poi riaccettata dal marito dato che l'adulterio l'ha veramente commesso.
Pirandello usa gli spunti autobiografici in primis per scegliere i temi da trattare nelle sue opere, poi nella rappresentazione di certe situazioni.
L'individuo non conta più, l'io s'indebolisce, perde la sua identità, si frantuma in una serie di stati incoerenti. La consapevolezza di questa inconsistenza suscita nei personaggi smarrimento, dolore, angoscia, orrore e solitudine: non si è "nessuno" e vi è un'impossibilità di consistere in un'identità.
La vita è vista come una "trappola", un "carcere" in cui l'individuo si dibatte, lottando invano per liberarsi. La società appare come un'"enorme pupazzata", una costruzione artificiosa e fittizia, che isola
32
irreparabilmente l'uomo dalla "vita", lo impoverisce e lo irrigidisce, lo conduce alla morte anche se egli apparentemente continua a vivere.
L'umorismo Saggio scritto nel 1908 da Pirandello
Esso si compone di due parti:
parte storica: l'autore esamina varie manifestazione dell'arte umoristica;
parte teorica: si definisce il concetto di umorismo.
Un'arte che scompone il reale Tratto dalla seconda parte dell'Umorismo, scritto da Luigi Pirandello
L'opera d'arte è composta da una serie di idee e immagini organizzate in modo armonioso dal libero movimento della vita interiore. La riflessione partecipa nella creazione dell'opera d'arte: assiste al nascere e al crescere, segna le fasi e ne gode, unisce gli elementi, li coordina e li compara. È possibile attingere dalla coscienza che è come uno specchio in cui il pensiero si "rimira" (v. 9).
La riflessione è una forma del sentimento che come in uno specchio si rimira; si pone come un giudice che analizza, elimina ogni forma di passione ed emotività, scompone l'immagine e da questa scomposizione, sorge e se ne ispira un altro, c.d. sentimento del contrario.
Esempio della vecchia signora: essa ha i capelli ritinti, tutti unti, è imbellettata, vestita con abiti giovanili. Da qui si evince la differenza tra …
il comico che ride poiché è il contrario di una vecchia rispettabile signora —› avvertimento del contrario;
l'umorista che usa la riflessione e pensa che essa non ha piacere a vestirsi così, ma lo fa per compiacere il marito più giovane di lei e per nascondere le rughe —› sentimento del contrario.
Pirandello ha una visione scomposta e frammentaria della società basata sul relativismo: vi è una frantumazione dell'io, l'uomo non è una sola persona, ma si suddivide in tanti —› non esistono verità e valori assoluti poiché ognuno percepisce la realtà non per quello che è effettivamente, ma per come la vede in un determinato momento. La realtà è multiforme poiché ognuno la guarda con i propri occhi.
La vita è un flusso continuo che l'uomo cerca d'arrestare, di fissare in forme stabili e determinate; è un libero fluire degli istinti umani. Per forme s'intendono una serie d'ideali cui vorremmo essere coerenti, di finzioni che ci creiamo, di condizioni / stati cui tendiamo a stabilirci; essa rappresenta una maschera che la società ci impone. Nell'anima vi è un flusso continuo, indistinto, oltre i limiti che ci imponiamo per crearci una coscienza e una personalità; in alcuni movimenti tempestosi, tutte quelle forme fittizie crollano miseramente. Il flusso della vita è in tutti e può rappresentare talvolta una tortura.
Metafora del magma vulcanico: la vita è così definita. Il magma a contatto con l'aria si solidifica; ma in realtà è un continuo fluire così come la vita. È l'uomo che ha bisogno di certezze che cerca di arrestarlo.
L'arte astrae, concentra, coglie, rappresenta degli individui come delle cose in maniera essenziale e caratteristica. Per l'umorista significa semplificare troppo la natura, renderla troppo ragionevole e coerente; le cause nella vita non sono così logiche ed ordinate come nelle opere d'arte (in cui tutto è combinato, congegnato, ordinato ai fini che lo scrittore s'è preposto).
Ognuno di noi, ha dentro di se 4-5 anime in lotta fra loro: l'anima istintiva, morale, affettiva, sociale; in base a quella che domina, s'atteggia la nostra coscienza.
Differenza tra poeta epico - drammatico e umorista: il poeta può rappresentare un eroe in cui vi siano in lotta elementi opposti e in conflitto gli uni con gli altri; si costituirà così un carattere cui ogni atto sarà coerente. L'umorista fa l'inverso: scompone il carattere nei suoi elementi e si diverte a rappresentarlo nelle sue incoerenze; non riconosce eroi nonostante conosca la leggenda e come si forma. L'umorista vede il mondo non completamente nudo, ma in camicia; si dissocia dalle concezioni comuni di cui gli scrittori comuni s'avvalgono.
33
Metafora dell'oro: in natura l'oro è misto alla terra. Gli scrittori ordinari buttano via la terra e presentano l'oro in zecchini, invece l'umorista tiene la terra. Egli ricerca i particolari più intimi e i dettagli —› differenza tra l'opera umoristica e la composizione dell'opera in generale.
Il fu Mattia Pascal Terzo romanzo di Pirandello dopo l'Esclusa e il Turno. Contenuto: Mattia Pascal è il custode di una biblioteca dimenticata nel comune di Miragno, costretto a
lavorare dopo una gioventù spensierata: infatti, dopo la morte del padre, la madre ingenuamente affida i beni della famiglia al Malagna e perde tutti i beni di famiglia. Ha una relazione con Olivia, la moglie del Malagna, con cui ha un figlio che però il perfido amministratore curerà come se fosse suo figlio. Mattia è costretto a sposare una donna che lo odia e ad ospitare in casa la suocera che lo disprezza, a soffrire la morte di sua figlia insana e quella di sua madre nello stesso giorno. Dopo una delle quotidiane liti con la suocera, Mattia scappa da casa dirigendosi a Montecarlo con cinquecento lire e con molta fortuna ne vince ottantadue mila. Tornando a casa, legge sul giornale l'annuncio della sua morte, cioè di un uomo a lui somigliante, che la suocera e la moglie avevano riconosciuto com’essere lui, liberandosene. Ha la possibilità di crearsi una nuova vita, decide di viaggiare senza meta. Mattia cambia identità, sceglie un nuovo nome: Adriano Meis. Per essere credibile con la gente si crea un passato; rimane un uomo sconosciuto per la legge, senza legami, amicizie, affetti e solo, non potrà mai rivelare il suo segreto a nessuno e dovrà vivere da forestiero. Così Adriano viaggia su e giù per l’Italia per un certo periodo dopo cui si stanca e decide di trasferirsi a Roma dove vivere in una camera affittata. Meis entra in casa Paleari, dove conosce Anselmo, il padrone di casa, la figlia Adriana e la signorina Caporale. Adriano, col passare del tempo, si apre, parla con le persone della casa. In una serata, scopre di essere amato da Adriana, ragazza diversa dalla moglie dell’ex se stesso; lui contraccambia il sentimento e tra i due si crea un nuovo equilibrio. Quest’ultimo però viene rotto dall’arrivo di Papiano Terenzio, marito della defunta sorella di Adriana e persona losca che vuole sposarsi con la giovane ragazza per non dover restituire la dote ad Anselmo. Adriano, intanto, decide di migliorare il suo aspetto, eliminando un difetto dell’occhio, ormai l’unico resto di Mattia Pascal; l’intervento va a buon fine, ma come di prassi è obbligato a rimanere nel buio. Tutti gli abitanti della casa gli stanno vicino. In suo onore, viene organizzata una seduta spiritica da Terenzio e tenuta da Anselmo, unico che ama le teorie sul post-morte. Quest’occasione viene sfruttata al meglio da Papiano per distrarre Adriano e rubargli dodici mila lire; lui non può denunciare il furto come desidera Adriana altrimenti la polizia avrebbe indagato e scoperto il suo segreto. Non può amare nemmeno Adriana, né sposarla, poiché la sua condizione è precaria; arriva ad una conclusione: decide di far morire Adriano Meis e di tornare ad essere Mattia Pascal. Ancora una volta leggerà su un giornale la notizia del proprio decesso, il secondo. Mattia si reca dal fratello Roberto che credendolo morto da due anni rimane stupito, ma in poco tempo si calma e lo informa che Romilda, sua moglie, si è risposata col vecchio e ricco amico Pomino. Pensa alle eventuali conseguenze del suo ritorno, infatti per legge, il matrimonio tra i due sarà annullato: Romilda tornerà ad essere, con o senza il suo consenso, sua moglie. Mattia torna al paese natale, Miragno, nessuno lo riconosce, ma entrando in casa Romilda sviene, Pomino si preoccupa per il matrimonio e la vecchia suocera reagisce gridando come una matta. Mattia, vedendo la famiglia felice, un figlio di Romilda finalmente sano, decide di non intromettersi più; decide perciò di vivere in solitario nel paese. Come una volta, riprende il suo lavoro come bibliotecario insieme a don Eligio; potrà dedicarsi alla scrittura della sua incredibile vita e ogni tanto, recarsi in visita alla sua tomba con l’apparenza di sentirsi morto e seppellito alla Stia, per un suicidio vicino al molino.
Narrato in prima persona ed inattendibile, non è un romanzo di formazione. Fino alla vincita di Montecarlo, Pirandello narra di fatti già accaduti, invece dopo, racconta i fatti man mano che accadono.
Mattia Pascal è vittima di una trappola: famiglia, non va d'accordo con sua moglie e sua suocera; lavoro, biblioteca non frequentata da nessuno (non riceve soddisfazioni)
Conclusione: affermazione dell'amico Don Eligio, anziché cogliere l'occasione egli decide consapevolmente di riappropriarsi: la sua vita è la negazione dell'individualità.
34
Strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia Testo di Luigi Pirandello tratto da Il fu Mattia Pascal. Racconta di una seduta spiritica di Anselmo Paleari,
padrone di casa di Adriano Meis, si occupa di spiritismo. Lanterninosofia: teoria secondo cui ciascuno di noi è dotato di un lanternino acceso capace di creare
intorno a noi un raggio di luce che ci permette di vedere quanto sia spaventosa la realtà oltre la luce. Oltre ai lanternini di cui l'uomo ha bisogno, ci sono dei lanternoni quali verità, virtù, bellezza e fede ognuno con un colore differente. Nei periodi di crisi questi lanternoni tendono a spegnersi, gli uomini diventano come delle formiche impazzite quando un bambino gli chiude l'entrata del formicaio. Cadute le certezze, si generano nell'uomo solo angosce.
È riportata nel testo una poesia di Nicolò Tommaseo, intellettuale del periodo tra i cui principi vi era la religione cattolica. Pirandello affermava che la lampada della fede si è spenta; la fede è utilizzata per illudersi (consapevolezza di una realtà fittizia ed illusoria).
Si riscontra una contrapposizione tra luce e buio con riferimento all'Inno alla notte di Novalis: luce realtà superficiale vs buio realtà vera.
Nella conclusione si ribadisce che la ricerca spasmodica di certezze è inutile: la realtà è un'altra e non è data conoscerla; tante sono le sue sfaccettature.
Le marionette sono beate in quanto prive di qualsiasi angoscia, perciò esse possono attendere senza sofferenza; mentre l'uomo non può farlo.
Sia lo strappo che il fischio del treno sono eventi improvvisi, casuali, inaspettati che causano reazioni differenti nei protagonisti: Belluca dopo aver sentito il fischio è confortato, riesce ad affrontare la durezza della vita quotidiana, mentre lo strappo causa panico ed angoscia in Oreste (eroe classico) il quale diviene Amleto, privo di certezze e sistemi fissi di valori.
Ciaula scopre la luna Novella di Luigi Pirandello. La situazione iniziale descritta è simile a quella di Verga in Rosso Malpelo: vi
sono i minatori ed un protagonista (Malpelo vs Ciaula), ma si inseriscono in due generi letterari diversi.
Non è una novella di denuncia sociale poiché non si vogliono riprodurre meccanismi sociali (come Rosso Malpelo), ma si vuole regalare un'esperienza irrazionale e mistica al lettore resa possibile con Ciaula (istintivo ed animalesco); invece, si tratta di una novella mitica e simbolica: il percorso di Ciaula simboleggia il mito della nascita e della rinascita; uscita all'aria aperta simboleggia la rinascita vista come l'uscita del grembo materno.
Il narratore è etero diegetico ed esterno. Pirandello esprime giudizi e commenti in maniera continua (ad esempio “cosa strana”), mentre Verga inaugura il principio dell'impersonalità, assume il punto di vista dei personaggi. In entrambi, vi è la descrizione in flash back di un incidente in miniera.
Sono evidenti riferimenti a Novalis all'Inno alla Notte infatti descritta come “notte arcana ed ineffabile” ed al canto notturno del pastore errante di Leopardi, la luna è simile alla natura Ciaula senza saperlo percepisce un grande conforto da essa. La luna ha sempre suscitato sensazioni sia un poesia che in prosa: ricorre anche in “Sera fiesolana” e “assiuolo” il primo di D'annunzio il secondo di Pascoli.
Linguaggio: popolare, ricco di espressioni dialettali (rimanda a Verga). Descrizione personaggi: non sono descritti all'ingresso in scena ma s'inseriscono alcuni dettagli durante la
narrazione. Sistema dei personaggi: è possibile individuare oppressori ed oppressi, vinti e non vinti. Ciaula è sfruttato
e maltrattato, vittima dell'ambiente sociale ingiusto e primitivo, sta sotto ad un padrona che lo tratta come una belva. Non si ribella perché è ingenuo ed è in una condizione mentalmente debole.
Pirandello Ciaula, minorato, privo di coscienza, inconsapevole, per lui la scoperta della Luna è un fatto irrazionale. È chiamato così perché non è in grado di parlare, ma emette un verso simile a quello di una cornacchia (in siciliano, ciaula). È il "caruso" di Zi' Scarda; "aveva più di 30 anni e poteva averne anche 7 o 70, scemo com'era" (vv. 60-61).
Verga Rosso Malpelo è colui che ha colto i meccanismi sociali e si comporta brutalmente con gli altri in modo da proteggerli; è cosciente delle avversità del mondo esterno. È così chiamato per il colore dei capelli.
35
Il treno ha fischiato Novella di Luigi Pirandello che inizia in medias res cioè in corso d'opera, priva d'antefatto. Contenuto: Il protagonista, Belluca, un contabile mansueto, metodico e paziente viene sottoposto a
pressioni sia nell'ambito familiare sia lavorativo. Al lavoro, è vittima dei colleghi che cercano di provocare in lui reazioni violente; in famiglia, deve mantenere la moglie, la suocera e la sorella della suocera - tutte e tre cieche - più le 2 figlie vedove e 7 nipoti. Belluca per mantenere la famiglia e poter soddisfare le esigenze delle donne è costretto a intraprendere un secondo lavoro, il copista di documenti, nelle ore notturne. Una sera, dopo aver sentito il fischio di un treno, che precedentemente non aveva mai notato, si ribella alle soprusi del capoufficio; ha una reazione inaspettata, fuori dagli schemi della società e dal suo modo di essere, i suoi colleghi lo ritengono pazzo e lo fanno rinchiudere direttamente nella casa dei matti. Solo un vicino di casa si rende effettivamente conto delle motivazioni che l'hanno spinto a tale gesto ed è l'unico a capire che il protagonista non è diventato pazzo, bensì il suo comportamento è stato una semplice reazione alla situazione diventata ormai insostenibile.
La famiglia è descritta in maniera paradossale, esagerata, come una situazione abnorme. Rappresenta, insieme alla situazione lavorativa, la trappola di Belluca che, invano, cerca di liberarsi.
Il narratore, prima imprecisato e voce autonoma, esprime parare in merito alle vicende narrate ("cose, ripeto, inaudite" - v.88); successivamente si rivela come un soggetto conosciuto a Belluca e al v. 112 afferma d'essere il vicino di casa per questo egli ne conosce bene la famiglia.
Emergono vari punti di vista: dei colleghi, del capo-ufficio, dello stesso Belluca e del narratore. Secondo i critici letterari, la reazione di Belluca è stata scatenata da un fatto inusuale, un'epifania dovuta
al fischio del treno che, gli permette di ricordarsi del mondo intorno a lui. Nel testo, è descritto invece come un fatto naturalissimo: Belluca non è impazzito, si è solo dimenticato dell'esistenza del mondo intorno a lui.
Tale avvenimento ha permesso a Belluca di cambiare la sua vita in meglio: egli con l'immaginazione può viaggiare e riuscire a sopportare al meglio le trappole (famiglia e lavoro); in questo modo Belluca può sostenere la famiglia senza dover soffocare nei problemi, prendendosi pause in mondi immaginari.
Contrapposizioni tra spazio interno ed esterno; quotidiano ed esotico: lo spazio interno fa riferimento ad una condizione angusta e di oppressione di Belluca, mentre lo spazio esterno è denotato positivamente perché grazie all'immaginazione egli può avere conforto. Simile a spazio quotidiano ed esotico: la casa di Belluca è lo spazio quotidiano ed assume una connotazione negativa, al contrario lo spazio esotico è positivo.
Lessico: usa termini del registro medico (es. febbre cerebrale, frenesia, encefalite ..); registro burocratico impiegatizio (es. partite aperte, partite semplice o doppie..); registro parlato (es. ma che dice? che dice?, ma che diavolo dici?...).
Descrizione della condizione di lavoro: “circoscritto” v. 28, “casellario ambulante” v. 32, “vecchio somaro” v. 32, “che tirava zitto zitto ... con tanto di paraocchi” v.33.
Descrizione della condizione familiare: “aveva con se tre cieche la moglie, la suocera e la sorella della suocera...Le due figliuole vedove una con 4 e l'altra con 3 figli...” vv.114-128. Non assimilabile al nido pascoliano in cui il personaggio trova protezione e sicurezza.
36
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero Novella di Luigi Pirandello in cui non si comprende chi dei due, la signora Frola o il signor Ponza, sia il
pazzo, ma entrambi si accusano a vicenda.
Presenza del relativismo: non esiste una verità poiché la realtà è molteplice, soggettiva e dipendente dal soggetto che l'osserva.
È ambientata a Valdana descritta come "città disgraziata, calamità di tutti i forestieri eccentrici" (v. 3). I due si sono appena trasferiti in un casolare "il Favo".
Non è rilevabile la caratterizzazione dei personaggi, né per quanto riguarda l’aspetto fisico, essendo la durata della vicenda molto limitata, né per quanto riguarda l’aspetto interiore, poiché quasi tutti restano intestarditi nella loro curiosità.
Contrapposizione tra modi gentili dei "pazzi" e le strida delle donne: è costruita in modo che la signora Frola e il signor Ponza usino dei modi gentili e rispettosi per dichiarare la pazzia dell'altro; le donne del paese che vorrebbero avere la certezza di chi sia il pazzo invece strillano. —› mondo gretto e disgustoso VS modi rispettosi dove ci si aspetterebbe arroganza e violenza.
Descrizione dei personaggi: Pirandello condiziona i lettori e i cittadini di Valdana già nella presentazione dei personaggi —› per pregiudizio, si è tenuti a pensare che il pazzo sia lui. Infatti:
LUI (SIGNOR PONZA) LEI (SIGNORA FROLA) tozzo senza collo nero come un africano folti capelli ispidi fronte bassa dense e aspre sopracciglia giunte
gracile pallida lineamenti fini, nobilissimi aria malinconica vaga e gentile affabile
Esempio di passaggio dalla novella al teatro: tale novella è stata trasposta da Pirandello nell'opera teatrale "Così è (se vi pare)". Essa presenta delle difformità:
nello spettacolo, Lamberto Laudisi è il narratore, interviene per commentare i fatti principali;
il finale: nella novella, la signora Ponza torna ed essendo che il marito non la riconosce la risposa, mentre nello spettacolo, ella afferma «io sono colei che mi si crede e colei nessuna» —› avviene una stigmatizzazione della realtà, si crea un nuovo disordine e confusionee si riafferma l'assenza di un'individualità che arriva ad essere relativismo estremo.
La trappola Novella programmatica di Luigi Pirandello.
Titolo: rappresenta la condizione economia e sociale dei personaggi sia la situazione famigliare e quindi, riprende dei riferimenti biografici di Pirandello. In questo caso, è vista un covo di sentimenti non sinceri, non spontanei, di tradimenti.
Contrapposizione tra notte buio e notte luce: notte-buio rappresenta la realtà vera, mentre notte luce è una realtà fittizia ed inconsistente, costruita artificiosamente dall'uomo per illudersi; la luce fa riaffiorare la realtà "oscura, orribile: la vera". (Rimando all'Inno della Notte di Novalis).
Si riprendono i concetti di forma e flusso: l'uomo anziché lasciare fluentemente la vita cerca di fissarne le forme. Nel saggio, c'è il bisogno dell'uomo di fissare delle certezze in forme note; qui invece, vi è un'esasperazione della forma che coincide con la morte (visione più dura ed estrema).
Visione della donna come concepitrice, atteggiamento misogino: la donna, essendo colei che procrea, ha la responsabilità terribile di staccare degli esseri dal flusso vitale e di avviarli alla morte . Quest'atteggiamento misogino è dovuto al fatto che il narratore è stato costretto ad avere un rapporto sessuale con la donna che curava il padre da cui egli avrà anche una figlia.
Figura del padre anziano, ammalato, sempre nel letto che viene imboccato e piange poiché si trova in trappola da tanti anni; per liberarlo, il figlio afferma di aver progettato d'interrompere la vita del padre.
37
Il teatro di Pirandello Pirandello si dedica al teatro c.d. teatro pirandelliano, nel 1915 intensifica notevolmente la sua produzione letteraria. A seconda del periodo egli dedicò a varie tipologie:
o dal 1910 scrive drammi appartenenti al teatro borghese; o dal 1916 al 1918 scrive drammi del grottesco: forma che assume l'umorismo in prosa (sentimento del
contrario, fusione tra tragico e comico). Rappresenta in Italia una rivoluzione, come quella di Goldoni: rifiuta le caratteristiche del dramma borghese, rappresenta principi e valori del conformismo; il dramma è serio, verosimile con personaggi a tutto tondo (ovvero descritti e rappresentati per intero); ritratta la famiglia ed i suoi problemi, in particolare l'adulterio; piuttosto che il verosimile Pirandello preferisce rappresentare le contraddizioni dei personaggi.
Nel 1917, Antonio Gramsci definisce Pirandello come:
Un esempio di dramma grottesco è "Così è (se vi pare)", dramma teatrale grottesco basato su La signora Frola e il suo genero Ponza.
o Dal 1921 al 1929 il cd metateatro, ovvero il teatro nel teatro, con il quale descrive i problemi insidi nel teatro (la messa in scena dell'impossibilità di scrivere e rappresentare il dramma). A questa categoria appartengono:
Sei personaggi in cerca di autore: del 1921, rappresenta il conflitto tra personaggi ed attori
Ciascuno a suo modo: del 1924, propone il conflitto tra gli attori e il pubblico
Questa sera si recita a soggetto: del 1929, affronta il conflitto tra attori e regista (colui che dirige gli attori coordinando lo spettacolo in tutti i suoi aspetti).
Pirandello, inoltre, scrive nel 1908 un saggio sull'argomento intitolato "Illustratori, attori e traduttori" in cui esprime una profonda diffidenza quando illustratore, attore e traduttore devono rappresentare. L'illustratore ha il ruolo di rappresentare un'idea, l'attore deve da un testo recitarlo, il traduttore da un testo scritto in una lingua deve tradurlo. Pirandello afferma che nel compiere queste operazioni vi è un passaggio: l'attore difatti, non riesce a rappresentare ciò che l'autore vorrebbe, egli modifica, deforma ciò che è scritto. —› Pirandello considera la rappresentazione teatrale parte di sé, non mette in conto che si possano operare scelte differenti. L'ossessione del relativismo esaspera la discrepanza tra autore e attore.
Sei personaggi in cerca di autore
Titolo: si allude a sei personaggi quali un Padre, una Madre, un Figlio, una Figliastra, una Bambina, un Giovinetto (tutti senza nome).
I sei personaggi sono creature vive di una vita propria, indipendenti, da chi le ha create; l'autore si è rifiutato di scrivere il loro dramma, essi hanno bisogno di viverlo. Essi compaiono in teatro perché possano almeno prendere vita sulla scena, nella rappresentazione teatrale. Dopo l'iniziale sbalordimento il capocomico e gli attori accettano di recite il dramma dei personaggi. Questi in parte lo narrano, in parte lo rivivono dinanzi alla compagna, ridando vita ai conflitti che li dividono. Il capocomico, insieme con il Padre, ne ricava un canovaccio con le azioni essenziali, che dovrà costituire la base dell'interpretazione degli attori.
Vicenda: il Padre scoperto che tra la moglie e il proprio segretario è nato un sentimento: egli decide di assecondarlo, e spinge la moglie a vivere con l'amante, a formarsi una nuova famiglia, abbandonando il Figlio nato dall'unione legittima. Il Padre, con morboso compiacimento, negli anni successivi assiste al
38
crescere della nuova famiglia, alla nascita di 3 bambini, e segue l'infanzia della Figliastra. La Madre, rimasta vedova, per ristrettezza economiche è costretta a lavorare come sarta per l'atelier di Madama Pace; la famiglia può sopravvivere perché la Figliastra di prostituisce nell'atelier, che maschera una casa d'appuntamenti. Qui un giorno giunge il Padre e, senza saperlo, sta per avere un rapporto con la Figliastra, che egli non ha riconosciuto, ma sopraggiunge a tempo la Madre a impedire l'unione quasi incestuosa. Successivamente, muore la Bambina, la figlia minore, che per disgrazia affoga nella vasca del giardino e il Giovinetto che si spara un colpo di pistola.
Pirandello vuole mettere in scena l'impossibilità di scrivere un dramma del genere, nonché di rappresentarlo sulla scena. Per lui, la rappresentazione scenica, a prescindere dagli attori, costituisce un tradimento, una deformazione dell'idea dell'autore (come teorizzato in Illustratori, attori e traduttori).
I Sei personaggi sono la storia di una rappresentazione teatrale che non si può fare per due motivi: 1. Perché l'autore si rifiuta di scrivere il dramma dei personaggi; 2. Perché gli attori non sono in grado di dar forma all'idea concepita dall'autore, per limiti loro
contingenti e per i limiti intrinseci al teatro stesso.
Temi trattati sono:
Impossibilità di comunicare :ognuno ha una visione soggettiva che resta sconosciuta agli altri;
Rapporto verità-finzione e l'inconsistenza della persona individuale: se le persone reali sono costruzioni fittizie, non possiedono maggiore realtà dei personaggi della finzione letteraria.
I personaggi vedendo recitare gli attori non sono d'accordo con gli attori sulla recitazione: essi avrebbero usato un tono diverso, una voce diversa. Personaggi ed attori iniziano a litigare tra loro.
Reazione del pubblico: disorientato, pensa d'essere stato truffato. Alla prima dei Sei personaggi, Pirandello è costretto ad andarsene uscendo da un'uscita secondaria. Le successive rappresentazioni ebbero grande successo tanto che furono riprodotte anche in capitali europee e a New York.
Presentazione del dramma agli spettatori: Quanto gli spettatori sono in sala, il sipario è aperto, un macchinista inchioda degli assi sul pavimento. Intanto gli attori intitolano un'altra commedia di Pirandello "Il giuoco delle parti". Poi, dal fondo compaiono i Sei personaggi vestiti con tuniche rigide, salgono sul palco e iniziano a provare.
Umberto Saba È lo pseudonimo di Umberto Poli. Nasce nel 1883 a Trieste, città che allora apparteneva all'Impero
austro-ungarico; ebbe la cittadinanza italiana per via del padre, Ugo Edoardo Poli. La madre era di origini ebree, venne abbandonata dal marito prima ancora della nascita del figlio.
Egli venne messo a balia da una contadina slovena, Peppa Sabaz, che se ne occupò come se fosse suo figlio; successivamente la madre lo reclamò presso di sé.
Privo di padre e diviso tra amore della madre naturale e della madre adottiva, egli trascorre un'infanzia difficile e malinconica.
Frequenta le scuole con scarso profitto ed abbandona gli studi decidendo di proseguirli come autodidatta. Gli piacciono le poesie di Leopardi, contrastate dalla madre che invece, cerca di fargli leggere scrittori classici più costruttivi e impegnati come Parini, per evitare tendenze pessimistiche.
È un intellettuale periferico, legato alle radici della cultura mitteuropea che agli atteggiamenti di quella nazionale. È un isolamento che perdurerà anche negli anni successivi per lo scarso interesse riservatogli dalla critica fra le due guerre.
Egli stesso soffre di disturbi nervosi e intraprende una cura presso l'allievo di Freud entrando a contatto con la psicoanalisi. Essa gli offre strumenti più raffinati per "smascherare l'intimo vero" e per approfondire quella "chiarezza psicologica" che già caratterizzava la sua produzione poetica.
Colpito dalle leggi razziali a causa della sua origine ebraica, Saba lascia l'Italia per recarsi a Parigi; allo scoppio della guerra si trova a Roma dove Ungaretti lo protegge; durante l'occupazione tedesca vive di nascosto a Firenze come ospite della casa di Montale.
A causa delle crescenti crisi depressivi e della malattia della moglie che decederà, Saba muore nel 1957.
39
Egli si vanta d'essere il poeta più chiaro del mondo, la sua poesia è definita schietta, semplice e onesta (onestà di Alessandro Manzoni vs disonestà di Gabriele D'Annunzio).
Temi trattati: città natale quale Trieste, animali comuni non esotici, natura, persone della famiglia (spesso figlia e moglie).
Egli aderisce ad una linea antinovecentista: era contrario alle correnti del Novecento improntate sullo sperimentalismo e sull'avanguardismo poiché egli scegli la tradizione e la chiarezza. —› Ribadisce che è più difficile fare poesia nel contesto con la tradizione che cadere in scelte diverse.
Elementi in comune con Italo Svevo:
pseudonimo: Svevo per indicare le proprie origini, mentre Saba perché non riconosce il padre;
città natale: Trieste;
intellettuali periferici: soffrono entrambi dell'isolamento rispetto agli altri intellettuali italiani, però Umberto Saba lo apprezzo e prova un atteggiamento d'indifferenza verso le guerre mondiali;
psicoanalisi: Svevo ritiene che serva più ai romanzieri che agli ammalati, mentre Svevo ritiene che dia una caratterizzazione profonda ai testi poetici.
Sintassi: ridurre il discorso a grado zero, riportarlo ad un livello elementare e non banale. Le parole sono scelte e non improvvisate e adatte a cogliere la verità.
Il Canzoniere È una raccolta di Umberto Saba; risulta divisa in sezioni che possono essere raggruppa te in 3 volumi
corrispondenti ad archi temporali (1900-1920; 1921-1932; 1933-1954).
Il Canzoniere è un'opera da considerarsi in modo organico, una sorta di biografia con personaggi e situazioni che lo stesso Saba definisce un romanzo —› accompagna una vita intera ("Il Canzoniere come romanzo, come storia").
Amai Testo poetico facente parte della sezione Mediterranee (1945-46, III volume Canzoniere).
È considerato un bilancio fatto da Umberto Saba sulle scelte e la vita poetica.
Scelte poetiche di Umberto Saba:
Predilige le parole comuni. Si contrappone agli altri autori del Novecento.
Usa le rime più note, più banali
Mette in evidenza i contenuti che rappresentano la verità
Alla fine ama lettore: egli instaura un rapporto amichevole di fiducia, speranza di conclusione positiva del futuro.
Parole chiave: amore, sogno, paura, cuore, gioco, amai, Trieste, rima, fiore, amore, verità, dolore.
A mia moglie Testo poetico facente parte della sezione Casa e campagna (1909-10, I volume Canzoniere).
La moglie è esplicitamente paragonata ad animali da cortile, comuni: a delle galline per la voce dolcissima, a una gravida giovenca per la fertilità, a una cagna per la dolcezza degli occhi e la ferocia nel cuore, a una rondine per la leggerezza, a una formica per la previdenza e ad un'ape per l'operosità.
Nel descrivere la moglie (gravida giovenca e pavida coniglia), riferisce caratteristiche materne —› emerge perciò il ritratto della balia che s'occupò di lui da piccolo.
40
La capra Testo poetico facente parte della sezione Casa e campagna (1909-10, I volume Canzoniere).
Tratta del dolore universale: riscontrato in Leopardi nel "canto notturno di un pastore errante". Si manifesta con affinità tra uomini e animali, in più è sottolineata con un viso con caratteristiche tipiche degli ebrei.
Dolore secondo Leopardi e Saba: Saba Leopardi
Il dolore ispira sentimenti di amore e pietà e lo accetta. Riscontrando l'affinità con gli animali, l'uomo diventa migliore (il dolore è sentimento comune con gli animali).
Il dolore è provoca rassegnazione e determina il pessimismo cosmico.
La capra è rappresentata come un animale solo, legato ovvero privo di libertà che non può far altro che mangiare per questo è sazio d'erba; l'autore paragona il lamento dell'animale in questa situazione a quello di una persona sofferente.
Trieste Testo poetico facente parte della sezione Trieste e una donna (1910-12, I volume Canzoniere).
"cantuccio" (v. 5): espressione riconducibile a una tragedia di Manzoni, luogo dove l'autore si sente protetto.
Si ritrovano le caratteristiche dell'autore schivo nella città che si trova nel luogo adatto. L'autore lascia libero il lettore di amarla o meno.
Trieste è descritta dall'alto, salita più deserta.
Città vecchia Testo poetico facente parte della sezione Trieste e una donna (1910-12, I volume Canzoniere).
Tratta ancora di Trieste, dal cuore della città, delle persone, del centro storico.
L'infinito è ritrovabile nella vita concreta delle persone umili. Inserisce l'elenco degli umili e degli emarginati della società (prostituta, marinaio, vecchio, femmina, dragone, tumultuante) per mettere in luce che essi sono tutte creature di Dio, accumunati tutti dal dolore.
Infinito secondo Leopardi e Saba: Saba Leopardi
Infinito coincide con il dolore Infinito suscita l'immaginazione e da' piacere all'uomo
Ulisse Testo poetico facente parte della sezione Mediterranee (1945-46, III volume Canzoniere).
Ulisse è la chiave di lettura del testo; personaggio-simbolo dell'uomo di rischiare; rimanda inoltre, al tema del viaggio quindi ai temi omerici e all'inferno dantesco (canto XXVI - Ulisse si trova li perché voleva vedere la montagna del purgatorio oltrepassando le colonne d'Ercole). È il titolo del capolavoro di James Joyce che tratta dell'uomo in crisi.
Lo spirito di Ulisse caratterizza Umberto Saba il quale preferisce luoghi insicuri, ignoti agli uomini, così come Ulisse.
Non presenta la suddivisione del testo in strofe e in versi, ma è ricca di enjambement.
41
ERMETISMO Tendenza poetica che si sviluppa negli anni 30 e che ha come centro Firenze
Ha come punto di riferimento la poesia di Giuseppe Ungaretti.
Termine: si fa risalire ad Ermete, dio delle scienze occulte. La definizione viene fornita da Francesco Flora che pubblica il libro “La poesia ermetica” in cui con "ermetismo" tratta di:
poesia indecifrabile ed oscura
linguaggio difficile ed arduo da comprendere; così come le scienze occulte —› accezione negativa che cela disprezzo.
Carlo Bo scrive un saggio “Letteratura come vita” dal quale traspare un'interpretazione positiva dell'ermetismo: la poesia ermetica è la vita stessa, è pura e rifiuta qualsiasi legame con la storia, rappresenta la realtà più intima dell'individuo e riflette la condizione dell'uomo (individuo è in crisi a causa delle due guerre).
Secondo Ungaretti, la poesia è unica, individuale e propria; non è da considerarsi come espressione di un determinato fatto od evento.
La poesia si rivolge ad un ristretto numero di persone, in particolare a coloro che ne condividono l’impostazione e le attese. La distanza tra i poeti ermetici e il pubblico è determinata dalla profondità della poetica.
I principali poeti ermetici sono: Salvatore Quasimodo, Mario Luzi e Alfonso Gatto. Ungaretti all'inizio si dedicherà all'ermetismo, ma poi lo abbandonerà.
Giuseppe Ungaretti Nasce nel 1888 ad Alessandria d'Egitto dove i genitori, provenienti da Lucca, gestivano un forno di pane.
Il padre muore nel 1890 in un incidente mentre lavorava come operaio agli scavi per il canale di Suez.
Ad Alessandria frequenta l'Ecole Suisse Jacot e inizia ad occuparsi di letteratura e di scrittori moderni e contemporanei, da Leopardi a Nietzsche. Di questo luogo ne rimarrà un paesaggio fantastico ed irreale.
Passando per l'Italia, si reca a Parigi, dove frequenta i corsi del Collège de France e della Sorbona; li ha modo di approfondire la conoscenza della poesia decadente e simbolista.
Nel 1914 va in Italia per partecipare con entusiasmo alla guerra e s'arruola come volontario; è mandato a combattere sul Carso dove scriverà nel 1916 Il porto sepolto e nel 1919 Allegria di naufragi (poesie scritte in trincea su fogli occasionali, ossimoro che indica la gioia di un momento in una situazione di guerra, per dar maggior peso alla gioia dell'attimo) che poi confluiranno nel volume L'allegria.
Nel 1921 si trasferisce a Roma; aderisce al fascismo convinto che la dittatura potesse rafforzare la solidarietà nazionale.
Nel 1936 ricopre la cattedra di letteratura italiana presso l'Università di San Paolo in Brasile fino al 1942 quando rientra in Italia e inizia ad insegnare letteratura italiana contemporanea all'Università di Roma.
Le vicende della Seconda guerra mondiale segnano il maturare di una nuova e dolorosa consapevolezza, preceduta da alcuni gravi lutti familiari: la morte del fratello e la perdite del figlio prematura. In questo periodo scrive Il dolore 1947.
Nel 1964 tiene alcune lezioni a New York presso al Columbia University.
Muore a Milano nel 1970.
L'Allegria Volume composto da due raccolte di poesie:
Porto sepolto del 1916
Allegria dei Naufragi del 1919, si compone di un insieme di poesie scritte in trincea su fogli occasioni. Il titolo richiama la gioia di un momento in una situazione di guerra. L'ossimoro del titolo serve a dar maggior peso alla gioia di un attimo.
42
Il porto sepolto È una la prima raccolta di poesie scritte da Ungaretti nel 1916.
Ungaretti da' la spiegazione del titolo facendo riferimento a una storia raccontatagli all'età di 16/17 anni da ingeneri francesi in cui si narrava l'esistenza di un porto di cui non esisteva più nulla.
Indica che la verità delle cose rappresenta il mistero.
Veglia
Poesia di Ungaretti che affronta il tema della guerra. Scritta il 23 dicembre 1915, periodo vicino Natale in cui l'autore prova sentimento.
Visione della guerra da un punto di vista “basso”: soldato semplice, volontario in trincea
I suoni delle parole sottolineano la crudezza della guerra.
v.11-12 “ho scritto lettere piene d’amore”: in situazioni come queste c’è la necessità, la voglia di scrivere lettere d’amore
Data l'esperienza vicina di un uomo morente sorge la necessità di sentimenti d'amore.
Ultima strofa: rovesciamento inatteso: dalla durezza della guerra all’esaltazione della vita.
San Martino del Carso Poesia di Ungaretti del 1916.
Poetica della parola: Ungaretti usa poche parole scelte con accuratezza comuni, non auliche per questo la parola è carica di significato.
Rappresentazione della guerra molto cruda e dura: non è un’accusa a livello ideologico, ma una riflessione sulle conseguenze che la guerra ha sulla vita umana.
v.4 “brandello” si usa di solito in riferimento al corpo umano; v.9-10-11-12 analogia tra cuore e cimitero / cuore e poesia.
Mattina Poesia di Ungaretti formata da 4 parole di cui 2 monosillabi.
Il titolo è parte integrante del testo. Inizialmente era “Cielo e mare”, ma pensava fosse scontato e banale; è diventato Mattina per l'analogia con l'immensità.
In una mattina luminosa e nella cornice della guerra, l’io lirico sente nel suo animo una sensazione d’infinito.
E’ l’esempio più estremo e noto della ricerca ungariettana e della poetica ermetica: poche parole per esprimere grandi significati (c.d. poetica della parola).
Soldati Poesia di Ungaretti; il titolo è parte integrante del testo.
Tema trattato: la guerra per sottolineare la precarietà della vita umana, soprattutto quella dei soldati.
“Si” (v. 1) uso volute dell'impersonale, accentua l’anonimato dei soldati.
La vita dei soldati è come la foglia d'autunno: essa può staccarsi è morire. Riprende l'inferno dantesco in cui Caronte afferma “le anime si staccano come le foglie d’autunno”.
Sentimento del tempo Raccolta poetica di Ungaretti. Fa riferimento allo scorrere del tempo veloce che provoca nostalgia e malinconia. Ungaretti sente il bisogno di recuperare una forma tradizionale con il Sentimento del tempo e il Dolore: usa periodi più complessi rispetto ad altri testi e ritorna all'uso della punteggiatura.
43
Di luglio Poesia di Ungaretti.
Con "lei" (v. 1) si fa un riferimento indeterminato all'estate; è una persona con gli occhi color calce. L'estate è rappresentata come distruttiva, impetuosa, aggressiva (toglie dalla terra qualsiasi copertura): la prima strofa prepara alla distruzione, poi si passa alla violenza che si manifesta in pieni; poi il ritmo spezzato si placa negli ultimi 3 versi e diviene più lento.
Non gridate più Poesia di Ungaretti scritta nell'immediato dopoguerra e indirizzata a coloro che hanno superato la
"tragedia di quest'anni".
Si tratta di un invito e preghiera (non un comando duro, come sembrerebbe): Ungaretti invita, con pietà, a non bombardare il cimitero in cui sono seppelliti i morti.
Occasione di stesura: bombardamento del cimitero del Verano (Roma).
L'autore vuole trasferire il sentimento.
Sono presenti tante liquide (ovvero tante l), es. lieta, dell', …
Eugenio Montale Traduttore, saggista ed attore che nasce a Genova come sesto figlio.
Frequenta le scuole tecniche, ottenendo il diploma di ragioniere. Prende intanto lezioni di canto che interromperà conservando quella per la musica.
Partecipa alla Prima guerra Mondiale come sottotenente.
Scrive un "Omaggio a Italo Svevo", un articolo con il quale apprezza l'attività letteraria di Italo Svevo, apparso su un giornale e segnala per la prima volta in Italia l'importanza dello scrittore triestino fino ad allora ignorato.
Egli firma il manifesto degli intellettuali antifascisti redatto da Benedetto Croce: espressione di un netto dissenso, civile e politico, nei confronti della dittatura, nella vita di Montale negli anni del fascismo.
Nel 1975 riceve premio Nobel per la letteratura.
Ossi di seppia Prima raccolta di versi di Eugenio Montale pubblicata nel 1925. Montale è ligure e vedeva spesso sulla spiaggia gli ossi di seppia lasciati dal mare. Simboleggiano l’aridità e l’asprezza dell’esistenza umana.
I limoni Posta all'inizio della raccolta Ossi di seppia. Presenta uno schema libero con prevalenza di endecasillabi.
Non vi è l'immediatezza e la semplicità di Saba; Montale ha una visione pessimistica della vita, data anche dal contesto storico della dittatura fascista.
Contenuto:
1° strofa: All’inizio della poesia, l’io lirico si rivolge al lettore con tono colloquiale. I “poeti laureati” sono coloro con la corona dall’alloro, il lauro è una pianta sacra, questi poeti sono riconosciuti grandi e con molto prestigio. Sembra che questi poeti debbano necessariamente fare poesie auliche e ricercate. Vi è quindi una contrapposizione tra i poeti laureati e l’autore, si differenziano per i luoghi. In questa prima strofa, infatti, vi sono luoghi comuni e familiari.
2° strofa: Il poeta passa dall’io lirico al noi come ad indicare una categoria di autori. Le prime due strofe rappresentano la parte descrittiva dei paesaggi liguri. L’autore sottolinea che prende le distanze dai laureati.
3° strofa: Di seguito vi è la parte più riflessiva della poesia. L’autore fa riferimento ai silenzi. Con essi sembra di essere in procinto nel trovare, capire una profonda verità.
4° strofa: Fa ancora riferimento ai silenzi.
44
5° strofa: Inizia con una frase avversativa (ma) che spezza l’illusione, la speranza. Il paesaggio cambia, diventa negativo. “I gialli dei limoni” (v45) è come un’apparizione, rappresenta l’illusione della felicità. Vi è un’illusione di gioia e di speranza (vv. 46-49).
Particolarità della poesia: uso del correlativo oggettivo. Lo ricava da Thomas Elliot, un poeta inglese. L’unico modo per dare espressione artistica all’emozione, è di trovare un insieme di oggetti che corrispondono all’emozione o al suo concetto astratto; cioè rendere attraverso un oggetto concreto ciò che è astratto. Es. per speranza il giallo; per la positività trombe d'oro (canzoni)
Non chiederci la parola È un documento di poetica.
Formato da 3 quartine di varia lunghezza, con rime ABBA e CDDC (incrociate), EFEF (alternate).
Contenuto:
1° strofa: L’autore si riferisce direttamente al lettore. È presente una natura arida e desolata.
2° strofa: L’ombra rappresenta i lati oscuri dell’uomo.
3° strofa: Afferma che la poesia non è in grado di dare un messaggio positivo, può solo dire ciò che non è e ciò che non vuole.
Rappresentazione della natura desolata ed aspra.
L'ombra rappresenta i lati oscuri dell'uomo —› l'uomo conformista non si accorge dei lati oscuri di sé (non si rende conto della sua esistenza).
Non (primo verso, terza strofa e in chiusura): accezione negativa, è posizionato strategicamente per sottolineare l’assenza di speranza (significato profondo della dittatura fascista).
Meriggiare pallido assorto Formato da 3 quartine ed una strofa di 5 versi che comprendono: novenari, decasillabi ed endecasillabi.
Vi è la descrizione di un paesaggio arido.
Non vi è nulla a che vedere con il panismo di D’Annunzio.
Nella prima strofa il verbo all’infinito “meriggiare” lascia il soggetto indefinito. Il paesaggio rimanda alla Selva dei suicidi del XIII canto dell’Inferno della Divina Commedia.
Spesso il male di vivere ho incontrato Aiuta a comprendere al meglio il correlativo oggettivo.
Formato da 2 quartine di endecasillabi, tranne l’ultima. Le rime sono ABBA e CDDA.
Contenuto:
1° strofa: Punto di vista basso. Il “male di vivere”, rappresentato come se fosse un qualcosa di concreto, è un insieme di sentimenti negativi che vengono considerati dall’autore come se fossero qualcosa di concreto, reso attraverso oggetti/animali, es. rivo strozzato, foglia riarsa, cavallo stramazzato.
2° strofa: Punto di vista alto. Vi è un concetto molto forte reso da “divina Indifferenza”. Sta ad indicare che l’indifferenza è come una divinità che non ha nulla a ce vedere con l’uomo. Rimanda all’indifferenza della Luna nei confronti del dolore umano presente nello Zibaldone di Leopardi.
45
Salvatore Quasimodo
Acque e terre Ed è subito sera Temi: solitudine, morte, precarietà della vita.
L’uomo è visto come esule della vita.
“Cuor della terra” indica il profondo delle cose.
La parola “sera” alla fine della poesia rimanda a Ugo Foscolo che paragona la sera alla morte.
Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici Viene scritta nel secondo dopo guerra.
È una poesia post-ermetica, in quanto si utilizza un linguaggio più accessibile.
Il titolo rimanda al salice piangente, simbolo di dolore.
Si sente l'esigenza di una poesia civile; linguaggio legato alla vicina realtà, meno oscura, meno ermetica —› poesia post-ermetica. La poesia ermetica non è una costante la ritroviamo in diversi autori.
È riferita ai poeti che non si dichiarano a sostegno della lotta partigiana.
Italo Calvino
Il sentiero dei nidi di ragno Si tratta del primo romanzo di Calvino risalente al 1948-1949. Prefazione scritta nel 1964: da' una serie di
indicazioni utili circa il contesto. Ha una rilevanza particolare, in quanto solitamente il primo romanzo per gli scrittori ha sempre qualcosa di particolare: è più forte, più emozionante, ha una maggiore carica emotiva.
Il sentiero dei nidi di ragno è il luogo in cui Pin, il protagonista delle vicende, decide di nascondere la pistola del tedesco. Questo luogo ha un ruolo simbolico, rimanda all’infanzia.
È un romanzo che si colloca nel neorealismo, in quanto da una parte vi è il realismo, dall’altra una dimensione fantastica. Tutto è visto dagli occhi di un bambino.
La vicenda della lotta partigiana è inserita come se si trattasse di una fiaba.
L’estraneità dei Pin a quella vita da adulto corrisponde all’estraneità dell’autore rispetto al vero mondo dei partigiani: questi erano principalmente appartenenti alle classe medio - bassa, Calvino invece apparteneva all’alta borghesia.
Dal 1943 al 1945 Italo Calvino partecipa come partigiano alla Seconda guerra mondiale (fece parte della Brigate Garibaldi).
Nel suo racconto sceglie una banda di sbandati, cioè non degli eroi con un chiaro obiettivo, perché vuole sottolineare l’esigenza di tutti, dalla classe sociale più elevata alla più bassa, nel dare un contributo effettivo ad un paese che si stava liberando dalla dominazione tedesca e fascista.
Contesto (scritto nella prefazione): Italo Calvino sottolinea che da parte della gente comune vi è la necessità di raccontare per senso di liberazione rispetto alla drammaticità degli eventi appena trascorsi.