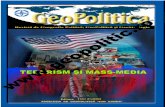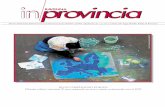"La Politica Europea di Vicinato tra condizionalità e geopolitica. Sfide alla governance esterna...
Transcript of "La Politica Europea di Vicinato tra condizionalità e geopolitica. Sfide alla governance esterna...
3
A mio fratello Riccardo,
che mi ricorda ogni giorno
quanto sia importante
rincorrere il proprio sogno.
5
S O M M A R I O
INTRODUZIONE ........................................................................................ 9
PARTE PRIMA
IL CONTESTO POLITICO DELLE RELAZIONI TRA UNIONE
EUROPEA E UCRAINA .................................................................................... 13
Capitolo 1
I primi passi della cooperazione UE-Ucraina (1991-2003) ..................... 15
1.1. La neonata Ucraina e il nuovo ordine internazionale ........................ 15
1.1.1 L´indipendenza dall´Urss ............................................................ 15
1.1.2. La "scelta europea" dell'Ucraina post-indipendenza ................ 16
1.1.3 Un passato ancora presente ........................................................ 18
1.2 Le fondamenta della cooperazione UE-Ucraina negli anni Novanta . 20
1.2.1 Alcune questioni irrisolte ............................................................ 20
1.2.2 L´Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC) del 1994 ...... 21
1.3 Diversi livelli di ambizione ................................................................ 23
1.3.1 La "scelta europea" nei decreti del Presidente Kuchma ............. 23
1.3.2 Una risposta deludente ................................................................ 25
1.4. Valutazioni ex-post: l´Ucraina a dieci anni dall´indipendenza ......... 27
1.4.1 "Integrazione per dichiarazione"? .............................................. 27
1.4.2 Lo stato delle istituzioni politiche e il processo di
democratizzazione .......................................................................................... 29
1.4.3. Alcuni segnali dalla sfera economica ........................................ 32
6
Capitolo 2
"L´Europa é piú grande": il lancio della Politica Europea di Vicinato
(PEV) ..................................................................................................................... 35
2.1 Le origini ............................................................................................ 35
2.1.1 Proposte per la nuova Europa .................................................... 35
2.1.2 Le origini della PEV .................................................................... 37
2.1.3 Le aspirazioni della PEV e il raggio d'azione ............................. 41
2.2 La PEV come nuova governance esterna dell´UE: tra condizionalità e
soft power ........................................................................................................... 43
2.2.1 La PEV all´interno delle istituzioni: una "cross-pillar policy" ... 43
2.2.2 Il "modello allargamento" applicato alla PEV ........................... 45
2.2.3 Condizionalità senza adesione: un esperimento fallito? ............. 47
2.2.4 La nascita del Partenariato Orientale ........................................ 50
2.4 Considerazioni critiche: la PEV 10 anni dopo ................................... 54
2.4.1 I principali punti critici nell´architettura concettuale della PEV
....................................................................................................................... 55
2.4.2 Lo stato dell´arte del nel 2014: molto resta ancora da fare ....... 57
PARTE SECONDA
UNIONE EUROPEA E UCRAINA NEL CONTESTO DELLA
POLITICA EUROPEA DI VICINATO. UN EFFICACE STRUMENTO DI
GOVERNANCE ESTERNA? .............................................................................. 61
Introduzione e nota metodologica ............................................................ 63
Capitolo 3
La dimensione commerciale: il cammino verso il DCFTA con l´UE ..... 65
3.1 Le priorità della cooperazione commerciale nei primi anni della PEV
7
........................................................................................................................... 65
3.1.1 Le relazioni commerciali all'interno della PEV .......................... 65
3.1.2 Progressi e punti di stallo nelle negoziazioni ............................. 68
3.2 Un salto qualitativo: verso il DCFTA con l'Unione ........................... 70
3.2.1 L'Agenda di Associazione e il DCFTA ........................................ 70
3.2.2 Il DCFTA dal punto di vista dell´oligarchia in Ucraina ............. 72
3.3 Il progetto di Unione Economica Euroasiatica (UEE): un ostacolo al
potere normativo dell´UE in Ucraina? ............................................................... 75
3.3.1 Dall´Unione Doganale (UD) al progetto di UEE ....................... 75
3.3.2 Oltre l´economia: l´UEE come progetto geopolitico parallelo
all´UE ............................................................................................................. 77
3.3.3 L´Ucraina contesa: quali prospettive? ........................................ 79
3.4 Un settore delicato: la questione energetica ....................................... 83
3.4.1 L'Ucraina: un ponte per il trasporto energetico tra Russia ed
Europa ........................................................................................................... 83
3.4.2 Il dialogo energetico UE-Ucraina nell'ambito della PEV .......... 84
3.4.3 L'impatto delle relazioni Russia-Ucraina sulla sicurezza
energetica europea ........................................................................................ 85
Capitolo 4
Politica e condizionalità in Ucraina nel quadro della PEV ..................... 89
4.1 Una democrazia instabile: élites, elezioni ed il caso Tymoshenko ... 90
4.1.1 La Rivoluzione Arancione: aspettative deluse ............................ 90
4.1.3 Una democrazia instabile: Yanukovych e il caso Tymoshenko ... 93
4.1.3 La condizionalità nel caso Tymoshenko: un approccio "costi-
benefici" ......................................................................................................... 95
4.2 La Repubblica Autonoma di Crimea: una questione irrisolta ............ 98
4.2.1 Una fonte di instabilità nella regione .......................................... 98
4.2.2 Aspetti della gestione politica della R.A. di Crimea ................. 101
4.3 Valutare la condizionalità politica europea applicata all'Ucraina .... 102
8
4.3.1 PEV e Piano d'Azione a Kiev: tra politica e burocrazia ........... 102
4.3.2 "Non solo PEV": riconsiderare l'approccio dell'UE ................ 106
Capitolo 5
L´internazionalizzazione della questione ucraina ................................. 109
5.1 Lo scoppio della crisi ....................................................................... 110
5.1.1 Il "no" di Yanukovych all'UE: prima e dopo il Summit di Vilnius
..................................................................................................................... 110
5.1.2 L'annessione della Crimea: vittoria o sconfitta per Mosca? .... 113
5.1.3 Reazioni internazionali e de-escalation della crisi ................... 115
5.2 Riflessioni su una crisi ancora in corso ............................................ 118
5.2.1 Quale futuro per l´Accordo di Associazione? ........................... 118
5.2.2 Ripensare la politica energetica in Europa .............................. 120
5.2.3 Le prospettive dopo le elezioni presidenziali del 25 maggio 2014
..................................................................................................................... 122
CONCLUSIONI ....................................................................................... 125
Bibliografia ................................................................................................ 129
9
INTRODUZIONE
Dal novembre 2013, una crisi profonda caratterizza l´Ucraina. Il Presidente
Yanukovych è stato deposto e si è dato alla fuga. Una parte del territorio, la
Repubblica Autonoma di Crimea, è stata annessa alla Federazione Russa e altre
città nell'Est del Paese hanno dichiarato la loro indipendenza dal governo centrale
di Kiev. I morti tra la popolazione civile finora sono centinaia e, nonostante la
forte condanna espressa da Europa e Stati Uniti, non sembra realistica in un
prossimo futuro l'ipotesi di una normalizzazione della situazione.
Questa tesi nasce dal bisogno di rispondere ad un'assillante domanda, sorta
spontaneamente già a partire dal Vertice del Partenariato Orientale tenutosi a
Vilnius del novembre 2013 e alimentatasi con il susseguirsi tragico degli eventi:
quali sono le condizioni che hanno reso possibile lo scoppio di una tale crisi in un
Paese situato appena oltre i confini dell'Unione Europea?
Per tentare di fornire qualche argomentazione a proposito, non è sufficiente
limitarsi a seguire la cronaca degli ultimi mesi. La ricerca svolta per questa tesi
risale fino all'indipendenza dell'Ucraina nel 1991, benché si concentri soprattutto
sull'ultimo decennio. Il taglio scelto, pur mirando il più possibile all'obiettività,
riflette l'intenzione di approfondire lo studio della Politica di Vicinato dell'UE
applicata al caso ucraino: inevitabile quindi che rimanga parziale ed incompleto.
La tesi non riguarda tuttavia solamente l'Unione Europea: per comprendere
a fondo la natura dei tragici fenomeni attuali, è necessario conoscere la particolare
situazione politica, economica e sociale dell'Ucraina, i suoi conflitti identitari e il
pesante retaggio dell'epoca sovietica, nonché le sue aspirazioni europeiste. Mentre
durante i decenni dell'URSS il senso di appartenenza dell'Ucraina risultava più
definito, sembra che con l'indipendenza questo Paese sia rimasto intrappolato tra
Est e Ovest. Pur cercando di sviluppare nel corso degli anni una propria identità,
non è mai riuscita a sfuggire al suo intrinseco dualismo. L'approccio con cui
l'Ucraina partecipa alle relazioni internazionali riflette la sua duplice identità e
10
gioca un ruolo importante nel definire la sua posizione attuale nello scacchiere
mondiale: i leader di Kiev infatti cercano di mantenere nella loro politica estera un
atteggiamento "multivettoriale", per sfruttare a proprio vantaggio sia la
cooperazione con la Federazione Russa sia quella con l'UE.
In questa tesi un'attenzione particolare viene dedicata all'atteggiamento
dell'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina, caratterizzato sin dall'inizio da
una certa ambiguità: nella PEV infatti, pur con l'obiettivo di raggiungere un alto
livello di integrazione, non si pone come punto di arrivo l'adesione all'UE, un
fattore che risulta invece determinante nello stimolare le riforme politiche ed
economiche dei Paesi del grande allargamento del 2004. Il Presidente Kuchma
(1994-2004), durante una conferenza a Varsavia, espresse in questo modo la sua
frustrazione per l'approccio europeo: "Solo Dio sa dove si trova l'Ucraina oggi,
anche se noi da molto tempo abbiamo preso la direzione strategica dell'Europa
(...). Non chiediamo molto all'UE oggi, vogliamo solo sapere se ci vuole come
membro...nel corso degli ultimi anni non abbiamo ricevuto un segnale chiaro che
mostrasse che l'Ucraina era la benvenuta nell'Unione Europea"1.
Un importante aspetto emerso dall'attività di ricerca, e che spiegherebbe in
parte perché il "pendolo geo-politico" dell'Ucraina continui ad oscillare tra l'UE e
la Federazione Russa, è la mancanza negli anni di un serio dibattito strategico in
Europa sul futuro delle relazioni con i vicini dell'Est2. A partire dal lancio della
Politica Europea di Vicinato nel 2004, la questione della membership è stata
considerata in modo superficiale nei corridoi di Bruxelles, mentre per Kiev rimane
ancora oggi un elemento imprescindibile e prioritario della sua politica estera.
Come si cerca di argomentare nella tesi, tuttavia, non è possibile prescindere
dall'importanza geopolitica di un Paese come l'Ucraina, vista come ponte tra
1 L. Kuchma, Forum Economico Europeo di Varsavia, 29 aprile 2004. Traduzione dell'autore.
2 Intervista dell´autore a L. Schiavo, Direttore Generale della DG Affari Esteri, Segretariato
Generale del Consiglio dell´UE, 6 maggio 2014. Le informazioni riportate rappresentano unicamente il punto di vista personale dell´intervistato e non intendono in alcun modo esprimere la posizione ufficiale del Consiglio dell´UE.
11
Europa e Russia: risulta quindi difficile immaginarla come un membro a pieno
titolo dell'UE o legata solamente a Mosca3. Senza addentrarsi in questo genere di
questioni cui è arduo dare una risposta, quello che più volte verrà sottolineato è
invece la necessità per l'UE di accompagnare lo sviluppo delle relazioni con
l'Ucraina con un solido e strutturato dialogo con la Russia, sia nella dimensione
politica (per garantire la pace e la sicurezza nella regione) sia in quella economica
(immaginando, forse, di poter realizzare in futuro una Zona di Libero Scambio
euroasiatica).
La tesi è suddivisa in due Parti: nella prima, si introduce il contesto politico
ed economico delle relazioni tra Unione Europea ed Ucraina dall'indipendenza del
1991 fino ai primi anni Duemila, un periodo caratterizzato dalle difficoltà di
costruire un nuovo Stato democratico ed orientato al mercato dopo decenni di
sovietismo. Si illustrano inoltre i principali aspetti della Politica Europea di
Vicinato, sottolineandone i successi ma soprattutto i punti deboli: gli elementi e le
critiche generali alla PEV vengono applicati concretamente al caso ucraino nella
Parte Seconda.
Innanzitutto, ci si sofferma sulla dimensione commerciale delle relazioni
UE-Ucraina, percorrendo le diverse tappe che sfociano nel Deep and
Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) , la cui firma pende tutt'ora4.
Viene affrontato il conflitto indiretto tra la politica di progressiva integrazione
economica offerta dall'UE ai Paesi del Partenariato Orientale e il progetto
parallelo di Unione Doganale Euroasiatica lanciato dal Presidente Putin nel 2010.
Infine, speciale considerazione viene data al settore energetico, in cui la Russia
gioca un ruolo fondamentale utilizzando la sua posizione di paese fornitore come
un'arma politica per influenzare le decisioni del governo di Kiev.
3 Prof P. Defraigne, intervento alla conferenza "Multipolarité et Multilateralisme.
Un «Concert Mondial des grandes Nations» (USA, Chine, Russie, Japon, UE) ou une «Gouvernance Globale renforcée» (G8, G20, FMI, Banque Mondiale)? Peut-il y avoir un monde sans hégémonie?", InfoPoint Europa, Bruxelles, 4 marzo 2014. 4 È previsto avvenga ai margini del Consiglio Europeo del 26-27 giugno 2014.
12
Un altro aspetto analizzato nella tesi riguarda la sfera politica ed il
meccanismo di condizionalità caratteristico della PEV. Senza una chiara
prospettiva di adesione, l'UE non è riuscita finora ad essere efficace nello
stimolare le riforme democratiche e la modernizzazione istituzionale in Ucraina.
Tuttavia altri fattori, esterni alla PEV, concorrono a spiegare la difficoltà di
attuare le necessarie riforme nel Paese: un'instabilità politica cronica, un altissimo
tasso di corruzione, l'influenza dell'oligarchia e le pressioni da parte della
Federazione Russa per ostacolare l'avvicinamento di Kiev all'Europa.
L'ultimo capitolo, che tratta la crisi attuale, deve essere letto alla luce delle
argomentazioni portate nei capitoli precedenti in modo tale da poter collocare i
dati di cronaca nel loro contesto. Alcuni fenomeni, anche se emersi solo negli
ultimi mesi, hanno infatti le loro radici in errori strategici commessi sia
dall'Ucraina, sia dall'Unione Europea negli anni trascorsi.
15
CAPITOLO 1
I PRIMI PASSI DELLA COOPERAZIONE UE-UCRAINA
(1991-2003)
1.1. La neonata Ucraina e il nuovo ordine internazionale
1.1.1 L´indipendenza dall´Urss
Con la caduta del Muro di Berlino e l'implosione del regime comunista
sovietico, la prospettiva di un'Europa unita riprendeva vigore e l'adesione
all'Unione Europea costituiva da subito un cardine della politica estera dei nuovi
Paesi dell'Est.
L'Ucraina, il più esteso e popoloso tra questi dopo la Federazione Russa,
divenne indipendente il 24 agosto 1991, cinque giorni dopo un tentativo fallito di
colpo di Stato ordito dagli elementi del PCUS per deporre Gorbatchev e restaurare
un rigido regime comunista. Nella stessa occasione venne fissata la data per il
referendum sull'indipendenza e per le elezioni presidenziali (1 dicembre 1991) che
videro vincitore Leonid Kravchuk. Un risultato sorprendente si rivelò quello del
referendum, in cui più del 90% dei cittadini ucraini si esprimeva a favore
delll'indipendenza. È interessante notare inoltre che, pur essendo stata la sesta
dichiarazione d'indipendenza dell'Ucraina nel corso del XX secolo, per la prima
volta nel 1991 non si verificava in seguito ad una guerra civile o ad un'invasione
straniera5.
L'ampio consenso popolare e la pubblicità che caratterizzarono l'intero
5 P. R. Magocsi, "A History of Ukraine: The Land and Its Peoples", University of Toronto Press,
2010, p. 724.
16
processo sono fattori che consentirono all'Ucraina di inserirsi di pieno diritto tra i
membri dell'ONU e di ricevere il riconoscimento da parte dei Paesi leader della
comunità internazionale. I primi provvedimenti del governo Kravchuk miravano a
prendere le distanze dall'egemonia sovietica e si concentravano su alcuni punti
essenziali: il riconoscimento delle frontiere, l'equilibrio militare con la Russia, le
relazioni economiche ed in particolare energetiche, l'integrazione nella Comunità
degli Stati Indipendenti (CSI)6.
Tuttavia, pur senza trascurare l'importanza di questi aspetti nella politica
ucraina post-indipendenza, questa tesi cerca di mettere in luce quale sia stato il
primo approccio di Kiev verso le relazioni da costruire con l'Unione Europea.
1.1.2. La "scelta europea" dell'Ucraina post-indipendenza
La letteratura specialistica si è impegnata nel descrivere il processo di
"europeizzazione" che coinvolgeva i nuovi Paesi candidati all'adesione negli anni
Novanta. L'Unione Europea infatti, come efficace strumento di politica estera,
sfruttava la prospettiva di membership per stimolare riforme strutturali nella sfera
economica ed istituzionale nei Paesi dell'ex Patto di Varsavia7. Al contrario, la
situazione di quelli senza una concreta prospettiva di adesione, come Ucraina e
Moldova, non è stata spesso oggetto prediletto di analisi da parte degli studiosi
(un'eccezione sono i membri dell'EFTA). La questione fondamentale da porsi in
questo contesto è quale sia stata veramente l'influenza dell'UE nella politica
interna ed estera di questi Paesi.
Nel caso ucraino, il dibattito su questo tema risultava particolarmente vivace
già negli anni Novanta8. In questi primi anni di emancipazione dall'ex URSS il
6 R. Wolczuk, "Ukraine's foreign and security policy, 1991-2000", Routledge, 2002, p.27.
7 Si analizzerà nel dettaglio concetto di "condizionalità" e le politiche ad esso legate nei successivi
paragrafi. 8 K. Wolczuk, "Integration without Europeanization: Ukraine and its Policy towards the
European Union", EUI Working Papers RSCAS No. 2004/15.
17
nuovo Stato cercava di ritagliarsi una posizione nello scacchiere internazionale,
siglando accordi di cooperazione e partenariato bilaterali nonché avviando le
procedure per prendere parte alle principali organizzazioni internazionali.
L'Unione Europea riconobbe ufficialmente l'indipendenza dell'Ucraina nel
dicembre 19919, durante il semestre di presidenza olandese. Le aspirazioni
europeiste di Kiev invece vennero espresse per la prima volta in un documento di
politica estera approvato dal Parlamento (la Verkhovna Rada) il 2 luglio 199310.
L'integrazione nelle strutture comunitarie era qui considerata una priorità, nella
misura in cui non compromettesse gli interessi nazionali. Le fasi di avvicinamento
all'UE prevedevano dapprima la firma di un Accordo di Partenariato e
Cooperazione (APC), seguito da un Accordo di Associazione (AA) per ottenere
infine la piena adesione.
Per l´Ucraina, l´avvicinamento all´Europa rientrava nella logica dell´
indipendenza in quanto avrebbe reso meno schiacciante la dipendenza da Mosca,
padrona incontrastata nei decenni del sovietismo. Inoltre, la situazione interna del
Paese all´inizio degli anni Novanta appariva molto difficile: il livello di vita della
popolazione ed il potere d´acquisto della moneta locale calarono
considerevolmente e il supporto dell´UE, agli occhi dell´élite ucraina, poteva
contribuire a risollevare lo stato dell´economia. Risultava tuttavia chiaro sin
dall´inizio che questo supporto non sarebbe stato concesso gratuitamente.
È importante notare che il concetto di "sicurezza nazionale" dopo la Guerra
Fredda non si limitava più alla difesa dei confini esterni di uno Stato tramite
mezzi militari; soprattutto per uno Stato di recente istituzione, la
democratizzazione e la costruzione di rapporti pacifici con gli altri Paesi
diventavano elementi caratterizzanti di questo nuovo approccio
multidimensionale11.
9Alcune di queste informazioni sono tratte dal sito web della Missione diplomatica dell'Ucraina
presso l'UE (http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/relations). 10
Verkhovna Rada, "On the key directions of the Foreign Policy of Ukraine", 2 luglio 1993. 11
A. M. Zlenko, "Foreign policy interestes of Ukraine and problems of European security",
18
Benché nelle dichiarazioni ufficiali Kiev affermasse le sue aspirazioni
europeiste, nei prossimi paragrafi si vedrà come l´eredità politica, economica,
sociale e culturale lasciata dalla Russia risultasse scomoda e onnipresente anche
negli anni successivi all´indipendenza. Anche per questo motivo, la stabilità
dell´Ucraina era una priorità per mantenere delle relazioni pacifiche tra l´UE e la
Russia12.
1.1.3 Un passato ancora presente
Prima di analizzare e valutare lo sviluppo delle relazioni bilaterali con
l'Unione Europea, è importante approfondire il contesto politico, sociale,
economico e culturale in Ucraina negli anni successivi al 1991. S. Velychenko
sostiene che all'indipendenza politica dalla Russia non seguì un'emancipazione
nella sfera economica, sociale o culturale13. Secondo l'autore, l'assenza di una vera
e propria "guerra di liberazione" permise alle élites sovietiche di rimanere al
potere, perpetuando l'egemonia russa in molti aspetti della vita quotidiana della
popolazione. Nel dibattito pubblico rimaneva la convinzione che supportare
l'Ucraina equivalesse a frammentare la Russia; in economia, la percezione dei
business-leader mondiali era che Kiev fosse ancora molto legata a Mosca, a causa
per esempio della sua totale dipendenza nel campo energetico. L'egemonia russa
copriva anche la dimensione psicologico-culturale: infatti, dopo il 1991, la lingua
russa restava preponderante nella maggior parte degli audio-visivi nonché per
l'insegnamento scolastico, mentre solo in rari casi veniva utilizzato l'Ucraino.
Per quanto attiene alla sfera politico-istituzionale, pur con il passaggio
all'indipendenza alcune caratteristiche tipiche del sistema sovietico rimanevano
Fordham international law journal vol. 21, no 1, Nov. 1997, p. 45-64. 12
Lo conferma la recente crisi politica in Ucraina, che ha aumentato la tensione tra Bruxelles e il Cremlino. Tuttavia M. Zlenko scrive nel 1997. 13
S. Velychenko (a cura di), "Ukraine, the EU and Russia. History, Culture and International Relations", Studies in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, 2007.
19
inalterate: su tutte, l'influenza della vecchia oligarchia e lo smisurato potere nelle
mani del Presidente14. Il Partito Comunista Ucraino (PCU) riuscì infatti a
sopravvivere all'implosione dell'URSS facendosi promotore dell'identità nazionale
e della sovranità del popolo. Questa strategia impedì la formazione di una valida
opposizione democratica anti-comunista. Le priorità del nuovo Stato erano la
conservazione della propria integrità territoriale e la costruzione di un nuovo
sistema istituzionale: riuscendo ad apparire il difensore di tali interessi prioritari, il
PCU si confermò il principale partito del Paese almeno fino al 1998. K. Wolczuk
afferma che tuttavia l'oligarchia ucraina non sfruttava il consenso popolare per
attuare le riforme strutturali tanto necessarie, quanto invece per assicurare il
proprio tornaconto personale.
Il cosiddetto "partito del potere" deteneva un forte controllo anche nei
confronti del Presidente, che nei primi anni dall'indipendenza utilizzava le sue
prerogative costituzionali per oscurare il ruolo dei governi regionali, della
magistratura e del Legislativo. La distribuzione del potere tra le istituzioni era
quindi caratterizzata da un grande squilibrio, e l'oligarchia tramite la sua relazione
privilegiata con il Presidente puntava unicamente a conservare il proprio potere.
È in questo contesto difficile che i rapporti tra Ucraina e Unione Europea
iniziavano a prendere forma. Nonostante le dichiarazioni europeiste di Kiev, il
cammino per le riforme sembrava in salita.
14
K. Wolczuk, "Integration without Europeanization: Ukraine and its Policy towards the European Union, cit.
20
1.2 Le fondamenta della cooperazione UE-Ucraina negli anni Novanta
1.2.1 Alcune questioni irrisolte
A seguito dell´indipendenza delle ex Repubbliche Sovietiche, la geografia
politica ai confini orientali dell´UE subì un radicale mutamento. Instaurare un
rapporto di collaborazione con il nuovo governo di Kiev, pur essendo un aspetto
fondamentale, richiedeva di porre determinate condizioni e affrontare alcune
questioni irrisolte15.
L´aiuto finanziario di Bruxelles era infatti subordinato alla realizzazione di
una serie di importanti riforme a livello politico, economico e sociale dopo
decenni di sovietismo: tra le più urgenti quella dell´amministrazione dello Stato,
dominata finora da una nomenklatura, e la privatizzazione progressiva
dell´economia. In previsione della firma di un Accordo di Partenariato e di
Cooperazione (APC), gli aiuti previsti all´Ucraina rientravano nel quadro del
programma TACIS16.
Prima di poter siglare un ACP, l´UE puntava a risolvere la questione del
disarmo nucleare ucraino. Considerando l´enorme arsenale ottenuto in eredità
dall´ex URSS, Kiev rappresentava infatti una potenza nucleare globale. Anche per
gli Stati Uniti la questione era prioritaria e grazie ad un´efficace pressione
diplomatica il processo di smantellamento di tale arsenale si chiuse il 12 giugno
1996, quando il presidente Kravchuk annunciò pubblicamente l´avvenuto ritiro di
tutte le testate dal proprio territorio. L´Ucraina inoltre aderì, come stato non
detentore di armi nucleari, al Trattato di Non-Proliferazione (TNP) il 5 dicembre
1994. Gli sforzi compiuti in questo settore venivano riconosciuti dall´UE, che
attraverso il programma TACIS concedeva finanziamenti per aiutare la
15
R. Yakemtchouk, "L´Union Européenne et l´Ukraine", Revue du Marché commun et de l’Union européenne n. 470, luglio-agosto 2003, p. 433-441. 16
Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States (1991-2006).
21
stabilizzazione a lungo termine della situazione, finanziando ad esempio la
chiusura della centrale nucleare di Chernobyl'17.
Anche nella sfera della democrazia erano necessarie radicali riforme per
avvicinarsi agli standard europei. Mentre l'UE sembrava lasciare questo aspetto in
secondo piano nei primi anni Novanta, concentrandosi soprattutto sullo
smantellamento dell'arsenale nucleare ucraino e le riforme verso un'economia di
mercato18, al Consiglio d'Europa di Strasburgo si affrontavano le questioni legate
a democrazia, diritti umani e Stato di diritto.
La richiesta di adesione al Consiglio d´Europa, formulata nel 1992, fu
accettata solo tre anni più tardi ed implicava l´adesione dell´Ucraina ad una serie
di convenzioni internazionali nonché l´adozione di nuovi Codici Civile e Penale.
Un punto sul quale si minacciava di sospendere la sua membership riguardava
l´abolizione della pena di morte, sancita con molto ritardo rispetto agli impegni
presi (1999).
Il lungo ed impegnativo processo di rinnovamento della legislazione interna
ucraina venne sigillato dalla nuova Costituzione del 28 giugno 1996, che sostituì
la precedente in vigore dal 1978.
1.2.2 L´Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC) del 1994
Concluso per un periodo iniziale di dieci anni, l´Accordo di Partenariato e di
Cooperazione (APC) del 1994 pose le basi per le relazioni politiche, economiche
e commerciali tra UE e Ucraina. Sostituí il precedente accordo tra l'UE e l´ex
URSS in vigore dal 1989 e rappresenta tuttora il quadro legale delle relazioni
bilaterali19. Mentre la ratifica da parte della Verkhovna Rada avvenne già il 10
17
Il contributo europeo si eleva a circa 203 milioni di dollari, il che rende l´UE il maggiore donatore per questa operazione. Nel periodo 1991-2001 il totale degli aiuti UE all´Ucraina ammonta a 1,072 miliardi di euro (R. Yakemtchouk, cit.). 18
I. Solonenko, "The EU´s impact on democratic tranformation in Ukraine", in S. Velychenko, cit. p. 138-150. 19
Infatti il presidente ucraino Yanukovich sceglie di posticipare la firma dell´Accordo di
22
novembre dello stesso anno, le istituzioni europee la conclusero solo nel 1998.
Nel 1995 si rese quindi necessario un accordo intermedio per permettere
l´implementazione rapida della parte commerciale, consistente in un prestito di 85
milioni di euro in 10 anni da parte dell´UE. Come condizione, l´Ucraina dovette
concludere un accordo con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e chiudere la
centrale nucleare di Chernobyl'20.
Per quanto riguarda la dimensione economica, tramite l´APC l´Unione
Europea promuoveva il passaggio di Kiev verso il libero mercato, in previsione di
un futuro accordo di libero scambio (ALS). In quest´ottica, una clausola evolutiva
presente nell´APC (art. 4) permetteva di adattarne le disposizioni a seconda dei
progressi compiuti dall´Ucraina nell´elaborazione ed implementazione delle
riforme economiche.
L´APC segnò una svolta anche nelle relazioni commerciali tra Ucraina e
UE. Oltre a garantirsi vicendevolmente lo status di "most-favoured nation"
(MFN)21, si prevedeva una significativa liberalizzazione nel commercio di beni,
investimenti, servizi e nella circolazione dei capitali, anche se l´UE manteneva
delle protezioni contro alcuni beni. Le imprese europee potevano quindi
finalmente agire in un quadro legale ben definito, investire in Ucraina facendo
rientrare in patria i loro profitti, pagare per beni e servizi in valute convertibili22.
Da notare inoltre che l´APC disponeva un allineamento delle normative ucraine a
quelle dell´UE nel settore dei diritti di proprietà intellettuale (IPRs), industriale e
commerciale entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.
Oltre all´economia di mercato (art. 2), l´APC stabiliva come punti cardine il
rispetto dei principi democratici e dei diritti dell´Uomo: nel caso in cui una delle
Associazione con l' UE previsto per il Summit di Vilinius del 28-29 novembre 2013. Questo evento, che scatena una serie di proteste popolari, segna l´inizio della situazione di crisi in cui attualmente versa il Paese. 20
R. Yakemtchouk, cit p 436. 21
Nel diritto internazionale, e precisamente nella legislazione del GATT/WTO, clausola "con la quale gli Stati contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento più favorevole che abbiano concesso o eventualmente concederanno in futuro, in una determinata materia (ad es. commercio, navigazione, circolazione delle persone, ecc.), a uno o più Stati" (tratto da Enciclopedia Treccani). 22
http://www.rozenbergps.com/books/future_role_of_russia/vanham.pdf
23
due parti avesse violato questi punti, l´altra avrebbe potuto prendere le misure
appropriate (art. 102). Il dialogo politico si svolgeva all´interno di un Consiglio di
Cooperazione istituito ad hoc, che ha tra i compiti maggiori quello di affrontare la
questione delle minoranze in Ucraina.
Il Ministro degli Affari Esteri all'epoca, Anatolyi M. Zlenko, riconobbe
pubblicamente l´importanza di tale accordo all´interno della strategia ucraina
verso l´integrazione europea, senza tuttavia l´illusione che si trattasse di una
garanzia per un posto tra i Paesi europei: era consapevole che l´UE concedeva una
possibilità agli Ucraini, lasciando loro la responsabilità di sfruttarla23.
1.3 Diversi livelli di ambizione
1.3.1 La "scelta europea" nei decreti del Presidente Kuchma
Il Presidente ucraino Leonid Danylovyč Kuchma (1994-2004) salì al potere
come successore di Leonid Kravchuk. Erano anni delicati per la stabilizzazione
del Paese, in quanto la cornice delle relazioni con UE e Russia era in via di
definizione. Gli studiosi evidenziano come la politica estera ucraina in questi anni
fosse "multivettoriale": per uno Stato di recente indipendenza, a maggior ragione
in una posizione geo-strategica come quella in cui si situa l´Ucraina, risultava
fondamentale per la sicurezza nazionale costruire solide cooperazioni con le
principali potenze della regione24.
La firma del decreto "Strategy of Ukranian Integration to the EU" (11
giugno 1998) avvenne solamente tre mesi dopo l´entrata in vigore dell´APC, in
un´atmosfera di frustrazione a causa del ritardo con cui le istituzioni europee
23
Intervista di A. M. Zlenko, "Un passo importante per l´Europa", in Holos Ukrainy, 17 giugno 1994. 24
M. R. Freire, "Ukraine´s multivectorial foreign policy: looking West while not overlooking its Eastern neighbour", UNISCI Discussion Papers, Nº 20 (Mayo / May 2009).
24
avevano ratificato tale accordo25. Kuchma chiarì che la priorità di medio-lungo
termine per l´Ucraina era ottenere lo status di membro associato all´UE entro il
2007: sembrava chiaro dal suo punto di vista che gli sforzi di riforma di Kiev
sarebbero stati volti a raggiungere quest'obiettivo.
Senza descrivere in dettaglio tutti gli aspetti del decreto, in questo paragrafo
se ne evidenziano i tratti più importanti26:
• Riforma del sistema legale ucraino per avvicinarlo agli standard europei.
Oltre al rispetto dei diritti umani, in questo punto si includevano le
condizioni dei lavoratori, la protezione dei consumatori e gli standard
sanitari e ambientali;
• Consolidamento ed intensificazione del dialogo politico per assicurare il
funzionamento del sistema democratico;
• Apertura reciproca e sincronizzata dei mercati europeo ed ucraino,
favorendo la libera concorrenza, gli investimenti e limitando le misure
protezionistiche. In quest´ottica si preparava la strada per una futura
adesione di Kiev all´Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC),
concretizzata solo nel 2008;
• Inclusione dell´Ucraina nel sistema di sicurezza paneuropeo, tramite una
maggiore collaborazione con l´Unione Europea Occidentale (UEO) e
altre strutture transatlantiche come la NATO. La posizione strategica del
Paese era riconosciuta a Bruxelles come fondamentale per preservare la
stabilità dell´intero continente;
Il Presidente Kuchma, consapevole che tali azioni non potevano essere
intraprese unilateralmente, con questo decreto chiedeva un impegno anche da
parte dell´UE con l´obiettivo di legittimare le sue aspirazioni ad ottenere lo status
di membro associato nel medio-termine. Risulta importante sottolineare che, per
25
K. Wolczuk, cit. p. 5. 26
A. Lewis (a cura di), "The EU & Ukraine : neighbours, friends, partners?", London, Federal Trust, 2002, Appendix 2 p. 285.
25
quanto riguarda l´integrazione europea, il Presidente non cercava nemmeno
l´appoggio delle altre istituzioni dello Stato (come il Parlamento), né tantomeno
della società civile. Dall´altro lato, sia il Gabinetto dei Ministri sia il Parlamento
accettavano passivamente la leadership presidenziale per quanto riguarda
l´integrazione con l´Unione Europea, sebbene nemmeno il Presidente si
dimostrasse realmente in grado di realizzare quanto affermato nei suoi decreti27.
Quest´asimmetria di potere e nel livello di coinvolgimento in politica estera risulta
cruciale nello spiegare le ragioni per cui la Politica Europea di Vicinato non sia
riuscita finora ad ottenere i risultati che si era prefissa in origine.
La "scelta europea" sulla carta sembrava esplicita e in cerca di
legittimazione, tanto che il 14 settembre 2000 venne emanato un secondo decreto
presidenziale dal titolo "Programme of Ukrainian Integration to the EU" per
ribadire gli sforzi di riforma e soprattutto le aspirazioni di Kiev. Uno sguardo
attento alla realtà del Paese negli anni Novanta porta tuttavia ad essere molto
cauti, se non scettici, sul reale impegno e sui risultati ottenuti.
1.3.2 Una risposta deludente
Il Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre 1999 approvò la "Common
EU Strategy on Ukraine" in risposta alle aspirazioni europeiste contenute nei
decreti del Presidente ucraino. Ancora prima del suo contenuto, è la forma scelta
per tale documento a suggerire che all´interno dell´UE non ci fosse una chiara
volontà politica di azione comune: le "Common Strategies" (CS) sono strumenti
di politica estera nati con il Trattato di Amsterdam (1997, art. 13) come
compromesso tra gli Stati Membri. In linea teorica si cercava di introdurre la
maggioranza qualificata in alcune decisioni della PESC. Lontani dal voler cedere
la minima sovranità in politica estera, gli Stati Membri si adoperavano tuttavia
27
K. Wolczuk, "Adjectival Europeanisation? The Impact of EU Conditionality on Ukraine under the European Neighourhood Policy", European Research Working Paper Series No. 18, ERI 2007.
26
nella prassi per raggiungere un consenso: il risultato erano dichiarazioni vaghe
senza un preciso né lungimirante significato strategico28. Inoltre si nota una sorta
di incoerenza, se non una tensione, tra l´Accordo di Partenariato e di
Cooperazione del 1994 (espressione dell´integrazione in senso funzionalista) e un
atto intergovernativo come la CS. Infatti, mentre l´implementazione del primo era
nelle mani della Commissione Europea, la seconda veniva invece rivista ogni sei
mesi a seconda delle priorità individuate dalla Presidenza del Consiglio dell´UE29.
Scorrendo rapidamente il contenuto della "strategia comune", l´UE salutava
con parole ponderate e prudenti gli sforzi compiuti dall´Ucraina e la sua scelta
europea, ribadendo l´impegno di Bruxelles a lavorare insieme per le necessarie
riforme e per l´avvicinamento ("rapprochement") della legislazione ucraina a
quella comunitaria. Affermando la presenza di valori condivisi ed interessi
comuni, l´UE confermava e rafforzava il ruolo dell´APC del 1994 come base per
le relazioni bilaterali e proponeva una strategia di medio termine basata
essenzialmente su tre pilastri: il rafforzamento della democrazia e dell´economia
di mercato, la cooperazione nell´ambito della sicurezza e l´intensificazione del
dialogo in vista del grande allargamento del 2004, che per la prima volta avrebbe
portato l´Ucraina ad avere una frontiera comune con l´UE.
Valutando in maniera generale questa CS, si può affermare che l´UE non
volesse né chiudere esplicitamente le porte all´Ucraina né prendere degli impegni
prematuramente. Il salto qualitativo tra le dichiarazioni ufficiali delle istituzioni
europee e le aspirazioni di Kiev restava evidente. Sorgevano inoltre spontanei i
dubbi sia sul carattere "comune" che su quello "strategico" del documento,
rivelatosi solo in misura limitata una risposta alle esplicite richieste da parte
dell´Ucraina.
28
G. Sasse, "The EU Common Strategy on Ukraine: a response to Ukraine´s pro-European choice?", in A. Lewis (a cura di), cit. Vedi anche la critica rivolta all´efficacia delle "Strategie Comuni" da Javier Solana, in Secretary General/High Representative: Common Strategies report, Brussels 21 December 2000, declassified 30 January 2001, 14871/00, CAB 21. 29
G. Sasse, "The EU common strategy on Ukraine. A response to Ukraine´s pro-European choice?", in A. Lewis (a cura di), cit. p. 214.
27
1.4. Valutazioni ex-post: l´Ucraina a dieci anni dall´indipendenza
1.4.1 "Integrazione per dichiarazione"?
Dopo aver velocemente passato in rassegna i pilastri principali delle
relazioni bilaterali UE-Ucraina negli anni Novanta, le dichiarazioni di intenti e le
chiare aspirazioni di Kiev per una futura membership nell´UE, può sembrare
inaspettata la decisione di Bruxelles di non includerla tra i Paesi del grande
allargamento del 2004. Ad un´analisi più approfondita emerge tuttavia una
sostanziale differenza tra le dichiarazioni pubbliche del governo ucraino e
l´effettiva implementazione delle riforme politiche ed economiche necessarie per
avvicinarsi agli standard europei. James Sherr parla a questo proposito di
"integration by declaration"30, sottolineando come la liberalizzazione economica
fosse ad inizio anni Duemila ancora incompleta e come i principi democratici, lo
stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani fossero ben lontani dall´essere
garantiti. Citando Tedstrom, l´Ucraina a dieci anni dall´indipendenza non era
riuscita a trasformarsi in un Paese pienamente europeo in termini di stabilità e
prosperità, rimanendo solamente un "Paese che si trova in Europa"31.
Una ragione, seppur parziale, per questa situazione sarebbe stata il fatto che
l´UE non avesse offerto esplicitamente la membership a Kiev, come invece era
accaduto con altri Paesi dell´Europa Centrale ed Orientale. In questo caso la
"condizionalità" si rivelò infatti uno strumento efficace di politica estera per
Bruxelles: la prospettiva di adesione all´UE costituisce un grande incentivo per i
Paesi candidati e li spinge ad elaborare ed implementare le riforme necessarie per
soddisfare i Criteri di Copenhagen32. Il sistema istituito con la PEV invece
30
J. Sherr, "Ukraine´s New Time of Troubles". Camberley: Conflict Studies Research Centre, 1998. 31
J. Tedstrom, "The EU and Ukraine: a transatlantic view", in A. Lewis (a cura di), cit. p. 31. 32
K. Wolczuk, cit. p. 8.
28
richiede sforzi considerevoli ai Paesi destinatari, in termini di implementazione
delle riforme per la modernizzazione politica ed economica, senza offrire una
chiara immagine del "ritorno" che questi Paesi riceverebbero in cambio:
specialmente per un Paese come l´Ucraina, la vaga formulazione "a stake in the
internal market" non sembra in linea con le aspirazioni espresse sin dai primi anni
dell´indipendenza33.
I leader politici ucraini faticavano ad accettare l´approccio adottato dall´UE
nei loro confronti. A. Zlenko, Ministro degli Esteri nei periodi 1991-1994 e 2000-
2003, sottolineava come i progressi dei Paesi dell´Europa Centrale derivassero
dalla concreta prospettiva di poter far parte, nel medio termine, dell´Unione
Europea34. Pur ammettendo che l´Ucraina avrebbe potuto senza dubbio dare un
maggiore contributo nella modernizzazione delle sue strutture e della legislazione,
era sua opinione che con un impulso deciso e chiaro da parte di Bruxelles la
situazione si sarebbe sviluppata in modo differente.
Nei paragrafi che seguono si cerca di fare il punto dei risultati ottenuti
dall´Ucraina a dieci anni dall´indipendenza in alcuni tra i principali settori di
policy: un interessante esercizio di astrazione per comprendere se il Paese
soddisfacesse o meno, e in quale misura, i Criteri di Copenhagen e se fosse quindi
un plausibile candidato per l´adesione al pari degli altri dieci Paesi. Questo quadro
sintetico della situazione ad inizio anni Duemila sarà utile per avere un termine di
confronto quando si affronteranno i progressi nelle relazioni UE-Ucraina negli
anni successivi. Dati i limiti di spazio, l´analisi riguarda solo gli aspetti ritenuti
più significativi e non pretende di essere esaustiva.
33
K.E. Smith, "The outsiders: the European Neighbourhood Policy", International Affairs 81, 4 (2005), pp. 757-773. 34
A. M. Zlenko, "Ukraine and the EU: it takes two to tango", in A. Lewis (a cura di), cit. p. 23.
29
1.4.2 Lo stato delle istituzioni politiche e il processo di democratizzazione
Il primo criterio di Copenhagen riguarda la dimensione politica. Un Paese
candidato all´adesione all´UE deve dimostrare la presenza di istituzioni stabili che
garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'Uomo, il rispetto delle
minoranze e la loro tutela.
La Costituzione ucraina del 1996 istituiva un regime presidenziale-
parlamentare. Un aspetto evidente era lo squilibrio di potere tra le istituzioni. Le
elezioni per il rinnovamento della Verkhovna Rada non erano sincronizzate con le
presidenziali e il Parlamento aveva poco controllo nei confronti dell´Esecutivo,
che invece deteneva ampio margine di manovra in diverse aree, tra cui il bilancio.
La debolezza del Legislativo derivava in sostanza dall´incapacità di formare
solide maggioranze che permettessero di attuare riforme costituzionali, di
contrastare il Presidente tramite procedure di impeachment o respingendo il suo
veto. Inoltre, come retaggio dell´epoca sovietica, l´apparato del Partito Comunista
Ucraino (PCU) aveva ancora molta influenza sulle scelte del Presidente, tanto che
si considera agisse come un "governo parallelo"35.
Il Consiglio d´Europa (CoE) criticava a gran voce gli standard democratici
in Ucraina, almeno fino alla Rivoluzione Arancione del 2004. Il CoE minacciava
addirittura di sospenderne la membership quando lo stesso Presidente venne
coinvolto nello scandalo seguito all´assassinio del giornalista Gongadze36,
nell´autunno del 200037. Alcuni studiosi definivano l´Ucraina una "defective
democracy", ovvero né un´autocrazia né una democrazia consolidata38. Nel 2000,
Transparency International giudicava l’Ucraina come uno dei paesi più corrotti
35
A. Wilson, "The political process in Ukraine. Democratization or virtualization?", in A. Lewis (a cura di), cit. p. 41. 36
Uno scandalo conosciuto anche come "Kuchmagate". 37
I. Solonenko, "The EU´s impact on democratic tranformation in Ukraine", cit. p. 140. 38
T. Beichelt e R. Pavlenko, "The Presidential election and constitutional reform", in H. Kurth e I. Kempe (a cura di), "Presidential election and orange revolution. Implication for Ukraine´s transition". Friedrich Ebert Stiftung, Kiev, 2005, pp. 50-85.
30
del mondo, collocandola all’88° posto su 90 stati39.
Il rispetto delle minoranze costituisce un altro aspetto importante per
valutare lo stato della democrazia in un Paese. L´Ucraina, secondo il censimento
del 2001, ospita al suo interno ben 130 differenti gruppi etnici, il maggiore dei
quali composto dai Russi. In totale queste minoranze costituiscono il 22%40
dell´intera popolazione. Tuttavia, complice il periodo comunista e la recente
indipendenza, queste identità non hanno avuto il tempo di radicarsi
profondamente nel territorio. Di conseguenza, la stessa struttura dello Stato e le
competenze dei vari livelli di governo sono messe continuamente in discussione,
come evidenziato nel caso della Repubblica Autonoma di Crimea menzionato
nella Parte Seconda. La scelta della decentralizzazione viene considerata un modo
per rispondere alle diversità tra le regioni, ma lo stato della sua implementazione
non appare sufficiente per garantire loro il necessario livello di autonomia41.
Il Parlamento ucraino nel 1999 ratificò la "European Charter for Regional
or Minority Languages" del Consiglio d´Europa, firmata nel 1996: un atto che
almeno in principio manifestava la volontà di proteggere le minoranze presenti nel
Paese permettendo la libera espressione della loro diversità e attuando politiche
proattive per promuoverla. Tuttavia, anche questa restò lettera morta in quanto
mai depositata a Strasburgo e anzi annullata dalla Corte Costituzionale ucraina nel
2000, con argomentazioni puramente tecniche42.
Per quanto riguarda la libertà di stampa, altro pilastro fondamentale di un
sistema genuinamente democratico, si assisteva in Ucraina ad una considerevole
moltiplicazione delle emittenti televisive e radiofoniche, controllate da attori
39
R. Woronowycz, “Ukraine named among most corrupt countries of the world,” The Ukrainian Weekly, 1 ottobre 2000, No. 40, Vol. LXVIII 40
Prof. V. Bakirov, "The study of ethnic minorities in Ukraine", ENRI-East presentation paper, 2011. 41
O. Protsyk, "Majority-Minority Relations in the Ukraine", European Centre for Minority Issues JEMIE 7 (2008). 42
La Corte sostiene che non sia stata rispettata la procedura, che richiede la firma del Presidente per legittimare la ratifica della Carta.
31
privati. Secondo il Presidente Kuchma, accusato durante un´intervista di non
garantire la libertà dei media, questo semplice elemento avrebbe dimostrato il
contrario. O. Solohubenko43 tuttavia contesta la pretesa e mette in evidenza il fatto
che i proprietari di tali emittenti erano nella maggior parte dei casi membri
dell´oligarchia ucraina pesantemente influente e presente nel mondo della politica
e del governo.
Poche parole infine sul livello di sviluppo della democrazia a livello locale,
dopo decenni di regime sovietico. Anche in questo caso, l´Ucraina cercava di
costruire un quadro legale in linea con gli standard europei, aderendo alla
European Charter for Local Self-Government del Consiglio d´Europa e varando
nel 1997 una legge nazionale sullo stesso tema. Se le premesse, almeno teoriche,
sembravano portare ottimismo, nel 1998 il Congresso dei Poteri Locali e
Regionali d´Europa (CPLRE) rilevò "il deteriorarsi della situazione nel campo
della democrazia e della preminenza del diritto a livello locale e regionale in
Ucraina"44, aggiungendo varie raccomandazioni concernenti finanza locale,
tassazione, disciplina di bilancio per le amministrazioni locali, status degli
amministratori ecc. Da sottolineare inoltre, a riprova del retaggio di epoca
sovietica ancora presente, la sottomissione dei rappresentanti locali e regionali
agli organi dello Stato: un caso particolarmente significativo erano i Governatori
regionali, nominati dal Presidente che li poteva in qualsiasi momento sostituire45.
Pur non avendo alcuna pretesa di esaustività, questa rapida serie di elementi
intende fornire un quadro istantaneo quanto realistico della situazione per quanto
riguarda la democrazia e lo stato di diritto in Ucraina nel primo decennio
dall´indipendenza. Se da un lato non mancavano sulla carta le premesse per
43
O. Solohubenko, "Unleashed, but still muzzled. The media in Ukraine", in A. Lewis, cit. pp. 71-80. 44
CPLRE, Raccomandazione 102 (2001) 1 sulla democrazia locale e regionale in Ucraina, Discussa ed adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 9 novembre 2001 (vedi Doc. CG (8) 22, progetto di raccomandazione presentato dai Sigg. L. Kieres e L. Roppe, relatori). 45
Vedi S. Maksymenko, "Local democracy, un unfinished business", in A. Lewis, cit. pp. 55-60.
32
affermare l´avvicinamento agli standard europei, dall´altro vi erano dati che
dimostravano il perpetuarsi nella prassi delle tradizionali logiche di matrice
sovietica che impedivano al Paese di intraprendere seriamente un cammino di
modernizzazione amministrativa e politica.
1.4.3. Alcuni segnali dalla sfera economica
Negli anni Novanta, una delle maggiori sfide per la nuova Ucraina
indipendente consisteva nel trasformare il sistema economico tradizionalmente
centralizzato per orientarlo verso il libero mercato.
Le potenzialità economiche del Paese sono indiscusse, in quanto è dotato di
manodopera qualificata ma relativamente poco costosa, si trova in una posizione
strategica tra Russia, Mar Nero ed Europa, le materie prime abbondano e i terreni
agricoli sono molto fertili (viene infatti definita "il granaio d´Europa"). A
deludere le aspettative, rendendo il processo molto difficile, hanno contribuito
tuttavia l’assenza di istituti forti, necessarie allo sviluppo dell’economia di
mercato, quali lo stato di diritto, la tutela dei diritti di proprietà, l’efficacia dei
contratti e uno Stato trasparente, in grado di mediare in modo imparziale fra
interessi contrastanti46.
Tra il 1991 e il 1995 la strategia del governo mirava principalmente a
mantenere lo status quo, continuando la sua politica di sussidi diretti47. Oltre a non
stimolare le imprese ad ammodernarsi né a cercare maggior efficienza, questo
creava gravi deficit nel bilancio dello Stato, finanziati tramite erogazione di
moneta e quindi alti tassi di inflazione.
I dati macroeconomici mostrano che dal 1991 al 1999 il PIL ucraino subì
una contrazione permanente, che in termini cumulativi arrivò al 60%. Una
46
Assemblea parlamentare NATO, Sottocommissione sulla cooperazione e la convergenza economica Est-Ovest, "La transizione in Ucraina", 065 ESCEW 06 (2006). 47
E. Segura, "Ukraine: the evolution of its economy since independence", in A. Lewis, cit. pp 93-102
33
parziale spiegazione risiede nell´interesse delle oligarchie per le rendite piuttosto
che per gli investimenti produttivi, elemento che non stimolava il Paese a dotarsi
di un sistema economicamente efficiente. Il processo di privatizzazioni, iniziato
nel 1992, veniva accusato di mancanza di trasparenza, corruzione e clientelismo48.
Inoltre, le strutture industriali dell´Ucraina si concentravano soprattutto nel settore
della produzione di beni per uso militare (25% della produzione totale) rimasti
senza mercato dopo il 1989. Da considerare anche il problema della quasi totale
dipendenza energetica: dopo il 1991 le attività industriali ucraine, nella maggior
parte dei casi fortemente energivore, furono danneggiate da un aumento del
prezzo dell´energia fornita da Mosca.
Durante il governo Kuchma (1994-2004), soprattutto a partire dal 1996-
1998, si iniziarono ad intraprendere delle riforme per la stabilizzazione
macroeconomica, la liberalizzazione commerciale, il rafforzamento della Banca
Nazionale Ucraina, l´introduzione di una nuova valuta (la hryvnia, nel settembre
1996) e una stretta alla politica monetaria per ridurre l´inflazione. Una risposta da
parte dell´UE fu il riconoscimento nel 1996 dell´Ucraina come "Paese con
un´economia in transizione"49. I risultati giunsero anche in termini di PIL, che
segnò i primi miglioramenti tra il 2000 e il 2004 con una crescita dell´8,4% media
annua50. Sane politiche economiche e monetarie, livelli di inflazione contenuti,
una ripresa della domanda interna e della produzione industriale sono alcuni
meriti importanti da riconoscere al Presidente Kuchma. Benché ancora lontana dal
livello di sviluppo dei Paesi del grande allargamento del 2004, l´Ucraina
sembrava tuttavia intraprendere la giusta strada verso la sua integrazione
nell´economia mondiale.
48
Vedi http://policydialogue.org/publications/backgrounders/casestudies/privatization_ukraine/ 49
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/chronology/index_en.htm#. Lo status di "economia di mercato" viene invece riconosciuto nel 2005, con significativi vantaggi per l´Ucraina per esempio in materia di dazi anti-dumping. 50
J. Blanke, "Assessing Ukraine´s competitiveness amid political change", Centre for Strategic Insight, World Economic Forum, 2004.
34
Nella sfera delle relazioni con l´Unione Europea, l´implementazione
dell´Accordo di Partenariato e di Cooperazione costituiva la priorità principale e
veniva ripetutamente dichiarato in occasione dei primi incontri del Consiglio di
Cooperazione UE-Ucraina51. La prospettiva di membership tanto agognata
dall´Ucraina, pur non essendo stata chiusa definitivamente, non venne mai
considerata da Bruxelles52 che si apprestava invece ad accogliere i nuovi 10 Paesi
dell´Europa Centrale ed Orientale. Per le altre ex Repubbliche Sovietiche l´UE
elaborò un altro quadro di relazioni, presentato dal Presidente della Commissione
Romano Prodi nel 2003 : la Politica Europea di vicinato (PEV).
51
Il primo dei quali tenutosi a Lussemburgo, l´8 settembre 1998. Vedi http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/page/open/id/3079 52
Intervista dell´autore a L. Schiavo, Direttore Generale della DG Affari Esteri, Segretariato Generale del Consiglio dell´UE, 6 maggio 2014.
35
CAPITOLO 2
"L´EUROPA È PIU GRANDE": IL LANCIO DELLA
POLITICA EUROPEA DI VICINATO (PEV)
In questo capitolo viene presentata la Politica Europea di Vicinato, il quadro
delle relazioni tra UE ed Ucraina a partire dal 2004. Rintracciandone in un primo
momento le origini e chiarendo la struttura giuridica in cui si inserisce, si analizza
in seguito questa nuova politica nei suoi aspetti principali cercando di
evidenziarne sia i punti di forza che le intrinseche debolezze. Le conclusioni tratte
in queste pagine vengono riprese nella parte relativa allo studio del caso ucraino,
per tentare di capire se e fino a che punto la PEV sia stata finora uno strumento
efficace e adatto per costruire le relazioni con Kiev, nel delicato contesto
dell'Europa orientale.
2.1 Le origini
2.1.1 Proposte per la nuova Europa
Il grande allargamento ufficializzato il 1 maggio 2004 portava all'ingresso di
dieci nuovi Paesi nell'Unione Europea: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia ed Ungheria. I confini esterni
dell'Unione venivano quindi ridisegnati e i nuovi "vicini" ad Est diventavano
Russia, Bielorussia ed Ucraina. L'ingresso Di Malta e Cipro, inoltre, rafforzava la
presenza dell'UE nel Mediterraneo.
Già negli anni precedenti, le istituzioni di Bruxelles e i governi degli Stati
Membri espressero a più riprese la necessità di costruire un nuovo quadro di
relazioni con i Paesi del vicinato orientale e meridionale, in modo da garantire
36
un'area di "pace, stabilità e prosperità" anche fuori dai propri confini. La
riflessione intorno a questo tema coinvolgeva una pluralità di attori politici, sia a
livello nazionale che europeo53.
La lettera inviata alla Presidenza di turno spagnola dell'UE dai Ministri
svedesi degli Affari Esteri Anna Lindh e del Commercio Leif Pagrotski l’8 marzo
2002 proponeva di considerare i rapporti con il vicinato "dalla Russia al
Marocco"54 sotto un'unica cornice. La nuova struttura di relazioni con questi
Paesi, concepita come un completamento degli esistenti Accordi di Partenariato e
di Cooperazione (APC), avrebbe permesso secondo la proposta svedese di
stimolare il processo di democratizzazione e le riforme economiche, chiarendo la
grande importanza che l'UE attribuisce ai suoi vicini.
Anche il Ministro degli Esteri inglese Jack Straw, con una lettera alla
Presidenza spagnola appena pochi mesi prima, esternava le sue preoccupazioni
per la situazione in Ucraina, Moldova e Bielorussia55. Pur con un obiettivo
geograficamente più circoscritto, ancora una volta l'intensificazione delle relazioni
politiche ed economiche e della presenza dell'UE in Europa orientale veniva
considerata come uno strumento chiave per garantire la stabilità nella regione.
La Commissione Europea era d'accordo nel considerare unitamente gli Stati
dell'Est e della sponda Sud del Mediterraneo56. Tuttavia, se per il primo gruppo la
prospettiva di adesione all'UE restava viva seppur nel lungo periodo, risultava
chiaro che per il vicinato meridionale le porte dell'UE sarebbero rimaste chiuse.
La Commissione infatti, nel 1986, aveva respinto la richiesta del Marocco di far
53
R. Alcaro e M. Comelli, "La politica europea di vicinato", IAI Quaderni n. 22, marzo 2005. 54
Letter by the Swedish Foreign Minister Anna Lindh and Trade Minister Leif Pagrotsky, March 8, 2002 55
Letter by UK Foreign Minister Jack Straw to the Spanish Presidency of the EU on January 28, 2002. 56
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – The Commission’s Work Programme for 2002, COM(2001)620 final, Brussels, 5 December 2001. Vedi anche: Joint letter by EU Commissioner Chris Patten und the EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy Javier Solana, August 2002
37
parte della CEE argomentando che non si trattava di un Paese europeo, condizione
prevista all'art. 49 del TUE.
Uno dei momenti più significativi per il lancio di questa nuova politica fu il
discorso tenuto dall'allora Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi,
a Bruxelles il 5 dicembre 200257. Alla vigilia del grande allargamento, la
questione da porsi era quale fosse l'approccio politico per relazionarsi con i nuovi
Paesi vicini. Prodi affermò più volte che l'adesione all'UE, pur essendo lo
strumento più efficace per motivare i candidati ad intraprendere le riforme, non
poteva essere utilizzato all'infinito. In quest'ottica era quindi necessario avere una
discussione seria sui confini dell'Unione.
La proposta di Prodi era una nuova politica di prossimità che garantisse "più
di un partenariato e meno dell'adesione, senza neppure escludere la seconda in
modo categorico". L'obiettivo era costruire intorno all'UE un "cerchio di amici" in
modo da allargare l'area di pace, stabilità e prosperità senza con questo concedere
la partecipazione al processo decisionale: in questo senso Prodi parlava di
"condividere tutto con l'Unione tranne le istituzioni".
Avendo presentato brevemente il clima politico europeo alla vigilia
dell'allargamento del 2004, con riferimento alla questione del nuovo vicinato, nei
prossimi paragrafi si analizza più da vicino la Politica Europea di Vicinato (PEV)
evidenziandone i successi ma anche gli aspetti più controversi.
2.1.2 Le origini della PEV
Al Consiglio Europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 venne lanciata la
Politica Europea di Vicinato (PEV). I Paesi destinatari, con una frontiera terrestre
o marina comune con l'UE ad Est o a Sud, erano inizialmente: Bielorussia,
Moldova, Federazione Russa, Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano,
57
R. Prodi, "A Wider Europe – A Proximity Policy as the key to stability", discorso tenuto presso “The Sixth Ecsa World Conference on peace, stability and security”, Bruxelles, 5 dicembre 2002.
38
Libia, Marocco, Autorità palestinese, Siria e Tunisia. Nel giugno 2004 il
Consiglio Europeo incluse anche Azerbaigian, Armenia e Georgia, in parte grazie
alla Rivoluzione delle Rose scoppiata nel novembre 200358.
Alcuni degli Stati menzionati tuttavia furono in un secondo momento
esclusi dalla PEV per diverse ragioni. La Bielorussia per esempio era in quegli
anni (e continua ad essere) un regime autoritario, quindi l'UE si limitava a
promuovere alcuni programmi rivolti alla società civile59. Anche la Libia si trovò
de facto fuori dalla PEV in quanto non aveva ancora sviluppato relazioni ufficiali
con l'UE e non rispettava gli impegni nel quadro del Partenariato Euro-
Mediterraneo.
La Russia è un caso che merita una considerazione particolare: nonostante
la Commissione Europea l´avesse inclusa nel quadro della Politica di Vicinato,
Mosca considerava la PEV un rapporto asimmetrico in cui l'UE godeva di una
posizione dominante rispetto ai Paesi beneficiari. Pur riconoscendo la necessità di
intensificare ed approfondire le relazioni con Bruxelles, la dimensione bilaterale
rimaneva la preferenza in quanto garantiva un rapporto da pari a pari tra potenze
regionali. Questa posizione venne riconosciuta in Europa, tanto che il quadro delle
relazioni bilaterali UE-Russia fu considerato come autonomo rispetto alla PEV60.
Uno dei documenti che segnarono l'origine della Politica Europea di
Vicinato fu la comunicazione della Commissione al Parlamento ed al Consiglio
dell'11 marzo 2003, intitolata "Wider Europe — Neighbourhood: A New
Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours"61, in
58
I sospetti brogli alle elezioni parlamentari georgiane del novembre 2003 portano a manifestazioni di piazza a Tbilisi, in cui i presenti tengono in mano delle rose in segno di protesta. Dopo un´invasione pacifica del Parlamento, il capo del governo E. Ševardnadze è costretto alle dimissioni per scongiurare una guerra civile. Alle successive elezioni di gennaio 2004 sale al potere il filo-occidentale M. Saakašvili. Questa Rivoluzione delle Rose è la prima delle cosiddette "rivoluzioni colorate": seguiranno la Rivoluzione Arancione in Ucraina (2004) e quella dei Tulipani in Kirghizistan (2005). 59
Una scelta confermata nel Commission ENP Strategy Paper del 2004. 60
La base giuridica per le relazioni bilaterali tra UE e Federazione Russa è l´Accordo di Partenariato e di Cooperazione del 1997. Attualmente è in fase di negoziazione un nuovo Accordo. 61
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf
39
risposta ad una lettera congiunta del Commissario per le Relazioni Esterne
(RELEX) Chris Patten e dell'Alto Rappresentante per la PESC Javier Solana
dell'agosto 2002. La Commissione poneva qui le basi per sviluppare una strategia
comune verso i Paesi senza una concreta prospettiva di membership nell'Unione,
che tuttavia restavano fondamentali per la stabilità e la prosperità europea
specialmente data la loro prossimità geografica. Riconoscendo i diversi livelli di
intensità delle relazioni dell'UE con ciascuno dei destinatari della PEV, la
Commissione rifiutava un approccio "one-size-fits-all" chiarendo allo stesso
tempo che gli interessi comuni all'intero gruppo dovevano essere perseguiti in un
quadro coerente.
Il principio della differenziazione nei rapporti con i singoli Paesi del
vicinato veniva applicato tramite dei "Piani d'Azione" (PA) bilaterali, redatti a
seconda della tipologia e dell'intensità delle relazioni di ciascuno di questi con
l'UE, nonché della loro capacità di implementazione e volontà politica. Essi
dovevano essere "agreed jointly with the neighbouring countries concerned. They
should have a minimum duration of three years and be subject to renewal by
mutual consent. Such action plans should be based on common principles but be
differentiated, as appropriate, taking into account the specificities of each
neighbour, its national reform processes and its relations with the EU. Action
plans should be comprehensive but at the same time identify clearly a limited
number of key priorities and offer real incentives for reform. Action plans should
also contribute, where possible, to regional cooperation"62.
Pur avendo caratteristiche distinte, i Paesi del vicinato erano accomunati da
alcuni importanti elementi: un PIL pro-capite sotto i 2000 euro annui (ad
eccezione di Israele), il fatto che l´UE fosse per molti di essi il maggior partner
commerciale e la maggiore fonte di investimenti diretti esteri (IDE), il forte
62
"Communication from the Commission to the Council on the Commission proposals for action plans under the European Neighbourhood Policy (ENP)", Brussels, 9 December 2004 COM(2004) 795 final.
40
vantaggio che avrebbero avuto nell´accedere al mercato interno europeo e a
beneficiare di condizioni preferenziali per quanto riguarda il mercato del lavoro e
la libera circolazione63.
Lo "Strategy Paper" della Commissione del maggio 200464 prendeva atto
della situazione politica ed economica nei Paesi destinatari della PEV, suggerendo
una roadmap per stabilire delle priorità d'azione a livello bilaterale e proseguire
con la fase di implementazione. La Commissione affermava chiaramente in
questo Paper che "L'obiettivo della PEV è condividere i benefici dell'allargamento
dell'UE del 2004 con i paesi limitrofi potenziando la stabilità, la sicurezza e il
benessere di tutte le popolazioni interessate. La PEV è volta ad evitare l'emergere
di nuove linee divisorie tra l'UE allargata e i suoi vicini e ad offrire a questi
ultimi la possibilità di partecipare a varie iniziative dell'UE, attraverso una
maggiore cooperazione politica, di sicurezza, economica e culturale". Pur senza
prevedere l'adesione all'UE, risultava chiara la volontà di andare oltre la
cooperazione per raggiungere elevati livelli di integrazione e permettere ai Paesi
del vicinato di avere accesso al Mercato Interno europeo. Lo Strategy Paper
inoltre proponeva, in vista dell'adozione delle nuove prospettive finanziarie 2007-
2013, un aumento dei contributi di assistenza europea per la PEV e la creazione
dello European Neighbourhood Policy Instrument (ENPI) per sostituire i
precedenti fondi TACIS e MEDA raggruppandoli in un quadro coerente.
63
W. Wallace, "Looking after the Neighbourhood: responsibilities for the EU-25", Policy paper No. 4, Paris, Groupement d´Etudes et des Recherches, Notre Europe, 2003, pp. 8-9. 64
COM(2004) 373 final, disponibile online al seguente link: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf
41
2.1.3 Le aspirazioni della PEV e il raggio d'azione
Sfogliando le pagine dello Strategy Paper del 2004 si nota come la PEV non
si limiti ad un approccio settoriale ma punti a rappresentare un quadro
complessivo per stimolare e facilitare riforme politiche ed economiche strutturali
nei Paesi destinatari. I Piani d´Azione da implementare a livello bilaterale coprono
principalmente due aree: da un lato, si propongono di concretizzare l'impegno a
rispettare e promuovere dei valori condivisi, come il rispetto dei diritti umani, la
democrazia e lo Stato di diritto; dall'altro prevedono misure per intensificare la
cooperazione nei diversi settori di policy, calibrando tali misure a seconda delle
ambizioni e delle possibilità dei Paesi destinatari. Il monitoraggio dei risultati è
regolarmente effettuato dagli organi previsti negli Accordi di Partenariato e di
Cooperazione (APC) nonché dalla stessa Commissione. Attraverso rapporti
periodici quest'ultima tiene informato il Consiglio, che decide in merito ai passi
successivi da intraprendere.
Per quanto riguarda i valori condivisi, l'UE intende rafforzare e
concretizzare l'impegno dei Paesi del vicinato verso il rispetto delle norme di
diritto internazionale a cui si sono vincolati: la Convenzione Europea dei Diritti
Umani per i membri del Consiglio d'Europa, i principi della Convenzione di
Barcellona per i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, nonché altri strumenti
come gli standard previsti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL),
quelli relativi allo sviluppo sostenibile ed alla politica ambientale.
Nell'ambito del "dialogo politico" sono incluse le azioni relative alla
PESC/PESD. L'UE intende rafforzare la dimensione multilaterale della politica
estera, la cooperazione nelle operazioni di sicurezza e di gestione delle crisi, con
lo scopo di condividere le responsabilità per mantenere la pace e la stabilità a
livello regionale.
La PEV ha un forte potenziale anche per migliorare la situazione economica
e sociale dei suoi partner: innanzitutto tramite la riduzione delle barriere tariffarie
e non tariffarie (NTBs) al commercio e l´assistenza finanziaria, ma anche in modo
42
più indiretto attraverso l'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche, degli
standard qualitativi per i prodotti, delle normative relative a igiene, ambiente e
protezione dei consumatori (SHEC). Seguendo la logica economica della PEV,
l´avvicinamento delle strutture economiche e finanziarie a quelle europee
verrebbe considerato come un segnale positivo dai potenziali investitori, che
contribuirebbero quindi a loro volta allo sviluppo dei Paesi in questione, creando
posti di lavoro e maggior benessere65.
Altri ambiti di cooperazione citati nello Strategy Paper del 2004 riguardano:
l'immigrazione e la sicurezza, la lotta al traffico di esseri umani, la creazione di
adeguate infrastrutture per le forniture energetiche e per i trasporti di merci, le
politiche ambientali, la ricerca e l'innovazione e la cooperazione a livello
regionale su questioni specifiche.
Le intenzioni con cui è stata lanciata la PEV sono quindi molto ambiziose.
Pur servendosi di Piani d'Azione bilaterali, l'UE si propone di impostare le
relazioni con i Paesi del vicinato tramite un'unica politica. La logica seguita per
stimolare le riforme in questi Paesi ricalca quella utilizzata nella politica di
allargamento ad Est, riaffermando condizionalità e differenziazione come i due
principi cardine: questa volta però senza la leva dell'adesione all'UE66.
Nei prossimi paragrafi si tenta di valutare, in uno sguardo generale, se e in
quale misura la condizionalità ed il soft power europeo siano stati efficaci e se la
PEV abbia raggiunto, nel suo primo decennio di applicazione, i risultati che si era
prefissi.
65
S. Milcher, B. Slay, M. Collins, "The economic rationale of the European Neighbourhood Policy", in A. Aslund, M. Dabronwski (a cura di), "Europe after Enlargement", Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 165-188. 66
G. Sasse, "The European Neighbourhood Policy: conditionality revisited for the EU´s Eastern Neighbours", Routledge, Europe-Asia Studies, Vol. 60, No 2, March 2008, 295-316
43
2.2 La PEV come nuova governance esterna dell´UE: tra condizionalità
e soft power
2.2.1 La PEV all´interno delle istituzioni: una "cross-pillar policy"
All'epoca del lancio della PEV, la divisione delle competenze tra Unione
Europea e Stati Membri nei diversi settori di policy era ancora definita dalla
struttura a "tre pilastri": il primo corrispondeva alle tre Comunità tradizionali (la
CECA, l'EURATOM e la CE), caratterizzate da un elevato grado d'integrazione e
di competenza esclusiva delle istituzioni UE; il secondo riguardava la Politica
Estera e di Sicurezza Comune, intergovernativa e dominata dal voto all'unanimità
in sede di Consiglio; infine il terzo concerneva la cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale67.
L'azione esterna dell'Unione coinvolge una pluralità di attori e di livelli di
governance, richiede una costante interazione tra Bruxelles e gli Stati Membri
(dimensione verticale) nonché tra gli stessi pilastri (dimensione orizzontale):
risulta quindi arduo assicurare una piena coerenza all'identità dell'UE nelle sue
relazioni con i Paesi terzi68. La PEV si presentava nel quadro dell'azione esterna
europea come un tentativo di attuare un approccio integrato nella PESC, facendo
confluire in una sola politica elementi appartenenti a diversi pilastri. Alcuni
studiosi vedono la PEV come l'implementazione regionale della "European
Security Strategy" (ESS) del 200369, sottolineando che proprio la necessità di
garantire la sicurezza in Europa rappresenta la base su cui la nuova Politica di
Vicinato è stata costruita. Altri obiettivi come la prosperità economica, la stabilità
della democrazia e lo Stato di diritto sarebbero quindi concetti derivati da questo
67
Sito ufficiale dell'UE: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/eu_pillars_it.htm 68
Gauttier, "Horizontal coherence and the external competences of the European Union", (2004) 10ELJ 23 69
Disponibile all'indirizzo http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf
44
obiettivo primario e contribuirebbero a consolidarlo70.
Il carattere multidimensionale della PEV è comunque fuori discussione.
Questo aspetto si riflette anche nella nuova organizzazione delle istituzioni
europee stesse in rapporto a questa nuova politica. La PEV ha trovato un'esplicita
base giuridica solo con il Trattato di Lisbona (in vigore dal 1 dicembre 2009): in
particolare, l'art. 8.1 TUE dispone che “l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi
relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato
fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche
basate sulla cooperazione”. Fino ad allora questo veniva gestito tramite
interazioni informali tra la DG Relazioni Esterne (RELEX) della Commissione ed
il Consiglio, in collaborazione con l'Alto Rappresentante per la PESC ed il
Consiglio Europeo71. Il Trattato di Lisbona ha portato ad un considerevole
cambiamento istituzionale, anche se secondo alcuni la nuova struttura risulta
"quantomeno barocca"72: infatti la PEV viene ora gestita prevalentemente dal
nuovo Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE)73 che tuttavia in questo
campo deve rispondere sia al Commissario per la Politica di Vicinato e
l'Allargamento che all'Alto Rappresentante per la PESC/Vice-Presidente della
Commissione/Presidente del Consiglio Affari Esteri. Quest'ultima figura, dai "tre
cappelli" appena citati, rappresenta il nuovo volto della diplomazia europea dopo
Lisbona74.
70
M. Cremona, C. Hillion, "L'Union fait la force? Potentials and limitations of the European Neighbourhood Policy as an integrated EU Foreign and Security Policy", EUI Working Papers LAW No 2006/39. 71
Lannon, Van Elsuwege, "The EU's emerging Neighbourhood Policy and its potential impact on the Euro-Mediterranean partnership", in P. Xuereb (a cura di), "Euro-Med integration and the "ring of friends": the Mediterranean's Europe challenge", European Documentation Centre, vol. IV, 2003. 72
M. Comelli, N. Pirozzi, Istituto Affari Internazionali (a cura di), "La politica estera dell'Unione Europea dopo Lisbona", Osservatorio di Politica Internazionale, Approfondimenti No 72, febbraio 2013 73
Art. 6 (6), (8), (11) della Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna. 74
Una valutazione critica sui primi tre anni di attività del SEAE si trova in A. Zotti, "The EU diplomacy under review", ISPI, analisi n. 214, dicembre 2013
45
2.2.2 Il "modello allargamento" applicato alla PEV
Molti degli strumenti utilizzati nella PEV sono mutuati dalla politica di
allargamento, che proprio nel 2004 portò all'ingresso nell'UE di dieci nuovi
Membri. Questo risultato considerevole si deve all'efficacia dell'approccio
adottato verso i Paesi candidati all'adesione: per ottenere la membership, tali Paesi
dovettero attuare le necessarie riforme della legislazione e del sistema politico ed
economico interno, per integrare le norme dell'acquis communautaire75. È stata
proprio la prospettiva di membership a fungere da stimolo per intraprendere il
percorso di riforme con serietà e costanza. Trattandosi di un processo che puntava
ad un alto livello di integrazione, la Commissione Europea esercitava un elevato
livello di controllo su questi Paesi, monitorandone i progressi attraverso rapporti
periodici e diversificando la sua azione secondo i risultati e le ambizioni di
ciascun candidato. Il sistema delle pre-accession strategies fu ideato ad hoc e non
era prevista alcuna tempistica comune da rispettare nell'avanzamento delle
negoziazioni76. La natura stessa dell'allargamento necessitava di un approccio
integrato e nonostante la sua complessità e multidimensionalità questa politica ha
saputo produrre risultati sorprendenti77.
La PEV riprende fondamentalmente le caratteristiche della politica di
allargamento. Kelley si esprime in modo ancora più risoluto, affermando che "the
path dependency of the ENP is strong. Its raison d’être is enlargement"78. In
primo luogo, attraverso la PEV l'UE cerca di trasmettere norme, valori e standard
europei ai Paesi del suo vicinato. Il mezzo principale attraverso cui questo
processo avviene sono i Piani d'Azione (PA) bilaterali, calibrati caso per caso
come le pre-accession strategies. Anche i PA sono strumenti onnicomprensivi, che
75
Nota su Criteri di Copenhagen? 76
Vedi Ott e Inglis (a cura di), "Handbook of European Enlargement", TMC, Asser, 2002. 77
Cremona, C. Hillion, cit p. 8. 78
Kelley, "New wine in old wineskins: policy adaptation in the European Neighbourhood Policy", (2006) Journal of Common Market Studies Volume 44, n.1 , p. 29-55.
46
ricoprono l'intero ventaglio delle politiche e non si limitano ad un settore
specifico. Un elemento da sottolineare è il carattere legalmente non vincolante dei
Piani d'Azione, che rimangono uno strumento di soft law come del resto le
accession partnerhips per i Paesi candidati all'adesione: se intuitivamente questo
potrebbe essere considerato una debolezza, in realtà permette un'implementazione
rapida da parte della Commissione ed evita lunghi e deleteri dibattiti sulla
divisione delle competenze con il Consiglio. Un altro aspetto comune tra la PEV e
la politica di allargamento è il monitoraggio dei progressi ottenuti dai Paesi
destinatari, attraverso un comune accordo con l'UE sui benchmarks e sulle priorità
politiche ed economiche di ciascun Paese. L'UE, sulla base dei progressi compiuti
in termini di riforme, può decidere di passare ad un livello più alto d'integrazione,
negoziando e siglando Accordi di Associazione (AA) in sostituzione degli APC.79
La differenza fondamentale tra le due politiche risiede nello scopo finale:
mentre l'allargamento si conclude naturalmente con l'adesione all'UE, la PEV si
colloca a metà strada tra una vera e propria membership ed una semplice
cooperazione, tanto che viene descritta da alcuni studiosi come "politics of the
half-open door"80. Nel 2004 il Commissario Waldner si espresse con queste
parole a proposito: "Let's be clear about what the ENP is and what it is not. It is
not an Enlargement policy. It does not close any doors to European countries that
may at some future point wish to apply for membership, but it does not provide a
specific accession prospect either"81.
Molti studiosi hanno sollevato dubbi sulla reale efficacia che gli strumenti di
condizionalità esercitati verso i Paesi del vicinato possano avere, senza una
79
Le due "generazioni" di accordi riflettono diversi gradi di ambizione e sono raggiunti in diversi momenti da ciascun Paese PEV. L'Ucraina ha iniziato le negoziazioni per l'AA nel 2008, concludendole nel 2012. Nella seconda parte della tesi viene approfondito il caso specifico dell'Ucraina 80
H. Timmermann, "Die EU un die "Neuen Nachbarn" Ukraine und Belarus", SWP Studie, Berlin, Stiftung Wissenschaft und Politik, 2003. Citato in G. Sasse (2008). 81
Commissario Ferrero Waldner, Conferenza stampa di lancio dei primi sette Piani d'Azione nella Politica Europea di Vicinato, Bruxelles, 9 dicembre 2004 SPEECH/04/529
47
prospettiva di membership che incoraggi questi Paesi ad intraprendere le riforme
necessarie. Nel prossimo paragrafo si prende in considerazione proprio la
questione della condizionalità come strumento di governance esterna dell'UE nel
quadro della PEV.
2.2.3 Condizionalità senza adesione: un esperimento fallito?
La condizionalità è un elemento centrale nella PEV ed anche questa trova la
sua ispirazione nella politica di allargamento. Viene abitualmente definita come
"a system of unilateral commitments of partner countries to the EU's political
principles and values, and the normative framework of the EU acquis, in
exchange for delayed actions and benefits from the EU"82.
L'Unione Europea incoraggia i Paesi del suo vicinato ad intraprendere le
riforme necessarie per avvicinarsi agli standard comunitari, proponendo in cambio
l'accesso al Mercato Interno, risorse finanziarie e la propria expertise per
collaborare in differenti settori. Il Commissario RELEX Ferrero Waldner, nel
discorso del 2004 sopra citato, riassumeva così i benefici che i partner dell'UE
avrebbero raccolto grazie alla PEV: "closer cooperation, greater financial
assistance, the chance to participate in EU programmes, and a stake in the
biggest Single Market in the world".
Innanzitutto, ci si può interrogare sull'essenza del concetto di condizionalità
e quindi della stessa PEV: si intende forse dire che l'UE impone in modo
paternalistico l'adozione di nuove legislazioni, stabilendo relazioni asimmetriche
con i destinatari? Oppure si può parlare di un tentativo di condivisione delle
responsabilità per assicurare pace, stabilità e prosperità ai confini dell'UE?
Nello Strategy Paper del 2004 la Commissione espresse chiaramente la sua
posizione in proposito: "L'UE non cerca di imporre priorità o condizioni ai
82
N. Bobitski, "Do ut des? The need for true reciprocity in the European Neighbourhood Policy", European Foreign Affairs Review, 13: 449-472, 2008
48
partner. Il successo dei Piani d'Azione dipende dal chiaro riconoscimento di
interessi reciproci nell'affrontare una serie di questioni prioritarie. È escluso che
venga chiesto ai partner di accettare una serie predeterminata di priorità, le quali
saranno definite di comune accordo e pertanto varieranno da un Paese all'altro".
Tuttavia non mancano le critiche a questo sistema, ritenuto da alcuni studiosi una
politica unilaterale dell'UE volta a cambiare l'ambiente circostante83. Si sottolinea
infatti che, nonostante la consultazione con i Paesi partner, la specifica
condizionalità dell'UE implica un forte controllo nonché una valutazione della
loro performance in termini di riforme e produzione di politiche. Kelley parla a
questo proposito di "intentional ambiguity" tra condizionalità e joint ownership84.
A livello concettuale la condizionalità è stata definita in diversi modi: in
questa tesi si fa riferimento a Schimmelfennig e Sedelmeier85, secondo i quali la
sua efficacia viene spiegata nel migliore dei modi dall´"external incentives
model". Si tratta di un modello razionale con una logica economica, per cui tale
politica risulta efficace se le condizioni sono coerenti e credibili ed i costi di
adozione restano bassi. Gli stessi due autori considerano quattro criteri principali
per definire l´efficacia della condizionalità politica nell´azione dell´UE86:
• "Determinacy of conditions", che riguarda il livello di chiarezza
delle condizioni imposte dall´UE e la loro formale implementazione.
Se il vantaggio concreto dopo gli sforzi compiuti risulta ben definito
e le regole per ottenerlo sono stabilite in modo chiaro, un governo
sarà più portato a scegliere di rispettare i parametri della
condizionalità;
83
Cremona, Hillion, cit. p. 21. 84
Kelley, cit. p. 36. 85
F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier (a cura di), "The Europeanization of Central and Eastern Europe", Ithaca, Cornell University Press 2005. 86
F. Schimmelfennig e U. Sedelmeier, "Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe", Journal of European Public Policy 11:4 agosto 2004: 669–687. Presentati in forma teorica, questi criteri vengono ripresi nella Parte Seconda e applicati al caso dell´Ucraina.
49
• "The size and speed of rewards", ovvero la velocità con cui l´UE
intende avvicinare i Paesi destinatari della PEV all´obiettivo finale,
nonché l´importanza stessa di quest´obiettivo per i destinatari. Se il
traguardo può essere raggiunto nel breve termine, lo stimolo per
intraprendere le riforme è maggiormente efficace verso i Paesi del
vicinato; per quanto riguarda la sua entità, certamente la membership
offerta ai Paesi dell´allargamento del 2004 ha maggiore potere di
attrazione rispetto ad una proposta di associazione.
• "Credibility of conditionality" indica la capacità dell´UE di
sanzionare i destinatari in caso non seguano le regole stabilite,
nonché di concedere i vantaggi promessi in caso il processo di
riforma sia portato a compimento con successo. Per essere efficace
nella sua azione, l´UE deve poter contare su di un´interdipendenza
asimmetrica in suo favore e di un potere negoziale dominante,
altrimenti le sue promesse non sarebbero credibili.
• "Veto players and adoption costs", infine, si riferisce ai costi di
adozione associati all´implementazione delle riforme richieste da
Bruxelles. Se tali costi risultano inferiori ai vantaggi di cui si potrà
beneficiare in futuro, e soprattutto se tali vantaggi soddisfano la
maggior parte dei veto players presenti nel governo e nella società
civile del Paese di riferimento, allora la condizionalità incrementa la
sua efficacia.
Tenendo in considerazione questo modello, si mette in questione la reale
efficacia dello strumento di condizionalità senza un'offerta di membership da
parte dell'Unione Europea. Se infatti il processo di allargamento ha prodotto i suoi
risultati, ciò si deve al fatto che la condizionalità poteva contare su chiari incentivi
ai Paesi candidati e strutture di implementazione le politiche. G. Sasse afferma
che entrambi questi elementi sembrano essere vaghi sia per quanto riguarda l'UE
50
che per i paesi del vicinato, tanto che conia il termine "conditionality-lite"87.
Inoltre, data la natura spesso semi-autoritaria dei regimi nel vicinato europeo, i
costi dell'adozione di riforme si mantengono alti88.
Con lo Strategy Paper del 2006 sul rafforzamento della PEV89 l'Unione
tentava di supplire a questo deficit d'offerta mettendo in evidenza le azioni e gli
strumenti a sua disposizione per supportare i Paesi del vicinato. Il Paper ne
identificava quattro gruppi principali: una maggiore cooperazione economica che
puntasse alla conclusione di ambiziosi accordi di libero scambio; una facilitazione
della mobilità tramite accordi sui visti; l'accesso ai programmi comunitari, anche
nel campo scientifico, della ricerca, dell'educazione e della cultura; un maggiore
impegno per prevenire i conflitti regionali con attività di monitoraggio, peace-
keeping e controllo delle aree di frontiera.
Per quanto riguarda l'Europa orientale, queste dichiarazioni di intenti si sono
concretizzae nella dimensione istituzionale con la creazione nel 2009 di un nuovo
quadro di relazioni tra l'UE e questi Paesi: la Eastern Partnerhip (EaP) o
Partenariato Orientale (PO). Il prossimo paragrafo si occupa di valutare se e
quanto questa innovazione abbia contribuito a diminuire, se non ad eliminare, gli
aspetti di criticità riscontrati nella PEV e nella condizionalità nei primi anni dalla
loro introduzione.
2.2.4 La nascita del Partenariato Orientale
Lontani dal voler fornire un quadro esaustivo sulle novità istituzionali
introdotte a partire dal 2009 sotto il nome di Partenariato Orientale (PO), questo
paragrafo ne accenna rapidamente la nascita e gli aspetti principali, mettendo in
evidenza il valore aggiunto che l'UE intende dare alle sue relazioni con i Paesi in
87
G. Sasse, cit. p 296. 88
Schimmelfennig e Sedelmeier, cit. 89
COM(2006) 726 final, 04.12.2006
51
questione. Sarà compito della Parte Seconda di questa tesi approfondire le
implicazioni di questi cambiamenti nelle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina nello
specifico.
La prima proposta di lanciare un nuovo quadro di relazioni specificamente
dedicato all'Europa dell'Est venne elaborata dalla Germania nel 2006, in
previsione della sua presidenza di turno del Consiglio dell'UE del primo semestre
del 2007. In quest'occasione si faceva riferimento ad una "Neue Ostpolitik", una
partnerhip rafforzata con Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica
di Moldova e Ucraina (chiamata anche "ENP Plus")90. Anche se l'idea non riuscì a
prendere forma, fornì una buona base per una successiva proposta da parte di
Polonia e Svezia nel 2008. Parallelamente, l'iniziativa del Presidente della
Repubblica francese Nicolas Sarkozy di dar vita ad una rinnovata Unione per il
Mediterraneo (UpM) lo stesso anno aprì un'importante finestra di opportunità per
ottenere un successo anche nel vicinato orientale91.
Il Consiglio Europeo nel giugno 2008 "conviene sulla necessità di
promuovere ulteriormente la cooperazione regionale tra i paesi limitrofi orientali
dell'UE e tra l'UE e la regione, nonché la cooperazione bilaterale tra l'UE e
ciascuno di tali Paesi rispettivamente, sulla base della differenziazione e di un
approccio individuale, nel rispetto del carattere della PEV quale quadro politico
unico e coerente. Tale cooperazione dovrebbe inoltre fornire un valore aggiunto
ed essere complementare alla cooperazione multilaterale già esistente e prevista
in base e in relazione alla PEV, in particolare la "Sinergia del Mar Nero" e la
dimensione settentrionale"92. In questi anni a Bruxelles si avvertiva la necessità di
90
I. Kempe, ‘A New Ostpolitik? Priorities and Realities of Germany’s EU Council Presidency’, CAP Policy Analysis, No. 4 / 2007, Monaco di Baviera, Bertelsmann Group for Policy Research, luglio 2007, p.2. 91
Agnieszka K. Cianciara, ‘‘Eastern Partnership’ – opening a new chapter of Polish Eastern policy and the European Neighbourhood Policy?’, Analyses & Opinions, No. 4/2008, Varsavia, The Institute of Public Affairs, giugno 2008, p. 22. In questa tesi tuttavia non vengono trattate le questioni riguardanti il Partenariato Euro-Mediterraneo. 92
Testo integrale disponibile al link: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/108645.pdf
52
rafforzare sia la dimensione bilaterale sia quella multilaterale del partenariato
orientale, per consolidare i risultati raggiunti dai Paesi in questione.
Da citare gli effetti della crisi economico-finanziaria globale iniziata nel
2008 negli Stati Uniti. Per le già fragili economie dei Paesi del vicinato orientale
si è trattato del periodo di maggior difficoltà dagli anni Novanta. Un contributo
considerevole a questo senso di urgenza arrivò inoltre dallo scoppio della guerra
tra Russia e Georgia nel 2008, che coincideva con il taglio delle forniture di gas
all'Ucraina da parte di Mosca93.
L´iniziativa politica denominata "Partenariato Orientale" (PO) fu lanciata in
occasione del Summit di Praga nel maggio 200994. L´Unione Europea con questo
nuovo quadro istituzionale distingueva, all´interno della PEV, la dimensione
meridionale ("Unione per il Mediterraneo" a partire dal 2008) da quella orientale,
rafforzando la cooperazione a livello regionale in Europa dell´Est. Questa
attenzione alla dimensione regionale e multilaterale era la novità principale del
PO e veniva generalmente considerata in modo positivo sia dagli Stati Membri
dell´UE che dai partner orientali95. Una dimostrazione della volontà di costituire
una struttura regionale con una propria fisionomia è rappresentata dalla nascita di
un´Assemblea Parlamentare (EURONEST) e l´organizzazione di Summit regolari
a diversi livelli di governo.
Nel PO finora resta comunque centrale la dimensione bilaterale: l´UE punta
a raggiungere con i partner orientali un nuovo livello di relazioni contrattuali,
sostituendo gli APC con Accordi di Associazione (AA). Inoltre prevede la
stipulazione di DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Agreements), che
coprono un maggior numero di settori e prevedono un maggior livello di
93
P. Miltner, "The Union for the Mediterranean and the Eastern Partnership: A Comparative Analysis". Natolin Best Master Thesis 02 / 2010, Master Thesis in European Interdisciplinary Studies, Academic Year 2009/2010. Master Thesis Supervisor: Prof. Dr. Erwan Lannon. 94
Sito del European Neighbourhood Policy Info Centre: http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=506&id_type=2 95
J. Boonstra, N. Shapovalova, "The EU’s Eastern Partnership:one year backwards", FRIDE, maggio 2010.
53
integrazione rispetto agli accordi di prima generazione; anche la mobilità viene
ulteriormente incentivata tramite le negoziazioni sugli accordi di liberalizzazione
dei visti96.
Uno degli aspetti più critici che gli studiosi hanno sottolineato riguarda il
protrarsi della tensione tra la condizionalità applicata dall´UE e il concetto di
"joint ownership" reclamato dai Paesi partner97. Una coerente applicazione del
principio di condizionalità resta un elemento chiave per la credibilità dell´Unione
verso i Paesi del PO, tuttavia questo aspetto contrasta con la necessità di
differenziare il trattamento riservato a ciascun Paese a seconda della situazione e
del grado di ambizione. Infatti, se l´obiettivo ultimo da raggiungere rimane lo
stesso per i sei membri del PO, ad oggi almeno la metà di questi non sembrano in
grado di raggiungere i criteri (democratici, economici ecc.) necessari per
soddisfare la condizionalità dell´UE e beneficiare degli effetti positivi derivanti
dagli AA, i DCFTA e la liberalizzazione dei visti.
Un altro aspetto da sottolineare è che il PO è stato visto in modo positivo
soprattutto dai Paesi per cui rappresentava un sensibile miglioramento rispetto alle
relazioni con l´UE in ambito PEV. Per Ucraina e Moldova, che godevano già di
un livello avanzato di relazioni con Bruxelles, il fatto che nemmeno nel PO fosse
stato dato spazio ad una prospettiva di adesione nel vicino futuro contribuiva ad
alimentare il clima di frustrazione98. Una certa delusione è stata recentemente
espressa anche dal presidente della delegazione UE presso la Commissione
Parlamentare di Cooperazione (CPC) UE-Ucraina, Adrian Severin, che in
Commissione Affari Esteri al Parlamento Europeo ha dichiarato che il PO non ha
portato innovazioni rispetto alla PEV, restando un "beautiful package, which is
96
European Commission, HR of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, Joint Staff Workink Paper on "Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010 Report: Eastern Partnership" COM(2011) 303, Brussels, 25/05/2011. 97
Per una visione generale vedi N. Ghazaryan, ‘The ENP and the Southern Caucasus: Meeting the Expectations?’, Global Europe Papers 5 (2008), pp.13–15. 98
J. Boonstra, N. Shapovalova, cit. p. 9.
54
empty inside"99.
In conclusione, nonostante le critiche si può affermare che l´iniziativa del
Partenariato Orientale abbia segnato un´evoluzione all´interno del quadro della
PEV, con l´approccio dell´UE che si è concentrato maggiormente sulla
dimensione multilaterale. Tuttavia, lo "zoccolo duro" della PEV rimane bilaterale
e si propone nuovi livelli di relazioni contrattuali. Permane, come retaggio della
PEV, una tensione tra la coerente applicazione del principio di condizionalità e la
necessità di differenziare il trattamento a seconda delle caratteristiche di ciascun
Paese partner.
2.4 Considerazioni critiche: la PEV 10 anni dopo
Come i precedenti paragrafi tentano di illustrare, la Politica Europea di
Vicinato è nata come un´alternativa alla geopolitica tradizionale. L'Unione
Europea, tramite una progressiva intensificazione ed evoluzione delle relazioni
politiche ed economiche con i Paesi destinatari, punta a favorirne la transizione
verso la democrazia, il rispetto dei diritti umani, lo stato di diritto e l'economia di
mercato, favorendone l'integrazione nel mercato europeo. A dieci anni dalla sua
messa in opera è tempo di chiedersi se effettivamente la PEV abbia raggiunto i
suoi scopi: basta sfogliare le pagine dei quotidiani per accorgersi che l'"area di
prosperità e buon vicinato" prevista all'art. 8 TEU è ben lontana dall'essersi
realizzata.
Pur non essendo la PEV nel suo complesso l'oggetto primario di questa tesi,
risulta interessante indagare sulle motivazioni di questa mancanza di efficacia.
Mettere in luce le criticità principali della PEV aiuta a fornire degli strumenti
99
Delegazione alla Commissione Parlamentare di Cooperazione (CPC) UE-Ucraina in tema di Affari Esteri, Parlamento Europeo, incontro straordinario congiunto, Bruxelles, 11 febbraio 2011, www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/d-ua_20090211_01_/D-UA_20090211_01_en.pdf).
55
teorici per analizzare in seguito il caso dell'Ucraina, valutando infine se questo
Paese rappresenti un caso tipico o un'eccezione a quanto sostenuto più in generale.
2.4.1 I principali punti critici nell´architettura concettuale della PEV
Alcuni commentatori affermano che la PEV è una delle politiche dell´UE in
cui si rileva il maggiore scarto tra le ambizioni espresse inizialmente ed i risultati
concreti raggiunti100.
Il primo aspetto che contribuisce allo scarso successo della PEV riguarda la
metodologia applicata: come visto negli scorsi paragrafi, essa riprende gli stessi
strumenti della politica di allargamento. I Piani d´Azione bilaterali stabiliscono le
priorità da seguire, rapporti periodici della Commissione valutano i progressi dei
Paesi PEV nell´avvicinamento agli standard politici ed economici europei,
l´assistenza finanziaria e tecnica da parte dell´UE punta ad aumentare quantità e
qualità delle relazioni per raggiungere elevati livelli di integrazione. Tuttavia la
prospettiva di membership, che rappresenta il maggiore stimolo per le riforme nei
Paesi partner, non viene mantenuta e questo indebolisce in maniera significativa il
potere di attrazione dell´offerta europea101.
Commenti critici sono sorti inoltre sulla scelta di includere Paesi con
caratteristiche, ambizioni ed esigenze tanto diverse in un solo quadro d´azione
politica102. L´UE ha riconosciuto il bisogno di una certa differenziazione
regionale, istituendo nel 2008 l´Unione per il Mediterraneo e nel 2009 il
Partenariato Orientale. Il solo criterio per la scelta dei Paesi da includere nella
PEV tuttavia rimane la vicinanza geografica all´Europa. Il risultato è da un lato un
certo disinteresse da parte dei partner senza particolari aspirazioni europeiste,
100
S. Lehne, "Time to reset the European Neighbourhood Policy", Carnegie Europe, Febbraio 2014. 101
M. Cremona, C. Hillion, cit. p. 16. 102
V. Ratsiborynska, "The European Neighbourhood Policy through its "Europeanization": the case of Ukraine", L´Europe Unie/United Europe, No. 6/2012, p. 50.
56
dall´altra un senso di frustrazione per quelli che invece ambiscono ad un posto tra
le nazioni europee (come l´Ucraina).
L´Unione Europea negli anni è stata accusata di aver basato la PEV su una
concezione incompleta e talvolta eurocentrica della geopolitica103:
nell´elaborazione di una strategia verso il Partenariato Orientale nel 2009, per
esempio, non è stato preso sufficientemente in considerazione il ruolo di potenza
regionale giocato dalla Federazione Russa. Mosca, in una mentalità in un certo
senso "imperiale", continua a considerarlo un gioco a somma zero in cui una
maggiore prossimità all´UE andrebbe a scapito della sua influenza sulle ex
Repubbliche Sovietiche. La costituzione nel 2010 dell´Unione Doganale
Euroasiatica con Bielorussia e Kazakistan ha segnato l´inizio di una competizione
geopolitica che l´UE non sembra aver previsto né tantomeno cercato. Questo
diventa ancora più evidente osservando il caso ucraino, di cui si tratta nella Parte
Seconda. Il fatto che si sia sfiorata la firma dell´Accordo di Associazione in
occasione del Summit di Vilnius nel 2013 porta a non sottovalutare il soft power
di Bruxelles; tuttavia la pressione di Mosca, almeno nel breve periodo, sembra
aver sortito i suoi effetti104.
La coerenza dell´azione esterna dell´UE viene spesso messa in questione.
Nel caso della PEV, il processo viene gestito quasi interamente dalla
Commissione, seguendo la logica "funzionalistica" dell´allargamento, mentre la
spinta politica proveniente dagli Stati Membri rimane scarsa, in quanto essi
continuano a seguire i propri interessi individuali in politica estera senza
concentrare gli sforzi su un obiettivo comune. Questo si è rivelato particolarmente
evidente durante i conflitti scoppiati a livello regionale: dalla Primavera Araba
all´irrisolta questione Israelo-Palestinese, dalle tensioni nel Caucaso Meridionale
alla guerra in Mali, la gestione delle crisi a livello europeo è risultata poco pronta
103
Boedeltje, Freerk (2012). “The Other Spaces of Europe: Seeing European Geopolitics Through the Disturbing Eye of Foucault’s heterotopias”. Geopolitics , 17 (1), 1-24. 104
Maggior dettaglio nel capitolo 5, dedicato all´internazionalizzazione della crisi Ucraina dopo il Summit di Vilnius del Novembre 2013.
57
e disordinata.
Infine, come accennato nei paragrafi precedenti, l´applicazione del principio
di condizionalità da parte dell´UE risulta quantomeno selettivo e manca spesso di
coerenza. Per esempio, se con la Bielorussia questo strumento è stato finora usato
a pieno regime, non si può dire lo stesso riguardo ad un importante partner
energetico come l´Azerbaigian105: un elemento che certamente non consolida la
credibilità dell´Unione nei Paesi del vicinato.
2.4.2 Lo stato dell´arte del nel 2014: molto resta ancora da fare
Nonostante i tentativi dell´UE di portare "pace, stabilità e prosperità" nel
suo vicinato, a dieci anni dalla messa in opera della PEV sia nella riva sud del
Mediterraneo sia in Europa dell´Est si assiste ad una considerevole
frammentazione. Lo scoppio della cosiddetta "Primavera Araba" nell´inverno
2010-2011 ha portato alla fine di diverse dittature sia in Nord Africa sia in Medio
Oriente. Non si può tuttavia affermare che il passaggio sia stato indolore né
tantomeno completo: in molte occasioni le insurrezioni hanno condotto ad una
vera e propria guerra civile con migliaia di morti tra la popolazione, instabilità nei
governi e reazioni violente come nel caso della repressione tuttora in atto in
Siria106. Una risposta da parte dell´UE è arrivata nel 2011 con un nuovo
documento strategico sulla PEV, che ha riconosciuto la necessità di coinvolgere
maggiormente la società civile e di differenziare in modo ancora più netto i propri
interventi a seconda dei progressi di ciascun Paese partner, introducendo il
principio del "more for more"107. Nel contesto turbolento in cui ci si trova a
105
S. Lehne, cit. p. 9. 106
Vedi J. Horst, A. Jünemann, D. Rothe (a cura di), "Euro-Mediterranean relations after the Arab spring : persistence in times of change ", Farnham, Ashgate 2013. 107
Commissione Europea, Alto Rappresentante dell´UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, "Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", COM(2011) 303 definitivo, Bruxelles, 25.5.2011.
58
scrivere questa tesi, non è ancora chiaro se questo rappresenti un vero cambio di
passo nell´atteggiamento europeo.
Anche nell'Europa dell´Est gli standard democratici e il livello di benessere
della popolazione sono in fase di erosione. Nessuna della sei repubbliche del PO
può infatti essere definita "democratica" secondo gli standard europei108: basti
citare la situazione in Bielorussia, ritenuta ancora oggi "l´ultima dittatura
d´Europa", o l´arresto e la condanna nel 2011 dell´ex Primo Ministro ucraino
Yulia Tymoshenko, che si considerano basati su pretesti di natura politica109.
Nemmeno nella dimensione commerciale i progressi sono stati all´altezza
delle aspettative iniziali: a dieci anni dall´aver offerto ai Paesi destinatari della
PEV una partecipazione al Mercato Interno, l´UE non ha ancora firmato110 con
nessuno di essi un Accordo di Associazione (né l´incluso DCFTA); le relazioni
bilaterali sono tuttora rette sulla base degli APC siglati negli anni Novanta111.
Nonostante l´Unione Europea sia sempre più presente nel Partenariato
Orientale e l´interdipendenza sia ad oggi un dato di fatto, Bruxelles non riesce
ancora ad essere efficace nelle sue politiche verso questi Paesi112. Con una
situazione economica fragile, affrontare seriamente le riforme e la condizionalità
richiesta da Bruxelles senza un obiettivo finale ben definito sarebbe una scelta
politicamente poco gratificante nel breve periodo. Anche per questo la scelta
108
Per le stime dell´Economist Intelligence Unit, vedi www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12 109
R. Sadowski, "Partnership in times of crisis. Challenges for the Eastern European COuntries´integration with Europe", Centre for Eastern Studies, N. 36, Varsavia, Luglio 2013. 110
Come si vede nella seconda parte della tesi, una parziale eccezione é costituita dall´Ucraina: concludendo le negoziazioni per l´AA nel 2012, la firma prevista per il Summit di Vilnius del novembre 2013 viene rinviata da Kiev a causa soprattutto della pressione da parte di Mosca. Il nuovo Primo Ministro Yatseniuk si reca a Bruxelles il 21 marzo 2014 per firmare la parte politica dell´AA. L´UE punta a fare lo stesso con il DCFTA dopo le elezioni presidenziali ucraine del maggio 2014. Un´altro risultato importante del Summit di Vilnius è la chiusura delle negoziazioni per l´AA con Moldavia e Georgia, anche se la firma dello stesso resta pendente. 111
Nel caso della Bielorussia, l´UE non ha ancora firmato l´APC del 1995 a causa delle continue violazioni dei principi di democrazia, diritti umani e Stato di diritto. Minsk ha inoltre richiesto di prendere parte all´OMC nel 1993 ma il processo non si è ad oggi ancora concluso. 112
E. Gnedina, N. Popescu, "The European Neighbourhood Policy´s first decade in the Eastern Neighbourghood", CIES, July 2012.
59
propende (almeno nel caso dell'Ucraina) verso una politica "multivettoriale" che
permetta di beneficiare allo stesso tempo dei legami con la Federazione Russia e
con l´UE113.
Vedendo la situazione dal punto di vista di Bruxelles, si nota come dal 2003
la PEV non sia stata concepita come una politica prioritaria. Infatti le questioni
interne sul "futuro dell´Europa" dopo il fallimento del trattato costituzionale e la
crisi economica dell´Eurozona hanno occupato i primi posti dell´agenda europea
negli ultimi anni. Questo contribuisce a spiegare almeno in parte perché l´UE sia
stata meno attiva in politica estera, e sicuramente nel Partenariato Orientale dove
alle dichiarazioni di intenti non sono seguiti analoghi risultati sul campo.
Le dimensioni di questa tesi non permettono la dovuta profondità d´analisi,
quindi la valutazione fatta rimane necessariamente parziale e inadeguata alla
complessità della materia. Risulta utile tuttavia in quanto fornisce un contesto
politico in cui inserire le relazioni tra UE ed Ucraina, aspetto su cui si concentra
maggiormente la Parte Seconda.
113
Idem
61
PARTE SECONDA
UNIONE EUROPEA E UCRAINA
NEL CONTESTO DELLA
POLITICA EUROPEA DI VICINATO
UN EFFICACE STRUMENTO DI
GOVERNANCE ESTERNA?
63
Introduzione e nota metodologica
Dopo averne presentato il background storico nonché il contesto politico
nella Parte Prima, questa Parte Seconda si prefigge di analizzare le relazioni tra
Unione Europea e Ucraina nel contesto della Politica Europea di vicinato e del
Partenariato Orientale.
L´Ucraina è un caso particolarmente interessante da studiare, in quanto
rappresenta il principale partner orientale dell´UE in termini sia di dimensioni che
di importanza strategica. Inoltre, alla luce dei recenti avvenimenti e della crisi che
dal novembre del 2013 imperversa nel Paese, sorge spontanea la questione
dell´efficacia delle politiche europee nei confronti di Kiev negli ultimi anni. La
risposta non può evidentemente essere univoca, in quanto i settori di policy in cui
UE e Ucraina intraprendono una più o meno intensa collaborazione sono diversi e
hanno finora ottenuto risultati divergenti.
Uno degli assunti alla base di quest´analisi lega l´efficacia della governance
esterna europea al livello di interdipendenza tra Kiev con i suoi due principali
partner della regione: l´Unione Europea stessa e la Federazione Russa114. Come
menzionato nei paragrafi conclusivi della Parte Prima, la Politica Europea di
Vicinato non sembra invece aver preso sufficientemente in considerazione
l´influenza di Mosca sulle scelte politiche in Ucraina115. Il modello di soft power
europeo si differenzia sostanzialmente da quello russo, "una combinazione fra
hard power militare, leva energetica e utilizzo del mito delle minoranze russe"116:
i prossimi capitoli cercano di evidenziare come in più di qualche occasione la
competizione tra questi due modelli abbia provocato instabilità e tensioni.
114
A. Dimitrova and R. Dragneva, "Constraining external governance : interdependence with Russia and the CIS as limits to the EU’s rule transfer in the Ukraine", Journal of European public policy 2009, v. 16, n. 6, September, p. 853-872. 115
Vedi pp. 47-48. 116
Tratto da M. Dassú, "Ecco perché la sfida di Putin aiuta l´Europa", editoriale pubblicato in La Stampa, 7 aprile 2014.
64
L´Ucraina, geograficamente e culturalmente "intrappolata"117 tra Occidente ed
Oriente, cerca nelle sue scelte di politica estera di ritagliare una propria identità
indipendente da Mosca e non ha rinunciato nel corso degli anni alle sue
aspirazioni europee, nonostante risposte spesso deludenti da parte di Bruxelles118.
Il capitolo 3 tratta la dimensione commerciale delle relazioni UE-Ucraina, a
partire dal lancio della PEV e dalla firma del Piano d´Azione del 2005. Vengono
in seguito presentati i punti principali delle negoziazioni del DCFTA, nonché le
potenziali conflittualità con il progetto parallelo dell´Unione Economica
Euroasiatica (UEE) perseguito dal Presidente russo Putin. Viene inoltre presa in
considerazione la questione energetica, in quanto rappresenta un chiaro esempio
di come l´influenza di Mosca sia decisiva per le scelte del governo ucraino nelle
sue relazioni con l´UE.
Il capitolo 4 si occupa invece della dimensione politica e si propone di
elaborare una critica del meccanismo di "condizionalità" che l´UE attua per
stimolare riforme democratiche in Ucraina. Tra i motivi del suo sostanziale
fallimento, oltre alla mancata prospettiva di adesione, è importante considerare
anche la perenne instabilità politica che caratterizza il Paese, gli interessi di breve
termine della classe politica e l´influenza dell´oligarchia.
Il capitolo 5 infine riguarda la crisi attualmente in corso in Ucraina e trae le
sue fondamenta teoriche dalle argomentazioni sviluppate nei capitoli precedenti.
Si citano le proteste "Euro-Maidan", l´annessione della Crimea da parte della
Russia, i referendum organizzati nell´Est del Paese per ottenere una non meglio
definita "indipendenza" e le principali reazioni internazionali, soprattutto di UE e
USA, di fronte al tragico susseguirsi degli eventi. Infine, un breve commento sulle
prospettive del Paese dopo le elezioni presidenziali del 25 maggio 2014.
117
Espressione utilizzata in I. Lukes, "Ukraine Trapped Between the Agile East and the Sleepy West", articolo pubblicato il 28 febbraio 2014 e disponibile online al sito: http://2paragraphs.com/2014/02/ukraine-trapped-between-the-agile-east-and-the-sleepy-west/ 118
Vedi ad esempio p. 18.
65
CAPITOLO 3
LA DIMENSIONE COMMERCIALE:
IL CAMMINO VERSO IL DCFTA CON L´UE
3.1 Le priorità della cooperazione commerciale nei primi anni della
PEV
3.1.1 Le relazioni commerciali all'interno della PEV
Nella Parte Prima si è sottolineato che la base giuridica delle relazioni
bilaterali tra l'Unione Europea e l'Ucraina è costituita dall'Accordo di Partenariato
e di Cooperazione (APC), firmato nel 1994 ed in vigore dal 1998. Le disposizioni
commerciali dell'APC sono invece applicate sin dal 1996. All'articolo 4, l'APC
contiene una clausola evolutiva che permette di adattare la legislazione a seconda
dei progressi e della volontà politica di portare la cooperazione ad un livello
superiore. Inoltre, accordi separati regolano gli scambi in alcuni specifici settori
(come il tessile e l´acciaio)119.
Con il lancio della Politica Europea di vicinato, vennero redatti il primo
Country report (2004)120 ed il Piano d'Azione riguardanti l'Ucraina (2005)121,
rispettivamente con lo scopo di fornire un quadro della situazione politica ed
economica nel Paese e di stabilire le priorità su cui concentrare le politiche
dell'UE. Per seguire le fasi d'implementazione del Piano d'Azione, si istituirono
119
M. Cremona (a cura di), "Developments in EU external relations law", Oxford University Press, 2008, p. 276. 120
Commission Staff Working Paper, "European Neighbourhood Policy - Country Report Ukraine" {COM(2004)373 final, Brussels, 12.5.2004 SEC(2004) 121
Adottato il 12 febbraio 2005 per un periodo iniziale di tre anni, viene in seguito prorogato fino al 2009.
66
incontri regolari a diversi livelli di governo: il Summit UE-Ucraina, il Consiglio
di Cooperazione, il Comitato di Cooperazione e sette sottocomitati122.
Fino all'allargamento del 2004, il principale partner commerciale
dell'Ucraina rimaneva la Federazione Russa, che rappresentava il 35% del totale
degli scambi per Kiev. L'Unione Europea si affermava come il maggiore partner
non-membro della CSI con il 20%, mentre l'Ucraina copriva solo una parte
modesta del commercio europeo: nel 2002 la percentuale stimata era lo 0,5%.
Dopo l'allargamento l'importanza degli scambi con l'UE crebbe
considerevolmente: Bruxelles raggiunse infatti il 39% nel 2007 divenendo il
principale mercato di riferimento per Kiev123. Nell'aprile del 2004 tuttavia la
Verkhovna Rada ratificò l'accordo con la Russia, il Kazakistan e la Bielorussia per
la creazione di uno "Spazio Economico Unico", in vista dell'eventuale istituzione
di una ALS e di un'Unione Doganale, l'armonizzazione delle politiche energetiche
e dei tassi di cambio tra i Paesi coinvolti. Si confermava quindi l'approccio
"multivettoriale" che caratterizzava le relazioni esterne ucraine sin dagli anni
Novanta.
Salutando, con la classica prudente retorica di Bruxelles, le aspirazioni
europee di Kiev, il Piano d'Azione del 2005 dipingeva un quadro dettagliato delle
aree che l'UE riteneva più importanti per sostenere il Paese nel suo processo di
riforme. Per quanto riguarda il commercio, tra i punti di intervento prioritari si
trovavano: l'adesione all'OMC, la riforma del sistema fiscale, lo smantellamento
progressivo delle barriere non tariffarie e il miglioramento del clima per gli
investimenti.
L'Ucraina veniva definita come una "relatively open economy", in quanto
122
Una lista dei documenti principali nelle relazioni bilaterali tra UE e l´Ucraina è disponibile sul sito del Servizio Europeo per l´Azione Esterna (SEAE): http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/index_en.htm 123
Commission Staff Working Document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, " Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2008 - Progress Report Ukraine", Brussels, 23/04/2009, SEC(2009) 515/2., p. 8.
67
le importazioni e le esportazioni di beni e servizi superavano il 50% del PIL
nazionale. Per quanto riguarda l'implementazione delle disposizioni contenute
nell'APC, la Commissione Europea segnalava dei progressi incoraggianti, anche
se in alcune aree le difficoltà rimanevano considerevoli: alcuni esempi erano il
settore dell'automobile, l'accesso al mercato dell'acciaio, gli standard sanitari e
fitosanitari per la qualità dei prodotti (SPS) e l'incapacità di attrarre investimenti
diretti esteri (IDE). Più in generale il problema risiedeva nei frequenti
cambiamenti nella legislazione commerciale del Paese, nonché nella mancanza di
trasparenza e nell'alto tasso di corruzione124.
È importante notare che già nel rapporto del 2004 veniva preannunciata la
possibilità di istituire un'Area di Libero Scambio tra UE ed Ucraina, concetto
ribadito nel Piano d'Azione del 2005. La condizione da soddisfare affinché questo
potesse avvenire era l'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione Mondiale del
Commercio, considerata di cruciale importanza per l'UE. La candidatura venne
depositata nel 1994 e nel 2004 l'Ucraina terminò le negoziazioni con un totale di
23 membri dell'OMC, compresa l'UE. Kiev si proponeva di ultimare il processo
entro la fine dello stesso anno, tuttavia l'adesione giunse solamente nel 2008.
Tramite assistenza tecnica e finanziaria, l'Unione Europea promuoveva
l'allineamento della legislazione ucraina agli standard internazionali dell'OMC, in
modo che l'Ucraina potesse mantenere gli impegni presi con gli altri Paesi
membri. In questo contesto i punti prioritari su cui lavorare non erano le tariffe
doganali o le restrizioni quantitative al commercio, su cui l'UE riconosceva un
soddisfacente processo di riforma, quanto invece le barriere non tariffarie (NTBs):
il sistema fiscale, le restrizioni alle esportazioni, i diritti di proprietà intellettuale
(IPRs), le misure sanitarie e fitosanitarie per la qualità dei prodotti (SPS), gli
standard tecnici e più in generale l'implementazione della nuova legislazione125.
124
Commission Staff Working Paper, "European Neighbourhood Policy - Country Report Ukraine" (2004, cit.). 125
Idem
68
L'adozione dell'acquis dell'OMC costituisce parte integrante degli obiettivi
della PEV, e più in generale della governance esterna e del potere normativo che
Bruxelles esercita nei confronti dei Paesi del vicinato. Nel caso ucraino sarebbe
quindi impreciso sostenere che le norme dell'UE siano state l'unico riferimento per
il processo di trasformazione, in quanto le stessa Unione Europea si proponeva di
promuovere l'inclusione di Kiev nel sistema commerciale multilaterale a livello
globale126.
3.1.2 Progressi e punti di stallo nelle negoziazioni
Un importante passo in avanti nelle relazioni commerciali bilaterali fu il
riconoscimento da parte di Bruxelles dello "status di economia di mercato" (SEM)
all'Ucraina, concesso nel dicembre 2005. I vantaggi economici di tale status
riguardavano soprattutto le misure anti-dumping applicate dall'UE su alcuni
prodotti industriali ucraini, specialmente in un settore trainante come quello
dell'acciaio, per un risparmio annuo stimato tra i 200 ed i 300 milioni di euro127;
tuttavia non si impediva l´utilizzo di misure commerciali difensive tra i partner
(come le misure anti-sussidio, le clausola di salvaguardia o le investigazioni).
Questa decisione faceva parte di una più ampia strategia europea per rafforzare i
legami con Kiev dopo la Rivoluzione Arancione e le elezioni che videro vincitore
V. Yuschenko. Il fatto che lo SEM fosse stato già riconosciuto alla Russia nel
2002 poneva l'industria ucraina in svantaggio nel mercato europeo, creando
frustrazione tra i filo-europeisti del governo ucraino128.
Sfogliando le pagine dei rapporti annuali sulla PEV, risulta chiaro come ai
126
E. Barbé et al., "Which rules shape EU external governance? Patterns of rule selection in foreign and security policies", Journal of European Public Policy, 16:6, 834 — 852, 2009. 127
Vedi l´articolo pubblicato sul NY Times: http://www.nytimes.com/2005/11/29/business/worldbusiness/29ihthryvnia.html?_r=0 128
Vedi l´articolo su European Voice: http://www.europeanvoice.com/article/imported/eu-set-to-grant-ukraine-market-economy-status/51397.aspx
69
progressi in alcune aree si contrapponessero ostacoli strutturali in altre, che
compromettevano l'efficacia di qualsiasi processo di riforma: tra questi ultimi la
frequente imposizione di dazi alle esportazioni in settori sensibili, per mantenere il
controllo dei prezzi nel mercato domestico, e la mancanza di trasparenza e di
chiarezza nella legislazione sugli appalti pubblici. Queste politiche causavano
imprevedibilità nei mercati e scoraggiavano gli investitori europei potenzialmente
interessati ad operare in Ucraina. Il problema principale non era nell´adozione
dell´appropriata legislazione, quanto invece nella sua efficace implementazione,
un aspetto che nel mercato interno europeo gioca un ruolo chiave. I progressi nella
dimensione commerciale dipendevano quindi dal miglioramento delle condizioni
politiche ed istituzionali come la stabilità del governo, l´indipendenza della
magistratura e la lotta alla corruzione129.
I capitoli che registravano maggiori progressi sembravano essere quelli
legati al processo di adesione all'OMC. Si trattava, come detto, di una conditio
sine qua non per poter approfondire le relazioni economiche e commerciali con
l´Unione Europea, quindi il livello di priorità rimaneva alto sia a Bruxelles,
soprattutto per quanto riguarda l´assistenza tecnica, sia a Kiev. Secondo gli studi
di K. Wolczuk, questo fenomeno potrebbe in parte essere spiegato da una
coincidenza di interessi economici tra la maggioranza al governo e l´opposizione
negli ultimi mesi del 2006, che rese possibile l´approvazione delle misure
richieste da Ginevra130. Tra il 2006 ed il 2007 nell'apposito Working Group
dell´OMC vennero terminate con successo le negoziazioni bilaterali e multilaterali
dell´Ucraina sull'accesso al mercato, mentre la questione dei dazi alle esportazioni
verso l'UE venne risolta solo all'inizio del 2008.
L'adesione all'OMC fu approvata dal Direttore Generale nel febbraio 2008 e
ratificata dalla Verkhovna Rada nel maggio dello stesso anno. I rapporti con
129
M. Emerson et al., "The Prospect of Deep Free Trade between the European Union and Ukraine", Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles-Kiev 2006. 130
K. Wolczuk, "Adjectival Europeanisation?" cit. p. 20.
70
l'Unione Europea di conseguenza registravano un salto qualitativo: se già nel
marzo 2007 erano iniziate le negoziazioni verso un un Nuovo Accordo
Rafforzato131, con l'adesione di Kiev all'OMC si soddisfacevano le condizioni per
discutere di una futura Area di Libero Scambio con l'UE.
3.2 Un salto qualitativo: verso il DCFTA con l'Unione
3.2.1 L'Agenda di Associazione e il DCFTA
Ad un´evoluzione della volontà politica di integrazione seguiva la necessità
di trovare nuovi mezzi di implementazione. A partire dal 2007 Unione Europea ed
Ucraina iniziarono a discutere di un nuovo strumento, l´Accordo di
Associazione132, per sostituire il Piano d´Azione del 2005. Al suo interno, con
l´adesione dell´Ucraina all´OMC nel 2008 venne integrata anche la relativa parte
commerciale, il DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement)133. Si
tratta di una nuova generazione di accordi, inclusi come obiettivi nel progetto di
Partenariato Orientale nel 2009, per portare le relazioni con i Paesi del vicinato ad
Est ad un livello superiore. Nel caso ucraino, la mancanza di una realistica
prospettiva di adesione all´UE rende tuttora l´Accordo di Associazione il più
importante, seppur potenziale, veicolo di modernizzazione politica ed
economica134.
131
"New Enhanced Agreement", per il comunicato stampa vedi http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-275_en.pdf. 132
Al Summit UE-Ucraina di Parigi del 2008 si conferisce al nuovo strumento "rafforzato" la denominazione di "Accordo di Associazione". 133
Il rapporto del Working Group dell´OMC viene pubblicato il 5 febbraio 2008 e le negoziazioni iniziano il 18 febbraio: vedi Joint Evaluation Report, EU-Ukraine Action Plan, Bruxelles/Kiev 2008. 134
M. Święcicki, "Ukrainian Economy and Economic Reforms", in T. Kuzio, D. Hamilton (a cura di), "Open Ukraine: Changing Course Towards A European Future", The Johns Hopkins University, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Center for
71
Lo strumento scelto per preparare la firma e l´entrata in vigore del nuovo
accordo è l´Agenda di Associazione, adottata il 23 novembre 2009 dal Consiglio
di Cooperazione (CC) UE-Ucraina. L´Agenda viene sottoposta ad un costante
monitoraggio e annualmente si pubblica una rapporto congiunto per prendere atto
dei progressi ottenuti135.
Il DCFTA con l´Unione Europea mira ad approfondire l´accesso di Kiev nel
mercato europeo e a stimolare un maggiore livello di investimento europeo in
Ucraina. La gamma di aree coperte dall´accordo è molto più ampia rispetto ad un
semplice Accordo di Libero Scambio: non si propone solamente la rimozione dei
dazi doganali per aumentare i flussi di beni, ma anche l´eliminazione delle
barriere non tariffarie (NTBs) ed un ambizioso lavoro di armonizzazione della
legislazione commerciale, per rendere gli standard ucraini compatibili con quelli
europei. Questa dimensione "istituzionale" e regolamentare caratterizza il DCFTA
rispetto agli accordi commerciali stipulati in seno alla Comunità degli Stati
Indipendenti (CSI), molto meno rigidi ed esigenti136. Le misure contenute nel
DCFTA spaziano dall´esportazione libera da dazi per i prodotti industriali allo
smantellamento del sistema di quote e di sussidi applicato in Ucraina per
proteggere quelli agricoli; inoltre, si prevede una liberalizzazione ambiziosa nel
settore dei servizi, l´allineamento delle normative ucraine con gli standard europei
in tema di politica della concorrenza, aiuti di Stato, appalti pubblici, misure
sanitarie e fitosanitarie per la qualità dei prodotti, diritti di proprietà intellettuale
(IPRs), sviluppo sostenibile e altre aree chiave per dare un impulso alla
modernizzazione del Paese. L´Unione Europea si impegna attraverso il DCFTA a
Transatlantic Relations, Washington, D.C. 2012. 135
L´Agenda di Associazione del 2009 è disponibile sul sito del SEAE al seguente link: http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf . Il Consiglio di Cooperazione UE-Ucraina riunitosi a Lussemburgo il 24 giugno 2013 approva una versione aggiornata dell´Agenda, disponibile al link: http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/eu_ukr_ass_agenda_24jun2013.pdf 136
V. Movchan, R. Giucci, "Quantitative Assessment of Ukraine´s Regional Integration Options: DCFTA with European Union vs. Customs Union with Russia, Belarus and Kazakhstan", Berlin/Kyiv, 2011
72
fornire assistenza finanziaria e tecnica per l´implementazione efficace di queste
misure: grazie al nuovo accordo i cittadini ucraini incrementerebbero il loro
livello di benessere, avendo la possibilità di scegliere tra una maggiore varietà di
prodotti e potendo godere di standard sanitari e di sicurezza elevati anche per i
prodotti del mercato domestico; la modernizzazione permetterebbe di allocare le
risorse in modo efficiente e di approfittare delle opportunità di sviluppare le
relazioni economiche; verrebbe inoltre affrontato (anche se non necessariamente
risolto) l´annoso problema del clima ostile per gli investimenti. Dopo quattro anni,
Ucraina e UE hanno terminato nel 2012 le negoziazioni dell´Accordo di
Associazione (compreso il DCFTA), anche se per la sua firma l´UE ha posto
chiaramente come condizione il raggiungimento di risultati soddisfacenti sia nella
riforma del sistema politico sia di quello economico, in vista del Summit del
Partenariato Orientale organizzato a Vilnius nel novembre 2013137. In particolare,
il Commissario per l´Allargamento e la Politica di Vicinato Stefan Füle ha
menzionato in un discorso del febbraio 2012 la riforma della magistratura,
l´indizione di elezioni libere e democratiche, la riforma costituzionale, una legge
sul servizio civile, l´allocazione del budget dell´UE e la revisione dei prezzi del
gas138.
3.2.2 Il DCFTA dal punto di vista dell´oligarchia in Ucraina
Sebbene le sorti dell´Accordo di Associazione e del DCFTA si giochino
soprattutto su condizioni di tipo politico, non va sottovalutato il suo significato
economico. Le disposizioni dell´accordo, una volta entrato in vigore,
cambierebbero il modo di operare degli attori economici in Ucraina: data
137
Maggiore dettaglio nelle Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 10 dicembre 2012, al link: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/134136.pdf 138
S. Füle, "Ukraine: relations with the EU at the cross-road", discorso tenuto presso lo European Policy Centre, Bruxelles, 27 febbraio 2012.
73
l´influenza degli oligarchi nella sfera politica, viene spontaneo chiedersi se e in
quale misura il DCFTA sia incoraggiato o ostacolato dai protagonisti del big
business nazionale.
Come primo aspetto, risulta importante sottolineare che tendenzialmente gli
oligarchi non si esprimono pubblicamente in materia politica, a meno che questo
non sia utile a proteggere i loro interessi; il metodo verso cui propendono consiste
in contatti informali con il governo139. Anche per questo, conservare lo status quo
permette loro di esercitare al meglio la loro influenza senza un quadro legale
ristretto che limiti la loro azione: l´eventuale firma di un DCFTA con l`Unione
Europea da questo punto di vista sarebbe uno svantaggio per l´oligarchia ucraina.
Un altro aspetto da prendere in considerazione è il generale supporto che il
processo di integrazione europea gode soprattutto nel corso degli ultimi anni in
seno all´élite economica del Paese, tanto che alcuni studiosi notano come in tempi
recenti finanziare eventi e progetti pro-europei diventi una sorta di promozione
della propria immagine140.
Date queste premesse, K. Zarembo sostiene che il sostegno al DCFTA con
l´Unione derivi in prima istanza dal recente indebolimento della posizione degli
oligarchi nel sistema politico ucraino. Nonostante la politica del Presidente
Yanukovych sia stata apparentemente atta a consolidare la sua posizione a scapito
degli stessi oligarchi, la ratifica del DCFTA potrebbe portare proprio quelle
garanzie istituzionali necessarie alla conservazione del potere da parte delle élites.
Sarebbe un errore tuttavia sostenere che l´oligarchia in Ucraina sia
composta da un gruppo omogeneo: anche al suo interno infatti si assiste ad una
divergenza di interessi a seconda del tipo di attività economica intrapresa. Non
tutti beneficiano allo stesso modo dei vantaggi offerti dal DCFTA: tra i "vincitori"
sicuramente sono da menzionare i produttori di beni alimentari, che nel breve
139
S. Matuszak, “How Ukrainian Oligarchs View Economic Integration with the EU and Russia”, EASWEEK, 14 settembre 2011. 140
K. Zarembo, "EU-Ukraine FTA: what do oligarchs think?", Kiev, Institute of World Policy (IWP), Policy Brief n. 1/2012.
74
termine usufruirebbero dell´eliminazione dei dazi doganali alle esportazioni verso
il mercato europeo e dell´allineamento degli standard sanitari e fitosanitari a quelli
dell´Unione. Al contrario, su basi puramente economiche gli esportatori di materie
prime non manifestano un grande interesse nei confronti di tale accordo, in quanto
nel loro settore la liberalizzazione è stata raggiunta con l´adesione dell´Ucraina
all´OMC nel 2008. Alcuni oligarchi invece sarebbero danneggiati dal DCFTA per
diversi motivi: tra questi ultimi, coloro che basano il loro benessere sul modello
politico esistente sono riluttanti ad accettare un allineamento agli standard
europei, specialmente in tema di assegnazione degli appalti pubblici141.
Per comprendere le dinamiche della crisi attualmente in corso nel Paese, è
fondamentale tenere in conto un importante fattore: il DCFTA porta dei vantaggi,
soprattutto nel lungo termine, ma l´oligarchia ucraina potrebbe benissimo
sopravvivere senza di esso142.
Per quanto riguarda le relazioni con la Federazione Russa, si considera che
la maggior parte dell´oligarchia ucraina guardi all´Accordo si Associazione con
l´UE soprattutto come ad un mezzo per bloccare i progetti di integrazione russi e
consolidare il proprio potere politico nei confronti di Mosca143. Se da un lato è
vero che alcuni potenti uomini d´affari ucraini traggono la loro ricchezza dalle
relazioni con la Russia, soprattutto nel settore della fornitura energetica e delle
materie prime, i dati confermano che i flussi commerciali sono rivolti soprattutto
verso l´Europa144. La sfida indiretta tra UE e Russia dopo l´offerta di un DCFTA
ai Paesi del Partenariato Orientale sarà oggetto di analisi nelle prossime pagine.
141
P. Kościński, I. Vorobiov, "Do Oligarchs in Ukraine Gain or Lose with an EU Association Agreement?", The Polish Institute of International Affairs (PISM), Bulletin n. 86 (539), 19 Agosto 2013. 142
Ibidem, p. 12. 143
S. Matuszak, cit. 144
Vedi pag. 58.
75
3.3 Il progetto di Unione Economica Euroasiatica (UEE): un ostacolo al
potere normativo dell´UE in Ucraina?
3.3.1 Dall´Unione Doganale (UD) al progetto di UEE
In seguito alla dissoluzione dell´URSS, sono stati intrapresi diversi tentativi
di integrazione economica in seno alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).
Queste iniziative non rappresentano un ritorno alle strutture pre-1989, quanto
invece un modo per mantenere un coordinamento tra le ex Repubbliche
Sovietiche: principalmente si tratta di accordi bilaterali, non vincolanti e con
frequenti eccezioni, mentre la dimensione multilaterale rimane limitata ad alcuni
settori specifici come l´unificazione delle procedure doganali e le indicazioni
d´origine dei prodotti. Risulta importante sottolineare come la CSI non rappresenti
un´entità economica fortemente integrata ma permetta invece ai Paesi Membri di
scegliere il tipo ed il livello di impegno a cui sottoporsi145.
Date queste premesse, la strategia adottata da Mosca per mantenere un certo
grado di influenza nella regione è quella della "multi-speed integration"146 in cui
uno zoccolo duro di Paesi approfondiscono le loro relazioni, cercando poi di
attrarre altri partecipanti: un esempio di questo tipo di integrazione è
rappresentato dall´Unione Doganale tra Federazione Russa, Bielorussia e
Kazakistan lanciata il 1 gennaio 2010. L´UD è un salto qualitativo
nell´integrazione rispetto ad una semplice Area di Libero Scambio (ALS), in
quanto implica anche la fissazione di una tariffa esterna comune (TEC), una
politica commerciale comune e uno sforzo di armonizzazione degli standard
qualitativi per i prodotti, come quelli sanitari e fitosanitari. La UD non rappresenta
145
Vedi Eastern European Studies Centre (EESC), "Why the Ukraine cannot become a EU Member?", analytical survey 1 (1), 2009. 146
EESC, "Eurasian Union: a challenge for the European Union and Eastern Partnership Countries", Vilnius, 2012, cit p. 5.
76
tuttavia l´obiettivo finale del progetto guidato dal Presidente russo Vladimir Putin:
infatti nel 1 gennaio 2012 è stato istituito lo Spazio Economico Comune (SEC) tra
i tre Paesi membri dell´UD con lo scopo di raggiungere lo stadio di una vera e
propria Unione Economica Euroasiatica (UEE) nel 2015. Il progetto appare fin
troppo ambizioso, in quanto si prefigge di raggiungere in appena cinque anni un
obiettivo che l´Unione Europea non ha ancora perfezionato dopo vari decenni.
Il progetto di UEE si è evoluto portando alla nascita di nuove istituzioni di
carattere sovranazionale come la Commissione Economica Euroasiatica (CEE),
che ha sostituito dal 2012 la Commissione per l´Unione Doganale. L´ampiezza
dello spettro di politiche affidate alla CEE dice molto sull'ambizione del progetto:
oltre alle competenze riguardanti la gestione dell´UD, uno Spazio Economico
Comune richiede azioni congiunte in politica macroeconomica, concorrenza,
commercio internazionale, politica industriale ed energetica, appalti pubblici,
trasporti, diritti di proprietà intellettuale, regolamentazione dei mercati finanziari
(banche, assicurazioni, borse valori)147.
La CEE si compone di un Consiglio, responsabile del controllo e della
gestione delle attività della Commissione, nonché di un Board, il braccio
esecutivo che prepara proposte per avanzare nel progetto di integrazione. I
membri di questi due gruppi sono nominati direttamente dagli Stati parte e le
decisioni sono prese per consenso, fatta eccezione per il Board che in alcuni casi
richiede la maggioranza dei due terzi. Il quadro istituzionale si completa con la
presenza di una Corte che regola i contenziosi interni all´UEE
sull´implementazione degli atti legislativi. Il suo reale grado di indipendenza resta
comunque da verificare, visto il tasso di corruzione e il coinvolgimento del potere
politico nell´amministrazione della giustizia interna ai Paesi parte.
L´istituzione più importante, che stabilisce la strategia e gli obiettivi
dell´UEE, è il Consiglio Supremo Economico Euroasiatico (CSEE) che si riunisce
147
Eurasian Economic Commission, "Eurasian Economic Integration: facts and figures", 2013.
77
al massimo livello della rappresentanza politica. Questi elementi indicano che non
si tratta di mera integrazione economica in senso "funzionalistico", quanto invece
di un mezzo per realizzare obiettivi politici e strategici più ampi.
3.3.2 Oltre l´economia: l´UEE come progetto geopolitico parallelo all´UE
Il modello istituzionale dell´UEE e il processo di presa delle decisioni
risultano dominati dall´intergovernativismo e soprattutto da una forte asimmetria
di potere tra i tre membri, in favore della Federazione Russa. Infatti, pur con la
volontà di introdurre il voto a maggioranza qualificata nel Board, Mosca detiene il
57% lasciando agli altri due membri il 21,5% ciascuno: questo dimostra
l'impossibilità di prendere una qualsiasi decisione a livello sovranazionale senza il
consenso del Presidente Putin148.
Le motivazioni geo-strategiche per la nascita del progetto di Unione
Doganale nel 2010 sono forse ancora più importanti di quelle prettamente
economiche: infatti, con il lancio del Partenariato Orientale nel 2009 da parte
dell´Unione Europea e la premessa per un´intensificazione dei rapporti politici,
economici e culturali con i sei Paesi destinatari in Europa dell´Est, l´influenza di
Mosca nella regione rischia di affievolirsi. Il reticolo di accordi bilaterali
costituito in seno alla CSI, molto flessibile e non vincolante, non risulta più
sufficiente per tenere questi Paesi sotto la "sfera di influenza" russa in presenza di
un´alternativa di integrazione così allettante come quella offerta dall´UE149. Si
profila quindi una competizione tra due diversi spazi di integrazione, e l´Europa
dell´Est si trova a fungere da campo di battaglia.
Da un lato, lo scenario della "Wider Europe" e della Politica Europea di
148
EESC, "Eurasian Union: a challenge for the European Union and Eastern Partnership Countries", cit p. 10. 149
R. Dragneva, K. Wolczuk, "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?", Chatham House, briefing paper, agosto 2012, REP BP 2012/01.
78
Vicinato: per i Paesi del PO significherebbe un impegno a rispettare i principi ed i
valori dell´UE nonché a conformarsi a degli standard relativamente alti per quanto
riguarda la qualità dei prodotti commerciati, i diritti dei consumatori e dei
lavoratori, la protezione dell´ambiente; in cambio vengono garantiti l´accesso al
mercato più grande del mondo (500 milioni di persone), la libera circolazione
all´interno del territorio dell´UE grazie alla progressiva liberalizzazione dei visti
ed il supporto finanziario e tecnico di Bruxelles. In breve, a dei costi di
aggiustamento relativamente alti corrisponderebbero dei vantaggi considerevoli
nel medio-lungo periodo150. Dall´altro lato, aderire all´Unione Doganale (dal 2015
"Unione Economica") Euroasiatica risponderebbe ad un ragionamento economico
di breve termine, costituito soprattutto dall´abbassamento dei prezzi dell´energia
fornita da Mosca. Inoltre, i costi di aggiustamento sarebbero più bassi dato il
grado di convergenza negli standard già presente grazie agli accordi siglati
all´interno della CSI.
Un altro aspetto da sottolineare è l´incompatibilità, almeno nel breve
termine, tra questi due sistemi: questo implica che per i Paesi dell´Europa dell´Est
la scelta di aderire all´Unione Economica Euroasiatica chiuderebbe le porte alla
possibilità di approfondire le relazioni bilaterali con l´Unione Europea tramite
l'Accordo di Associazione (nonché il DCFTA151) e viceversa. Una scelta che negli
ultimi anni (ma soprattutto negli ultimi mesi) sta diventando sempre più
importante per le sorti di un Paese in particolare: l´Ucraina.
150
M. Vahl, "A privileged partnership: 'EU-Russian relations in a comparative perspective", DIIS Working Paper, 3, 2006, 9-11. 151
Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, la parte commerciale degli Accordi di Associazione. Gli AA sono la generazione di accordi che con il lancio del Partenariato Orientale nel 2009 intende sostituire i PCA firmati negli anni Novanta.
79
3.3.3 L´Ucraina contesa: quali prospettive?
Mentre l´Accordo di Associazione con l´Unione Europea non precluderebbe
a priori lo sviluppo di relazioni approfondite con altre aree di libero scambio,
l´adesione all´Unione Doganale Euroasiatica impedirebbe di elaborare una propria
politica commerciale indipendente vis-à-vis Bruxelles.
Prendendo in considerazione il caso ucraino, questo significa che Mosca
acquisirebbe il potere di controllo sulle scelte commerciali di Kiev, la cui politica
"multivettoriale" troverebbe in tal caso il suo punto d´arrivo. Effettuare una scelta
univoca tuttavia non sembra, basandosi sulla situazione attuale, un´opzione facile:
infatti l´UE e la CSI sono i due partner principali per il Paese, contando per circa i
due terzi del totale del suo commercio. Le dinamiche del recente passato mostrano
come prima del 2008 il ruolo dell´UE risultasse in netta crescita a scapito
dell´area oggi detta Unione Doganale Euroasiatica; in seguito, con la recente crisi
economica e finanziaria, i cambiamenti nella struttura della domanda interna
ucraina e i lievitati prezzi dell´energia hanno reso il mercato a Est più appetibile
per Kiev sia in termini di export che di import152. Vi è infatti una chiara differenza
tra lo spazio economico dell´UE e quello Euroasiatico: mentre l´integrazione nel
primo richiede costi alti nel breve termine, per modernizzare le strutture interne, il
secondo risponde in maniera più diretta ai bisogni immediati e non richiede
complesse riforme.
Con uno sguardo attento al rapporto costi/benefici, l´Unione Europea
tramite l´Accordo di Associazione (e il DCFTA) offre una prospettiva di crescita
allettante, stimata intorno al 6.2% del PIL, nonché un relativo miglioramento del
clima per gli investimenti diretti esteri (IDE), senza tuttavia risolvere
completamente i problemi strutturali ucraini in quest'ambito. In cambio di questi
vantaggi, che si sentirebbero comunque nel medio e lungo termine, sono previsti
costi relativamente alti di aggiustamento. Inoltre, come in tutti gli accordi di libero
152
V. Movchan, R. Giucci, cit p. 2.
80
scambio, non tutti i settori ne beneficerebbero allo stesso modo: l´agricoltura,
l´efficienza energetica, il tessile e la metallurgia sono considerati tra i più
promettenti in termini di investimenti potenziali, mentre qualche problema si
potrebbe riscontrare nel campo della costruzione di macchinari industriali153. Da
notare inoltre che l´accesso al mercato europeo causerebbe un aumento della
concorrenza per le imprese ucraine, che non necessariamente si trovano in
condizione di poterla sostenere: per questo sono previsti nel DCFTA dei periodi di
transizione per la liberalizzazione delle barriere tariffarie, specialmente per quanto
riguarda le produzioni più delicate154.
Aderire al progetto di Unione Economica Euroasiatica (previsto in
operatività dal 2015) significherebbe invece per l´Ucraina perdere la sua
indipendenza nell´elaborazione della politica commerciale: sarebbe la
Commissione Economica Euroasiatica a condurre le negoziazioni con i Paesi terzi
e, come visto dalla breve analisi sul suo funzionamento, questo implica concedere
un considerevole livello di controllo a Mosca sulle scelte di Kiev. Da escludere
quindi la possibilità di continuare bilateralmente i negoziati con l´UE sul DCFTA.
Inoltre la tariffa esterna ucraina dovrebbe essere allineata a quella dell´UD
(ovvero a quella russa), sensibilmente più alta della tariffa media attualmente in
vigore: si calcola infatti un passaggio dal 2,7% al 9,5%155. Da sottolineare anche
la chiusura ai potenziali investimenti europei in Ucraina conseguente ad un
eventuale ingresso nell´UD.
Un altro fattore da tenere in considerazione è l´incompatibilità della
partecipazione ucraina all´UEE con gli impegni presi in sede OMC. Bielorussia e
Kazakistan non sono ancora membri dell´organizzazione di Ginevra, mentre la
153
Dr. R. Giucci (Berlin Economics/German Advisory Group Ukraine), "EU-Ukraine. Deep and Comprehensive Free-trade Area. New Opportunities for Europe", conferenza internazionale all´Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma, 19 novembre 2013. 154
EESC, "Eurasian Union: a challenge for the European Union and Eastern Partnership Countries", cit p. 32. 155
Dr. R. Giucci, cit.
81
Federazione Russia vi ha aderito nel 2012 dopo dei ritardi provocati proprio dal
lancio del progetto di Unione Doganale156. Kiev sarebbe da un lato obbligata a
rivedere gli accordi negoziati bilateralmente con i Paesi membri dell´OMC, per
allinearli con gli standard previsti dall´Unione Doganale. I costi previsti per
questo aggiustamento si aggirerebbero intorno ai due miliardi di dollari157:
l´opzione sarebbe quindi da valutare solamente dopo l´adesione di Kazakistan e
Bielorussia all´OMC.
Tra i vantaggi che l´UD porterebbe all´Ucraina, è da citare soprattutto il
potenziale abbassamento dei costi dell´energia e del petrolio fornito dalla
Federazione Russa. Nel 2010, il 67% delle importazioni ucraine dalla Russia
riguardava infatti l´energia e il risparmio in questo senso sarebbe stimato intorno
ai 3,5 miliardi di dollari158. Da alcune ricerche emerge inoltre che grazie alla
crescita delle esportazioni verso i Paesi della futura UEE il PIL ucraino potrebbe
crescere intorno al 6-7% in più in prospettiva 2030 rispetto allo scenario basato
sullo status quo attuale159. Tuttavia, questi benefici non deriverebbero
automaticamente dalla partecipazione all´integrazione euroasiatica, quanto invece
dai potenziali incentivi economici concessi da Mosca. Proprio questo stato di
incertezza contribuisce ad aumentare scetticismo e riluttanza tra i leader ucraini.
La Federazione Russa, sin dall´istituzione dell´Unione Doganale
Euroasiatica nel 2010, ha guardato all´Ucraina come ad un tassello fondamentale
per permettere a questa nuova entità di dialogare alla pari con altre realtà regionali
come l´UE. L´elezione del Presidente Yanukovych nel 2010 veniva interpretata
come un segnale positivo a Mosca per imprimere una svolta in questo senso, tanto
che si considerava che il Cremlino fosse pronto a coprire i costi derivanti dalla
156
La lista aggiornata dei membri dell´OMC è disponibile al sito: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 157
V. Movchan, R. Giucci, cit.p. 9. 158
M. Bugriy, "Strategic Flexibility a key issue for Ukraine in trade relations with Russia and the EU", in Foreign Policy Journal, 2011. 159
Eurasian Development Bank´s Saint Petersburg Centre for Integration Studies, "Ukraine and the Customs Union", Report 1, 2012, 29.
82
compensazione dei membri dell´OMC dopo l´allineamento tariffario ucraino con
l´UD euroasiatica160. Tuttavia l´Ucraina si è dimostrata riluttante a cedere
porzioni della propria sovranità rischiando di (ri)cadere sotto l´egemonia russa: a
testimonianza di questa tendenza, la partecipazione selettiva agli accordi siglati in
seno alla CSI ed il rifiuto da parte di Yanukovych di aderire all´Unione
Doganale161 per proseguire invece nei negoziati verso un Accordo di
Associazione con l´UE.
Le pressioni russe sull´Ucraina prima del Summit di Vilnius del novembre
2013, che riuniva i membri del Partenariato Orientale, hanno avuto un parziale
successo in quanto il Presidente Yanukovych ha posticipato unilateralmente la
firma dell´Accordo di Associazione con l´Unione Europea. Una scelta che ha
provocato scalpore nei corridoi di Bruxelles, e che ha scatenato un´ondata di
proteste in piazza a Kiev in favore di una maggiore integrazione con l´UE (Euro-
Maidan); una scelta tuttavia motivata da un ragionamento economico di breve
termine, rivelatasi qualche mese dopo essere solo un passo falso e non una battuta
d´arresto.
Il seguente paragrafo si concentra su un´altra questione molto delicata
riguardante l´Ucraina e storicamente fonte di tensioni con Mosca: il tema della
politica energetica.
160
O. Shumylo-Tapiola, "The Eurasian Customs Union: Friend or Foe of the EU?", the Carnegie Papers, Carnegie Europe, ottobre 2012. 161
Prof. G. M. Perepelytsia (a cura di), "Foreign Policy of Ukraine, 2009/2010. Strategic Assessments, Forecasts and Priorities", cit.
83
3.4 Un settore delicato: la questione energetica
3.4.1 L'Ucraina: un ponte per il trasporto energetico tra Russia ed Europa
L'importanza strategica dell'Ucraina deriva in gran parte dalla sua posizione
geografica, che la rende un ponte per il trasporto di energia elettrica e gas naturale
dalla Federazione Russa all'Europa. Nel 1992 il transito attraverso l'Ucraina
costituiva l'unica rotta possibile per le esportazioni in Europa: per tentare di
allentare la dipendenza dai decisori politici di Kiev, la compagnia di bandiera
russa Gazprom ed alcuni operatori europei finanziarono la costruzione di
infrastrutture alternative, tra le quali oggi sono attive Yamal-Europa (che collega
Russia e Polonia, passando per la Bielorussia), North-Stream (che raggiunge la
Germania attraverso il Mar Baltico) e Blue-Stream (che rifornisce la Turchia). La
portata di questi nuovi gasdotti tuttavia risulta relativamente modesta e non in
grado di sostituire le vie di fornitura tradizionali ucraine. Il tassello mancante nel
progetto di Gazprom è South-Stream, un progetto ancora in fase di realizzazione
la cui conclusione è prevista per il 2015 e che collegherebbe la Russia alla
Bulgaria attraverso il Mar Nero162.
Nel 2004, anno in cui viene lanciata la Politica Europea di Vicinato, il gas
naturale fornito da Gazprom rappresentava il 40% delle importazioni dei Paesi
dell'UE ed il 28% della loro domanda totale per quel prodotto. L'Ucraina gioca un
ruolo centrale in quanto l'80% di questi flussi di gas naturale transitano sul suo
territorio163. I problemi strutturali del Paese lo rendono tuttavia estremamente
inefficiente dal punto di vista energetico: pur disponendo di giacimenti di petrolio,
gas naturale e carbone, l'Ucraina riesce a soddisfare appena il 47-49% della sua
162
M. Verda, "La crisi ucraina ed il transito di gas russo verso l'Europa", Istituto Italiano di Studi Strategici "N. Machiavelli", Machiavelli Edizioni, marzo 2014. 163
J. Stern, "The Russian-Ukrainian gas crisis of January 2006", Oxford Institute for Energy Studies, Oxford University Press 2006.
84
domanda interna. La Federazione Russa rimane il suo maggiore fornitore,
coprendo il 75-80% delle importazioni di petrolio e il 85-90% di quelle di gas
naturale164. Questa situazione si deve in parte ad un livello altissimo di consumo
energetico nazionale (3,9 volte la media UE per unità di PIL e 2,6 volte la media
mondiale nel 2010) ma soprattutto alle riforme non effettuate nel corso degli anni.
Le principali imprese di distribuzione sono ancora sotto il controllo dello Stato,
che inoltre mantiene artificialmente bassi i prezzi del gas tramite un sistema di
sussidi oggi insostenibile165. Senza una profonda modernizzazione e
liberalizzazione del settore energetico, l'Ucraina non sarà in grado di aumentare la
produzione e di soddisfare la propria domanda interna166.
Nell'ambito della Politica Europea di Vicinato si è distinto tuttavia il
tentativo da parte dell'UE di costruire un dialogo specifico riguardante il settore
dell'energia con l'Ucraina, con la doppia finalità di sostenere le necessarie riforme
interne al Paese integrando le sue strutture nel sistema europeo e di assicurare il
continuo flusso di forniture dalla Russia verso l'UE. Pur non potendo analizzarne i
dettagli, il prossimo paragrafo cerca di delinearne gli aspetti principali.
3.4.2 Il dialogo energetico UE-Ucraina nell'ambito della PEV
Il primo rapporto sull'Ucraina nel quadro della PEV, stilato dalla
Commissione Europea nel 2004, considerava il settore dell'energia come una
priorità per l'Unione nella sua cooperazione con Kiev167.
164
Teyana Kistnyuk, “Energy Efficient Ukraine: Is There a Light at the End of the Tunnel?” Ukrainian Energy, August 31, 2011 165
International Energy Agency, "Ukraine 2012", Energy Policy Beyond IEA Countries, Report 2012 166
F. Umbach, "Ukraine’s Energy Security Challenges: Implications for the EU", in T. Kuzio/D. Hamilton (a cura di), "Open Ukraine. Changing Course towards a European Future", Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, John Hopkins University, Washington D.C. 2011, pp. 93-116). 167
Commission Staff Working Paper, "European Neighbourhood Policy - Country Report Ukraine", COM(2004)373 final, Brussels, 12.5.2004 SEC(2004), cit.
85
In origine, uno degli obiettivi della collaborazione tra UE ed Ucraina era
creare le condizioni per l'ingresso di quest'ultima nel Trattato che istituisce la
Comunità dell'Energia168, comprendente i membri dell'UE a cui si aggiungono
Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Albania, Kosovo169 e
Moldova. L'Ucraina ha ottenuto dapprima lo status di osservatore, concludendo
infine le negoziazioni tecniche nel dicembre 2009; l'ingresso ufficiale è avvenuto
in data 1 febbraio 2011. Questo trattato è parte integrante della politica per la
sicurezza energetica europea, che ricevette un nuovo slancio proprio dalla crisi tra
Ucraina e Russia del 2006: l'UE intende porre le basi per l'estensione del suo
mercato interno dell'energia (elettrica e gas) alle altre Parti Contraenti, attraverso
impegni giuridicamente vincolanti. La presenza di un quadro normativo stabile e
orientato al mercato rappresenta la chiave per garantire la sicurezza energetica dei
Paesi UE, e data l'importanza dell'Ucraina come Paese di transito del gas naturale
proveniente dalla Russia il suo ingresso nel Trattato ha segnato un punto di svolta
verso la creazione di un mercato integrato dell'energia in Europa.
3.4.3 L'impatto delle relazioni Russia-Ucraina sulla sicurezza energetica europea
Pur con molte difficoltà di implementazione, si riconosce nei governi che si
sono succeduti a Kiev una continuità nelle intenzioni politiche: integrare le
proprie strutture al mercato europeo. Tale posizione tradizionalmente non è stata
accolta con favore dalla Russia, che ha piú volte utilizzato la sua posizione
dominante nel settore energetico come un'arma negoziale per esercitare pressione
politica sull'Ucraina170. Questo si è reso particolarmente evidente in alcune
168
Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006. L'obiettivo è annunciato già nel MoU, e viene ribadito nel primo Progress Report del 2006: http://eeas.europa.eu/ukraine/pdf/joint_progress_report1_en.pdf), ukraine/2010_ukraine_enct_protocol.pdf). 169
Secondo la risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. 170
Nota: M. R. Freire, "Ukraine's multi-vectoral foreign policy: looking west while not overlooking its eastern neighbour", cit.
86
specifiche occasioni, le cosiddette "Guerre del Gas"171 tra Ucraina e Russia del
2006 e del 2009: un fenomeno di cui l'Europa ha subito in modo diretto le
conseguenze, facendo emergere la necessità di ripensare la propria politica
energetica. Attraverso accordi bilaterali con Mosca o multilaterali in seno alla
CSI, l'Ucraina stabilì negli anni Novanta condizioni e tariffe preferenziali per la
fornitura ed il trasporto del gas naturale, tuttavia la compagnia nazionale Naftogaz
ha accumulato negli anni un enorme debito nei confronti della russa Gazprom.
Interessata da tempo ad acquisire le reti di distribuzione dell'energia ucraine, la
Russia ha stipulato con l'Ucraina accordi specifici e fornisce prestiti per sostenere
Naftogaz: tuttavia, in coincidenza con alcune scelte politiche dei governi di Kiev
volte ad approfondire l'integrazione nel mercato europeo, la questione del debito è
stata fatta riemergere e Gazprom ha ridotto gli approvvigionamenti di gas per
brevi periodi di tempo per spingere l'Ucraina alla disciplina dei pagamenti172.
Secondo fonti ucraine si tratta di un comportamento politicamente motivato ed
opportunista, volto a gettare discredito sull'affidabilità di Naftogaz agli occhi
dell'opinione pubblica internazionale173. Altri studiosi invece affermano che il
vero problema è rappresentato proprio dal transito dell'energia sul territorio
ucraino, a causa della condizione di "cattivo pagatore" di Naftogaz e
dell'instabilità politica che caratterizza il Paese. L'Europa rappresenta per Mosca il
principale partner commerciale nel settore ed è quindi comprensibile che sia nel
suo interesse mantenere la solida relazione costruita nel corso degli anni174.
Attualmente la situazione di dipendenza dall'Ucraina per quanto riguarda il
transito energetico sembra essere meno pronunciata per l'Unione Europea, che con
la conclusione dei lavori sul North-Stream nel 2012 ha ridotto la percentuale di
171
Atlante Geopolitico, Enciclopedia Treccani 2012 172
Stern, "The Russian-Ukrainian gas crisis of January 2006", cit. 173
H. Perepelytsia, "Geopolitical aspect of Russia's energy policy in relations with Ukraine and the EU", in "EU-Ukraine relations: in the focus of energy security", Foreign Policy Research Institute, International Review n. 1(9), marzo 2009). 174
M. Verda, "Crisi ucraina: per il gas dell'Europa il problema non è la Russia", ISPI, 7 aprile 2014.
87
gas russo importato via Ucraina al 50%175. Il mercato comune dell'energia in
Europa è comunque ancora lontano dalla realizzazione. La competenza normativa
in politica energetica, sebbene il Trattato di Lisbona abbia stabilito per la prima
volta una base giuridica per legittimare il ruolo dell'UE (art. 194 TFUE), è ancora
condivisa tra Bruxelles e gli Stati Membri: di conseguenza ogni Paese dispone di
una propria lista di fornitori e risulta diversamente vulnerabile agli shock politici
ed economici in Europa dell'Est. Infatti, in caso di una nuova "guerra del gas"
durante l'attuale crisi ucraina, a risentirne maggiormente non sarebbero i grandi
consumatori (come Italia, Germania o Francia) che possono contare su dei
fornitori alternativi, quanto invece i Paesi che contano quasi esclusivamente sul
trasporto di energia attraverso l'Ucraina (Slovacchia, Ungheria e Bulgaria).
Continuare ad approfondire il dialogo energetico con Kiev (e con Mosca)
costituisce quindi un bisogno primario per la sicurezza degli approvvigionamenti
nell'UE. Concludendo con una frase diretta quanto eloquente: "in pratica, i
governi europei dovranno pagare le bollette del gas ucraine per continuare a
ricevere il gas russo"176.
In questo capitolo si è cercato di illustrare il quadro delle relazioni
commerciali tra UE e Ucraina nel contesto della Politica Europea di Vicinato.
Presentate le tappe fondamentali del percorso di integrazione offerto dall'Unione
Europea. è stata introdotta in seguito la situazione di conflitto verificatasi con il
progetto di Unione Economica Euroasiatica, evidenziando i potenziali costi e
benefici che una scelta da parte dell'Ucraina implicherebbero. Un'attenzione
particolare è stata concessa al settore energetico, forse l'esempio più chiaro di
quanto l'influenza russa giochi un ruolo fondamentale nell'arena domestica
ucraina. Nel prossimo capitolo il focus si sposta sulla dimensione politica della
175
Simon Pirani et al., "What the Ukrainian crisis means for gas markets", Oxford Institute for Energy Studies, 2014. 176
M. Verda, "La crisi ucraina: per il gas dell'Europa il problema non è la Russia", cit. p. 2.
88
PEV, più nello specifico sul meccanismo di condizionalità esercitato dall´UE per
promuovere riforme democratiche in Ucraina. Vengono illustrati i principali
ostacoli all´efficace implementazione della PEV in questo Paese, riprendendo i
concetti introdotti nella Parte Prima.
89
CAPITOLO 4
POLITICA E CONDIZIONALITÁ IN UCRAINA
NEL QUADRO DELLA PEV
La prospettiva di entrare nell'Unione Europea è spesso considerata come il
più efficace strumento di democratizzazione a disposizione di Bruxelles. Si può
affermare che, ad oggi, tutti i Paesi ex comunisti che hanno aderito alll'UE sono
diventati delle democrazie consolidate, pur con qualche distinzione caso per caso;
non si può invece dire lo stesso per i Paesi del Partenariato Orientale, in cui si
assiste ancora (sempre con le dovute distinzioni) a tendenze autoritarie.
Tramite la Politica Europea di Vicinato l'UE intende promuovere i valori di
democrazia, rispetto dei diritti umani e stato di diritto oltre i suoi confini fornendo
in cambio degli incentivi principalmente di tipo economico-commerciale, come i
programmi di assistenza finanziaria (TACIS, ENPI) e una graduale apertura del
Mercato Unico, nonché la liberalizzazione dei visti e uno stimolo alla
cooperazione regionale. Tuttavia, se per i Paesi dell'allargamento del 2004 i
risultati sono stati soddisfacenti, molto si deve alla prospettiva di membership che
offerta loro dopo gli sforzi compiuti per attuare le necessarie riforme. Finora non è
stato questo invece il caso dell'Ucraina, nonostante le sue aspirazioni europee
siano state affermate pubblicamente sin dai primi anni dell'indipendenza.
Questo capitolo prende in considerazione alcuni aspetti-chiave nelle
relazioni tra l'Unione Europea e l'Ucraina nell'ultimo decennio, evidenziando gli
elementi che ostacolano l'efficacia della condizionalità politica europea. Citando
Kubicek, e seguendo le argomentazioni della Parte Prima, in questo Paese si è
assistito ad un "substantial disconnect between the rhetoric of Ukraine’s
90
'European choice' and the authoritarian trends in the country"177.
Non potendo ricoprire la complessità dell'argomento in questa tesi,
particolare attenzione viene dedicata al caso della detenzione dell'ex Primo
Ministro Yulia Tymoshenko, protagonista della Rivoluzione Arancione del 2004,
nonché alla situazione di perenne instabilità e conflittualità nella Repubblica
Autonoma di Crimea. Entrambi questi aspetti sono "crepe democratiche" venute
alla luce con lo scoppio dell'attuale crisi ucraina.
4.1 Una democrazia instabile: élites, elezioni ed il caso Tymoshenko
4.1.1 La Rivoluzione Arancione: aspettative deluse
Come visto nella Parte Prima, il decennio di presidenza di Leonid Kuchma
fu caratterizzato da una chiara retorica in favore dell´integrazione europea178.
Tuttavia, a questo non seguirono coerentemente le azioni politiche che avrebbero
portato l´Ucraina allo stesso livello dei candidati all´adesione nel 2004. Il sistema
istituzionale presentava infatti importanti contraddizioni: un alto tasso di
corruzione, una spropositata influenza dell´oligarchia e tendenze autoritarie da
parte del Presidente, i cui poteri erano sbilanciati rispetto a quelli delle altre
istituzioni179.
In occasione delle elezioni presidenziali del 2004, la vittoria di soli tre punti
percentuali di Viktor Yanukovych (Partito delle Regioni), filosovietico e delfino
dello stesso Kuchma, venne denunciata dal leader dell´opposizione Yushenko
(della coalizione Nostra Ucraina) a causa di presunti brogli. In reazione allo stato
177
P. Kubicek, "The European Union and democratization in Ukraine", Journal of Communist and Post-Communist Studies, 38 (2), 269-292, 2005. 178
Vedi pag. 17 e ss. 179
Vedi pag. 12 e ss.
91
della democrazia nel Paese, si assistette ad una vasta mobilitazione della
popolazione, che pacificamente invase le piazze di Kiev vestita di arancione (il
colore simbolo dell´opposizione) per chiedere la ripetizione delle elezioni180. La
reazione a livello internazionale, con Stati Uniti e OSCE in primis decisi a non
riconoscere il nuovo Presidente, costrinse il Parlamento ucraino a sfiduciare il
governo e ad indire nuove elezioni nel dicembre 2004. La vittoria di Yushenko
questa volta risultò netta e il ruolo di Primo Ministro venne conferito a Yulia
Tymoshenko, tra i protagonisti della cosiddetta Rivoluzione Arancione. Da
sottolineare in questa occasione il ruolo dell´Unione Europea e soprattutto di
Polonia e Lituania, storiche sostenitrici dell´integrazione europea dell´Ucraina,
che appoggiarono l´instaurazione del governo filo-europeista guidato da Yulia
Tymoshenko181.
Le aspirazioni, sia in Ucraina che in Europa, suscitate da questo evento
rivoluzionario erano alte: sembrava infatti terminata l´era del "multivettorialismo"
del Presidente Kuchma, in cui l´identità ucraina veniva definita tramite un
permanente compromesso tra l´Est (Russia) e l´Ovest (l´UE)182. Con i leader
"arancioni" il Paese sembrava scegliere con convinzione la strada
dell´integrazione europea nonché della democrazia; Bruxelles accolse con favore
la Rivoluzione Arancione e l'Alto Rappresentante della PESC Javier Solana compì
diversi viaggi a Kiev per mostrare il supporto dell'UE per il consolidamento del
nuovo governo. La Federazione Russa in questo frangente giocò un ruolo
speculare a quello dell'UE, in quanto il leader Putin appoggiava Yanukovych:
tuttavia la transizione venne accettata in modo meno belligerante da parte di
Mosca rispetto a quanto sta accadendo durante la crisi attuale183.
180
"Rivoluzione arancione" in Enciclopedia Treccani, 2013. 181
R. Wolczuk, "Will the Orange Revolution bear fruit? EU–Ukraine relations in 2005 and the beginning of 2006", Varsavia, Stefan Batory Foundation, 2005. 182
I. Melnyovska, R. Schweickert, T. Kostiuchenko, "EU Neighbourhood Europeanization and European Identities of Elites in Ukraine", paper presentato alla conferenza "Elites and the Formation of Identity in Post Soviet Space", Università di Cambridge, 11 giugno 2010. 183
Intervista dell´autore a L. Schiavo, Direttore Generale della DG Affari Esteri, Segretariato
92
Il Piano d´Azione del 2005 fu firmato con delle aspettative diverse tra
Ucraina e UE: la popolazione ucraina accoglieva con entusiasmo le nuove
prospettive europee, ritenendo il Presidente Kuchma l´unico ostacolo che
separasse il loro Paese dall´ottenere la membership dell´UE184. In Europa questo
entusiasmo non era condiviso da tutti, in quanto, a differenza di Lituania e
Polonia, altri Paesi come Francia e Germania si dimostravano sensibilmente
preoccupati di non deteriorare le loro relazioni con la Federazione Russa185. La
mancanza di una concreta offerta di membership non faceva che aumentare la
frustrazione in seno all´élite ucraina, solo parzialmente accontentata dal
riconoscimento dello "status di economia di mercato" nel 2005.
L'UE in questo frangente non riuscì ad imporsi come promotrice del
cambiamento, principalmente perché deluse le aspettative della classe politica
ucraina: perpetuando la logica ereditata dal Presidente Kuchma, a Kiev si riteneva
che la credibilità di Bruxelles sarebbe stata dimostrata solamente quando sul
tavolo negoziale fosse stata presentata un'offerta di adesione all'UE. Molti in
Ucraina erano convinti nel 2004 che, dopo le dimostrazioni di attaccamento ai
valori europei espresse durante la Rivoluzione Arancione, sarebbe stato difficile
per l'UE negare la prospettiva di membership all'Ucraina. Pur riconoscendo e
apprezzando tali azioni, la risposta europea rimaneva molto pragmatica e si
limitava ad incorporare ulteriori concessioni a favore di Kiev nel Piano d'Azione
del 2005186. Un altro aspetto importante, quello dell'instabilità politica che
storicamente caratterizza il Paese, viene analizzato nei prossimi paragrafi.
Generale del Consiglio dell´UE, 6 maggio 2014. 184
T. Kolar, "EU – Ukraine relations since the Orange revolution", Global Politics, 3.5.2013. Disponibile online: http://www.globalpolitics.cz/clanky/eu-ukraine-relations-since-the-orange-revolution 185
R. Wolczuk, 2005 cit. 186
K. Wolczuk, "Implementatn without coordination: the impact of EU conditionality on Ukraine under the European Neighbourhood Policy", Europe-Asia Studies, 61:2, 187-211, 2009.
93
4.1.3 Una democrazia instabile: Yanukovych e il caso Tymoshenko
Una pesante "crepa democratica" in Ucraina, che ha condizionato negli
ultimi anni le relazioni con l´Unione Europea, è rappresentata dalla vicenda
dell´ex primo Ministro Yulia Tymoshenko (2007-2010). Nel dicembre del 2010 fu
infatti accusata di abuso di potere per aver firmato (2009) un accordo con la
Federazione Russa sulle forniture di gas naturale, giudicato particolarmente
sfavorevole per Kiev. Il processo, iniziato ufficialmente nel giugno 2011, si
concluse nell'ottobre dello stesso anno con una sentenza di condanna a sette anni
di reclusione e tre anni di interdizione dai pubblici uffici: una sentenza che le
impedì di candidarsi alle elezioni politiche del 2012. Già dal mese di agosto però
fu disposta la sua custodia cautelare per comportamento oltraggioso nei confronti
del giudice e fu trasferita preventivamente al carcere di Kiev187. La Corte Europea
dei Diritti dell´Uomo di Strasburgo, tuttavia, dichiarò "illegale ed arbitraria" la
detenzione preventiva della Tymoshenko perché in violazione del suo diritto alla
libertà ed alla sicurezza188.
La detenzione della Tymoshenko, e di altri leader dell´opposizione,
costituiva parte di una più ampia strategia di Viktor Yanukovych in vista delle
elezioni del 2012. Questo gli permise infatti di escludere dalla competizione
elettorale un´avversaria pericolosa, consolidando in tal modo il supporto alla sua
Presidenza189. La Tymoshenko infatti rifiutava di riconoscere il risultato delle
elezioni presidenziali del 2010, in cui Yanukovych riportò una vittoria di misura
al secondo turno (48, 95% contro il 45, 47% della sfidante190); inoltre, data la
statura di livello internazionale della Tymoshenko, Yanukovych mise in atto con
187
http://www.ilpost.it/2013/04/30/la-sentenza-sul-caso-tymoshenko/ 188
Articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell´Uomo (CEDU), 1950. Il testo della sentenza, datata 30 aprile 2013, è disponibile online al sito http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=001-119382 189
S. Kudelia,"When external leverage fails. The Case of Yulia Tymoshenko´s trial", Problems of Post-Communism, vol. 60, n. 1, gennaio-febbraio 2013, pp. 29-42. 190
Elezioni Presidenziali In Ucraina, al sito: www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011.html
94
questo processo giudiziario un´efficace dimostrazione di forza nei confronti delle
altre potenze mondiali ma soprattutto della stessa popolazione ucraina,
cancellando qualsiasi dubbio sulla sua volontà (e capacità) di reprimere ogni
forma di opposizione191.
Il primo intervento ufficiale di un governo occidentale che denunciasse
l´uso selettivo della giustizia venne dagli Stati Uniti, che si dimostrarono attivi
nell´indicare le motivazioni politiche di Yanukovych come la causa principale
della detenzione di Yulia Tymoshenko192. Nell´UE il primo a schierarsi dalla
parte della Tymoshenko fu l´allora Presidente del Partito Popolare Europeo (PPE)
Wilfried Martens, che accusò Yanukovych di manipolare la giustizia e di costruire
un caso "politically motivated"193. Dopo Martens, altri personaggio dello scenario
politico europeo si pronunciarono (da citare ad esempio il J.M. Barroso, H. van
Rompuy, N. Sarkozy) con un approccio tuttavia più generico e attento a non
concentrare la critica sulle politiche di Yanukovych, quanto invece sulle
condizioni della democrazia ucraina in senso ampio194.
La preoccupazione di Bruxelles venne ribadita nel 2011 con un commento
del capo della diplomazia europea, Catherine Ashton: "L´Ue dovrà riflettere sulle
sue politiche nei confronti dell'Ucraina. Il modo con cui le autorità ucraine
rispetteranno i valori universali e lo stato di diritto avrà implicazioni sulle
relazioni bilaterali"195. Al Summit UE-Ucraina del dicembre 2011 l´Accordo di
Associazione era pronto per essere siglato, tuttavia Bruxelles espresse
chiaramente la sua posizione contro la "giustizia selettiva" esercitata da Kiev196 e
191
S. Kudelia,"When external leverage fails. The Case of Yulia Tymoshenko´s trial", cit p. 34. 192
"US Government Statement on Investigation of Ukrainian Opposition Politicians", 30 dicembre 2010, disponibile al link: http://ukraine.usembassy.gov/opositionstatements.html 193
"Yanukovich-Led Power Holders are Destroying the Democratic Achievements of Tymoshenko´s Government", articolo pubblicato nel sito ufficiale di Yulia Tymoshenko, il 14 maggio 2010. Vedi www.tymoshenko.ua/uk/article/87a992on 194
Con l´eccezione dell´allora Presidente del Parlamento Europeo, il polacco Jerzi Buzek. 195
http://www.corriere.it/esteri/11_ottobre_11/tymoshenko-processo-colpevole_328b9f86-f3d7-11e0-8382-87e70525ad6b.shtml 196
"The European Union has stated its firm stance in regard to Yulia Tymoshenko - we are
95
pose la liberazione di Yulia Tymoshenko come conditio sine qua non per la sua
conclusione197.
In questa occasione la posizione, pur ben definita, dell´UE non riuscì ad
influenzare in modo determinante il corso degli eventi: la liberazione della
Tymoshenko è avvenuta solamente il 21 febbraio 2014, all´indomani delle
proteste scoppiate a Kiev (Euro-Maidan) e in seguito alla fuga dello stesso
Yanukovych, di cui si tratta in dettaglio nel prossimo capitolo. Risulta interessante
nel paragrafo che segue indagare le principali motivazioni del fallimento della
condizionalità europea in questo particolare caso.
4.1.3 La condizionalità nel caso Tymoshenko: un approccio "costi-benefici"
Riprendendo alcuni dei criteri proposti da Schimmelfennig e Sedelmeier198,
si cercano di analizzare i punti deboli della condizionalità politica che l´UE
utilizza nei confronti dell´Ucraina. Imprigionata nel 2011, Yulia Tymoshenko
trascorse ben tre anni in carcere e la pressione diplomatica europea (ed americana)
non intaccò la ferma posizione di Yanukovych circa la sua detenzione. Nel corso
dell´argomentazione si nota come, nonostante i chiari vantaggi economici
derivanti dal rilascio della Tymoshenko, siano stati i costi politici di questa
condizionalità a guidare le scelte del governo ucraino.
Per quanto riguarda la "determinacy of conditions", la posizione dell´UE è
stata sostenuta con coerenza e costanza tanto che la liberazione della Tymoshenko
venne persino posta come condizione da soddisfare per la firma dell´Accordo di
Associazione: almeno secondo questo criterio quindi la posizione negoziale
against the selective use of justice” afferma Maja Kocijancic, portavoce del capo della diplomazia UE Catherine Ashton, il 10 ottobre 2011. http://en.ria.ru/crime/20111010/167533063.html 197
S. Pifer, "Ukraine, Europe, and Tymoshenko: does Yanukovic get it?", Up Front, 19 settembre 2011. 198
Vedi p. 44.
96
dell´UE risulta ben elaborata199.
Valutando in secondo luogo "the size and speeed of conditional rewards",
ancora una volta l´UE si sarebbe dovuta trovare in una posizione negoziale
vantaggiosa in quanto, come visto nel precedente capitolo, l´Accordo di
Associazione (e il DCFTA) porterebbero enormi benefici all´Ucraina200. Inoltre,
da notare che l´Unione Europea si è impegna ad implementare il DCFTA anche
prima di aver raggiunto la ratifica dell´AA da parte di tutti i Parlamenti degli Stati
Membri, una procedura che richiederebbe circa un anno dopo la firma201.
Da un punto di vista teorico, anche il criterio della "credibility of
conditionality" è stato soddisfatto: infatti, se per l´UE ritardare la messa in atto
dell´AA con l´Ucraina sarebbe un problema relativamente trascurabile (in termini
economici), per Kiev è invece molto importante assicurare la conclusione del
processo in quanto l´UE rappresenta un partner commerciale di prim´ordine202. La
credibilità della condizionalità europea può essere stata intaccata da un lato dalla
percezione, da parte del governo ucraino, di una divisione interna all´UE;
dall´altro lato è importante sottolineare la possibile alternativa che Kiev avrebbe
in termini di integrazione economica, e che implicherebbe meno costi di
aggiustamento: l´Unione Doganale Euroasiatica con la Federazione Russa, il
Kazakistan e la Bielorussia. Nel precedente capitolo sono stati illustrati alcuni dei
motivi per cui Yanukovych si è mostrato riluttante ad accettare l´offerta di Mosca,
confermando l´integrazione europea come priorità strategica per il suo Paese203.
Il criterio più problematico, che contribuisce a spiegare le ragioni del
comportamento del governo ucraino nel caso Tymoshenko, é quello dei "veto
players and adoption costs". Schimmelfennig e Sedelmeier sostengono che la
soddisfazione della condizionalità, con i costi che questa implica in termini di
199
S. Kudelia,"When external leverage fails. The Case of Yulia Tymoshenko´s trial", cit p. 31. 200
Vedi pag. 64 e ss. 201
S. Kudelia,"When external leverage fails. The Case of Yulia Tymoshenko´s trial", cit p. 31. 202
Vedi pag. 60 e ss. 203
Vedi pag. 73 e ss.
97
modernizzazione e riforme, diventa meno probabile all´aumentare degli attori
ostili presenti all´interno del Paese204 (nel caso ucraino, gli oligarchi preoccupati
della difesa dei propri interessi e privilegi, che dipendono dal mantenimento dello
status quo). Inoltre, Kudelia sostiene che l´UE abbia sottovalutato l´importanza
della detenzione della Tymoshenko per gli interessi politici di Yanukovych:
questa infatti rappresentava un´indispensabile prova, nei confronti dell´opinione
pubblica ucraina, della credibilità del Presidente e della sua capacità di reprimere
eventuali opposizioni205. Con le elezioni politiche (2012) e le presidenziali (2015)
in vista, non era possibile per Yanukovych accettare alcun compromesso con l´UE
sul caso Tymoshenko: ne andava della sua stessa sopravvivenza politica. Questo
testimonia come i costi politici nel breve termine per il Presidente siano riusciti a
superare i benefici di medio-lungo termine derivanti dall´Accordo di Associazione
con l´Unione Europea.
L´errore di valutazione è stato commesso anche da parte dello stesso
Yanukovych, che ha sopravvalutato l´importanza dell´AA e dell´Ucraina agli
occhi di Bruxelles ritenendo di poter trascurare le regole basilari della democrazia
giocando sul timore europeo di un possibile avvicinamento di Kiev a Mosca206. È
risultata tuttavia chiara nell´approccio europeo la posizione prioritaria dei valori di
democrazia, diritti umani e stato di diritto rispetto alla firma dell´Accordo di
Associazione. L´importanza relativa dei due elementi veniva pesata in modo
opposto da UE e Ucraina, un aspetto che ha impediva di trovare un punto di
incontro e manteneva la negoziazione in uno stato di perenne tensione.
Nonostante la condanna dell'UE per l'atteggiamento di Yanukovych fosse
unanime, permaneva una frammentazione interna sui passi successivi: se per
alcuni Stati la condizionalità doveva essere applicata rigorosamente, altri erano
204
F. Schimmelfennig e U. Sedelmeier, "Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe, cit. 205
S. Kudelia,"When external leverage fails. The Case of Yulia Tymoshenko´s trial", cit p. 32. 206
S. Pifer, "Ukraine´s Foreign Policy: Losing Its Balance", Brookings Institution, maggio 2012.
98
più attenti a non dare tempo a Putin di sfruttare la vulnerabilità dell'Ucraina207. Il
caso Tymoshenko, politicizzato molto più di altre questioni non meno importanti,
rappresenta forse il più chiaro esempio di come la leva negoziale dell'UE sia stata
finora applicata senza la necessaria coerenza208.
Nel prossimo paragrafo si introduce un´altra questione spinosa, che gioca un
ruolo chiave sia nella dimensione interna al Paese sia nelle sue relazioni con
l´Unione Europea e la Federazione Russa: lo status della Repubblica Autonoma di
Crimea. Come analizzato più in dettaglio nel Capitolo 5, la crisi ucraina dopo il
Vertice di Vilnius del novembre 2013 ha portato ad una manovra militare russa
che è sfociata nell´annessione (o "adesione", dato che in pochi giorni è stato
organizzato un referendum) della Crimea alla Russia, in violazione del diritto
internazionale209. È compito del prossimo paragrafo contestualizzare questa
vicenda ed evidenziarne i punti di potenziale conflittualità, riemersi con le
proteste dell´Euro-Maidan.
4.2 La Repubblica Autonoma di Crimea: una questione irrisolta
4.2.1 Una fonte di instabilità nella regione
La Repubblica Autonoma di Crimea è una regione molto particolare
all´interno dell´Ucraina, sia dal punto di vista della composizione etnica sia da
quello storico e più prettamente politico210.
Un tempo appartenente all´URSS, venne trasferita dal leader sovietico
207
M. Emerson, "The Ukraine question", European Neighbourhood Watch, 2012. 208
E. Kropatcheva, "Ukraine's EU Integration during the Presidency of Viktor Yanukovich", University of Tartu, Centre for EU-Russia Studies (CEURUS), febbraio 2014. 209
http://it.euronews.com/2014/03/21/russia-ucraina-putin-firma-annessione-crimea/ 210
M. Maigre, "The EU Can Take a Number of Concrete Steps in Crimea", Tallinn, International Centre for Defence Studies, giugno 2009.
99
Nikita Chruscev (di origini ucraine) alla Repubblica Socialista di Ucraina nel
1954, in commemorazione del trecentesimo anniversario dei Trattato di
Pereyaslav tra i Cosacchi ucraini e la Russia211. Questa scelta è stata più volte
criticata in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica, soprattutto per quanto
riguarda la mancanza di una precisa base giuridica. Si può sostenere che un tale
gesto, senza alcun fondamento nella realtà storica, potesse avere un senso
solamente all'interno di un unico Paese, com'era l'URSS prima della sua
implosione; non sarebbe stato invece nemmeno pensabile che avvenisse lo stesso
tra due Stati diversi212.
Nel 1992, con l´indipendenza dell´Ucraina, la Crimea inizialmente
proclamò l´autogoverno, accettando in seguito, grazie ad un accordo con Kiev, lo
status di "Repubblica Autonoma" riconosciuto nella Costituzione ucraina213. La
R.A. di Crimea, unica a godere di un tale tipo di accordo, possiede un proprio
Parlamento che elegge un Presidente con il consenso del governo centrale di Kiev.
La regione presenta un quadro etnico differenziato ma dominato da una
forte presenza russa: questo si rivela un aspetto cruciale anche per comprendere lo
sviluppo della crisi ucraina oggi in atto. Dei due milioni di abitanti totali, il 58% è
infatti russo, mentre gli Ucraini rappresentano solo il 24% e la minoranza
musulmana dei Tatari il 12%214. A Sebastopoli, la città più popolosa della
regione, la presenza dei Tatari non è nemmeno segnalata, mentre il 24% è ucraino
e ben il 70% russo215. La lingua russa, maggioritaria in Crimea, è inoltre l'unica
utilizzata nella Pubblica Amministrazione e la Costituzione ucraina le garantisce
211
http://www.lapresse.it/mondo/europa/ucraina-crimea-il-regalo-di-khrushchev-nelle-mire-di-mosca-1.468803 212
Intervista dell´autore a L. Schiavo, Direttore Generale della DG Affari Esteri, Segretariato Generale del Consiglio dell´UE, 6 maggio 2014. 213
K. Wolczuk, "Catching up with 'Europe'? Constitutional Debates on the Territorial-Administrative Model in Independent Ukraine", Regional and Federal Studies, vol. 2 (2), 2002. 214
Secondo i dati del Censimento del 2001 (quindi da considerare come indicativi). 215
http://voiceofrussia.com/news/2014_02_27/Ukraine-in-crisis-history-behind-Crimeas-aspiration-for-autonomy-2234/
100
lo status di lingua officiale accanto all'Ucraino e al Tataro.
Con queste percentuali, risulta facile capire perché in Crimea non si sia
sviluppata nel corso degli anni una forte lealtà nei confronti del governo centrale
di Kiev, e come allo stesso tempo permanga un legame speciale con la
Federazione Russa216. Pur votando a favore del referendum per l'indipendenza
dell'Ucraina nel 1991, la regione vide lo sviluppo di movimenti separatisti già a
partire dagli anni Novanta con l'appoggio del governo russo, che non ha mai
riconosciuto la sovranità ucraina su tale territorio e non ha mai rinunciato ad
esprimere le sue pretese al riguardo nei confronti di Kiev217.
Accanto all'elemento etnico, a legare la regione alla Federazione Russa vi è
il fatto che la città-porto di Sebastopoli ospita dal 1783 la Flotta russa del Mar
Nero218. Con la dissoluzione dell'URSS Mosca ha perso la giurisdizione sulla
Crimea, dal 1991 parte dell'Ucraina indipendente, e di conseguenza sul quartier
generale della sua flotta. Una temporanea soluzione a questa situazione di
tensione si trovò nel 1997 con la firma del Trattato di Amicizia e di Cooperazione
che divise la flotta in due parti, una sotto il controllo di Mosca e l'altra sotto quello
di Kiev. L'accordo fissava al 2017 la scadenza concessa ai Russi per lasciare il
porto di Sebastopoli e durante il governo Tymoshenko (2007-2010) la posizione
ucraina risultava molto risoluta nel far rispettare tale data219; tuttavia questa
clausola è stata rivista nel 2010 dal neo-presidente Yanukovych e prorogata fino
al 2042. In cambio di questa concessione, Mosca ha concesso degli sconti sulle
forniture di gas all'Ucraina per un totale di 40 miliardi di dollari nell'arco di dieci
anni220.
216
K. Pishchikova, "Ukraine at the crossroads: towards more unity or further disintegration?", ISPI, analisi n. 242, marzo 2014. 217
N. Shapovalova, B. Jarabik, "Crimea: Next Flashpoint in the European Neighbourhood?"FRIDE Policy Paper n. 14 - luglio 2009. 218
T. Buba, "Russian-Ukrainian Relations and the Black Sea Fleet", Georgetown University, The International Affairs Review, vol. XIX n. 1, primavera/estate 2010. 219
D. Marples, “Russia and Ukraine Dispute Over Sevastopol,” Current Politics in Ukraine, 13 luglio 2008. 220
Sono i cosiddetti "Accordi di Kharkiv", il luogo in cui avviene la firma (21 aprile 2010).
101
Lo status della Repubblica Autonoma di Crimea rappresenta tuttora un
punto di particolare importanza per la Russia, con un duplice scopo: salvaguardare
la sua Flotta del Mar Nero a Sebastopoli e allo stesso tempo mantenere una
relazione amichevole con il governo centrale ucraino, affinché possano continuare
a prosperare le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.
4.2.2 Aspetti della gestione politica della R.A. di Crimea
Le premesse del paragrafo precedente mettono in evidenza la necessità di
adottare un approccio politico particolarmente attento verso la R.A. di Crimea, sia
per il governo di Kiev che per l'Unione Europea. Tuttavia la gestione, da parte di
entrambi questi attori, della potenziale conflittualità nella regione appare a
posteriori non abbastanza efficace: si ipotizza dunque che alcune responsabilità
per l'attuale situazione siano attribuibili alla mancanza di un focus specifico che
attenuasse le spinte separatiste diffuse sin dagli anni Novanta.
Da un lato l'approccio scelto dal governo centrale di Kiev nel corso degli
anni non sembra incentrato a promuovere una maggiore integrazione della Crimea
all'interno dello Stato ucraino; le politiche scelte si sono piuttosto rivolte al
mantenimento dello status quo riconosciuto dalla Costituzione del 1996221. Per
quanto riguarda l'OSCE ed il Consiglio d'Europa, l'attenzione principale ha avuto
come oggetto la protezione dei diritti delle minoranze, come la discriminazione
nei confronti dei Tatari222.
La questione della Crimea non è stata affrontata in profondità nemmeno nel
dialogo politico tra Unione Europea e Ucraina in seno alla PEV. Analizzando il
Piano d'Azione del 2005, si nota una terminologia generica in riferimento allo
221
N. Shapovalova, B. Jarabik, "Crimea: Next Flashpoint in the European Neighbourhood?", cit. 222
Una questione ancora piú grave dallo scoppio della crisi ucraina, vedi per esempio http://www.humanrightseurope.org/2014/04/ukraine-minorities-rights-experts-deeply-concerned-about-safety-of-crimean-tatars/?bcsi_scan_dd8016818d07334e=0
102
sviluppo regionale e alla continuazione delle riforme amministrative a livello
locale223. Un'eccezione è riscontrabile nella Joint Cooperation Initiative in
Crimea, intrapresa dalla Commissione Europea nel maggio 2011 e costituita da un
finanziamento di 12 milioni di euro. Questo intende sostenere il governo ucraino
nella gestione e promozione della regione, “with a specific focus on tourism,
building social infrastructure and promoting Foreign Direct Investment”224.
Analizzando l'approccio globale dell'UE nei confronti dell'Ucraina, non si
nota tuttavia un'impostazione specifica verso la R.A. di Crimea: questa è rimasta
una questione di equilibrio tra Mosca e Kiev, legata soprattutto alla Flotta russa
del Mar Nero a Sebastopoli ed alla forte presenza etnica russa nel territorio. L'UE
in questa vicenda non ha finora giocato un ruolo determinante, mentre con lo
scoppio della crisi attuale si è espressa fermamente in favore del rispetto
dell'integrità territoriale del Paese225. Nel commentare gli eventi tragici successivi
al Vertice di Vilnius del Novembre 2013 è importante tenere in considerazione
questo approccio storicamente adottato dall'UE e comprendere come la Russia sia
un attore con un ruolo fondamentale negli equilibri dell'intera regione.
4.3 Valutare la condizionalità politica europea applicata all'Ucraina
4.3.1 PEV e Piano d'Azione a Kiev: tra politica e burocrazia
Nel quadro della Politica Europea di Vicinato, la condizionalità europea
prevede la concessione di benefici di ordine economico-commerciale in cambio di
riforme del sistema politico-istituzionale, del sistema economico e della
223
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Ukrain.pdf 224
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-563_en.htm?locale=en 225 Intervista dell´autore a L. Schiavo, Direttore Generale della DG Affari Esteri, Segretariato Generale del Consiglio dell´UE, 6 maggio 2014.
103
legislazione verso una maggiore convergenza con gli standard dell'UE. A dieci
anni dal lancio della PEV, non sembra che gli obiettivi prefissati siano stati
raggiunti in modo soddisfacente, nonostante il sostegno tecnico e finanziario
proveniente da Bruxelles.
Si può sostenere che l'impatto delle politiche dell'Unione Europea in
Ucraina sia cambiato a partire dal Piano d'Azione del 2005, rimanendo tuttavia
inferiore rispetto ai livelli raggiunti nei Paesi dell'Europa Centrale che aderirono
all'UE nel 2004. Senza dubbio la mancanza di una prospettiva di adesione ha
privaro l'UE della sua più efficace leva negoziale, tuttavia sarebbe semplicistico
far dipendere un fenomeno così complesso da un unico fattore. Ci sono altri
motivi alla base della lacunosa implementazione della PEV da parte dell'Ucraina:
questo paragrafo si concentra sull'instabilità politica che caratterizza la storia del
Paese e che ha tra le sue conseguenze la mancanza di una leaderhip politica in
tema di integrazione europea. Una chiave per comprendere quanto la governance
esterna dell'Unione Europea produca dei risultati si trova analizzando le
dinamiche interne all'élite politica e all'amministrazione pubblica ucraina.
Sin dalla Rivoluzione Arancione del 2004 il clima politico risulta instabile
e i punti di scontro all'interno dell'élite riguardano soprattutto gli affari interni,
come la divisione dei poteri tra il Presidente ed il Primo Ministro. L'integrazione
europea non rientra tra gli argomenti conflittuali in quanto almeno nelle
dichiarazioni ufficiali si è assistito ad una continuità di vedute nel corso degli
anni; tuttavia l'elaborazione e l'adozione delle riforme richieste dall'UE non è mai
stata considerata una priorità226. Se il Presidente Kuchma durante il suo mandato
seguiva una politica di "integrazione per dichiarazione"227, dopo la deludente
risposta europea alla Rivoluzione Arancione i leader ucraini hanno scelto un
approccio molto pragmatico e, in mancanza di una prospettiva di membership,
226
K. Wolczuk, "Implementation without coordination: the impact of EU conditionality on Ukraine under the European Neighbourhood Policy", Europe-Asia Studies, 61:2, 187-211, 2009. 227
Vedi Sherr, 1998, cit n. 27.
104
gestiscono il processo di riforma secondo una pura logica di "costi-benefici". La
governance esterna dell'UE viene limitata dall'atteggiamento della classe politica
ucraina, che si dimostra favorevole a degli sforzi di riforma selettivi e rivolti
solamente verso azioni che non pregiudichino i suoi privilegi o interessi di breve
termine228.
L'implementazione della PEV resta quindi vittima delle contingenze
politiche e risulta addirittura difficile capire dove vengano controllate le decisioni
ad essa relative229. Essa è lasciata nelle mani della burocrazia di Kiev, mentre i
Ministri non si sentono in dovere di rendere conto alla popolazione per la
mancanza di efficienza nel seguire il Piano d'Azione ("no evidence of political
accountability")230. Di conseguenza in questo periodo il concetto politico di
integrazione europea dell'Ucraina è stato equiparato a quello meramente tecnico di
avvicinamento all'acquis communautaire.
La struttura istituzionale dell'Ucraina non ha subito particolari modifiche
per adattarsi alle necessità di implementare la PEV, altro segnale che dimostra il
ruolo secondario attribuito a questa politica. Un'eccezione si trova nel primo
governo Tymoshenko (gennaio-settembre 2005), nel cui ambito venne creato il
posto di Vice-Primo Ministro con delega all'integrazione europea: l'unico in
assoluto a ricoprire questo ruolo fu Oleh Rybachuk, fino al settembre 2005,
quando si decise per la sua abolizione231. Durante questo breve periodo tuttavia è
da segnalare l'adozione della "Roadmap per l'implementazione della PEV"
(vincolante per le agenzie governative che si occupano della relativa legislazione),
uno degli esempi più importanti del potere normativo dell'UE in Ucraina.
228
Razumkov Centre, "EU-Russia relations: problems and prospects", The National Security and Defence, vol. 4-5 n. 133-134. 229
A. Mayhew et al., "Ukraine's European choice: a review of the mechanism for the implementation of Ukraine's policy towards the European Union", Rapporto finale di uno studio per il governo ucraino, 2005 (paper non pubblicato. 230
K. Wolczuk, "Adjectival Europeanisation? The Impact of EU Conditionality on Ukraine under the European Neighbourhood Policy", cit. p.15 231
K. Wolczuk, "Implementation without coordination", cit. p. 200.
105
All'interno dell'apparato burocratico, i principali attori coinvolti nel Piano
d'Azione sono i Ministeri degli Affari Esteri (MAE), dell'Economia e della
Giustizia. K. Wolczuk rileva come, pur in presenza di una qualche forma di
divisione del lavoro, non vi sia invece traccia di una strategia globale né di una
coordinazione tra questi Ministeri. All'interno del MAE si assiste ad una
tradizionale spinta verso l'approfondimento dell'integrazione europea, in linea con
le priorità dichiarate dai governi, senza tuttavia uno sguardo preciso ai problemi di
breve termine nell'implementazione delle misure economiche o giuridiche previste
nel Piano d'Azione: i funzionari del MAE vengono definiti dei "visionary
Euromantics"232. Al contrario, il Ministero dell'Economia e dell'Integrazione
Europea (MEEI) rappresenta dal 2005 il vero motore della condizionalità, in
quanto si occupa degli aspetti più pragmatici e tecnici delle riforme economiche.
Negli anni antecedenti l'adesione dell'Ucraina all'OMC, questo Ministero giocava
un ruolo chiave nel garantire la compliance delle normative ucraine con gli
standard internazionali: da ricordare come l'adesione all'OMC venisse considerata
da Bruxelles la principale pre-condizione per approfondire la cooperazione
economico-commerciale233. Lo stesso livello di tecnicità si può attribuire al
Ministero della Giustizia e al Dipartimento di Stato per l'Approssimazione
Giuridica (SDLA) creato nel 2004: focalizzando l'attenzione in settori specifici di
policy, si perdono tuttavia lo sguardo d'insieme e le priorità politiche della
cooperazione con l'Unione Europea234. Questa divergenza di approcci ha
provocato tensioni tra le istituzioni e non contribuisce a facilitare il cammino del
Paese verso una maggiore integrazione con l'UE.
In conclusione del capitolo, il prossimo paragrafo presenta le relazioni
difficili tra la PEV e il sistema politico ucraino, che si è dimostrato inadeguato e
non particolarmente votato alla ricezione dell'acquis communautaire preferendo
232
K. Wolczuk, "Adjectival Europeanisation?, cit. p. 16. 233
Vedi p. 58. 234
K. Wolczuk, "Implementation without coordination", cit. p. 203.
106
dare priorità alla dimensione interna ed ai suoi interessi di più breve termine.
4.3.2 "Non solo PEV": riconsiderare l'approccio dell'UE
In questo capitolo si prende in considerazione il meccanismo di
condizionalità politica applicato dall'UE in Ucraina, nel quadro della PEV. Nella
teoria lo si definisce come un accordo tra due attori in cui l'uno offre una
ricompensa all'altro se quest'ultimo soddisfa alcune condizioni date. In caso
contrario, la ricompensa può essere ritirata (condizionalità positiva) o si possono
mettere in atto delle sanzioni (condizionalità negativa)235.
Con riferimento al caso ucraino, si parte dalla consapevolezza che una
chiara e concreta prospettiva di adesione sia l'arma più efficace a disposizione
dell'UE per incentivare le riforme istituzionali e democratiche. A differenza dei
Paesi protagonisti dell'allargamento del 2004, Kiev non gode di questa possibilità
nonostante abbia dimostrato (a livello di dichiarazioni pubbliche) un sentimento di
appartenenza all'Europa. Per spiegare i motivi che hanno ostacolato l'azione
dell'UE in Ucraina tuttavia risulta riduttivo fare riferimento esclusivamente alla
mancanza di un'offerta di membership. In questo capitolo si è menzionato, come
un esempio particolarmente significativo, il caso della detenzione dell'ex Primo
Ministro Yulia Tymoshenko: la pressione diplomatica di Bruxelles non è stata
sufficiente per convincere il Presidente Yanukovych a provvedere alla sua
liberazione e questo principalmente perché i costi politici nel breve termine di un
tale gesto sono stati valutati come prioritari per la stessa sopravvivenza politica
del Presidente, anche di fronte alla pendente firma dell'Accordo di Associazione
con l'UE. Si è fatto inoltre riferimento ad un altro fattore, ovvero la cronica
instabilità politica, che contribuisce a spiegare la mancanza di una leadership in
235
J. T. Checkel, "Compliance and Conditionality", ARENA Working Paper Series n. 18, 2000.
107
tema di integrazione europea proprio negli anni in cui l'UE esercita il suo potere
normativo tramite la PEV e il Piano d'Azione. Se dei progressi sono stati
raggiunti, specialmente in campo economico e commerciale con l'ingresso
nell'OMC e la negoziazione di AA e DCFTA, lo si deve principalmente al lavoro
tecnico dei funzionari della burocrazia di Kiev, non ad un reale senso di
responsabilità dell'élite politica.
Negli anni successivi al lancio della PEV, in Ucraina si è assistito ad una
serie di miglioramenti apprezzabili solamente in quella che Tom Casier definisce
"democrazia formale", mentre l'influenza dell'UE non è riuscita a penetrare nella
dimensione della "democrazia sostanziale"236. Tramite la PEV e la condizionalità
infatti l'UE non può chiedere altro se non l'istituzione di un quadro normativo
vicino agli standard europei per quanto riguarda (tra le altre cose) l´indizione di
libere elezioni democratiche, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e
l'indipendenza della magistratura. Questi non sono invece gli strumenti adeguati
per influenzare positivamente un cambiamento nelle abitudini, nei modi di
pensare ed agire della società e della classe politica237.
Nelle precedenti pagine si tenta di evidenziare come siano proprio le
relazioni personali, l'influenza dell'oligarchia e le dinamiche informali a costituire
l'ossatura del sistema politico ucraino, ancora prima del quadro normativo dentro
il quale i suoi attori si trovano ad agire238.
Un altro difetto concettuale nella struttura della PEV è l'inadeguata
considerazione data al "fattore Russia" nella costruzione di un quadro di relazioni
con l'Ucraina. Sia nella dimensione economico-commerciale (con il progetto di
Unione Economica Euroasiatica e la minaccia di tagliare le forniture del gas
236
T. Casier, "The EU's two-track approach to democracy promotion: the case of Ukraine", Democratization, 18(4), 956-977, 2011. 237
J. Reinhard, "EU Democracy Promotion through Conditionality in its Neighbourhood: the Temptation of Membership Perspective or Flexible Integration?", Caucasian Review of International Affairs, vol. 4(3) - Estate 2010. 238
S. Matuszak, "The oligarchic democracy: the influence of business groups on Ukrainian politics", Varsavia, Centro di Studi Orientali (CES), 2012.
108
naturale) che in quella più strettamente politica (con il sostegno a Yanukovych o
la gestione della situazione in Crimea) Mosca ha influito negativamente nel
processo di integrazione europea del Paese, a causa di interessi (spesso legittimi) e
strategie divergenti da quelle di Bruxelles. Se all'epoca del lancio della PEV la
Federazione Russa mostrava un interesse relativamente scarso, l'atteggiamento è
cambiato con l'istituzione del Partenariato Orientale nel 2009: il Cremlino lo
considera infatti un "gioco a somma zero" che potrebbe minacciare la sua
influenza nell'intera regione. L'approccio dell'UE appare in questo senso alquanto
ingenuo (S. Lehne parla addirittura di "illusioni eurocentriche") e non abbastanza
attento ad accompagnare la PEV con un solido dialogo politico con Mosca239.
Concentrandosi sugli aspetti tecnici della compliance dell'Ucraina alle
condizioni stabilite nel Piano d'Azione, senza un'adeguata strategia di lungo
termine per quanto riguarda il futuro delle relazioni con l'Ucraina in mancanza di
una prospettiva di adesione, l'Unione Europea non è riuscita a costruire una solida
credibilità in seno all'élite di Kiev, le cui aspirazioni sono state continuamente
deluse, lasciando invece che fossero gli interessi politici ed economici di breve
termine e l'influenza dell'oligarchia a stabilire l'agenda del governo.
Con queste premesse si è giunti al Vertice di Vilnius del novembre 2013,
data in cui Unione Europea ed Ucraina avrebbero dovuto firmare l'Accordo di
Associazione concluso l'anno precedente. Nel prossimo capitolo si utilizzano i
concetti e le argomentazioni fino a qui riportati per analizzare lo sviluppo degli
eventi negli ultimi mesi, nonché per ipotizzare un'eventuale futura prospettiva per
la soluzione della crisi che proprio a partire dal Vertice di Vilnius imperversa in
Ucraina.
239
S. Lehne, "Time to reset the European Neighbourhood Policy", cit. p. 7.
109
CAPITOLO 5
L´INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA
QUESTIONE UCRAINA
Dopo aver presentato nelle precedenti pagine le relazioni tra l´UE e
l´Ucraina nel quadro della PEV, questo capitolo conclusivo si propone di
introdurre la crisi attualmente in corso nel Paese all´indomani del Vertice di
Vilnius del novembre 2013. Dato che si tratta di un fenomeno ancora in pieno
svolgimento, non rientra nello scopo di questa tesi formulare delle conclusioni a
proposito. L´intenzione è di fornire una sintesi degli elementi principali e le sfide
per il prossimo futuro, commentando l´atteggiamento dell´Unione Europea nel
gestire non solo la crisi, ma anche le sue relazioni con la Federazione Russa e gli
Stati Uniti. Si mette in evidenza come questa crisi trascenda la dimensione della
PEV per coinvolgere altre potenze mondiali. Inoltre, lo svolgersi degli eventi
costringe Bruxelles a serie riflessioni sulle strategie da perseguire in altri settori
come la politica estera e l´approvvigionamento energetico.
Le elezioni presidenziali del 25 maggio 2014 in Ucraina rappresentano il
punto d´arrivo della tesi, nonché un potenziale punto di svolta negli sviluppi della
crisi ucraina. Il nuovo Presidente Poroshenko, dichiarando di voler riprendere il
cammino del suo Paese verso l´Europa e di voler difendere la sovranità territoriale
ucraina, ha conferito dei chiari orientamenti al dialogo che nel prossimo futuro
dovrà essere messo in atto con l´UE e la Federazione Russa.
110
5.1 Lo scoppio della crisi
5.1.1 Il "no" di Yanukovych all'UE: prima e dopo il Summit di Vilnius
Le negoziazioni dell´Accordo di Associazione tra l´UE e l´Ucraina sono
state effettuate nel periodo 2007-2011 e terminate nel 2012. Il 10 dicembre 2012,
il Consiglio dell´UE ha espresso un chiaro impegno a firmare l´Accordo non
appena l´Ucraina avesse soddisfatto determinate condizioni240 (tra cui la
liberazione di Yulia Tymoshenko), ponendo come data di riferimento il Vertice
del Partenariato Orientale di Vilnius del 28-29 novembre 2013. Tuttavia, già a
partire dall´estate del 2013 la pressione da parte di Mosca sull´Ucraina ha iniziato
ad aumentare e il Cremlino ha messo in atto una serie di sanzioni economiche che
hanno ridotto il volume di commercio con Kiev del 25%, per una perdita stimata
intorno ai 15 miliardi di euro241. Queste misure sono giunte in un momento di
crisi economica profonda per l´Ucraina e hanno raggiunto efficacemente il loro
scopo politico: dissuaderla dal firmare l´Accordo di Associazione (ed il DCFTA)
con l´Unione Europea. Infatti, appena una settimana prima del Vertice, il Primo
Ministro Azarov ha comunicato la decisione di sospendere il processo per
dedicarvi una più attenta riflessione, nonostante il supporto popolare senza
precedenti per questo accordo tra la popolazione ucraina. La Verkhovna Rada
qualche giorno prima aveva respinto un pacchetto di norme che avrebbero
consentito a Yulia Tymoshenko di sottoporsi a cure mediche in Germania, un
provvedimento ritenuto dall´UE come un passo essenziale per poter passare alla
240
"La conformità delle elezioni politiche del 2012 con le norme internazionali e le azioni di follow up, nonche i progressi dell'Ucraina nell'affrontare la questione della giustizia selettiva e evitarne la reiterazione, cosi come nell'attuare le riforme definite nell'agenda di associazione convenuta di comune accordo". Comunicato stampa al link: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/IT/foraff/134843.pdf 241
A.O., "Ukraine-EU. Politics of brutal pressure", The Economist, 22 novembre 2013.
111
firma dell´Accordo242.
In coerenza con l´analisi effettuata nei precedenti capitoli, si può valutare la
scelta del Presidente Yanukovych come dettata principalmente da motivazioni di
sopravvivenza politica nel breve termine. Pressato sia da Bruxelles sia da Mosca,
ha preso una decisione pragmatica e logica dal punto di vista politico: in vista
delle elezioni presidenziali del 2015, il sostegno del Presidente Putin appariva più
prezioso di quello europeo; inoltre, rilasciare Yulia Tymoshenko non solo avrebbe
stravolto il clima politico interno ucraino ma avrebbe contribuito anche a
destabilizzare e a mettere in questione i poteri acquisiti dall´oligarchia, interessata
evidentemente a mantenere lo status quo. In un Paese già martoriato dalla crisi
economica, la manipolazione dei prezzi dell´energia si è rivelata una leva efficace
a disposizione della Russia per condizionare le scelte politiche di Kiev. Nel
gestire l´avvicinamento al Vertice di Vilnius invece, Bruxelles ha commesso
quello che alcuni esperti considerano un errore strategico: condizionare, senza
alcun margine di flessibilità, la firma dell´AA alla liberazione di Yulia
Tymoshenko ha posto Yanukovych di fronte ad una scelta obbligata, su cui (per
motivi principalmente di politica interna) non era possibile trovare un
compromesso243.
Alla richiesta di Yanukovych di includere anche la Federazione Russa in
una discussione trilaterale sul´Accordo di Associazione, l´UE ha risposto
negativamente sottolineandone la dimensione prettamente bilaterale ("The time of
limited sovereignty is over", ha commentato Josè Manuel Barroso ai margini del
Summit)244. Secondo molti si è trattato di un altro grossolano errore strategico da
parte di Bruxelles, non limitato a questa singola occasione ma protrattosi sin dal
concepimento della PEV e del Partenariato Orientale: non tenere adeguatamente
conto degli interessi della Russia in Europa dell´Est, in particolare dei forti legami
242
A. Gardner, "Ukraine rejects Tymoshenko bills", European Voice, 21 novembre 2013. 243
S. Grazioli, "La Russia batte l’Unione Europea e si riprende l’Ucraina", LIMES, 25 novembre 2013. 244
"EU seeks ‘time for reflection’ after Vilnius summit failure", Eunews, 29 novembre 2013.
112
industriali esistenti con la parte orientale dell´Ucraina, e non coinvolgerla
nell´elaborazione di una strategia di lungo termine per garantire la pace e la
sicurezza nella regione245.
Dopo il congelamento dell´AA e il presunto riavvicinamento a Mosca, in
piazza Maidan a Kiev ed in altre città sono iniziate delle manifestazioni popolari
contro la politica del governo ed in favore dell´integrazione europea dell´Ucraina,
un fenomeno che per questo motivo ha preso il nome di "Euro-Maidan". I partiti
dell´opposizione non sono tuttavia riusciti a prendere il controllo né a dare una
forma organizzata alle proteste, a cui partecipavano gruppi eterogenei e in cui la
componente "europeista" non era maggioritaria: una parte considerevole
apparteneva infatti a frange nazionaliste e di estrema destra (come Right Sector o
Svoboda)246. Questo aspetto contribuisce a spiegare perché dopo due mesi le
manifestazioni pacifiche siano degenerate in violenza, con numerosi scontri tra
civili e forze armate. Gli ordini del Presidente Yanukovych di reprimere le
proteste popolari hanno causato decine di vittime tra la popolazione civile. Mentre
giungeva unanime la condanna alle violenze da parte di UE, USA e ONU, la
Russia accusava l´Occidente di fomentare la folla a rivoltarsi contro il potere
legalmente costituito247. Per mettere fine alla tragica escalation in corso a Kiev, il
21 febbraio 2014 Yanukovych ha firmato con i principali membri
dell´opposizione ed i Ministri degli Esteri di Francia, Germania e Polonia un
accordo che prevede il ritorno alla costituzione del 2004, riducendo i poteri del
Presidente, la formazione di un nuovo Parlamento e nuove elezioni (fissate in
seguito il 25 maggio)248. Yanukovych, parlando apertamente di "colpo di Stato",
dal giorno successivo ha lasciato Kiev facendo perdere le sue tracce; contro di lui
245
Intervista dell´autore a L. Schiavo, Direttore Generale della DG Affari Esteri, Segretariato Generale del Consiglio dell´UE, 6 maggio 2014. 246
http://www.thenation.com/article/178013/ukrainian-nationalism-heart-euromaidan 247
http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/18/news/ucraina_riforma_costituzionale_scontri_tra_polizia_e_manifestanti-78916090/ 248
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ucraina-cosa-prevedono-gli-accordi-del-21-febbraio-90b6d931-72c4-4579-9a04-b69d5dc25c4f.html
113
è stato emesso un mandato di arresto internazionale249. La Rada ucraina ha eletto
(secondo le regolari disposizioni costituzionali) Oleksandr Turchinov, ex capo dei
servizi segreti, come suo Presidente e quindi anche come Presidente ad interim
dopo la destituzione di Yanukovych; il ruolo di Primo Ministro invece è stato
conferito ad un fedelissimo di Yulia Tymoshenko, Arseny Yatseniuk.
Il prossimo paragrafo prende in considerazione la portata geopolitica di un
altro avvenimento che segna profondamente l´Ucraina: l´annessione della R.A. di
Crimea da parte della Federazione Russa.
5.1.2 L'annessione della Crimea: vittoria o sconfitta per Mosca?
Dopo gli avvenimenti di piazza Maidan e lo stravolgimento del panorama
politico ucraino, Mosca ha reagito mobilitando le sue truppe stanziate sul Mar
Nero e occupando le principali città della regione. L´UE ha condannato duramente
la violazione della sovranità territoriale ucraina e l´utilizzo della forza militare da
parte di Mosca, ritenendo il dialogo l´unica via da intraprendere per trovare una
soluzione alla crisi250. Le prime reazioni di Bruxelles tuttavia sono state proprio il
congelamento del dialogo bilaterale con la Russia, la cancellazione del Summit
del G8 in programma a Sochi e delle sanzioni mirate ed individuali all'entourage
del Cremlino.
Sotto la pressione militare russa, il 16 marzo 2014 è stato indetto in Crimea
un referendum per la sua annessione de facto alla Russia251, che l´UE si è rifiutata
di riconoscere in quanto contrario alla Costituzione ucraina e al diritto
internazionale. Il Consiglio Europeo, nelle sue conclusioni del 20-21 marzo, ha
249
http://www.lastampa.it/2014/02/22/esteri/kiev-obamaputin-attuare-laccordo-si-dimette-il-presidente-del-parlamento-yjbj7Gl7NCcd0S36OEmd8H/pagina.html 250
Vedi ad esempio le Conclusioni del Consiglio straordinario UE del 3 marzo 2014, o quelle del Consiglio Europeo straordinario del 6 marzo. 251
Al referendum partecipa l´81,3% degli aventi diritto e il "sí" raggiunge il 96, 7% dei voti. Vedi G. Cuscito, "Le conseguenze dell’annessione della Crimea alla Russia", LIMES, 20 marzo 2014.
114
precisato che "any further steps by the Russian Federation to destabilise the
situation in Ukraine would lead to additional and far reaching consequences for
relations in a broad range of economic areas"252.
Alla luce di quanto affermato nelle precedenti pagine, si può sostenere che
l´annessione della Crimea non sia stata un atto estemporaneo escogitato da Mosca
in reazione allo scoppio della crisi; il momento politico certamente è stato scelto
con cura, tuttavia il fenomeno ha le sue radici storiche: forme di separatismo e
conflittualità tra la maggioranza russa di Crimea e il governo centrale ucraino
sono andate sviluppandosi sin dall´indipendenza del 1991253.
È evidente che questo evento comporta serie conseguenze politiche per
l´Europa dell´Est: innanzitutto, si rimettono in questione i principi di sovranità
nazionale e integrità territoriale, gettando un velo di incertezza nella definizione
dei confini in Europa. Per la Russia le implicazioni hanno un doppio volto: da un
lato il suo isolamento internazionale e il rischio di ingenti danni economici nel
caso le sanzioni comminate da UE e USA vengano rese ancora piú stringenti;
dall´altro un rafforzamento considerevole dell´autorità e della popolarità del
Presidente Putin nell´arena domestica. Secondo alcuni esperti tuttavia
l´annessione della Crimea rifletterebbe una situazione di debolezza, non di forza,
interna alla Russia soprattutto per quanto riguarda lo stato dell´economia, la
mancanza di modernizzazione e la corruzione dilagante. Lanciarsi in una
campagna militare all´estero (la Storia lo conferma) può in questi casi avere un
effetto positivo sulla popolarità di un leader in difficoltà254.
La situazione di instabilità e le spinte separatiste non si sono limitate al caso
della Crimea, essendosi estese anche nelle regioni orientali del Paese (Donetsk,
Lugansk, Kharkiv). I filorussi, occupati gli edifici simbolo del potere politico,
252
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf 253
O. Thranert, M. Zapfe, "The ambivalent implications of Crimea", Carnegie Europe, 28 marzo 2014. 254
A. Prankevicius, "What the Crimea crisis means for Europe", intervista a Nouvelle Europe il 15 aprile 2014.
115
hanno proclamato la nascita di Stati sovrani autonomi dall'Ucraina come nel caso
della Repubblica Popolare di Donetzk (7 aprile). Sono stati inoltre indetti dei
referendum popolari per ufficializzare la secessione de facto dallo Stato centrale
(11 maggio): il risultato è stato un plebiscito a favore dell'annessione alla
Federazione Russa, opinione espressa da circa il 95% dei votanti255. Ancora una
volta, il nuovo governo Yatseniuk ha denunciato la presenza di Mosca come
motore delle rivolte chiedendo il supporto dell'Occidente per ristabilire l'ordine
nel Paese. La retorica di condanna e non riconoscimento attuata da Bruxelles e
Washington tuttavia non è finora riuscita ad essere incisiva né a persuadere la
Russia a desistere dalla sua azione.
Per quanto riguarda l´Europa, gli avvenimenti in Ucraina orientale stanno
mettendo (nuovamente) a nudo le sue deficienze in politica estera: nella scelta
delle misure per contrastare l´azione della Russia, l´Unione ancora una volta
manca di una strategia precisa e di obiettivi chiari nell´affrontare la questione in
quanto gli Stati Membri fanno prevalere i loro interessi nazionali. Se da un lato la
Polonia, la Svezia e l´Estonia premono per un approccio deciso e per rafforzare le
sanzioni economiche, dall´altro Paesi come l´Italia, la Germania e la Spagna sono
interessati a preservare le loro buone relazioni bilaterali con Mosca256: a riprova di
questa incoerenza, al Consiglio Affari Esteri di Lussemburgo (14-15 aprile 2014) i
Ministri dell'UE hanno deciso di posporre l´adozione di ulteriori sanzioni per
evitare di guastare il dialogo in programma a Ginevra il 17 aprile.
5.1.3 Reazioni internazionali e de-escalation della crisi
L'annessione della Crimea da parte della Russia e le ulteriori azioni di
255
http://www.corriere.it/esteri/14_maggio_11/ucraina-filorussi-votano-referendum-separatista-nuovi-scontri-f0209b4c-d8da-11e3-b8f7-5c1c0bbdabb2.shtml. 256
J. Dempsey, "Europe looks on as Russia marches through Ukraine", Carnegie Europe, 17 aprile 2014.
116
destabilizzazione perpetuate in Ucraina orientale hanno contribuito a compattare
l'Occidente (UE e USA) contro la politica di Mosca, attuata in violazione della
sovranità territoriale ucraina e delle più basilari norme di diritto internazionale.
Data la presenza della Russia come membro permanente del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU, non è stato possibile prevedere un regime di sanzioni a
livello globale e quindi l'Unione Europea si è trovata nella necessità di mettere in
atto misure unilaterali in collaborazione con altre potenze, soprattutto gli Stati
Uniti. L'approccio scelto dall'UE prevede tre fasi principali: la sospensione di una
serie di dialoghi bilaterali con Mosca, il congelamento di patrimoni e visti
imposto ad alcune decine di individui vicini al Cremlino, per giungere alla terza
fase (per ora solo preannunciata) di pesanti sanzioni economiche257.
Il 26 marzo 2014 a Bruxelles, in occasione della prima visita del Presidente
statunitense Obama presso le istituzioni europee, è stata pubblicata una
dichiarazione congiunta che pone la situazione ucraina in primo piano, ribadendo
la determinazione di entrambe le sponde dell'Atlantico a fornire supporto alla
popolazione e al nuovo governo per riportare la stabilità nel Paese. Infine,
l'utilizzo di sanzioni economiche è stato paventato nel caso il Cremlino si ostini
nella sua azione nell'Est dell' Ucraina258.
Sebbene le posizioni ufficiali in Europa e negli USA siano di unanime
condanna, le continue provocazioni attraverso la retorica del Presidente Putin e
una considerevole presenza militare alla frontiera sono segnali a cui "l'Occidente"
sta rispondendo in modo disorganizzato e poco incisivo: le misure concrete si
limitano finora al cosiddetto "secondo livello"259. L'UE sembra temporeggiare,
annunciando che passerà a più pesanti sanzioni economiche ("terzo livello")
contro la Russia solo nel caso non contribuisca in modo adeguato alla "de-
257
P. Ivan, "EU's sanctions against Russia - the dpneed for clear goals", European Policy Centre, 21 marzo 2014. 258
Per il testo completo della dichiarazione congiunta vedi http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf 259
A. Paul, "Ukraine on the edge", European Policy Centre, 24 aprile 2014.
117
escalation" della crisi260. Nel frattempo le regioni orientali dell'Ucraina cadono
preda dell'esercito russo, che incita i separatisti alla violenza, ad occupare edifici
pubblici e a ribellarsi contro il governo centrale.
Una soluzione diplomatica sembrava possibile al momento della
convocazione del Summit di Ginevra, tenutosi il 17 aprile tra Ucraina,
Federazione Russa, Unione Europea e Stati Uniti. Un primo passo era stato
compiuto a fine marzo, quando Mosca si era detta disponibile ad incaricare una
Missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina. A Ginevra sembrava
confermarsi questa volontà di de-escalation, grazie ad un accordo in cui le parti
avrebbero rinunciato all'uso della violenza, di qualsiasi azione intimidatoria o
provocatoria ed in cui si intimava l'evacuazione degli edifici e degli spazi pubblici
occupati e lo scioglimento dei gruppi armati in azione. Pochi giorni dopo tuttavia
è risultato chiaro che il Summit di Ginevra sarebbe restato lettera morta, e parte
della responsabilità si può attribuire al debole approccio "a tre livelli" di Europa e
USA, incapaci di distogliere la Russia dai suoi intenti. L'efficacia nell'azione
diplomatica dell'UE è minata in partenza dalla divergenza di interessi tra gli Stati
Membri: mentre Paesi come la Polonia e gli Stati baltici premono perché si
attuino dure sanzioni economiche, altri come la Germania sono riluttanti a
guastare gli ottimi rapporti commerciali instaurati con Mosca in via bilaterale261.
Proprio tramite la logica "divide et impera" il Presidente Putin si è assicurato una
posizione negoziale favorevole nei confronti dell'UE, la cui politica estera viene
infatti stabilita ancora dagli Stati Membri all'unanimità.
Nel prossimo, conclusivo paragrafo si abbozzano alcune riflessioni sulla
crisi ancora in corso, evidenziando la necessità per l'Unione Europea di ripensare
il suo approccio verso il Partenariato Orientale e la Russia. Infine, un breve
commento sul futuro del Paese alla luce delle elezioni del 25 maggio.
260
Conclusioni del Consiglio Europeo, 20-21 marzo 2014. Vedi http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST 7 2014 INIT 261
A. Paul, V. Filipchuk, "Ukraine in deadlock - What next?", Europan Policy Centre, 12 febbraio 2014.
118
5.2 Riflessioni su una crisi ancora in corso
5.2.1 Quale futuro per l´Accordo di Associazione?
La crisi ucraina è scoppiata in seguito al rifiuto da parte dell´allora
Presidente ucraino Yanukovych di firmare l´Accordo di Associazione con l´UE al
Summit di Vilnius del novembre 2013. La pressione esercitata dalla Russia,
benché si efficace nel breve periodo, non è riuscita ad arrestare Kiev nel suo
processo di avvicinamento all´Europa: il nuovo Primo Ministro Yatseniuk si è
recato a Bruxelles il 21 marzo per apporre la sua firma sulla parte politica
dell'Accordo, un gesto rilevante soprattutto dal punto di vista simbolico in vista
delle elezioni del 25 maggio. Una volta costituitisi un un nuovo Parlamento e un
nuovo governo eletti e legittimati democraticamente, il processo potrà essere
completato anche con la parte commerciale (DCFTA, la cui firma è prevista ai
margini del Consiglio Europeo del 26-27 giugno 2014). Al momento della
scrittura di questa tesi non è ancora chiaro se questo possa essere realizzato senza
ulteriori reazioni da parte di Mosca: per ora l´atteggiamento del Presidente Putin
rimane ostruzionista in quanto considera un DCFTA con tra Ucraina e l'UE come
un ostacolo al compimento del progetto di Unione Economica Eurasiatica262. Un
riorientamento verso l'Europa sarebbe "politicamente doloroso ed
economicamente costoso"263 per Kiev e Mosca è pronta ad accentuare in ogni
modo l´entità di questi costi, sia livello retorico (definendolo un "suicidio" per
l'economia ucraina) sia sfruttando la dipendenza dell'Ucraina dal suo mercato
tramite restrizioni commerciali unilaterali, in violazione degli stessi impegni
internazionali assunti da Mosca in sede OMC. Questo aspetto, solo in apparenza
tecnico ma intriso di un chiaro significato geopolitico, pone una sfida all'intera
politica europea verso i Paesi dell'Europa Orientale. Un passo nella giusta
262
Vedi il Capitolo 3. 263
K. Wolczuk, "Ukraine and the EU: turning the Association Agreement into a success story", European Policy Centre 23 aprile 2014.
119
direzione è stato effettuato da Bruxelles con la concessione unilaterale di
preferenze commerciali all'Ucraina fino al novembre 2014, equivalenti ai livelli
previsti nel DCFTA: un processo legislativo durato appena cinque settimane,
segno della consapevolezza di Consiglio e Parlamento Europeo riguardo
all´urgenza della situazione ed alla necessità di adottare misure efficaci in modo
rapido.
Nei primi mesi del 2014, il Presidente russo Putin ha chiesto all´UE di
istituire un gruppo di esperti incaricati di effettuare uno studio congiunto sulle
potenziali conseguenze negative che gli Accordi di Associazione tra l´UE ed i
Paesi del Partenariato Orientale avrebbero sull´economia russa (in particolar
modo quello con l´Ucraina)264. A livello tecnico la Commissione Europea ha
espresso in modo efficace i suoi argomenti, sostenendo che i principali punti di
conflitto non abbiano le loro radici negli AA dell´UE quanto invece nel
successivo progetto di Unione Doganale (dal 2015 Unione Economica)
Euroasiatica. La critica che è possibile formulare è invece di natura politica:
all´approccio seguito dall´UE negli ultimi anni si può infatti rimproverare una
scarsa considerazione degli interessi (spesso legittimi) della Federazione Russa in
Europa Orientale, dovuti soprattutto ai forti legami di natura industriale costituitisi
all´epoca dell´URSS265. L´intera Politica Europea di Vicinato è fondata su un
approccio essenzialmente tecnocratico, in cui la Commissione valuta il progresso
nelle riforme tramite rapporti annuali e un meccanismo di condizionalità che non
tiene conto delle mutevoli condizioni economiche, politiche e sociali nei Paesi
destinatari. Quello che manca è un forte sostegno da parte dei più alti
rappresentanti politici europei, che conferiscano alla PEV una chiara strategia nel
lungo termine266.
264
Chi scrive segue da vicino questo processo, nella sua attività di tirocinio presso il Segretariato Generale del Consiglio dell´UE. 265
Intervista dell´autore a L. Schiavo, Direttore Generale della DG Affari Esteri, Segretariato Generale del Consiglio dell´UE, 6 maggio 2014. 266
J. Techau, "Europe’s Neighbourhood Policy is in Trouble, but Not Beyond Saving", Carnegie Europe, 7 aprile 2014.
120
5.2.2 Ripensare la politica energetica in Europa
Un´attenzione particolare alla politica energetica è opportuna alla luce degli
avvenimenti in corso in Ucraina, che stimolano negli ultimi mesi delle riflessioni
sul futuro delle relazioni UE-Russia per quanto riguarda la sicurezza
dell´approvvigionamento energetico. Come evidenziato nel capitolo 3, la Russia
in diverse occasioni ha utilizzato la sua posizione vantaggiosa di Paese fornitore
come un´arma politica nei confronti dell´Ucraina e della stessa Unione
Europea267.
Molti Paesi dell´UE hanno subito le conseguenze negative dello scoppio
delle "guerre del gas" nel 2006 e nel 2006, quando la Russia decise di tagliare
unilateralmente le forniture all´Ucraina. Ancora oggi la dipendenza europea dal
gas russo è accentuata e questo rappresenta un elemento di vulnerabilità: l´UE a
Ventotto importa oltre il 53% dell´energia che consuma, ed una percentuale
considerevole proviene dalla Russia268. Nonostante sulla carta l´UE si stia
dotando di un mercato unico dell´energia269, la sua implementazione è ancora
nelle fasi iniziali ed esistono nella realtà ancora ventotto mercati nazionali,
ciascuno con la propria lista di fornitori ed i propri contatti bilaterali: per quanto
riguarda le importazioni dalla Russia, il maggiore utilizzatore in termini assoluti è
la Germania, ma in percentuale la dipendenza supera il 90% nei Paesi Baltici, in
Polonia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Finlandia270.
Mosca ha l´opportunità di sfruttare la dipendenza europea, tramite una
logica di "divide et impera" che diluisce l´efficacia delle misure restrittive dell´UE
durante la crisi in Ucraina. Sono infatti proprio gli Stati con una maggiore
267
Vedi pag. 77 e ss. 268
A. Ahtonen, "Russian belligerance and Europe´s energy security", European Policy Centre, 19 marzo 2014. 269
Con la direttiva "Third Energy Package" adottata nel 2007, gli Stati Membri dell´UE si propongono di liberalizzare i prezzi di gas ed elettricità entro il 2015, per incrementare la competitività del mercato europeo dell´energia. 270
Idem
121
interazione commerciale bilaterale con la Russia a rallentare il passaggio al
cosiddetto "terzo livello" delle sanzioni economiche271. Il 10 aprile 2014 il
Presidente Putin ha inviato ai 18 Stati dell´UE che utilizzano il gas russo in
transito dall´Ucraina una lettera, in cui propone urgentemente il lancio di
consultazioni sul futuro dell´economia ucraina e della sicurezza del trasporto
energetico. Questa iniziativa fa parte di un più ampio tentativo di delegittimare il
governo ucraino, accentuando le sue caratteristiche di "partner insolvente", in
riferimento all´enorme debito accumulato nel corso degli anni da Naftogaz nei
confronti di Gazprom. Il fatto che tra i destinatari di questa lettera non figuri la
Commissione Europea è un´altra prova della strategia russa, che si rivolge
bilateralmente agli Stati Membri nuocendo alla coerenza complessiva dell´UE in
tema di politica energetica272.
L´uso politico del fattore energia e le altre azioni perpetrate da Mosca
durante la crisi attualmente in corso in Ucraina hanno reso chiara la sua riluttanza
al rispetto delle regole e degli impegni assunti in sede internazionale. L´Unione
Europea, per poter dialogare con la Russia da pari a pari ed in una posizione
solida, ha bisogno di Stati Membri con politiche tra di loro armoniose e coerenti.
Uno dei principali obiettivi da perseguire, oltre a quello dell´efficiente utilizzo
dell´energia, è la diversificazione dei fornitori per garantire da un lato la sicurezza
dell´approvvigionamento e dall´altro una diminuzione della dipendenza dal gas
russo. Una maggiore cooperazione a livello europeo avrebbe un effetto positivo
sui prezzi dell´energia e quindi sulla competitività delle imprese. In questo
contesto, è opportuno notare come il tema della sicurezza energetica sia diventato
di primaria importanza nei negoziati commerciali tra l´UE e gli USA per il
Transatlantic Trade and Investment Partnerhip (TTIP). Lo sfruttamento dei
giacimenti di gas di scisto (shale gas) americani negli ultimi anni ha trasformato
gli Stati Uniti in un Paese produttore, rivoluzionando il mercato mondiale delle
271
Vedi pag. 109. 272
S. Kardaś, " Putin challenges Brussels to a gas duel", OSW analysis, 14 aprile 2014.
122
forniture: secondo le proiezioni dell´Agenzia Internazionale per l´Energia, nel
2035 gli USA supereranno la Russia diventando il primo produttore di gas a
livello globale. Per adesso, l´ostacolo maggiore per l´Unione Europea rimane
l´alto costo del trasporto di questo gas attraverso l´Atlantico; ciononostante,
risulta di fondamentale importanza costruire un dialogo strutturato con gli USA e
contemplare l´importazione del gas naturale americano in alternativa al gas
russo273.
5.2.3 Le prospettive dopo le elezioni presidenziali del 25 maggio 2014
Punto d´arrivo di questa tesi, ma auspicabilmente l´inizio di una nuova
stagione per l´Ucraina, le elezioni presidenziali del 25 maggio 2014 hanno
rappresentato sicuramente un momento storico per un Paese che sta vivendo una
situazione di profonda crisi ed instabilità politica, economica e sociale. Con la
maggioranza assoluta dei consensi già al primo turno, il nuovo Presidente è Petro
Poroshenko, un oligarca soprannominato "il re del cioccolato" in quanto
proprietario della celebre impresa Roshen; la principale sfidante ed ex Primo
Ministro Yulia Tymoshenko ha ottenuto il 13% dei voti.
Da una prima valutazione dell´OSCE è emersa una valutazione positiva del
processo elettorale, caratterizzato da un´alta affluenza (intorno al 60 % a livello
nazionale, non molto lontana dal 69% del 2010274) ed in linea con gli impegni
internazionali, nonostante un clima esterno ostile275. Anche il Presidente del
Consiglio Europeo, Herman van Rompuy, ha accolto con favore il processo
elettorale come democratico e partecipato, considerandolo un segnale importante
273
European Parliament, Directorate General for External Policies, "The Shale gas 'revolution' in the United States: Global implications, options for the EU", Policy briefing, aprile 2013. 274
A. Wilson, "Ukraine votes", European Council on Foreign Relations, 26 maggio 2014. 275
Joint Statement on Presidential Elections in Ukraine by President of the European Council Herman van Rompuy and President of the European Commission José Manuel Barroso, 26 maggio 2014, EUCO 116/14.
123
per l´UE che ha nei prossimi mesi delle responsabilità nei confronti dell´Ucraina,
soprattutto nel fornire assistenza finanziaria e tecnica per le tanto necessarie
riforme276. La situazione è lontana dalla normalizzazione nelle regioni orientali,
ancora in balia dei gruppi dei filorussi separatisti, dove la maggior parte dei seggi
è rimasta chiusa: i ribelli rifiutano infatti di riconoscere la legittimità del nuovo
Presidente e ribadiscono l´indipendenza delle Repubbliche Popolari di Donetsk e
Lugansk, unitesi in un nuovo Stato chiamato "Novorossiya" (Nuova Russia).
Proprio nei giorni successivi alle elezioni il Consiglio Supremo separatista ha
imposto la legge marziale, affermando come scopo principale quello di "ripulire
la regione dalle unità militari ucraine"277. Poroshenko, l´unico tra gli oligarchi ad
appoggiare l´opposizione pro-europea sin dalle origini delle proteste Euro-
Maidan278, ha affermato subito dopo la sua elezione che "ora la priorità è porre
fine alla guerra e al caos e ristabilire la pace, il mio paese ha scelto l'Europa279.
Il neo-Presidente ucraino non si è pronunciato invece in merito ad eventuali
collaborazioni con il presidente russo Vladimir Putin, anche se è ipotizzabile che i
primi incontri si terranno nel prossimo futuro. Dopo il fallimento dei primi
dialoghi di Ginevra il 17 aprile, infatti, un nuovo round è auspicabile per ritornare
al dialogo politico e diplomatico e trovare una soluzione condivisa; il Ministro
degli Esteri russo Lavrov si è dichiarato disponibile ad un "Ginevra II" solamente
con la partecipazione dei ribelli separatisti della Novorossiya: una retorica che
nasconde la volontà di conferire loro una legittimità internazionale per indebolire
il governo centrale di Kiev e minare alla radice il suo tentativo di riportare l´unità
nel Paese280.
276
Dichiarazioni rilasciate personalmente da H. van Rompuy a chi scrive, durante un incontro con i tirocinanti del Segretariato Generale del Consiglio dell´UE, 26 maggio 2014. 277
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/05/24/ucrainaribelli-donetskqui-seggi chiusi_825415ef-91ec-4687-9dc6-82fb26c71a41.html 278
http://www.bbc.com/news/world-europe-26822741 279
http://www.repubblica.it/esteri/2014/05/25/news/presidenziali_ucraina-87137350/ 280
A. Wierzbowska-Miazga, M. Menkiszak, "Russia to Ukraine: subversion and diplomacy", OSW analysis, 8 maggio 2014.
124
Il prossimo importante passo sarà lo scioglimento del Parlamento e
l´indizione di elezioni anticipate281: gli attuali deputati, eletti nel 2012 in totale
mancanza di trasparenza, non sembrano più essere rappresentativi della vera
struttura della popolazione dopo gli ultimi avvenimenti. Un altro argomento
dibattuto nelle ultime settimane riguarda un eventuale processo di
decentralizzazione: date le mutate circostanze, la situazione ancora non
chiaramente definita in Crimea e le rivendicazioni nell'Est del Paese, ritornare alla
pace potrebbe implicare il riconoscimento di maggiori autonomie a livello
regionale. Fonti vicine al governo ucraino tuttavia ritengono questo processo una
minaccia all'unità nazionale282.
Sarà presto chiaro se e in quale misura l´Ucraina sarà davvero in grado di
voltare pagina e di intraprendere il cammino delle riforme per la ricostruzione
delle istituzioni politiche e dell'economia.
281
A. Aslund, "Dissolve the Ukrainian Parliament!", Peterson Institute for Economic Studies, 27 marzo 2014. 282
Amb. K. Yelisieiev, Rappresentante Permanente dell'Ucraina presso l'UE, intervento alla conferenza "The Ukraine Crisis between Stabilization efforts and Sanctions", organizzata dalla Hanns Seidel Foundation al Goethe Institute di Bruxelles, 14 maggio 2014.
125
CONCLUSIONI
Questa tesi ha cercato di delineare i tratti principali delle relazioni tra
Unione Europea e Ucraina all'interno della Politica Europea di Vicinato e del
Partenariato Orientale. Per spiegare lo stato di crisi in cui versa il Paese,
analizzare le dinamiche ed i processi politici ed economici del passato si è rivelato
utile ad inquadrare nel loro contesto gli avvenimenti attualmente in corso.
Nella Parte Prima si sono ripercorsi gli anni successivi all'indipendenza del
1991, caratterizzati soprattutto dalla necessità di consolidare la sovranità
territoriale per garantire la sicurezza dell'Ucraina, di dotarla di istituzioni
democratiche e di una Costituzione, nonché di iniziare il processo di
trasformazione verso un'economia di mercato. In questo contesto, è stata
affermata almeno a livello retorico la volontà di intraprendere il percorso di
integrazione europea. L'evidenza empirica tuttavia ha messo in luce come le
dichiarazioni dei presidenti Kravchuk e Kuchma non abbiano portato nella realtà
ad un'effettiva modernizzazione del Paese.
Nel grande allargamento del 2004, l'Ucraina non figurava tra gli Stati
facenti il loro ingresso nell'Unione. Bruxelles, grazie alla spinta dell'allora
Presidente della Commissione Romano Prodi, ha elaborato la Politica Europea di
Vicinato come quadro per sviluppare le relazioni con i Paesi, ad Est e a Sud, senza
una prospettiva concreta di adesione. Lanciata nel 2004, la PEV rappresenta
un´alternativa alla geopolitica tradizionale, un mezzo con cui l´UE si propone di
allargare lo spazio di "pace, stabilità e prosperità" oltre i suoi confini
promuovendo la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto e l´economia di
mercato nei Paesi vicini. Lo scoppio della crisi in Ucraina tuttavia rappresenta
un´ulteriore prova di come la PEV non riesca, a dieci anni dalla sua adozione, a
conseguire gli ambiziosi risultati prefissati.
Dopo averne introdotto il contesto politico, nella Parte Seconda è stato
126
affrontato il caso specifico dell'Ucraina. Il meccanismo della PEV prevede la
redazione congiunta di un Piano d'Azione bilaterale (adottato nel 2005) e una serie
di rapporti annuali stilati dalla Commissione Europea per monitorare i progressi
compiuti dall'Ucraina nel processo di riforme politiche ed economiche.
Cercando di non trascurare il carattere multidimensionale della PEV, nel
capitolo 4 è stata approfondita la sua dimensione commerciale: dopo l'Accordo di
Partenariato e di Cooperazione del 1994, le riforme nel quadro della PEV hanno
aiutato l'Ucraina ad aderire all'OMC nel 2008, permettendo alle relazioni con l'UE
di compiere un salto qualitativo e proseguire i negoziati per un DCFTA. L'aspetto
geopolitico di questo processo apparentemente tecnico è emerso con la nascita nel
2010 dell'Unione Doganale Euroasiatica, conseguente al lancio del Partenariato
Orientale da parte dell'UE nel 2009. Sentendosi minacciata dal potenziale
aumento del livello di integrazione tra le ex Repubbliche Sovietiche e Bruxelles,
la Federazione Russa ha avviato un progetto parallelo con lo scopo di raggiungere
nel 2015 una vera e propria Unione Economica Euroasiatica. Nella tesi si è messo
in evidenza come l'UE abbia sottovalutato l'importanza del progetto di Unione
Doganale per la Russia, continuando ad interpretare la PEV in modo
"tecnocratico" senza tenere debitamente conto dela sua componente politica e
strategica.
La necessità di una nuova chiave di lettura è evidente se si considera il
meccanismo di condizionalità adottato nella PEV: mutuato dalla Politica di
Allargamento dopo i suoi indiscutibili successi nel 2004, questo strumento perde
gran parte della sua leva negoziale senza un obiettivo chiaramente definito, com'è
invece l'adesione nel caso dei Paesi candidati. Anche durante la crisi attuale, è
importante evidenziare che i rappresentanti politici ucraini restano convinti della
necessità che l'UE offra un concreto percorso per una futura membership
dell'Ucraina283. Pur ammettendo che l'Unione rappresenti comunque un'opzione
283
Amb. K. Yelisieiev, cit.
127
appetibile all'Ucraina tramite la sua integrazione con mercato più grande del
mondo, una progressiva liberalizzazione dei visti e supporto tecnico e finanziario
per le riforme, dalle argomentazioni sviluppate nella tesi è risultato che sono i
costi politici di breve termine ad influenzare le scelte delle élites ucraine: un
chiaro esempio è rappresentato dalla detenzione dell'ex Primo Ministro Yulia
Tymoshenko. Sarebbe tuttavia riduttivo affermare che la mancanza di una
concreta prospettiva di membership per l'Ucraina sia l'unico fattore da considerare
per spiegare la scarsa efficacia della PEV: nella tesi si è fatto riferimento alla
cronica instabilità politica che caratterizza il Paese, all'influenza dell'oligarchia ed
alle pressioni esterne provenienti da Mosca, che ha piú volte utilizzato come arma
politica la dipendenza dell'Ucraina soprattutto nel settore energetico. A riprova di
questo atteggiamento, le sanzioni comminate a Kiev nell'estate del 2013 per
dissuadere il Presidente Yanukovych dal firmare l'Accordo di Associazione con
l'UE al Summit di Vilnius.
L'ultimo capitolo ha introdotto la crisi ucraina, scoppiata con le proteste in
Piazza Maidan a Kiev: senza la pretesa di essere esaustivo né di formulare
conclusioni a proposito, dato che si tratta di un processo ancora in corso, ha messo
in evidenza come ancora una volta l'azione esterna dell'Unione Europea non riesca
ad essere incisiva nemmeno trattandosi di un Paese ad essa limitrofo: se da un lato
le dichiarazioni dei leader europei esprimono un unanime messaggio di condanna
alle violenze e alle azioni militari di Mosca, dall'altro gli Stati Membri rimangono
divisi nella strategia da adottare per cambiare il tragico susseguirsi degli eventi.
Questo si deve ai loro interessi politici ed economici divergenti e al diverso
approccio che ciascuno di essi ha scelto per impostare le proprie relazioni
bilaterali con la Federazione Russa.
Nei prossimi mesi e anni sarà quindi necessario un processo di revisione
complessiva della PEV, partendo proprio dagli aspetti che finora hanno
dimostrato le maggiori lacune. Stephan Lehne sostiene che la "PEV II" dovrà
128
essere "più onnicomprensiva, più flessibile e soprattutto più politica"284. Questo
implica in primo luogo una riflessione complessiva sulla sua stessa metodologia:
l'approccio top-down seguito dalla Commissione si è rivelato incapace di
coinvolgere a fondo la classe politica ucraina, dominata dai suoi interessi di breve
termine e riluttante ad assumersi i costi e le responsabilità dell'implementazione
delle riforme caldeggiate da Bruxelles; inoltre questo approccio non è stato finora
in grado di coinvolgere la società civile, ancora oggi molto divisa sulla reale
importanza dell'integrazione europea per il Paese. Un altro aspetto da tenere in
considerazione è la necessità di accompagnare lo sviluppo delle relazioni bilaterali
con i Paesi del vicinato orientale con un dialogo solido e strutturato con la
Federazione Russa, il maggiore portatore di interessi nella regione. Un tale
percorso trascende la dimensione della PEV per coinvolgere altre politiche
dell'UE, che alla luce della crisi ucraina necessitano di essere riconsiderate: si
dovrà infatti realizzare la necessità e l'urgenza di dotarsi di una vera politica
estera, di sicurezza e di difesa comune, nonché di un vero e proprio mercato unico
dell'energia che diminuisca sensibilmente la dipendenza dell'Europa negli
approvvigionamenti.
284
S. Lehne, "Time to reset the European Neighbourhood Policy", cit. Traduzione dell´autore.
129
BIBLIOGRAFIA
1. Documentazione officiale
Assemblea parlamentare NATO, Sottocommissione sulla cooperazione e la convergenza
economica Est-Ovest, "La transizione in Ucraina", 065 ESCEW 06 (2006).
Commissario Ferrero Waldner, Conferenza stampa di lancio dei primi sette Piani
d'Azione nella Politica Europea di vicinato, Bruxelles, 9 dicembre 2004
SPEECH/04/529.
Commissione Europea, Alto Rappresentante dell´UE per gli Affari Esteri e la Politica di
Sicurezza, "Comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Una risposta nuova ad un
vicinato in mutamento", COM(2011) 303 definitivo, Bruxelles, 25.5.2011.
Communication from the Commission to the Council on the Commission proposals for
action plans under the European Neighbourhood Policy (ENP), Brussels, 9 December
2004 COM(2004) 795 final.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – The Commission’s
Work Programme for 2002, COM(2001)620 final, Brussels, 5 December 2001.
CPLRE, Raccomandazione 102 (2001) 1 sulla democrazia locale e regionale in Ucraina,
Discussa ed adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 9 novembre 2001
(vedi Doc. CG (8) 22, progetto di raccomandazione presentato dai Sigg. L. Kieres e L.
Roppe, relatori).
Eurasian Development Bank´s Saint Petersburg Centre for Integration Studies, "Ukraine
and the Customs Union", Report 1, 2012, 29.
Eurasian Economic Commission, "Eurasian Economic Integration: facts and figures",
2013.
European Commission, HR of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, Joint Staff
Workink Paper on "Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010
Report: Eastern Partnerhip" COM(2011) 303, Brussels, 25/05/2011.
130
S. Füle, "Ukraine: relations with the EU at the cross-road", discorso tenuto presso lo
European Policy Centre, Bruxelles, 27 febbraio 2012.
International Energy Agency, "Ukraine 2012", Energy Policy Beyond IEA Countries,
Report 2012.
Joint Statement on Presidential Elections in Ukraine by President of the European
Council Herman van Rompuy and President of the European Commission José Manuel
Barroso, 26 maggio 2014, EUCO 116/14.
Letter by the Swedish Foreign Minister Anna Lindh and Trade Minister Leif Pagrotsky, 8
Marzo 2002.
Letter by UK Foreign Minister Jack Straw to the Spanish Presidency of the EU, 8 gennaio
2002.
R. Prodi, "A Wider Europe – A Proximity Policy as the key to stability", discorso tenuto
presso “The Sixth Ecsa World Conference on peace, stability and security”, Bruxelles, 5
dicembre 2002.
Secretary General/High Representative: Common Strategies report, Brussels 21
December 2000, declassified 30 January 2001, 14871/00, CAB 21.
Verkhovna Rada, "On the key directions of the Foreign Policy of Ukraine", 2 luglio 1993.
2. Volumi
M. Cremona (a cura di), "Developments in EU external relations law", Oxford University
Press, 2008.
J. Horst, A. Jünemann, D. Rothe (a cura di), "Euro-Mediterranean relations after the
Arab spring : persistence in times of change ", Farnham, Ashgate 2013.
A. Lewis (a cura di), "The EU & Ukraine : neighbours, friends, partner?", Londra,
Federal Trust, 2002.
P. R. Magocsi, "A History of Ukraine: The Land and Its Peoples", University of Toronto
Press, 2010.
131
S. Milcher, B. Slay, M. Collins, "The economic rationale of the European
Neighbourhood Policy", in A. Aslund, M. Dabronwski (a cura di), "Europe after
Enlargement", Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 165-188.
Ott e Inglis (a cura di), "Handbook of European Enlargement", TMC, Asser, 2002.
F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier (a cura di), "The Europeanization of Central and
Eastern Europe", Ithaca, Cornell University Press 2005.
J. Sherr, "Ukraine´s New Time of Troubles". Camberley: Conflict Studies Research
Centre, 1998.
M. Święcicki, "Ukrainian Economy and Economic Reforms", in T. Kuzio, D. Hamilton (a
cura di), "Open Ukraine: Changing Course Towards A European Future", The Johns
Hopkins University, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS),
Center for Transatlantic Relations, Washington, D.C. 2012.
S. Velychenko (a cura di), "Ukraine, the EU and Russia. History, Culture and
International Relations", Studies in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan,
2007.
R. Wolczuk, "Ukraine's foreign and security policy, 1991-2000", Routledge, 2002R.
3. Articoli, analisi ed approfondimenti
R. Alcaro e M. Comelli, "La politica europea di vicinato", IAI Quaderni n. 22, marzo
2005.
A. Aslund, "Dissolve the Ukrainian Parliament!", Peterson Institute for Economic
Studies, 27 marzo 2014.
Prof. V. Bakirov, "The study of ethnic minorities in Ukraine", ENRI-East presentation
paper, 2011.
E. Barbé et al., "Which rules shape EU external governance? Patterns of rule selection in
foreign and security policies", in Journal of European Public Policy, 16:6, 834 — 852,
2009
132
T. Beichelt e R.Pavlenko, "The Presidential election and constitutional reform", in H.
Kurth e I. Kempe (a cura di), "Presidential election and orange revolution. Implication
for Ukraine´s transition". Friedrich Ebert Stiftung, Kiev, 2005, pp. 50-85.
J. Blanke, "Assessing Ukraine´s competitiveness amid political change", Centre for
Strategic Insight, World Economic Forum, 2004.
N. Bobitski, "Do ut des? The need for true reciprocity in the European Neighbourhood
Policy", European Foreign Affairs Review, 13: 449-472, 2008.
Boedeltje, Freerk (2012). “The Other Spaces of Europe: Seeing European Geopolitics
Through the Disturbing Eye of Foucault’s heterotopias”. Geopolitics , 17 (1), 1-24.
J. Boonstra, N. Shapovalova, "The EU’s Eastern Partnerhip: one year backwards",
FRIDE, maggio 2010.
T. Buba, "Russian-Ukrainian Relations and the Black Sea Fleet", Georgetown
University, The International Affairs Review, vol. XIX n. 1, primavera/estate 2010.
M. Bugriy, "Strategic Flexibility a key issue for Ukraine in trade relations with Russia
and the EU", in Foreign Policy Journal, 2011.
T. Casier, "The EU's two-track approach to democracy promotion: the case of Ukraine",
Democratization, 18(4), 956-977, 2011.
J. T. Checkel, "Compliance and Conditionality", ARENA Working Paper Series n. 18,
2000
A. K. Cianciara, ‘‘Eastern Partnerhip’ – opening a new chapter of Polish Eastern policy
and the European Neighbourhood Policy?’, Analyses & Opinions, No. 4/2008, Varsavia,
The Institute of Public Affairs, giugno 2008.
M. Comelli, N. Pirozzi, Istituto Affari Internazionali (a cura di), "La politica estera
dell'Unione Europea dopo Lisbona", Osservatorio di Politica Internazionale,
Approfondimenti No 72, febbraio 2013.
M. Cremona, C. Hillion, "L'Union fait la force? Potentials and limitations of the
European Neighbourhood Policy as an integrated EU Foreign and Security Policy", EUI
Working Papers LAW No 2006/39.
133
R. Dragneva, K. Wolczuk, "Russia, the Eurasian Customs Union and the EU:
Cooperation, Stagnation or Rivalry?", Chatham House, briefing paper, agosto 2012, REP
BP 2012/01.
M. Dassú, "Ecco perché la sfida di Putin aiuta l´Europa", editoriale pubblicato in La
Stampa, 7 aprile 2014.
J. Dempsey, "Europe looks on as Russia marches through Ukraine", Carnegie Europe, 17
aprile 2014.
Eastern European Studies Centre (EESC), "Why the Ukraine cannot become a EU
Member?", analytical survey 1 (1), 2009.
EESC, "Eurasian Union: a challenge for the European Union and Eastern Partnerhip
Countries", Vilnius, 2012
M. Emerson et al., "The Prospect of Deep Free Trade between the European Union and
Ukraine", Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles-Kiev 2006.
Parlamento Europeo, DG "External Policies", "The Shale gas 'revolution' in the United
States: Global implications, options for the EU", Policy briefing, aprile 2013.
G. Flikke, "Norms and Conditionality: the EU and Ukraine", Oslo, Norwegian Institute
for International Affairs, Policy Brief 15/2013.
M. R. Freire, "Ukraine´s multivectorial foreign policy: looking West while not
overlooking its Eastern neighbour", UNISCI Discussion Papers, Nº 20 (Mayo / May
2009)
P. Gauttier, "Horizontal coherence and the external competences of the European
Union", (2004) 10ELJ 23
N. Ghazaryan, ‘The ENP and the Southern Caucasus: Meeting the Expectations?’, Global
Europe Papers 5 (2008).
R. Giucci (Berlin Economics/German Advisory Group Ukraine), "EU-Ukraine. Deep and
Comprehensive Free-trade Area. New Opportunities for Europe", conferenza
internazionale all´Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma, 19 novembre 2013.
E. Gnedina, N. Popescu, "The European Neighbourhood Policy´s first decade in the
134
Eastern Neighbourghood", CIES, July 2012.
P. Ivan, "EU's sanctions against Russia - the dpneed for clear goals", European Policy
Centre, 21 marzo 2014.
R. James, A. Tsintsiruk, "Ukraine needs an economic freedom reset", the Heritage
Foundation, 14 settembre 2011.
S. Kardaś, " Putin challenges Brussels to a gas duel", OSW analysis, 14 aprile 2014.
J. Kelley, "New wine in old wineskins: policy adaptation in the European Neighbourhood
Policy", (2006) Journal of Common Market Studies Volume 44, n.1 , p. 29-55.
I. Kempe, ‘A New Ostpolitik? Priorities and Realities of Germany’s EU Council
Presidency’, CAP Policy Analysis, No. 4 / 2007, Monaco di Baviera, Bertelsmann Group
for Policy Research, luglio 2007.
T. Kistnyuk, “Energy Efficient Ukraine: Is There a Light at the End of the Tunnel?”
Ukrainian Energy, August 31, 2011.
P. Kościński, I. Vorobiov, "Do Oligarchs in Ukraine Gain or Lose with an EU
Association Agreement?", The Polish Institute of International Affairs (PISM), Bulletin n.
86 (539), 19 Agosto 2013.
E. Kropatcheva, "Ukraine's EU Integration during the Presidency of Viktor Yanukovych",
University of Tartu, Centre for EU-Russia Studies (CEURUS), febbraio 2014.
P. Kubicek, "The European Union and democratization in Ukraine", Journal of
Communist and Post-Communist Studies, 38 (2), 269-292, 2005.
S. Kudelia,"When external leverage fails. The Case of Yulia Tymoshenko´s trial",
Problems of Post-Communism, vol. 60, n. 1, gennaio-febbraio 2013, pp. 29-42.
J. Langbein, K. Wolczuk, "Convergence without membership? The impact of the
European Union in the neighbourhood: evidence from Ukraine", Journal of European
Public Policy, 19:6, 863-881, (2012).
Lannon, Van Elsuwege, "The EU's emerging Neighbourhood Policy and its potential
impact on the Euro-Mediterranean partnerhip", in P. Xuereb (a cura di), "Euro-Med
integration and the "ring of friends": the Mediterranean's Europe challenge", European
135
Documentation Centre, vol. IV, 2003.
S. Lavenex, F. Schimmelfennig (a cura di), "EU external governance: projecting EU
rules beyond membership", Routledge, Journal of European Public Policy Studies, 2005.
S. Lehne, "Time to reset the European Neighbourhood Policy", Carnegie Europe,
Febbraio 2014.
M. Maigre, "The EU Can Take a Number of Concrete Steps in Crimea", Tallinn,
International Centre for Defence Studies, giugno 2009.
S. Matuszak, “How Ukrainian Oligarchs View Economic Integration with the EU and
Russia”, EASWEEK, 14 settembre 2011.
S. Matuszak, "The oligarchic democracy: the influence of business groups on Ukrainian
politics", Varsavia, Centro di Studi Orientali (OSW), 2012.
I. Melnyovska, R. Schweickert, T. Kostiuchenko, "EU Neighbourhood Europeanization
and European Identities of Elites in Ukraine", paper presentato alla conferenza "Elites
and the Formation of Identity in Post Soviet Space", Università di Cambridge, 11 giugno
2010.
P. Miltner, "The Union for the Mediterranean and the Eastern Partnerhip: A
Comparative Analysis". Natolin Best Master Thesis 02 / 2010, Master Thesis in European
Interdisciplinary Studies, Academic Year 2009/2010. Master Thesis Supervisor: Prof. Dr.
Erwan Lannon.
V. Movchan, R. Giucci, "Quantitative Assessment of Ukraine´s Regional Integration
Options: DCFTA with European Union vs. Customs Union with Russia, Belarus and
Kazakhstan", Berlino/Kiev, 2011, 2.
A. Paul, "Ukraine on the edge", European Policy Centre, 24 aprile 2014.
H. Perepelytsia, "Geopolitical aspect of Russia's energy policy in relations with Ukraine
and the EU", in "EU-Ukraine relations: in the focus of energy security", Foreign Policy
Research Institute, International Review n. 1(9), marzo 2009.
S. Pifer, "Ukraine, Europe, and Tymoshenko: does Yanukovic get it?", Up Front, 19
settembre 2011.
136
S. Pifer, "Ukraine´s Foreign Policy: Losing Its Balance", Brookings Institution, maggio
2012.
S. Pirani et al., "What the Ukrainian crisis means for gas markets", Oxford Institute for
Energy Studies, 2014.
A. Prankevicius, "What the Crimea crisis means for Europe", intervista a Nouvelle
Europe il 15 aprile 2014.
O. Protsyk, "Majority-Minority Relations in the Ukraine", European Centre for Minority
Issues JEMIE 7 (2008).
V. Ratsiborynska, "The European Neighbourhood Policy through its "Europeanization":
the case of Ukraine", L´Europe Unie/United Europe, No. 6/2012.
J. Reinhard, "EU Democracy Promotion through Conditionality in its Neighbourhood:
the Temptation of Membership Perspective or Flexible Integration?", Caucasian Review
of International Affairs, vol. 4(3) - Estate 2010.
R. Sadowski, "Partnerhip in times of crisis. Challenges for the Eastern European
Countries´integration with Europe", Centre for Eastern Studies, N. 36, Varsavia, Luglio
2013.
G. Sasse, "The European Neighbourhood Policy: conditionality revisited for the EU´s
Eastern Neighbours", Routledge, Europe-Asia Studies, Vol. 60, No 2, Marzo 2008, 295-
316.
N. Shapovalova, B. Jarabik, "Crimea: Next Flashpoint in the European
Neighbourhood?"FRIDE Policy Paper n. 14 - luglio 2009.
O. Shumylo-Tapiola, "The Eurasian Custo ms Union: Friend or Foe of the EU?", the
Carnegie Papers, Carnegie Europe, ottobre 2012
K.E. Smith, "The outsiders: the European Neighbourhood Policy", International Affairs
81, 4 (2005).
J. Stern, "The Russian-Ukrainian gas crisis of January 2006", Oxford Institute for Energy
Studies, Oxford University Press 2006.
J. Techau, "Europe’s Neighbourhood Policy is in Trouble, but Not Beyond Saving",
137
Carnegie Europe, 7 aprile 2014.
O. Thranert, M. Zapfe, "The ambivalent implications of Crimea", Carnegie Europe, 28
marzo 2014.
H. Timmermann, "Die EU un die "Neuen Nachbarn" Ukraine und Belarus", SWP Studie,
Berlin, Stiftung Wissenschaft und Politik, 2003.
M. Vahl, "A privileged partnerhip: 'EU-Russian relations in a comparative perspective",
DIIS Working Paper, 3, 2006, 9-11.
M. Verda, "Crisi ucraina: per il gas dell'Europa il problema non è la Russia", ISPI, 7
aprile 2014.
M. Verda, "La crisi ucraina ed il transito di gas russo verso l'Europa", Istituto Italiano di
Studi Strategici "N. Machiavelli", Machiavelli Edizioni, marzo 2014.
Prof. R. Vilpišauskas et al., "The Eurasian Customs Union: a challenge for the European
Union and Eastern Partnerhip Countries", Eastern European Studies Centre (EESC),
Vilnius, July 2012.
W. Wallace, "Looking after the Neighbourhood: responsibilities for the EU-25", Policy
paper No. 4, Paris, Groupement d´Etudes et des Recherches, Notre Europe, 2003, pp. 8-9.
A. Wierzbowska-Miazga, M. Menkiszak, "Russia to Ukraine: subversion and
diplomacy", OSW analysis, 8 maggio 2014.
A. Wilson, "Ukraine votes", European Council on Foreign Relations, 26 maggio 2014.
K. Wolczuk, "Integration without Europeanization: Ukraine and its Policy towards the
European Union", EUI Working Papers RSCAS No. 2004/15.
K. Wolczuk, "Adjectival Europeanisation? The Impact of EU Conditionality on Ukraine
under the European Neighourhood Policy", European Research Working Paper Series
No. 18, ERI 2007.
K. Wolczuk, "Catching up with 'Europe'? Constitutional Debates on the Territorial-
Administrative Model in Independent Ukraine", Regional and Federal Studies, vol. 2 (2),
2002
138
K. Wolczuk, "Implementatn without coordination: the impact of EU conditionality on
Ukraine under the European Neighbourhood Policy", Europe-Asia Studies, 61:2, p187-
211, 2009.
K. Wolczuk, "Ukraine and the EU: turning the Association Agreement into a success
story", European Policy Centre 23 aprile 2014.
R. Wolczuk, "Will the Orange Revolution bear fruit? EU–Ukraine relations in 2005 and
the beginning of 2006", Varsavia, Stefan Batory Foundation, 2005.
Woronowycz, “Ukraine named among most corrupt countries of the world,” The
Ukrainian Weekly, 1 ottobre 2000, No. 40, Vol. LXVIII
R. Yakemtchouk, "L´Union Européenne et l´Ukraine", Revue du Marché commun et de
l’Union européenne n. 470, luglio-agosto 2003, p. 433-441.
K. Zarembo, "EU-Ukraine FTA: what do oligarchs think?", Kiev, Institute of World
Policy (IWP), Policy Brief n. 1/2012.
A.M. Zlenko (intervista), "Un passo importante per l´Europa", in Holos Ukrainy, 17
giugno 1994.
A. M. Zlenko, "Foreign policy interestes of Ukraine and problems of European security",
Fordham international law journal vol. 21, no 1, Nov. 1997, p. 45-64.
A. Zotti, "The EU diplomacy under review", ISPI, analisi n. 214, dicembre 2011.