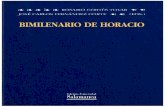Dalla 'cohors Ascalonitana' agli arruolamenti in Italia centrale. La carriera di un anonimo...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dalla 'cohors Ascalonitana' agli arruolamenti in Italia centrale. La carriera di un anonimo...
1. Vorrei proporre in questa sede alcune riflessioni su un’iscrizione perduta (CIL, IX 3664, qui fig. 1), che a mio giudizio è stata finora radicalmente fraintesa. Vista a San Benedetto dei Marsi, antica Marruvium, dal Brunn, dal Mommsen e dal Fernique, è tra le tante iscrizioni della zona di cui si sono perse le tracce dopo il disastroso terremoto della Marsica del 1915. Sulla sua interpretazione ha pesato come un macigno il suggerimento del Mommsen, che nella menzione di Germanico alla lin. 7 riconosceva una datazione consolare al 18 d.C.: Germanico Caesare II [L. Seio Tuberone co(n)s(ulibus)]. Anche l’integrazione tra[dunt] da lui proposta alla fine della lin. 5 risulta fuorviante.
D’altra parte, che si trattasse di un testo di notevole interesse s’intuisce già dal fatto che in esso ricorrano non solo i nomi di Tiberio e Germanico, ma anche un’espressione come ordini scripsit, che fa pensare a un’epistola inviata da un imperatore a un senato municipale, e termini come principes e imperium. Vale dunque certamente la pena di riesaminare questo testo, per verificare se possa dirci qualcosa di più.
* Dedico volentieri queste pagine a Silvio Panciera, genius loci della Rencontre e punto di riferimen‑to per tutta la comunità degli epigrafisti. È un omaggio modesto, ma sincero, e assume valore essenzialmente
Cesare Letta
DALLA COHORS ASCALONITANA AGLI ARRUOLAMENTI IN ITALIA CENTRALE. LA CARRIERA DI UN ANONIMO MARRUVINO DI ETÀ
GIULIO-CLAUDIA (CIL, IX 3664)*
1136 C. LETTA
2. Fondamentale per inquadrare epoca e contenuto dell’iscrizione è il nome di Tiberio alla lin. 2. Poiché esso appare nella forma Ti(berius) Caesar, senza Aug(ustus), può riferir‑si solo a Tiberio prima della sua ascesa alla porpora imperiale, cioè prima della morte di Augusto. Questo consente di escludere la lectio facilior che sembrerebbe implicitamente suggerita dal Mommsen, secondo la quale l’iscrizione riprodurrebbe il testo di un’epistola scritta dall’imperatore Tiberio al senato municipale di Marruvium nel 18 d.C., al tempo del secondo consolato di Germanico.
Si potrebbe certo pensare che il nome di Germanico non abbia nulla a che fare col contenuto delle prime linee e che queste, in realtà, parlassero di una lettera ufficiale indiriz‑zata al senato di Marruvium da Tiberio prima del 14 d.C., quando era ancora solo principe ereditario, ma allora bisognerebbe ammettere che la frase imperniata sul verbo scripsit com‑prendesse solo le linn. 2-3, e che la lin. 1 costituisse una frase a sé, mentre mi sembra assai più probabile che essa facesse parte della stessa frase.
Se si ammette questo, si dovrà pensare che alla lin. 1, comprendente la parola Aug., fosse ricordato Augusto per qualcosa che aveva fatto ancora da vivo, quando cioè Tiberio non aveva ancora il titolo di Augustus. In altri termini, questa prima frase ricorderebbe un’azione ufficiale di Augusto vivo, che aveva in qualche modo coinvolto anche il principe ereditario Tiberio: dunque nel periodo tra il 4 (adozione di Tiberio) e il 14 d.C. (morte di Augusto).
Possiamo perciò essere pressoché certi che la parola Divos con cui si apre l’iscrizio‑ne non sia un accusativo plurale da riferire a più imperatori divinizzati, ma un nominativo singolare, stia cioè per Divus, e in unione con Aug(ustus) designi Augusto come soggetto di un’azione; naturalmente Augusto qui è detto divus perché l’iscrizione è stata incisa dopo la sua morte, ma viene menzionato per qualcosa che aveva fatto da vivo, prima di cedere il posto a Tiberio.
Con queste premesse, è ragionevole supporre che il soggetto di scripsit, cioè l’autore dell’epistola al senato di Marruvium, fosse Augusto, e non Tiberio, anche se bisognerà cerca‑re di capire come mai anche il nome di Tiberio figuri al nominativo.
3. Che l’iscrizione alluda a questa epistola imperiale, è di per sé evidente, ma non è altrettanto chiaro se possa considerarsi essa stessa il testo dell’epistola. Certamente l’inci-pit dell’iscrizione non può essere l’incipit dell’epistola, perché in quest’ultimo Augusto non poteva essere detto divus ma doveva figurare con la sua titolatura completa, le tribuniciae potestates e i consolati. Ma anche ammettendo che questa parte iniziale sia una sorta di pre‑sentazione o didascalia introduttiva premessa all’epistola, si deve comunque riconoscere che anche quello che viene subito dopo scripsit non può essere la diretta trascrizione dell’episto‑la, perché comincia ex abrupto con un pronome relativo cuius che lega strettamente questa parte a quella precedente mostrando che sono elementi di un unico testo.
dall’essere parte del coro spontaneo e affettuoso che da questa comunità si è levato nelle intense giornate romane. Colgo l’occasione anche per ringraziare cordialmente quanti, con le loro osservazioni e i loro suggerimenti, mi hanno permesso di migliorare e completare la mia analisi; ricordo in particolare Werner Eck, Ségolène Demougin, Ivan Di Stefano Manzella, Lidio Gasperini, Attilio Mastino, Marc Mayer e Simonetta Segenni.
DALLA COHORS ASCALONITANA AGLI ARRUOLAMENTI IN ITALIA CENTRALE 1137
Almeno in linea teorica, si può rimanere incerti se cuius debba essere riferito ad Augusto (come mi sembrerebbe più probabile), a Tiberio, all’ordo, all’inquisitio o magari a qualche altra parola perduta in lacuna alle linn. 1-2, ma non possono esserci dubbi sul fatto che questo pronome relativo leghi tra loro le due parti dell’iscrizione, e questo mi sembra suf‑ficiente ad escludere che in essa fosse riportato direttamente il testo dell’epistola di Augusto. Del resto, subito dopo, alle linn. 3-4, c’è una formula che sembra interpretabile solo come riferimento agli imperatori succeduti ad Augusto, che ovviamente non può ammettersi in un’epistola scritta dallo stesso Augusto.
4. Secondo quanto leggiamo alla lin. 2, l’oggetto dell’epistola era un’inquisitio. Si potrebbe pensare a un’inchiesta o un’indagine giudiziaria, ma il fatto che subito dopo si par‑li, come abbiamo appena detto, degli imperatori succeduti ad Augusto e quindi dei comandi militari di un personaggio forse di rango equestre, mi induce a preferire un’altra ipotesi, che cioè il termine inquisitio vada inteso come sinonimo di conquisitio o dilectus, per indicare degli arruolamenti1.
Si potrebbe pensare a un reclutamento ordinato da Augusto, che si sarebbe avvalso, in forme che dovremo cercare di chiarire, della collaborazione di Tiberio. Potrebbe allora trattarsi dello stesso reclutamento che è ricordato come dilectus ingenuorum quem Romae habuit Augustus et Ti. Caesar in un’iscrizione di Alexandria Troas2. È significativo che anche in questo caso Tiberio figuri semplicemente come Ti. Caesar, evidentemente per indicare la sua posizione di collaboratore in subordine in un’operazione voluta e ordinata da Augusto.
Nell’iscrizione di Alexandria si parla di arruolamenti eseguiti a Roma. Se è esatta l’interpretazione che propongo, l’iscrizione marruvina proverebbe che nella stessa occasione furono condotti arruolamenti anche tra i Marsi ed è naturale supporre che l’iniziativa avesse riguardato anche altre aree dell’Italia centrale che fino all’età triumvirale erano state aree tradizionali di reclutamento3.
5. Alle linn. 3-5, come si è detto, sembra celarsi un accenno a vari imperatori succe‑duti ad Augusto: non può trattarsi del solo Tiberio, perché si parla di principes e di succes-siones al plurale, e quindi sono coinvolti per lo meno Tiberio e Caligola. Quanto al contesto,
1 V. ad es. Curt., IV, 6, 30 (Amyntam… in Macedoniam ad inquisitionem novorum militum misit); Plin., ep., X, 30, 2 (nella risposta di Traiano a Plinio); APul., met., VII, 4, 3; cfr. Thes. ling. Lat., VII, 1, c. 1822, linn. 15-21, s.v. inquisitio, II.B.2.
2 G. BeAn, in Cook, Troad, 1973, p. 412, nr. 50, tav. 73 (= AE 1973, 501); v. ora riCl, Inscriptions, 1997, pp. 66 s., nr. 34, con bibl. prec.
3 Cfr. Brunt, Manpower, 1971, pp. 440-509; MAnn, Recruitment, 1983, in partic. pp. 1-11; kePPie, Face, 1997, pp. 89-90. Specificamente per Marsi e Peligni v. Plut., Crass., 6, 3 (nell’83 Silla invia Crasso a reclu‑tare truppe tra i Marsi); Hor., carm., III, 5, 5-12 (Marsi nell’esercito di Crasso a Carre); CAes., b.c., I, 15, 7 (nel 49 a.C. Domitius per se circiter XX cohortes Alba, ex Marsis et Paelignis, finitimis ab regionibus, coegerat, cfr. CiC., ad Att., VIII, 12, 1 e IX, 6, 1); II, 26, 1 e 29, 4 (nel 49 a.C. in Africa ci sono Marsi e Peligni sia tra i pompeiani che tra i cesariani di Curione); luCAn., Phars., IX, 790 (Marsi nell’esercito di Catone Uticense in Africa); più generici, ma molto significativi gli accenni in Hor., carm., I, 2, 40-41 e II, 20, 17-18, in cui i Marsi sono presentati come il nerbo dell’esercito romano (cfr. lettA, Marsi, 1996, p. 512).
1138 C. LETTA
se subito prima si parlava di un arruolamento ordinato da Augusto, è probabile che in questa parte si dicesse che l’operazione fu ripetuta anche dai suoi successori.
La formula scelta per designare i successori di Augusto, che più avanti cercheremo di ricostruire più precisamente, ma che fin d’ora ci appare volutamente vaga, doveva proba‑bilmente servire proprio ad includere anche Caligola, evitando di nominarlo esplicitamente. Questo sembra implicare che l’iscrizione sia stata redatta dopo la morte e la damnatio memo-riae di Caligola, quasi certamente durante il regno di Claudio4.
6. Alle linn. 6-8 la menzione di comandi militari (praefecto sagittar[iorum] alla lin. 6, [praefecto cohortis] / Ascalonitanae alle linn. 7-8) e di una magistratura municipale (IIIIvir[o - - -] alla lin. 8) presuppone che subito prima, cioè necessariamente nella lacuna della lin. 5, figurasse al dativo la formula onomastica di un personaggio locale a cui riferire gli uni e l’altra, in qualche modo collegato alle operazioni di reclutamento di cui si parlerebbe in precedenza5.
La spiegazione più convincente di questo inatteso accostamento tra il ricordo di reclu‑tamenti ordinati dai successori di Augusto e quello del cursus di un personaggio locale con una carriera militare alle spalle è quella suggerita dal confronto con l’iscrizione di Alexandria Troas già ricordata: come in quel caso, per far eseguire a Roma gli arruolamenti ordinati da Augusto con la collaborazione di Tiberio, ci si era serviti dell’esperto ufficiale Gaio Fabricio Tusco, già praef(ectus) cohort(is) Apulae, praef(ectus) operum quae in colonia iussu Augusti facta sunt, trib(unus) mil(itum) leg(ionis) III Cyr(enaicae), e successivamente magistrato municipale nel‑la stessa colonia Alexandria Troas, così nel caso della nostra iscrizione l’esecuzione materiale degli arruolamenti ordinati dai successori di Augusto tra i Marsi sarebbe stata affidata al nostro anonimo ufficiale, già praefectus sagittariorum e praefectus cohortis Ascalonitanae, e succes‑sivamente magistrato municipale a Marruvium, che evidentemente era la sua città.
Questo consente finalmente di capire meglio che tipo di iscrizione è la nostra: anzi‑ché il testo di un’epistola imperiale, sarebbe l’iscrizione onoraria che ricordava i meriti di un ignoto marruvino, incaricato da alcuni imperatori di eseguire tra i Marsi arruolamenti che riprendevano una precedente iniziativa di Augusto. Proprio il richiamo ad Augusto e alla sua epistola al senato di Marruvium, con cui si apre l’iscrizione, serve a sottolineare e ad esaltare l’importanza della missione affidata all’anonimo e il prestigio che gliene era derivato6.
4 Escluderei una datazione ancora più tarda, che implicherebbe per l’anonimo ufficiale marruvino di cui cercheremo di ricostruire la carriera, un’attività troppo prolungata nel tempo (v. oltre, § 12).
5 A lin. 8, tra [praefecto cohortis] Ascalonitanae e IIIIvir[o - - -], figurava un segno d’interpunzione di‑verso dagli altri, simile a quello che figurava a lin. 3 tra scripsit e cuius. Nell’apparato del CIL il Mommsen chiama questi segni virgulae e attribuisce loro un valore di pausa sintattica in fine di periodo (nota virgulas, ubi sententiae finiunt). In realtà questo valore non sembra dimostrato, e in ogni caso il segno a lin. 8 può esprimere semplicemente la volontà di separare, nella carriera del personaggio, i comandi militari dalle magistrature municipali.
6 Non mancano casi di iscrizioni onorarie in cui sono citate lettere ufficiali di un’autorità superiore, come il governatore provinciale, il senato di Roma o l’imperatore: cfr. ad es. AE 1947, 68, linn. 39 s., su cui v. ora FisHwiCk, Priest, 1998, pp. 97-102. Si veda anche oltre, nota 24.
DALLA COHORS ASCALONITANA AGLI ARRUOLAMENTI IN ITALIA CENTRALE 1139
7. In base a quanto appena detto, è evidente che alla lin. 7 il nome di Germanico Cesare non può essere riferito a una datazione consolare, come aveva supposto il Mommsen, perché essa spezzerebbe in modo incongruo il cursus del personaggio locale, interponendosi tra i due comandi militari da lui rivestiti. Il nome di Germanico doveva figurare piuttosto in riferimento al primo di questi comandi, per segnalare che esso era stato rivestito in una spe‑dizione comandata dal figlio di Druso maggiore: [sub] / Germanico Caesare, ovvero [cum] / Germanico Caesare7.
Le due aste verticali dopo Caesare non possono quindi essere intese come un nume‑rale, in riferimento al secondo consolato rivestito da Germanico nel 18 d.C., tanto più se si tiene conto di quanto segnala il Mommsen in apparato: secunda hasta dubia est. Potrebbe trattarsi piuttosto della preposizione in in un’indicazione geografica del teatro di guerra in cui fu rivestito quel comando, ad esempio in [Germania], o meno probabilmente in [Syria]8, oppure della parola im[perator], che però implicherebbe un’asta inclinata9.
8. Per ricostruire le dimensioni delle linee, e quindi poter proporre restituzioni plau‑sibili, sembra decisiva la lin. 6, dove la restituzione praefecto sagittar[iorum qui militaverunt sub] / Germanico Caesare etc. mi sembra l’unica possibile. Va precisato che possiamo tran‑quillamente escludere che le parole comprese nella lacuna fossero abbreviate, perché, a parte Aug(ustus) a lin. 1, l’iscrizione appare priva di abbreviazioni; decisive per questa conclusione appaiono le forme praefecto a lin. 6 e Ascalonitanae a lin. 8, che inducono a ipotizzare nella lacuna della lin. 7 [praefecto cohortis] scritto plenis litteris.
Tornando alla lin. 6, la restituzione appena proposta darebbe una linea di 40 lettere, e a giudicare dall’impaginazione schematicamente riprodotta nella trascrizione del CIL, si può presumere che più o meno lo stesso numero di lettere avessero tutte le linee, salvo la prima, che risulta scritta in caratteri più grandi, e la seconda, che sembra sporgere un po’ sulla sini‑stra e quindi doveva avere circa due lettere in più (42).
Per quanto riguarda la prima, che pure sporge sulla sinistra come la seconda, si può notare che nello spazio corrispondente alle prime 11 lettere della lin. 2, la lin. 1 ne comprende solo 9. Con una semplice proporzione (42 : 11 = x : 9) si può dunque calcolare che la lin. 1 doveva comprendere circa 34 lettere.
7 Cfr. ad es. CIL, V 7007 = ILS 2544, dedica onoraria a un p(rimus) p(ilus) posta dai decuriones alae Gaetulorum quibus praefuit bello Iudaico sub divo Vespasiano Aug(usto) patre; CIL, III 6687 = ILS, 2683: [in] castris divi Aug(usti) s[ub] P. Sulpi[c]io Quirinio; CIL, VI 1451: dedica a L. Mario Massimo Perpetuo Aureliano, cos. II nel 223 d.C., posta da qui sub eo militaver(unt).
8 Formule di questo tipo sono comunissime; tra i tanti esempi possibili ricordo quello del marso M. Vettio Scatone, [trib]uno militum in / [Germania legio]nis (quartae) Macedonicae (CIL, IX 3649, nella ricostru‑zione di lettA, Vettio, 1990, pp. 317-328). L’integrazione in [Syria] sarebbe forse preferibile per la lunghezza, ma - come mi fa notare W. Eck - in Siria il nostro personaggio sarebbe stato, almeno ufficialmente, agli ordini di Pisone e non di Germanico. Non escluderei tuttavia in [Syria], se la formula fosse stata, con voluta ambiguità, [cum] Germanico Caesare anziché [sub].
9 Cfr. ad es., nella già ricordata iscrizione di Alexandria Troas (supra, n. 2), la formula hasta pura et corona / aurea donatus est a Germanico / Caesare imp(eratore) bello Germanico.
1140 C. LETTA
9. Riesaminiamo ora la prima frase, alle linn. 1-3. Il fatto che figurino al nominativo sia Augusto che Tiberio potrebbe far pensare che l’epistola fosse stata inviata da entrambi: il singolare scripsit potrebbe infatti valere per l’uno e per l’altro, come nell’iscrizione di Alexandria Troas più volte ricordata, dove leggiamo dilectus … quem Romae habuit Augustus et Ti. Caesar. Ma una lettera firmata insieme da Augusto e Tiberio, di cui mancano esempi e che implicherebbe una vera correggenza formalmente paritetica, come ai tempi di Marco Aurelio e Lucio Vero o di Severo e Caracalla, mi sembra del tutto improbabile.
Penserei piuttosto che, una volta deciso di procedere ad arruolamenti in Italia, Augusto avesse incaricato Tiberio di studiare per lui la situazione e suggerire le possibili aree di re‑clutamento. Questo piano operativo, che includeva il territorio di Marruvium, doveva essere contenuto in una relazione scritta (commentarius), a cui Augusto potesse far riferimento nella sua epistola, così come nella tabula Clesiana Claudio fa riferimento al commentarius redatto dal suo inviato in Val di Non: cetera quidem ut mihi demons/trata commentario facto ab ipso sunt statuat pronun/tietque ipsi permitto10.
Proporrei quindi qualcosa come Divos Aug(ustus) e[x commentario quem fecerat] / Ti(berius) Caesar de inquisitio[ne novorum militum, Marsorum] ordini scripsit. Con queste restituzioni avremmo a lin. 1 un numero di lettere uguale a quello che avevamo calcolato sul piano puramente teorico (34) e a lin. 2 un numero leggermente diverso (44 anziché 42), ma sostanzialmente accettabile11.
Un’eventuale restituzione de inquisitio[ne militum, ovvero tironum, Marsorum Marr(uvinorum)] / ordini scripsit, che porterebbe a 41 le lettere della lin. 2, mi sembra meno probabile, perché implicherebbe la presenza di un’abbreviazione e soprattutto perché la co‑munità civica di Marruvium era per lo più indicata semplicemente come Marsi12.
10. La frase che viene dopo scripsit doveva in sostanza affermare che anche i prin-cipes succeduti ad Augusto avevano compiuto degli arruolamenti tra i Marsi, e precisare che essi ne avevano affidato l’esecuzione materiale all’anonimo ufficiale marruvino il cui nome, come si è già detto al § 6, doveva essere nella lacuna della lin. 5.
Per questo la parola principes era molto probabilmente il soggetto di un’azione (quel‑la appunto di affidare l’incarico al nostro anonimo) che doveva figurare dopo il cursus del personaggio, in una lin. 9 interamente perduta.
Nel cuius con cui si apre la frase vedrei invece un riferimento ad Augusto, e in parti‑colare al fatto che i suoi successori ne avevano ripetuto l’esempio, rinnovando a distanza di
10 CIL, V 5050 (= ILS 206; CHisté, Epigrafi, 1971, pp. 174-183), su cui v. soprattutto lAFFi, Adtri-butio, 1966, pp. 29-36 e 181-191; sCHillinger-HäFele, Edikt, 1967, pp. 353-365; Frézouls, Tabula, 1981, pp. 239‑252.
11 Ho proposto la formula de inquisitio[ne novorum militum], che troverebbe diretto riscontro nel passo di Curzio Rufo citato a n. 1, perché l’integrazione tironum suggeritami da S. Demougin risulterebbe troppo bre‑ve (e d’altra parte, dato il significato di tironum, l’aggiunta di novorum è da escludere, perché risulterebbe una tautologia).
12 Cfr. già tH. MoMMsen, in CIL, IX p. 349; v. ad es. CIL, IX 3773; lettA - D’AMAto, Epigrafia, 1975, nn. 151 e 176; per altre attestazioni, anche da Roma e dalle province, v. ivi, p. 247.
DALLA COHORS ASCALONITANA AGLI ARRUOLAMENTI IN ITALIA CENTRALE 1141
tempo con gli stessi criteri le operazioni di reclutamento tra i Marsi. Propongo dunque Cuius [praeceptum? secuti etiam] / principes in quos imperi[um populi Romani postea] / per suc-cessiones tra[nslatum est ‑ ‑ ‑].
In questo modo avremmo 40 lettere alla lin. 3 e 41 alla lin. 4, mentre alla lin. 5 reste‑rebbero disponibili solo 10 lettere circa per il nome dell’ufficiale che doveva figurare al da‑tivo dopo tra[nslatum est]. Molto probabilmente il personaggio era privo di cognomen, cosa abbastanza normale per un notabile municipale morto durante il regno di Claudio13. A puro titolo di esempio, per restare ai gentilizi attestati a Marruvium per ufficiali di rango equestre e magistrati municipali dei primi tempi dell’impero, segnalo che un eventuale C. Octavio C.f. occuperebbe esattamente 10 lettere14.
Alla lin. 3 praeceptum mi è sembrato preferibile ad altri termini come exemplum, edic-tum, iussum (più brevi), sententiam, rescriptum (di eguale lunghezza). Alla lin. 5 tra[nslatum est] va preferito a tra[ditum est], perché il verbo tradere (a cui pensava il Mommsen resti‑tuendo tra[dunt]) richiederebbe quibus anziché in quos15.
11. Il cursus del nostro anonimo alle linn. 6-8 si può quindi ricostruire come segue: praefecto sagittar[iorum qui militaverunt sub] / Germanico Caesare ió [Germania?, prae-fecto cohortis] / Ascalonitanae, IIIIvir[o quinquennali Marsis], con 40 lettere alla lin. 6, 43 alla lin. 7 e 39 alla lin. 8.
L’espressione praefectus sagittar[iorum qui militaverunt sub] / Germanico Caesare ió [Germania?] non sembrerebbe riferita ad una singola unità definita e strutturata, ma piut‑tosto a piccoli contingenti aggregati alle legioni. Di certo sappiamo da Tacito che tra le truppe di Germanico operanti in Germania c’erano anche sagittarii16. È più che logico supporre che ce ne fossero anche nell’esercito siriaco al tempo della sua spedizione in Oriente, soprattutto se si considera che il potenziale avversario era l’esercito partico, il cui punto di forza erano proprio gli arcieri a cavallo, divenuti proverbiali come “la freccia del Parto”17.
Una formazione a sé stante di arcieri sembrerebbe invece la cohors Ascalonitana18. Sembra peraltro probabile che, come altre unità denominate dall’originaria area di recluta‑
13 Ancora sotto Claudio anche personaggi di primo piano dell’aristocrazia senatoria erano privi di co-gnomen; si pensi a L. Vitellio (cos. III nel 47 d.C.), M. Vinicio (cos. II nel 45), Q. Veranio (cos. nel 49).
14 Cfr. CIL, IX 3669 (L. Octavius N.f. Ser. Balbus / praef. fabr., praef. castror., prim. pil., / (duo)vir); 3688 ([-] Octavius Laenas, … (quattuor)vir quinq.).
15 Per la costruzione di transferre con in + l’accusativo della persona, cfr. ad es. ter., An., 379: culpam in te transferet; CiC., Tusc., II, 36: quod Spartiatae etiam in feminas transtulerunt; ulP., dig., IV, 7, 4, 3: si quis … litem in alium transtulerit. Sia pure con ad anziché in, la costruzione è attestata anche in relazione alla parola imperium in Rhet. ad Her., IV, 13: imperium orbis terrae… ad se transferre… conarentur (per imperium transfer-re, senza specificazione del destinatario, v. anche tAC., hist., I, 25: suscepere duo manipulares imperium populi Romani transferendum et transtulerunt).
16 Cfr. tAC., ann., II, 9, 2; 16, 3; 17, 6; cfr. sADDington, Development, 1982, pp. 29 s.17 V. ad es. iustin., XLI, 2, 5 e 7; Plut., Crass., 24-27; luCAn., Phars., I, 230 (missa Parthi post terga
sagitta). Cfr. wiDengren, Iran, 1976, p. 290.18 Le altre attestazioni note, tutte più tarde, essendo distribuite tra l’età flavia e il 163 d.C., vengono
dalla Palestina e dalla Siria e documentano la forma cohors I Ascalonitanorum equitata sagittariorum; in CIL,
1142 C. LETTA
mento nel Vicino Oriente, fosse una delle più antiche formazioni composte esclusivamente di arcieri19.
Più difficile è dire se questa carriera militare si possa definire come una carriera eque‑stre o rimanga, come mi suggerisce S. Demougin, a livello di centurionato.
Quanto alla carica municipale, rivestita dal nostro anonimo quasi certamente dopo il congedo e il definitivo rientro in patria, quinquennali (scritto plenis litteris) sembra preferi‑bile a iure dicundo, che comporterebbe una linea di sole 38 lettere.
12. In un’ultima linea interamente perduta, che è necessario postulare dopo la fine del cursus perché la frase di cui i principes sono il soggetto possa concludersi, presumo che ci fosse il termine curam, probabilmente con una specificazione del tipo inquisitionis o dilectus, seguito da un verbo col significato di “affidarono”, ad esempio detulerunt o com-miserunt.
Con una restituzione curam inquisitionis (ovvero dilectus) detulerunt, avremmo un numero di lettere (28 o 23) sensibilmente inferiore a quello delle altre linee, ma se questa era l’ultima linea dell’iscrizione la cosa non avrebbe nulla di strano. Se invece il testo con‑tinuava, ad esempio con una formula di dedica da parte della comunità cittadina, dovremmo immaginare a lin. 9 un testo un po’ più lungo, come potrebbe essere curam inquisitionis no-vorum militum detulerunt, di 42 lettere, o magari, con un esplicito richiamo alla condizione libera delle reclute come nell’iscrizione di Alexandria Troas, una formula come curam dilec-tus ingenuorum habendi detulerunt (o agendi commiserunt), che risulterebbe esattamente di 40 lettere. Ma mi sembra più probabile che la dedica vera e propria occupasse un’altra faccia dello stesso basamento, rispetto alla quale il testo parzialmente conservato avrebbe più o meno la funzione di un elogium.
Si potrebbe per la verità sospettare che il nostro anonimo avesse già curato anche il reclutamento ordinato da Augusto a cui si fa riferimento all’inizio dell’iscrizione, e in tal caso qui dovremmo pensare a un verbo come confirmaverunt. Ma questa eventualità mi sembra molto remota, perché postulerebbe per il nostro anonimo una permanenza in servizio decisa‑mente troppo lunga. Egli, infatti, che per poter essere scelto come dilectator doveva aver già rivestito in precedenza almeno uno dei comandi militari ricordati, avrebbe condotto ben tre arruolamenti distribuiti su un arco di tempo che andava dagli ultimi dieci anni del regno di Augusto (4-14 d.C.) fino al regno di Caligola (37-41 d.C.).
D’altra parte, se è vero che il primo comando fu da lui rivestito agli ordini di Germanico20, i casi possono essere solo due. Se si trattò di un comando ió [Germania], per poter ammettere che ad esso fosse seguito ancora sotto Augusto un reclutamento in Italia,
III 600 = ILS 2724, di età traianea, figura come cohors I Ascalonitanorum fel(ix). Cfr. HolDer, Auxilia, 1980, pp. 204, 206, 232.
19 Cfr. DAvies, Arrowheads, 1977, p. 261 (“Of the 43 known units of auxiliary archers, no fewer than 26 were raised in Syria”); v. anche DABrowA, Cohortes, 1986, pp. 221‑230.
20 Ritengo improbabile che il cursus sia indicato in ordine inverso e che il nostro anonimo fosse stato prima comandante della cohors Ascalonitana e poi prefetto degli arcieri di Germanico.
DALLA COHORS ASCALONITANA AGLI ARRUOLAMENTI IN ITALIA CENTRALE 1143
dovremmo pensare necessariamente all’invio di Germanico sul fronte renano nell’11 d.C.21 e collocare il reclutamento nel 12; abbiamo visto, infatti, che il piano operativo di queste leve straordinarie in Italia sarebbe stato predisposto in loco da Tiberio, il quale solo a partire dal 12 fu presente stabilmente in Italia22. Ma di arruolamenti in Italia nel 12 non si vede bene la necessità e non a caso per il dilectus di cui parla l’iscrizione di Alexandria Troas si è pensato a date diverse: al 6 d.C., in relazione con la rivolta pannonica del 6-8 d.C., oppure al 9-10, come conseguenza della clades Variana23.
Se invece quel primo comando del nostro anonimo fu rivestito ió [Syria], come po‑trebbe indurre a credere la lunghezza dell’integrazione, saremmo rinviati alla spedizione orientale del 18-19 d.C. e avremmo quindi la certezza che egli non possa aver curato già l’ar‑ruolamento ordinato da Augusto, perché non è pensabile che tale incarico gli fosse conferito prima che avesse fatto esperienza di vita militare.
La conclusione che mi sembra di poter trarre è che il personaggio della nostra iscri‑zione fu incaricato di compiere arruolamenti tra i Marsi solo sotto Tiberio e sotto Caligola; pertanto il verbo da restituire nella lin. 9 è molto probabilmente detulerunt.
A questo punto si può tentare una ricostruzione complessiva del testo:
Divos Aug(ustus) e[x commentario quem fecerat]Ti(berius) Caesar de inquisitio[ne novorum militum, Marsorum]ordini scripsit. Cuius [praeceptum? secuti etiam]principes in quos imperi[um populi Romani postea]
5 per successiones tra[nslatum est, ‑ ‑ ‑ c. 10 ‑ ‑ ‑]praefecto sagittar[iorum qui militaverunt sub]Germanico Caesare ió [Germania?, praefecto cohortis]Ascalonitanae, IIIIvir[o quinquennali? Marsis,][curam inquisitionis? (sive dilectus) detulerunt].
In questa ricostruzione può sorprendere che il nome del personaggio onorato figuras‑se solo nella parte finale della lin. 5, senza essere evidenziato in alcun modo per la colloca‑zione e per le dimensioni delle lettere. Considerato, però, il carattere particolare del testo, che sembra concepito come un elogium, ritengo che in esso la menzione del personaggio onorato costituisse una semplice ripresa rispetto a una precedente menzione, fatta con tutto il rilievo del caso.
Si potrebbe quindi pensare che in una o più linee perdute immediatamente precedenti alla prima linea conservata figurasse al dativo, in caratteri più grandi, il nome dell’onorato (forse completo del cognomen e della tribù, che sicuramente dovevano mancare nella lin. 5
21 Cfr. C.D., LVI, 25, 2-3.22 Come attestano i Fasti Prenestini, il 23 ottobre Tiberio celebrò il trionfo ex Pannonis Delmatisque, e
da allora non lasciò più l’Italia: cfr. kienAst, Kaisertabelle, 19962, p. 77.23 Pensa al 6 d.C. Brunt, Fabricius, 1974, p. 161, seguito da sHerk, Empire, 1988, p. 38, nr. 21.
Preferiscono il 9-10 d.C. il primo editore G.E. BeAn, cit. a n. 2; ortH, Fabricius, 1978, pp. 57-60; syMe, Salutations, 1979, pp. 317-318 (= iDeM, Papers, 1984, p. 1207).
1144 C. LETTA
del testo parzialmente conservato), seguito probabilmente dal suo cursus e da una formula di dedica da parte della comunità marruvina24.
Tuttavia, a giudicare dalla trascrizione del CIL, che riproduce l’attuale lin. 1 in caratteri più grandi e indica che le prime due sporgevano lateralmente sulla sinistra, sem‑brerebbe che il nostro testo cominciasse proprio con esse. Mi sembra quindi più probabile una spiegazione leggermente diversa. Si potrebbe pensare a una base di statua che portasse sulla faccia anteriore la dedica vera e propria, col nome dell’onorato in caratteri grandi, seguito dal cursus e da una formula di dedica, mentre il testo parzialmente giunto fino a noi, in forma di elogium, occupava una faccia laterale o la faccia posteriore, come possia‑mo constatare, ad esempio, in un’iscrizione di Ferentinum su cui mi sono recentemente soffermato25.
13. Resta da esaminare il dato storicamente più interessante che emergerebbe da questa ricostruzione: il fatto che, sulla base di un piano operativo predisposto da Tiberio in una data da precisare fra il 4 e il 14 d.C., per ben tre volte nei primi decenni dell’im‑pero sarebbero state effettuate operazioni straordinarie di arruolamento tra i Marsi e quasi certamente in tutta l’Italia centrale, in controtendenza rispetto a uno spostamento delle aree di reclutamento verso la Cisalpina e le province occidentali più romanizzate che sembrava già sostanzialmente compiuto con la fine delle guerre civili e l’avvento del principato26.
Questi tre episodi risalirebbero rispettivamente ai regni di Augusto, di Tiberio e di Caligola. Per Augusto, come si è già detto, deve trattarsi dello stesso dilectus che vide impe‑gnato a Roma un ufficiale di Alexandria Troas e per il quale sono state proposte due possibili occasioni: la rivolta pannonica del 6 d.C. o il disastro di Teutoburgo del 9 d.C.27.
Forse la rilettura che ho proposto dell’iscrizione marruvina consente una scelta più netta. Se è vero che l’arruolamento fu indetto da Augusto sulla base di uno studio e di un piano operativo predisposti per lui da Tiberio, possiamo escludere la prima proposta, perché
24 Werner Eck, che ringrazio vivamente, mi suggerisce alcuni significativi confronti; innanzi tutto con l’iscrizione di L. Volusio Saturnino, cos. nel 3 d.C., trovata nel larario della villa di Lucus Feroniae (AE 1972, 174), in cui, dopo il nome e il cursus, si ricorda il decreto approvato dal senato, su proposta di Nerone, per ono‑rarlo dopo la morte (cfr. eCk, Epigrafia, 1996, pp. 125-145; S. PAnCierA, in AA.VV., Volusii, 1982, pp. 83-85). Ancora più puntuale, per il richiamo a uno scritto dell’imperatore, può essere il confronto con l’iscrizione fune‑raria di Ti. Plauzio Silvano Eliano, cos. suff. nel 45 e nel 74 d.C. (CIL, XIV 3608 = ILS, 986), nella quale, dopo il cursus (che si espande in un minuzioso rendiconto delle gesta da lui compiute come legato di Mesia), si ricorda che il senato deliberò per lui gli ornamenta triumphalia, su proposta di Vespasiano, del quale sono riportate le parole pronunciate in senato: auctore Imp(eratore) Caesare Augusto Vespasiano, verbis ex oratione eius q(uae) i(nfra) s(cripta) s(unt). Caratteristiche analoghe avevano anche altre iscrizioni onorarie, come CIL, XIV 3613 = ILS 918, forse relativa a P. Sulpicio Quirinio.
25 CIL, X 5829 = ILS 2726; cfr. lettA, Caduta, 2007, p. 43. 26 V. bibl. cit. a nota 3. Tuttavia la presenza di molti nomi centroitalici tra i circa 200 nomi di le‑
gionari graffiti su frammenti di terra sigillata di età augustea (8/5 a.C. - 9 d.C.) del campo di Haltern è stata giustamente sottolineata da gAlsterer, Graffiti, 1983 e in BJ, 184, 1984, p. 823 (cfr. Forni, Esercito, 1992, p. 110).
27 V. supra, n. 23.
DALLA COHORS ASCALONITANA AGLI ARRUOLAMENTI IN ITALIA CENTRALE 1145
allo scoppio della rivolta pannonica Tiberio era impegnato sul fronte germanico, e di lì pas‑sò direttamente al nuovo fronte di guerra, rimanendo continuativamente assente da Roma e dall’Italia fino al 9 d.C.
Tra l’annuncio della clades Variana nell’estate del 928 e la nuova partenza di Tiberio per il fronte germanico nell’estate del 10 d.C., l’erede di Augusto rimase sicuramente in Italia e il 16 gennaio del 10 potè dedicare il tempio della Concordia a Roma29. Potrebbe essere questo il momento in cui, su incarico di Augusto, predispose un piano di arruola‑menti straordinari in Italia per compensare la perdita delle tre legioni di Varo, e quindi le operazioni di reclutamento vere e proprie potrebbero essere state effettuate nell’inverno 9‑10 d.C.30
Anche per gli arruolamenti che sarebbero stati indetti successivamente, con gli stessi criteri, da Tiberio e da Caligola si dovrà pensare a situazioni di emergenza che suggerissero, anche in termini di ideologia e propaganda, un appello solenne per uno sforzo unitario di Roma e dell’Italia di fronte al barbaro, come ai tempi del consensus totius Italiae contro la regina d’Egitto.
Per Tiberio la cosa più naturale è pensare alla rivolta di Tacfarinas in Africa, che sembra l’episodio militare più serio e impegnativo del suo regno, essendosi protratta dal 17 al 24 d.C.31 Naturalmente, se il nostro anonimo ha in precedenza rivestito un comando in Germania (o in Siria) sotto Germanico e poi anche un secondo comando, dovremmo pensare che l’arruolamento straordinario ordinato da Tiberio non fosse anteriore al 20 d.C.
Gli arruolamenti sotto Caligola, infine, saranno molto probabilmente da collegare con la progettata spedizione britannica, che portò nel 39 d.C. alla creazione di due nuove legioni, la XV e la XXII Primigeniae32.
Se questa ricostruzione risultasse confermata, la storia dell’Italia centro-appenninica come area di reclutamento legionario andrebbe almeno in parte riscritta. Tra gli arruolamenti
28 Secondo C.D., LVI, 18, 1 la notizia della disfatta giunse a Roma nel momento in cui venivano de‑cretati gli onori a Tiberio e Germanico per la vittoria pannonica e vell., II, 117, 1 precisa che Tiberio ricevette la notizia cinque giorni dopo la conclusione della guerra pannonica. Questo sembra indicare per la clades Variana una datazione verso la fine di luglio del 9 d.C., dal momento che i Fasti Antiates quasi certamente assegnano al 5 agosto la 19a acclamazione imperatoria di Augusto e la 5a di Tiberio, da mettere in relazione con la vittoria pan‑nonica di quell’anno (cfr. kienAst, Kaisertabelle, 1996, pp. 66 e 78).
29 Per l’anno e il giorno c’è la testimonianza dei Fasti Prenestini, confermati da C.D., LVI, 25, 1 e oviD., Fast., I, 637-650. V. da ultimo gAsPArri, Aedes, 1979, p. 14; siMPson, Livia, 1991, p. 450.
30 C.D., LVI, 23, 3 dice che Augusto subito dopo Teutoburgo arruolò molti congedati e liberti e li spedì al fronte con Tiberio (per i liberti cfr. anche suet., Aug., 25, 2). Un’allusione indiretta a questo potrebbe scorgersi nell’iscrizione di Alexandria Troas, che parla di dilectus ingenuorum, forse per sottolineare con orgoglio che C. Fabricio Tusco non si occupò dell’arruolamento di liberti.
31 Cfr. roMAnelli, Storia, 1959, pp. 226-245; lAssère, Conflit, 1982, pp. 11-25; sirAgo, Tacfarinas, 1988, pp. 199-204; Devillers, Rôle, 1991, pp. 203‑211.
32 V. ad es. BArrett, Caligola, 1992, pp. 195-196. Altri hanno pensato alle operazioni contro i Chatti (tH. FrAnke citato più avanti) o hanno sostenuto che le due legioni fossero state create solo da Claudio (MoMigliAno, Claudius, 19612, p. 59 e n. 37 a p. 111). Su di esse cfr. E. ritterling, in RE, XII, 2 (1925), cc. 1758-1760, s.v. legio; le BoHeC, Legio XV, 2000, pp. 69-70; FrAnke, Legio XXII, 2000, pp. 95‑104.
1146 C. LETTA
massicci di Marsi e Peligni nell’età delle guerre civili33 e quelli eseguiti per conto di Adriano lungo il percorso della via Valeria da Q. Voconius Saxa Fidus al tempo della rivolta giudaica34 s’inserirebbero i ripetuti arruolamenti della prima età giulio-claudia testimoniati dall’iscri‑zione marruvina, giustificando almeno il sospetto di una continuità ben maggiore di quanto si fosse finora pensato, e che potrebbe forse includere la creazione delle nuove legiones Italicae da parte di Nerone prima e di Marco Aurelio poi35, e perfino quella delle legiones Parthicae da parte di Settimio Severo36.
BiBliogrAFiA
AA.vv., Volusii, 1982 = AA.vv., I Volusii Saturnini, Roma 1982.ABsil, Legio I, 2000 = M. ABsil, Legio I Italica, in le BoHeC - wolFF, Légions, 2000, I, pp. 227-238.BArrett, Caligola, 1992 = A. BArrett, Caligola. L’ambiguità di un tiranno, trad. it., Milano 1992.BlACkMAn, Phaselis, 1983 = D.J. BlACkMAn, in J.S. sCHäFer (ed.), Phaselis. Beiträge zur Topographie und
Geschichte der Stadt und ihrer Häfen, Tübingen 1983, pp. 154-159.Brunt, Manpower, 1971 = P.A. Brunt, Italian Manpower, Oxford 1971.Brunt, Fabricius, 1974 = P.A. Brunt, C. Fabricius Tuscus and an Augustan dilectus, in ZPE 13, 1974, pp.
161‑185.CHiAruCCi, Settimio, 2006 = P. CHiAruCCi, Settimio Severo e la Legione Seconda Partica, Albano Laziale 2006.CHisté, Epigrafi, 1971 = P. CHisté, Epigrafi trentine dell’età romana, Rovereto 1971.Cook, Troad, 1973 = J.M. Cook, The Troad, Oxford 1973.DABrowA, Cohortes, 1986 = E. DABrowA, Cohortes Ituraeorum, in ZPE 63, 1986, pp. 221‑230.DAvies, Arrowheads, 1977 = J.L. DAvies, Roman Arrowheads from Dinorben and the Sagittarii of the Roman
Army, in Britannia, 8, 1977, pp. 257-270.Devillers, Rôle, 1991 = O. Devillers, Le rôle des passages relatifs à Tacfarinas dans les Annales de Tacite, in
L’Africa romana, 8 (Sassari 1990), 1, Sassari 1991, pp. 203-211.Dietz, Legio III, 2000 = K. Dietz, Legio III Italica, in le BoHeC - wolFF, Légions, 2000, I, pp. 133‑143.eCk, Epigrafia, 1996 = W. eCk, Tra epigrafia, prosopografia e archeologia, Roma 1996.
33 V. supra, nota 3.34 Cfr. un’iscrizione di Faselide (TAM, II, 3, 1201 = IGR, III 763 = ILS 8828, ora completata da un
nuovo frammento pubblicato da BlACkMAn, Phaselis, 1983, pp. 154-159); alle linn. 7-10 si legge: ejpimeleth;n oJdou' Ouj(a)leriva" T(ei)bourteivnh" kai; ejn toi'ı aujtoi'" tovpoi" stratologhvsanta. A questo testo greco corrisponde quello latino di un’iscrizione di Perge (I. kAygusuz, in EA 2, 1983, pp. 37-39 = AE 1986, 686), che alla lin. 68 riporta curatorem viae Valeriae Tiburtinae, qui et per eundem tractum dilectu[m e]git. Risulta così definitivamente smentita la lettura errata ejn a[lloi" tovpoi" che era stata data dell’iscrizione di Faselide. Per la datazione di questo dilectus (in base alla carriera del personaggio) al 134-136 anziché al 132 come proposto da Eck, v. lettA, Provincializzazione, 2004, p. 258.
35 Per Nerone, cfr. C.D., LV, 24, 2 e suet., Ner., 19; per M. Aurelio v. AE 1956, 123: proc. … ad dilec-tum cum Iulio Vero per Italiam tironum (utriusque) leg(ionis) Italicae. Cfr. E. ritterling, in RE, XII, 2 (1925), cc. 1407-1417, 1468-1476, 1532-1538; MAnn, Raising, 1963, pp. 483-489; ABsil, Legio I, 2000, pp. 227-238; lörinCz, Legio II, 2000, pp. 145-149; Dietz, Legio III, 2000, pp. 133‑143.
36 Come è stato evidenziato negli studi sull’origine di queste legioni, le principali aree di reclutamen‑to sembrano la Tracia e l’Italia: v. sHoCHAt, Recruitment, 1979-1980, pp. 245-249; wolFF, Legio, 2000, I, pp. 247-249; riCCi, Legio II, 2000, pp. 397-406; vAn rengen, Légion, 2000, pp. 407-410; wolFF, Legio III, 2000, pp. 251-252; CHiAruCCi, Settimio, 2006, pp. 50‑52.
DALLA COHORS ASCALONITANA AGLI ARRUOLAMENTI IN ITALIA CENTRALE 1147
FisHwiCk, Priest, 1998 = D. FisHwiCk, Our first high Priest: A Gallic Knight at Athens, in Epigraphica, 60, 1998, pp. 97-102.
Forni, Esercito, 1992 = G. Forni, Esercito e marina in Roma antica. Raccolta di contributi (“Mavors”, V), Stuttgart 1992.
FrAnke, Legio XXII, 2000 = tH. FrAnke, Legio XXII Primigenia, in le BoHeC - wolFF, Légions, 2000, pp. 95‑104.
Frézouls, Tabula, 1981 = E. Frézouls, À propos de la tabula Clesiana, in Ktema, 6, 1981, pp. 239‑252.gAlsterer, Graffiti, 1983 = Br. gAlsterer, Die Graffiti auf der römische Gefäßkeramik aus Haltern, Münster
1983.gAsPArri, Aedes, 1979 = C. gAsPArri, Aedes Concordiae Augustae, Roma 1979.HolDer, Auxilia, 1980 = P.A. HolDer, The Auxilia from Augustus to Trajan (BAR, Int. Ser., 70), Oxford 1980.kePPie, Face, 1997 = L. kePPie, The changing Face of the Roman Legions, 49 BC - 69 AD, in PBSR, 65, 1997,
pp. 89‑102.kienAst, Kaisertabelle, 19962 = D. kienAst, Römische Kaisertabelle, Darmstadt 19962.lAFFi, Adtributio, 1966 = U. lAFFi, Adtributio e contributio, Pisa 1966.lAssère, Conflit, 1982 = J.-M. lAssère, Un conflit routier: observations sur les causes de la guerre de Tacfarinas,
in Ant. Afr., 18, 1982, pp. 11‑25.le BoHeC, Legio XV, 2000 = Y. le BoHeC, Legio XV Primigenia, in le BoHeC - wolFF, Légions, 2000, I, pp.
69-70.le BoHeC - wolFF, Légions, 2000 = Y. le BoHeC - C. wolFF (edd.), Les légions de Rome sous le Haut-Empire,
Actes du Congrès de Lyon (17-19 sept. 1998), Lyon 2000.lettA, Vettio, 1990 = C. lettA, Un Vettio Scatone a Mogontiacum e il tesoro di Hildesheim, in SCO, 40, 1990,
pp. 317-328.lettA, Marsi, 1996 = C. lettA, Marsi, in Enciclopedia Oraziana, I, Roma 1996, p. 512.lettA, Provincializzazione, 2004 = C. lettA, La provincializzazione dell’Italia e la nascita della provincia
Valeria, in U. lAFFi, F. PronterA, B. virgilio (edd.), Artissimum memoriae vinculum. Scritti di geogra-fia storica e di antichità in ricordo di Gioia Conta, Firenze 2004, pp. 255-271.
lettA, Caduta, 2007 = C. lettA, Caduta e resurrezione di un cavaliere di Ferentino nei difficili inizi del regno di Adriano, in H. solin (ed.), Atti del Terzo Convegno epigrafico cominese (San Donato Val di Comino, 27 maggio 2006), 2007, pp. 43-58.
lettA - D’AMAto, Epigrafia, 1975 = C. lettA - s. D’AMAto, Epigrafia della regione dei Marsi, Milano 1975.lörinCz, Legio II, 2000 = B. lörinCz, Legio II Italica, in le BoHeC - wolFF, Légions, 2000, I, pp. 145‑149.MAnn, Raising, 1963 = J.C. MAnn, The Raising of new Legions during the Principate, in Hermes 91, 1963, pp.
483‑489.MAnn, Recruitment, 1983 = J.C. MAnn, Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the Principate,
London 1983.MoMigliAno, Claudius, 19612 = A. MoMigliAno, Claudius. The Emperor and his Achievement, Cambridge
19612.ortH, Fabricius, 1978 = W. ortH, Zum Fabricius-Tuscus-Inschrift aus Alexandria Troas, in ZPE 28, 1978, pp.
57-60.riCCi, Legio II, 2000 = C. riCCi, Legio II Parthica. Una messa a punto, in le BoHeC - wolFF, Légions, 2000, I,
pp. 397-406.riCl, Inscriptions, 1997 = M. riCl, The inscriptions of Alexandria Troas (Inschr. Griech. Städte in Kleinasien,
Bd. 53), Bonn 1997.roMAnelli, Storia, 1959 = P. roMAnelli, Storia delle province romane dell’Africa, Roma 1959.sADDington, Development, 1982 = D.B. sADDington, The Development of the Roman Auxiliary Forces from
Caesar to Vespasian (49 BC - AD 79), Harare 1982.sCHillinger-HäFele, Edikt, 1967 = u. sCHillinger-HäFele, Das Edikt des Claudius, CIL, V, 5050 (Edictum de
civitate Anaunorum), in Hermes, 95, 1967, pp. 353-365.sHerk, Empire, 1988 = R.K. sHerk, The Roman Empire: Augustus to Hadrian, Cambridge 1988.
sHoCHAt, Recruitment, 1979-1980 = y. sHoCHAt, The Recruitment of the Legio II Parthica, in Scr. Class. Isr., 5, 1979-1980, pp. 245-249.
siMPson, Livia, 1991 = C.J. siMPson, Livia and the Constitution of the Aedes Concordiae: the Evidence of Ovid Fasti 1, 637 ff., in Historia, 40, 1991, pp. 449‑455.
sirAgo, Tacfarinas, 1988 = V.A. sirAgo, Tacfarinas, in L’Africa romana, 5 (Sassari 1987), Sassari 1988, pp. 199‑204.
syMe, Salutations, 1979 = R. syMe, Some imperial salutations, in Phoenix, 33, 1979, pp. 308-329 (= iDeM, Papers,1984, pp. 1198-1219).
syMe, Papers, 1984 = R. syMe, Roman Papers, III, Oxford 1984.vAn rengen, Légion, 2000 = W. vAn rengen, La IIe Légion Parthique à Apamée, in le BoHeC - wolFF, Légions,
2000, I, pp. 407-410.wiDengren, Iran, 1976 = G. wiDengren, Iran, der grosse Gegner Roms, in ANRW, II.9.1 (1976), pp. 217-306.wolFF, Legio I, 2000 = C. wolFF, Legio I Parthica, in le BoHeC - wolFF, Légions, 2000, I, pp. 247-249.wolFF, Legio III, 2000 = C. wolFF, Legio III Parthica, in le BoHeC - wolFF, Légions, 2000, I, pp. 251‑252.