Desierto, Arqueología y el Dakar. El Quinto Poder 03-01-2015
CRITTOGRAFIE PER AMICI E NEMICI IN RUTILIO NAMAZIANO: LA QUESTIONE DEL “QUINTO LEPIDO” E IL...
Transcript of CRITTOGRAFIE PER AMICI E NEMICI IN RUTILIO NAMAZIANO: LA QUESTIONE DEL “QUINTO LEPIDO” E IL...
CRITTOGRAFIE PER AMICI E NEMICIIN RUTILIO NAMAZIANO:
LA QUESTIONE DEL “QUINTO LEPIDO”E IL COGNOMEN DI RUFIO VOLUSIANO
Mi è particolarmente grata l’opportunità offertami dai curatori diquesta miscellanea di rendere omaggio ad un maestro come GiuseppeScarpat, cui mi legano profonde ragioni di riconoscenza. Se non aves-si casualmente incontrato sulla mia strada di studente liceale (non par-ticolarmente diligente) la figura di Rutilio Namaziano, difficilmentemi sarei mai appassionato all’antichità; parallelamente, nel mio quoti-diano lavoro di antichista, non dimentico che fu una commissione diconcorso presieduta dal professor Giuseppe Scarpat a ritenermi degnodi esercitarlo. Con la più viva gratitudine gli offro dunque questoesperimento rutiliano, nell’auspicio che non abbia a deluderlo.
1. I nomi dell’“innominato”: l’invettiva di Porto Ercolee il “quinto Lepido”
Com’è noto, trovandosi a fare tappa a Porto Ercole (I 293-312),Rutilio coglie l’occasione per elaborare un’aggressione contro la stirpedei Lepidi. Giunto al quinto, e a lui contemporaneo, membro della fa-miglia – proprio colui per attaccare il quale Rutilio ha con evidenzamontato l’intera digressione vituperativa – Rutilio lo tuffa all’ultimomomento in un’aposiopesi e conseguentemente lo vela di anonimato(vv. I 305 ss.). Ecco il passo nella sua interezza1:
1 Per i singoli particolari rinvio a I. LANA (Rutilio Namaziano, Torino, Giappichelli, 1961,pp. 61-73), ai commenti di E. CASTORINA (Claudio Rutilio Namaziano, De reditu, introdu-zione, testo critico, traduzione e commento, Firenze, Sansoni, 1967, pp. 185 s.) e diE. DOBLHOFER (Rutilius Claudius Namatianus, De reditu suo sive Iter Gallicum, herausge-geben, eingeleitet und erklärt von E.D., 2 voll., Heidelberg, Winter, vol. I Einleitung, Text,Übersetzung, Wörterverzeichnis, 1972; vol. II, Kommentar, 1977: II, pp. 143 ss.) e alle pp. 87 ss.della mia edizione (Rutilio Namaziano, Il ritorno, introduzione, testo, traduzione, note dicommento, Torino, Einaudi, 1992, ed. riveduta 1994, da cui cito). Per comodità del lettore ri-cordo comunque che i Lepidi qui attaccati sono nell’ordine: 1) M. Emilio Lepido che, con-sole nel 78 a.C., cercò di abrogare la costituzione di Silla: dichiarato nemico pubblico mar-ciò su Roma e, sconfitto dalle truppe dell’altro console (Catulo) e di Pompeo, fuggì in Sar-degna, dove poi morì, imbarcandosi proprio a Porto Ercole; la digressione muove appunto
Paideia LIX (2004)170
Haud procul hinc petitur signatus ab Hercule portus;vergentem sequitur mollior aura diem.
Inter castrorum vestigia sermo retexit 295Sardoam Lepido praecipitante fugam;
litore namque Cosae cognatos depulit hostesvirtutem Catuli Roma secuta ducis.
Ille tamen Lepidus peior, civilibus armisqui gessit sociis impia bella tribus, 300
qui libertatem Mutinensi Marte receptamobruit auxiliis urbe pavente novis.
Insidias paci moliri tertius ausustristibus excepit congrua fata reis.
Quartus Caesareo dum vult inrepere regno 305incesti poenam solvit adulterii.
Nunc quoque… sed melius de nostris fama queretur,iudex posteritas semina dira notet.
Nominibus certos credam decurrere mores?Moribus an potius nomina certa dari? 310
Quidquid id est, mirus Latiis annalibus ordo,quod Lepidum totiens reccidit ense malum.
Quanto a questo segmento del diario rutiliano, l’attenzione deglistudiosi si è concentrata soprattutto sull’invettiva nei riguardi dei Le-pidi e sul problema dell’identificazione del quinto ed “innominato”fra loro. È di conseguenza sfuggito un particolare che non mi pareprivo di una certa importanza. Si è spesso sottolineato come Rutilio“modelli” alcuni aspetti della sua vicenda esistenziale e letteraria sul-
da questa vicenda. 2) Lepido il tiumviro (figlio del n. 1), che Rutilio imputa di responsabilitàin guerre civili (DOBLHOFER pensa a quella contro i cesaricidi): in particolare corse in aiutodelle truppe di Antonio al fiume Argenteo (29 maggio 43 a.C.), salvandolo dalla sconfittacontro l’esercito senatorio nel corso della Guerra di Modena. 3) Si ritiene che il terzo deiLepidi rutiliani sia M. Emilio Lepido (figlio del n. 2 e nipote del n. 1), che nel 31 a.C. ordìcontro Ottaviano – e conseguentemente contro la pax ch’egli poi instaurò – una congiurastornata da Mecenate, attentato in seguito a cui fu giustiziato (LANA pp. 64-66 ha propostoun’identificazione alternativa con il di lui cugino L. Emilio Paolo, console dell’1 d.C. e ma-rito della nipote di Augusto Giulia, che congiurò contro Augusto in data ignota all’inizio delI. d.C.: in questo caso, se il quinto è davvero – come spesso ritenuto – Claudio PostumoDardano, avremmo già con il terzo Lepido (p. 66) «un personaggio che era figlio di un Le-pido ma non ne portava il medesimo cognomen». Tuttavia la sua tesi non è stata accolta dal-la critica: vd. CASTORINA pp. 186 s. e DOBLHOFER II p. 146). 4) Il quarto Lepido è ilM. Emilio Lepido giustiziato nel 39 d.C. per aver cospirato, insieme a Getulico, contro Ca-ligola: ne aveva sposata la sorella Drusilla, di cui peraltro era consanguineo, e si diceva cheavesse violato anche le altre due sorelle, Agrippina e Livilla. 5) Il quinto è l’“innominato”contemporaneo a Rutilio, di cui si discute oltre nel testo. Uno speciale ringraziamento a An-drea Rodighiero e Simona Rota per il prezioso aiuto nel reperire titoli bibliografici difficilida rintracciare.
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 171
l’esilio di Ovidio2. Ebbene anche la tappa di Porto Ercole appare in li-nea con quella prospettiva: l’invettiva contro i Lepidi nasce dalla spin-ta ad attaccare il Lepido contemporaneo, dilatando l’esecrazione sullabase di una digressione storica (e sarcasticamente “collezionistica”).Ora, anche l’attacco al nemico personale è un motivo ricorrente nellapoesia ovidiana dell’esilio, e per di più si articola proprio lasciando in-nominato il bersaglio3.
Inoltre, non mi risulta sia stata finora notata una singolare sintoniafra un passo dei Tristia e il nostro luogo rutiliano; Ovidio infatti at-tacca il suo nemico in questi termini (Tristia IV 9, 25 s. e 31 s.):
Nec tua te sontem tantummodo saecula norintperpetuae crimen posteritatis eris.
[…]
Hoc quoque, quam volui, plus est. Cane, Musa, receptus,dum licet huic nomen dissimulare suum.
A questi versi fanno riscontro nel de reditu il gesto rutiliano del-l’aposiopesi (I 307 Nunc quoque… sed melius de nostris fama quere-tur) e lo specifico richiamo alla posteritas (I 308 iudex posteritas semi-na dira notet).
Nella generica convergenza s’apre una cospicua divergenza: Ovi-dio pensa alla propria futura fama poetica, con l’infamia che – corri-spondentemente – frutterà al suo avversario, sebbene al momento gliconceda, in attesa di un suo ravvedimento, il beneficio dell’anonima-
2 Mi permetto di rinviare, oltre che alla mia ricordata edizione (pp. XII s.), al breve sguardoriassuntivo che sono tornato a stilare nell’articolo Da una breve distanza: Rutilio fra Roma e ilsuo lido (in AA.VV., Arma virumque. Studi di poesia e storiografia in onore di Luca Canali, acura di E. LELLI, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e poligrafici internazionali, 2002, pp. 163-188),a nota 20 e contesto. Gioverà aver ricordato paralleli molto stretti, come quelli fra Ov. TristiaIII 12, 25 s. e de reditu I 5 s., fra Ov. ep. ex Ponto I 3, 31 ss. e de reditu I 163 ss., e fra Ov. Tri-stia III 12, 23 s. e de reditu I 201 ss. La mia posizione è ora attaccata da N. BROCCA, A che ge-nere letterario appartiene il de reditu di Rutilio Namaziano?, in F. E. CONSOLINO (curatrice),Forme letterarie nella produzione latina di IV-V secolo, Roma, Herder, 2003, pp. 231-255.3 Vd. l’introduzione (di F. DELLA CORTE) a Opere di Publio Ovidio Nasone, vol. II Tristia,Ibis, Ex Ponto, Halieuticon liber a cura di F. DELLA CORTE e S. FASCE, Torino, UTET, 1986,particolarmente pp. 50-54; G. LUCK, P. Ovidius Naso, Tristia (herausgegeben, übersetzt underklärt von G. L., Heidelberg, Winter, Band I: Text und Übersetzung, 1967; Band II: Kom-mentar 1977), vol. II pp. 263 s. La proposta di R. VERDIÈRE, secondo cui «Ibis» andrebbeidentificato con Gaio Ateio Capitone, è stata ripresa su basi “crittografiche” da L. JANSSENS,Deux complexes d’acrostiches délateurs d’“Ibis”, alias C. Ateius Capito. Le mysticisme duculte d’Abrasax, «Revue de Philologique de Littérature et d’Histoire Anciennes» III s. 55,1981, pp. 57-71 (cfr. più oltre, nota 7).
Paideia LIX (2004)172
to; Rutilio invece demanda a noi posteri il giudizio su colui che si sta-va accingendo a vituperare e che all’ultimo momento più non nomina,contando tuttavia sul fatto che sapremo riconoscerlo – non foss’altroche “per chiara infamia”. Pur all’interno, dunque, di un più ampio at-teggiamento di taglio ovidiano, non è sicuro che l’attacco al Lepidoinnominato segni rispetto all’attacco di Ovidio al suo “Ibis” un episo-dio di specifica, diretta “allusività”, sul tipo di quella che collega niti-damente altri contesti rutiliani alle elegie dell’esilio (vd. nota 2). E lastessa parola chiave posteritas, che i due passi hanno in comune, puòdipendere in Rutilio almeno anche da una diversa intenzione (a mioparere, anzi, in ogni caso soprattutto da essa). Ne siamo trascinati adedicarci anche noi alla “protagonistica” questione riguardante chipossa nascondersi nel Lepido scelto a bersaglio.
Nel 1840 August Wilhelm Zumpt propose di individuare il “famo-so” quinto e innominato Lepido nel prefetto del pretorio per le Gal-lie Claudius Postumus Dardanus: nonostante qualche occasionale per-plessità, l’identificazione si è largamente affermata presso molti e au-torevoli studiosi.
Non sarà inutile ripercorrere brevemente il dibattito. Zumpt proposel’identificazione nelle sue Observationes in Rutilii Claudii Namatianicarmen de reditu suo pars prior (diss. Berolini 1836, § XXVII) e quin-di nella sua edizione commentata (Rutilii Claudii Namatiani de redi-tu suo libri duo, recensuit et illustravit Aug. Wilh. Zumptius […],sumptibus Ferd. Dümmleri, Berolini 1840, p. 118). L’ipotesi fu recepi-ta da vari studiosi, fra cui Jules Vessereau (Cl. Rutilius Namatianus:édition critique accompagné d’une traduction française et d’un index,et suivie d’une étude historique et littéraire sur l’oeuvre et l’auteur,Paris, Fontemoing, 1904, particolarmente pp. 319-320, dove fra le al-tre cose Vessereau osserva «tout ce passage est sûrement un des pluscurieux du poème»).Nella RE Ensslin tratta il nostro personaggio s.v. Postumius n. 93(Pauly-Wissowa, RE XXII 1, 1953, col. 955); tuttavia l’unica nostra at-testazione del nome completo del personaggio – l’epigrafe CIL XII1524 (=H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berolini apud Weid-mannos 1962, n.1279, vol. I, p. 285) – reca la forma Postumus: vd. La-na cit. p. 61 n. 1; da vedere nella Pauly-Wissowa anche la voce Darda-nos n. 10, curata da Otto Seek (RE IV 2, 1901, coll. 2179-80, ma con leimportanti puntualizzazioni di LANA cit. p. 62, nota 6 e contesto).Il primo che, sviluppando gli spunti di Zumpt, abbia cercato di illu-strare con ampiezza di trattato «perché mai il poeta lo abbia scelto asuo bersaglio, cioè quali fossero le ragioni dell’animosità che eventual-mente nutriva verso di lui e, di conseguenza, qual grado di probabilitàraggiunga la proposta identificazione» è stato Italo Lana (nella prima
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 173
delle Appendici alla sua monografia Rutilio Namaziano, Torino, Giap-pichelli 1961, pp. 61-73: cit. da p. 61), cui rinvio per la sistematicaescussione delle fonti. Il suo punto di partenza è la ricordata epigrafeCIL XII 1524, in cui Cl(audius) Postumus Dardanus è ricordato peraver fatto aprire una strada su una rupe nei pressi dell’odierna Sisteronin Provenza, con il sostegno della moglie N(a)evia Galla e del vir in-lustris, comes e frater memorati viri (cioè di Dardano), Cl(audius) Le-pidus, già consularis Germaniae Primae, magister memoriae e comesrerum privatarum.Su questo Claudius Lepidus non abbiamo altre fonti. Non è mancatochi abbia ritenuto che fosse proprio lui, e non già Dardano, il quintoe innominato Lepido del passo rutiliano: così François Préchac, nel ri-vedere per la «Collection des Universités de France» la precedenteedizione di Jules Vessereau (Rutilius Namatianus, Sur son retour, tex-te établi et traduit par J.V. et F.P., Paris, Les Belles Lettres 1933, 19612,p. 41; Préchac non illustra tuttavia le ragioni dell’ipotesi).Quanto a Claudius Postumus Dardanus, qualcuno ha posto in discus-sione che fosse in senso stretto, come attesta l’epigrafe, il «fratello» diClaudio Lepido; Lana ha mostrato la sostanziale inconsistenza di que-ste riserve (e a me sembra che sia stato anzi fin troppo prudente nelconcedere margini a queste supposizioni) e ha ribadito come sia co-munque «evidente che Dardano era strettamente imparentato coi Le-pidi». Il rilievo è naturalmente importante, perché l’unico reale “svan-taggio” dell’identificazione proposta da Zumpt è che Dardano – sepur «fratello» di un Lepido – a quanto ci risulta non reca nella propriaserie onomastica il cognomen specifico di Lepidus.A Dardano e alla sua iniziativa di trasformare, con l’aiuto della mogliee del fratello Claudio Lepido, una sua tenuta in un luogo di devozionechiamato Theopolis, ha dedicato una monografia François Chatillon4.Lo studio di Lana, ricostruendo con efficacia il suo importante ruolocome prefetto del pretorio per le Gallie nel delicato e drammatico mo-mento dell’invasione della Narbonese da parte di Ataulfo, mette in lucepiù di una buona ragione per cui Rutilio potesse riprovarne l’operato.Dardano venne nominato prefetto del pretorio per le Gallie dal legit-timo imperatore Onorio e rivestì tale carica, con sede in Arles, duevolte nell’arco di un periodo che corre fra 409/412 (vd. Lana p. 67 no-ta 25) e 418, in alternanza con Agricola: Dardano era comunque in ca-
4 F. CHATILLON, Locus cui nomen Theopoli est… Essai sur Dardanus Préfet du Prétoire desGaules au Ve siècle, correspondent de saint Jérôme et de saint Augustin, et sur sa fondationde Theopolis, 2e édition, «Revue du Moyen Age Latin» 46, 1990, pp. 11-149 (Gap 19431). Lostudio è liquidato sbrigativamente da P. COURCELLE (che in Histoire littéraire des grandes in-vasions germaniques, troisième édition, augmentée et illustrée, Paris, Études Augustinienne,1964, p. 96, nota 1 scrive di «conjectures très ardies»: vd. LANA cit. p. 63, nota 12); vi si ri-collega invece l’articolo di H.-I. MARROU, Un lieu dit «Cité de Dieu», in AA.VV., Augusti-nus Magister. Congrés International Augustinien, Paris, 21-24 septembre 1954, Paris, ÉtudesAugustiniennes, 1954, pp. 101-110.
Paideia LIX (2004)174
rica nel 412-413 e, con ogni verisimiglianza (probabilmente per la se-conda volta), negli anni (415-418) in cui si collocano – con le notecontroversie circa l’esatta datazione: vd. il citato Doblhofer vol. Ipp. 33 ss. – il viaggio di Rutilio, oggi tendenzialmente assegnato al tar-do autunno 417, e il conseguente poemetto.Quando nel 412 Ataulfo passò nelle Gallie si trovò di fronte da un la-to l’esercito di Onorio, ai comandi di Flavio Costanzo, insediato inArles; dall’altro le truppe dell’usurpatore Giovino. Questi, a Magonzanell’estate del 411, si era sollevato contro Onorio (e contro l’altrousurpatore Costantino III, che frattanto Onorio s’era trovato a dover“riconoscere” come legittimo) e marciava verso la Provenza, ma si erafermato in Alvernia, dove aveva riscosso l’adesione di molti nobili del-l’aristocrazia arverna alla sua insurrezione. Ataulfo, stretto fra i dueeserciti rivali, nella necessità di scegliere come comportarsi, dapprima,sollecitato da Attalo, si accordò con Giovino. Ma presto alcuni gestidi Giovino lo irritarono, e allora il prefetto del pretorio per le GallieClaudio Postumo Dardano ebbe buon gioco a distaccarlo da Giovinoe a “reclutarlo” alla causa di Onorio (operazione per cui è lodato inChronica Gallica a. DXI, 69: vd. Chronica minora I, ed. Th. Momm-sen, «MGH, AA» IX 1, Berolini 1892, p. 654). Secondo gli accordi in-tavolati da Dardano, Ravenna avrebbe concesso a Ataulfo vettovaglieper i suoi Visigoti e una provincia di Gallia in cui stanziarsi; Ataulfoavrebbe dovuto sconfiggere Giovino (e il di lui fratello Sebastiano, nelfrattempo elevato a collega nell’usurpazione) e restituire Galla Placidiache deteneva in ostaggio. Nel 413 Ataulfo sconfisse i gioviniani e uc-cise Sebastiano; consegnò Giovino a Dardano. Questi lo uccise di per-sona in Narbona (fine maggio/inizi giugno 413), e fece seguire unastrage di nobili galli coinvolti nella cospirazione. Erano costoro so-prattutto arverni, e figurava fra loro Decimio Rustico, un antenato diAquilino, amico e corrispondente di Sidonio Apollinare: di modo chesi spiega come anche lo stesso vescovo Sidonio, nonostante Dardanofosse stato lealista e cristiano, sia pervenuto ad avversarne la memoria(ep. V 9, 1; su questa e sulle altre fonti relative alla strage di nobili vd.Lana pp. 69-71). A questo punto, tuttavia, Onorio non mantenne ipatti, poiché non si trovava in condizione di inviare vettovaglie ai Vi-sigoti. Essi, di conseguenza, si diedero al saccheggio della Provenza:nell’autunno del 413, fallito l’assedio a Marsiglia, presero Narbona eBordeaux: forse fu in questo contesto che venne saccheggiata Tolosa(con le note conseguenze per l’amico di Rutilio Vittorino – ora rifu-giato in Italia: de reditu I 493-510 – e per i beni di Rutilio stesso). Fal-lite nuove trattative, Ataulfo sposò Galla Placidia in Narbona nel gen-naio 414 e nominò augusto Attalo, insediandolo a Bordeaux: a quantopare Attalo decretò lo stanziamento dei Goti in Aquitania. Ma FlavioCostanzo tornò nelle Gallie con nuove truppe, bloccò i porti, costrin-se i Goti a ripiegare nella penisola iberica: Ataulfo lasciò Bordeaux in-cendiandola e passò nella Tarraconese: a inizio del 415 i Visigoti eranoormai nelle Spagne.
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 175
L’atteggiamento di Rutilio di fronte a questi fatti non è facilissimo daprecisare: egli è probabilmente un lealista che però avversa l’altro lea-lista Dardano per ragioni personali, ideologiche e di strategie politico-militari. Sotto Onorio, Rutilio è stato magister officiorum e praefectusUrbi; e il suo parente Esuperanzio, padre di Palladio, all’altezza cro-nologica del viaggio rutiliano sta reprimendo – cosa che gli vale gli en-comi di Rutilio – moti sovversivi in Aremorica; ma, soprattutto, neiframmenti del II libro vengono levate alte lodi a Flavio Costanzo.Possiamo assumere dunque che Rutilio identificasse ancora la propriaposizione politica con la lealtà al potere centrale, per lo meno nellamisura in cui quest’ultimo andava incontro all’interesse di tutti, e deipossidenti gallici in particolare, debellando i Visigoti.Quanto a Postumo Dardano, la sua figura ha molto di che urtare Ru-tilio, tanto per l’indole personale quanto per il comportamento nellagestione dell’affare Ataulfo-Giovino:a) pur difendendo il potere centrale, Dardano ha aggredito la nobiltà
gallica schierata con Giovino, e ne ha fatta strage, iniziando con ilgiustiziare di persona Giovino in Narbona, cuore del mondo ruti-liano;
b) Dardano è cristiano convinto, al punto da vantare fra i suoi corri-spondenti Girolamo (se ne veda l’ep. 129, databile al 419/420) eAgostino (si veda la sua ep. 187, dell’estate 417), che si esprimonosu di lui in termini di vivo apprezzamento; non va dimenticato cheAgostino è il grande avversario di uno fra i migliori amici di Ruti-lio: quel Rufio Volusiano su cui torneremo più oltre;
c) Dardano ha compiuto un gesto di politica “stiliconiana” cercandodi venire a patti con i barbari e di sfruttarli come “braccio” del-l’impero (la celeberrima avversione di Rutilio per Stilicone e la suapolitica si esprime notoriamente nell’invettiva specificamente indi-rizzata al defunto generale vandalo – che pure aveva anch’egli tan-to operato in direzione “lealista” e in materiale difesa dell’impero– in de reditu II 41-60);
d) a causa di questi accordi “stiliconiani” stipulati da Dardano (anchese in realtà – piuttosto – a causa dell’impossibilità proprio da par-te onoriana di tenervi fede), i Visigoti hanno messo a ferro e fuocole terre di Rutilio e dei suoi amici in Provenza e nella Narbonese,fino a Bordeaux.
Come si è visto, Rutilio non attacca apertamente il quinto Lepido: La-na p. 74 scrive che non lo «nomina espressamente» ma, come vedre-mo, ritengo ne abbia comunque evocato il nome con sufficiente icasti-cità. Lana ritiene che Rutilio, pur essendo un ex prefetto, temesse unpotente funzionario tuttora in carica, e proprio con immediata giuri-sdizione nelle sue terre (p. 67); è anche possibile che Rutilio non vo-glia andare contro una sorta di lealismo che poi ribadisce nelle lodi diFlavio Costanzo del II libro. Attaccare Dardano era non solo attacca-re un potente, ma anche criticare direttamente un’intera gestione dellacrisi da parte del potere imperiale centrale, e precisamente da parte di
Paideia LIX (2004)176
un funzionario di Onorio (Dardano, appunto) contro un settore del-l’aristocrazia di Gallia. L’ambiguità della posizione di Rutilio sta nelfatto che egli (come avverrà per Sidonio nel ricordato caso di ep. V 9,1) sembrerebbe un lealista e nello stesso tempo avversa Dardano: lasua posizione fra protesta/invettiva e reticenza si colloca appunto inquesto discrimine fra l’avversione personale a Dardano, con la puntadi critica politica connessa, e il lealismo di fondo dell’ex funzionarioinnamorato di Roma e grato a Costanzo e a Esuperanzio.L’invettiva contro i Lepidi, letta precisamente come aggressione neiconfronti di Dardano, ha conosciuto interessanti sviluppi nel quadrodella “fortuna” del poemetto rutiliano. È proprio in questa zona am-bigua, di indeterminatezza fra lealismo e distinguo politico-militari,con rincalzo ideologico-religioso anticristiano, che alcune odierne “ri-scritture” del poemetto rutiliano hanno individuato la possibilità disviluppare elaborazioni a sfondo politico. Così il racconto di MariaClelia Cardona, L’altra metà del dèmone (terzo della silloge che netrae titolo: Venezia, Marsilio 1997), fa leva su questa ombra di “fron-da” per incardinare la nuova fantasia rutiliana su di una cospirazionemirante a sostituire Rutilio (e il suo mondo) ad Onorio (e il suo mon-do) sul soglio imperiale. Indipendentemente, percorre una via analogail film che il regista Claudio Bondì – insieme ad Alessandro Ricci,coautore della sceneggiatura – ha tratto dal poemetto, intitolato De re-ditu-Il ritorno, uscito nelle sale italiane il 16 gennaio 2004. Per questevicende della fortuna rutiliana rinvio a un mio ampio studio di prossi-ma pubblicazione (i cui principali risultati sono stati esposti nell’inter-vento Il viaggio di Rutilio dall’Antichità al grande schermo, alla setti-mana di studi romano-barbarici di Monte Sant’Angelo l’8 ottobre2003 e in seno al convegno sulla fortuna dei classici organizzato daEmanuele Narducci a Sestri Levante in data 26 marzo 2004, nei cui at-ti uscirà, con titolo leggermente diverso, nel 2005 presso ETS di Pisa).La questione del “quinto Lepido” è solo marginalmente sfiorata daJohn Matthews (Western Aristocracies and the Imperial Court AD364-425, Oxford 1975); egli dà per acquisito il fatto che l’invettiva ru-tiliana sia da collegarsi con la strage dei nobili ad opera di Claudio Po-stumo Dardano (pp. 322-323), ma resta il dubbio che egli ritenga cheRutilio si riferisse al fratello di Dardano, Claudio Lepido (forse sullascorta dell’opinione di Préchac, ma senza illustrare la propria sceltacon ulteriori particolari; vd. p. 315 n. 4: «Lepidus shared the reputa-tion of Dardanus, cf. Rut. Nam., De Red. I 295 f., esp. 307»). Il luogorutiliano non viene invece mai chiamato in causa da J. R. Martindale,The Prosopography of the Later Roma Empire, vol. II A.D. 395-527,Cambridge, University Press 1980, né alla voce Claudius PostumusDardanus (pp. 346-47) né alla voce Cl. Lepidus (p. 675; cfr. anche lavoce N(a)evia Galla, p. 491).Di recente la problematica è stata ripresa in due specifici interventi.G. Fisher (Rutilius and the Fifth Lepidus, «Museum Philologum Lon-diniense» 7, 1986, pp. 31-36) si schiera per l’identificazione del “quin-
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 177
to Lepido” con Postumo Dardano e insiste sull’ipotesi che l’odio ru-tiliano fosse, più che politico, religioso (in particolare Rutilio avrebbesaputo delle intenzioni di Dardano di farsi monaco); David Frye (IsCl. Postumus Dardanus the Lepidus of ‘De reditu suo’ 1.307?, «Her-mes» 121, 1993, pp. 382-383), in una nota (breve e superficiale quantopoco informata), senza proporre alternative, revoca invece in dubbioche si tratti di Dardano, facendo leva proprio sul lealismo verso Co-stanzo mostrato dal fr. B del de reditu rutiliano (per la questione dellealismo, vd. sopra; non va dimenticato il riscontro con quanto già no-tava Lana p. 71 a proposito della strage dei nobili nel 413: «nessunafonte menziona Costanzo, il generale di Onorio a cui pure era affida-to il comando supremo nella lotta contro gli usurpatori e controAtaulfo, come responsabile di tali uccisioni»).
Traducendo e commentando Rutilio per l’edizioncina di Einaudiuscita nel 1992 (19942), mi sembrava che alla questione del quinto Le-pido si potesse guardare da un punto di vista nuovo. Vorrei qui ripro-porre i rilievi che vi operavo (rimasti, come spesso avviene per le os-servazioni disseminate in note di commento, piuttosto defilati), incombinazione con nuove osservazioni che un mai intermesso amoreper il poemetto di Rutilio mi ha offerto l’occasione di fare.
Il mio nuovo punto di vista sulla questione del Lepido innominatoera il seguente: a ben osservare la tramatura fonica dei versi contro il“quinto Lepido”, una circostanza rimasta inosservata sembra invitarci aindividuare un’inattesa conferma di quella tradizionale identificazionedel “quinto Lepido” con Postumo Dardano, cui gli studiosi erano peraltra via pervenuti. Le occorrenze combinate, a breve distanza, del so-stantivo astratto posteritas e dell’infinito dari lasciano la sensazione cheRutilio, nel momento stesso in cui campiva l’aposiopesi, intendesse tut-tavia istoriare nel tessuto dei versi il nome del personaggio esecrato.Apparentemente negati all’esplicitazione, ben due elementi della serieonomastica del suo “nemico” sarebbero ugualmente emersi, abbreviati,tramite un gioco di parole dotato di quello stesso effetto di ammiccan-te enfasi che noi spesso assegnamo ai puntini di sospensione:
Nunc quoque… sed melius de nostris fama queretur,iudex POSTeritas semina dira notet.Nominibus certos credam decurrere mores?Moribus an potius nomina certa DARi?
Nel quadro di una concettosa elucubrazione sul significato dei no-mi, che ci convoca a giudizio in quanto posteri, Rutilio avrebbe dun-que evocato “i nomi dell’innominato” tramite richiami occultati nelleopzioni lessicali POSTeritas (I 308) e DARi (I 310), sigillando infine
Paideia LIX (2004)178
il passo con un diverso tipo di calembour (I 312), inteso a richiamareuna volta di più – in tono beffardo – la stirpe nel cui mosaico di per-versione veniva con naturalezza ad inserirsi la nuova tessera contem-poranea5.
Se l’osservazione coglie nel segno, tramite questa peculiare risorsaRutilio avrebbe voluto “strizzare l’occhio” alla propria cerchia di im-mediati lettori, evocando in maniera al contempo prudente e sofistica-ta il concreto nome del personaggio contro cui si rivolgeva. Da un la-to, con l’“ufficiale” ritrosia a denunciare espressamente il Lepido ag-gredito, sollevava il problema dell’identificazione; subito dopo, dal-l’altro, ne avrebbe proposta la soluzione, per una via segreta e cifrata– ma del tutto evidente a chi, come i suoi conoscenti, era bene infor-mato dei fatti politici contemporanei.
Ora, per vari rispetti Rutilio ama arricchire il proprio poemetto dirisonanze facendo ricorso a un’ampia e finissima rosa di implicazioni6.L’idea dell’eventuale cesello POST DAR presuppone che la trama diqueste implicazioni potesse risultare così elaborata da giungere a lavo-rare sui margini delle orditure foniche, indirizzandosi a un orecchio (oa una recitazione), ovvero – in caso di lettura silenziosa – ad occhi,dotati tutti di particolare attenzione7.
5 Alludo al gioco di parole bene illustrato da DOBLHOFER II pp. 150 s., al luogo: Rutilio hausato la parola lepidum al contempo quale nome proprio (“con la maiuscola”: quella che,creando imbarazzo all’editore moderno, lo trascina a disambiguare forzatamente l’espressio-ne e segnalare un’opzione ecdotica per una delle due letture sovrapposte) e quale aggettivoconcordato con malum (per una battuta a taglio ossimorico). Merita credo un accenno anchela considerazione che, se pure con rimescolamento nell’ordine, le lettere della sequenza DARcompaiono già anche nell’ominosa parola dira (che non escluderei sia stata convocata nelcontesto proprio per questa sua proprietà). Quanto al terzo elemento della serie onomastica,Claudius, non mi pare necessario che si cerchino ragioni per giustificarne l’omissione perquesta via crittografica; i due elementi Post(umus) Dar(danus) bastavano ampiamente a far“scattare” la scintilla evocativa. Possono comunque essere intervenute ragioni quali privile-giare l’economicità della risorsa, o evitare l’elemento (Claudius) che, per quanto ci risulta,Rutilio stesso aveva in comune con Dardano.6 Vd. quanto osservato nell’introduzione alla mia edizione (p. XV, note 21 e 22 e contesto).7 Si aggiunga a queste occorrenze la possibilità – in cui personalmente credo: vd. il mio Ru-tilio, pp. 75 s., e il ricordato (a nota 2) Da una breve distanza, pp. 173 s. – che Rutilio ab-bia giocato anche su AMOR come inversione di ROMA nella chiusa del passo I 179-204. Suqualche ipotetico precedente di analoghe soluzioni tecniche di tipo crittografico si possonosecondo me consultare con profitto vari contributi, segnalati – con sintesi dei risultati dellericerche e/o delle singole proposte – in G. BRUGNOLI-R. SCARCIA, a conclusione della voceNumerologia in Enciclopedia Virgiliana (Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani,vol. III, 1987, pp. 788-793), con rinvio anche alla voce Indovinelli (redatta da A. LA PENNA,vol. II, 1985, pp. 948-950). Vd. per es. il caso su cui è tornato J. FARRELL, Vergil’s Georgicsand the Traditions of Ancient Epic. The Art of Allusion in Literary History, New York-
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 179
Un lettore diffidente e incline alla prudenza nel ricostruire la gam-ma di risorse tecniche eventualmente a disposizione di Rutilio potreb-be a questo punto dubitare che noi siamo di fronte a un consapevolee sottile artificio, inclinando piuttosto a ritenere che la sequenza PO-ST DAR ricostruibile nel testo sia frutto di un caso (se si voglia co-munque identificare in Postumo Dardano il quarto e innominato Le-pido) e/o si riveli del tutto irrilevante (soprattutto qualora si neghiquella specifica identificazione).
Ma che Rutilio potesse davvero ricorrere a un simile espediente misembra a sua volta confermato da quanto propongo di riconoscere inun’altra circostanza del De reditu che non ha mancato di sollevareproblemi: l’“autocitazione” che, a proposito di Rufio Volusiano e delsuo cognomen, Rutilio opera durante il resoconto della tappa di Po-pulonia (I 415-428), rinviando a quanto aveva annotato precedente-
Oxford, Oxford University Press, 1991, pp. 81-83: Arato, phaen. 778-791, che presenta ungioco sulla parola lepté – iniziale del v. 783, al centro del v. 784, in acrostico ai vv. 783-787 –viene imitato da Virgilio georg. I 427-437; ora, i vv. 429, 431, 433 iniziano rispettivamentecon MAximus, VEntus e PUra destando l’impressione che Virgilio abbia adibito una diversatecnica crittografica, che istoria le iniziali dei suoi tria nomina. Il tutto in un contesto in cui,nell’inciso del v. 432, si legge una frase come namque is erit certissimus auctor. La “chiave”dell’acrostico e quasi un invito a rintraccciarlo si avrebbe così nel tessuto stesso del passo;come avviene a ben guardare già in Arato, che inserisce la parola-chiave del gioco nella te-stura verbale esplicita; e come, in altro contesto virgiliano, torna ad accadere in Aen. VII601-604, dove, mentre le iniziali compongono l’acrostico MARS, il v. 603 suona Roma, cumprima movent in proelia Martem. Ora, georg. I 433 inizia con la parola pura, che traduce ilkatharé del v. 783 di Arato, cioè il primo dei versi interessati all’acrostico nell’autore greco;secondo FARRELL p. 82, «this is a signal: Vergil’s acrostic must be read backwards». Moltoardite mi sembrano le elucubrazioni crittografiche in tema di «acrostici complessi» del sopraricordato (nota 3) articolo di JANSSENS – il quale si richiama fra l’altro a J. RICHARD, Cryp-tographie, in L’Historie et ses méthodes, volume publié sous la direction de Charles Samaran,Paris 1961 («Encyclopédie de la Pléiade» XI, pp. 616-632): pp. 616 e 629-631 – sull’“Ibis” diOvidio. Può per lo meno destare qui una certa curiosità il fatto che lo stesso Jannsens se-gnala (p. 68) come in Ov. Pont. IV 6 G. NÉMETHY avesse identificato un acrostico POSTU-MUS (mentre peraltro TH. J. DE JONGHE vi scopriva il nome SILANUS: G. NÉMETHY, Sup-plementum Commentariorum ad Ovidii Amores, Tristia et Epistulas ex Ponto, Budapest1922, pp. 44 e 46; TH. J. DE JONGHE, Publii Ovidii Nasonis Tristium Liber IV, Groningen1945, p. 10). Rutilio non ricorre a un acrostico in senso stretto ma ad una cesellatura critto-grafica, articolata su versi distanti (due distinti pentametri, intervallati da un esametro estra-neo al gioco). Anche questa è soluzione non priva di precedenti. L’acrostico virgiliano digeorg. I 429 ss. investe versi intervallati fra loro; la cosa si ripete – con intervalli non più diuno ma di due versi –, qualora si voglia riconoscere per tale l’acrostico individuato da E. L.BROWN, Numeri Vergiliani. Studies in Eclogues and Georgics, Bruxelles-Berchem, «Collec-tion Latomus» 63, 1963, p. 105, in georg. II 321+324+327+330+ 333, così riferito dal citatoBrugnoli-Scarcia (cui appartengono le quadre): «P(ublius) VER(gilius) MA(ro)PART(henopaeus) [o forse PART(henias)(?)] CRE(monensis), conchiuso dal v. 336 non aliosPrima CREscentis origine mundi» (in cui vedremmo ribattuti gli estremi crittografici del gio-co: la P iniziale e la sequenza CRE conclusiva).
Paideia LIX (2004)180
mente, e cioè all’altezza del distacco da Roma (I 165-178). Non misembra privo d’interesse – non solo per un’ipotetica inclinazione ruti-liana alle “crittografie”, ma anche da altri punti di vista che svilupperònel seguito – tornare a studiare con una certa attenzione, e nel suo piùampio contesto, il medaglione che, nel dittico populoniese, riguarda ilcaro amico appena elevato alla dignità della prefettura urbana.
2. Caducità e consolazioni a Populonia: novità su Rufio Volusiano
La quinta tappa del viaggio di Rutilio conduce la sua piccola flottada Falesia al porto di Populonia. Non paiono esservi ragioni per du-bitare che questa quinta tappa coincida anche con il quinto consecuti-vo giorno di viaggio. E dunque, allineandosi ai calcoli degli studiosiche indicano come anno dell’iter il 417, quanto Rutilio descrive do-vrebbe potersi precisamente ricondurre al 2 di novembre (saremmoinvece al 22 novembre per chi, con il Lana, preferisse il 415).
Nel diario poetico, il segmento di Populonia si articola in due mo-menti. Il primo parla del percorso, delle difficoltà che vi insorgono edel panorama che si apre agli occhi del viaggiatore, piegandone gliumori a sconsolata pensosità. Il secondo, con un contrasto palesemen-te intenzionale, segnala come proprio lì, a Populonia, Rutilio avrebbeappreso la felice notizia che uno fra i suoi migliori amici, Rufio Volu-siano, ha conseguito in Roma la carica della prefettura urbana.
Del primo di questi due momenti, mi sono occupato in altro lavo-ro. Come ho lì puntualizzato8, ritengo che Rutilio a Populonia abbia
8 Una giornata di viaggio: Rutilio a Populonia, in AA.VV., Materiali per Populonia 2, a curadi C. MASCIONE e A. PATERA, «Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Ar-ti, Sezione Archeologica» dell’Università di Siena, Firenze, Edizioni All’Insegna del Giglio,2003, pp. 257-270. Dopo aver ricordato come Rutilio abbia l’abitudine di avviare i singoliquadri sui binari di gamme semantiche e/o insiemi d’immagini coerenti, vi ho segnalato chedue motivi appaiono configurarsi come le “gamme di Populonia”: da un lato il contrasto frarisultanze di levarsi e di cadere, dall’altro l’opposizione fra – diciamo così – natura e “cul-tura”. Questa sua inclinazione a cogliere nel dato contingente una trama semantica che di-venga una sorta di profonda identità poetica del luogo e del momento trattati invita a rite-nere che Rutilio non abbia elaborato il suo quadro a partire da astrazioni retoriche, e ci in-clina ad accettare con una certa fiducia come effettivamente reali i tratti di paesaggio che ciconsegna. Almeno la rocca di Populonia – laddove si voglia ritenere che la parte bassa dellacittà fosse ancora fiorente – doveva effettivamente essere in rovina. E agli occhi di Rutilio ilfatto dovette presentarsi tanto più colorato di pathos in quanto la sconfortante registrazionedell’universa precarietà e di una lotta fra vita e disgregazione, fra uomo e natura, veniva aporsi nell’irenico quadro di un luogo “benedetto”, esso stesso autentico dono della natura.Non credo in altre parole che Rutilio, mosso da nostalgia o da retorica, abbia falsificato la
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 181
di fatto veduto delle rovine e ne sia stato conseguentemente invitato auna “fotografia poetica”, con coda di riflessione filosofico-retorica: ilcelebre pensoso commento che perequa le sorti di uomini e città9. Lacritica ha accumulato in calce a questi versi una grande quantità di lo-ci similes10, segnalando come il passo più antico e significativo per lastoria di questo motivo vada individuato nella lettera consolatoria cheServio Sulpicio Rufo indirizzò a Cicerone dopo avere appreso dellasua disperazione in seguito alla morte della figlioletta Tullia11.
Da un altro punto di vista, nel suo ricchissimo studio sul motivoletterario delle rovine, Francesco Orlando ha classificato il passo ruti-
realtà delle cose, né esagerando nello sminuire una realtà insediativa ancora invece vivace, néall’opposto “ricostruendo” nei versi rovine che il tempo s’era già incaricato di radere al suo-lo (sono rispettivamente le due opposte tesi di Sauro Gèlichi e di Enrico Zanini: le cito e di-scuto alle pp. 258-261 dell’articolo). Segnalo su questi temi l’articolo di A. LIGNANI, Il temadella morte della città in Rutilio Namaziano (una proposta didattica), in AA.VV., Tredici se-coli di elegia latina, Atti del Convegno Internazionale di Assisi 21-24 aprile 1988, a cura diG. CATANZARO e F. SANTUCCI, Assisi, Accademia del Subasio, 1989, pp. 311-330; si tratta diun’utile puntualizzazione della problematica che, pur senza registrare sostanziali novitàscientifiche, propone interessanti spunti di riflessione agli insegnanti che non desiderinoavallare l’oblio della Tarda Antichità nei correnti programmi scolastici.9 Vd. I 409 ss.: Agnosci nequeunt aevi monumenta prioris / grandia consumpsit moenia tem-pus edax; / sola manent interceptis vestigia muris, / ruderibus latis tecta sepulta iacent. / Nonindignemur mortalia corpora solvi: / cernimus exemplis oppida posse mori.10 Nel quadro della bibliografia rutiliana è stato soprattutto O. SCHISSEL-FLESCHEMBERG(Rutilius Claudius Namatianus, De reditu suo I, 399-414, «Wiener Studien» 61-62, 1943-47,pp. 155-161, specialmente pp. 158-161) a puntualizzare come lo spunto del confronto fra ca-ducità di uomini e caducità di città avesse attecchito a fondo nella topica retorica. Rinviandoal manuale di Menandro retore, segnala come ormai rientrasse negli insegnamenti di pram-matica, quanto ai discorsi di consolazione, ricorrere all’argomento della caduta delle città.Più di recente, il quadro delle risultanze è esaurientemente ricapitolato dal commento diDOBLHOFER 1977: egli chiosa il passo rilevando che questa pointe della nostra sezione è ca-ratteristica da un lato per la visione del mondo e della vita che ha Rutilio, e dall’altro per lostretto legame fra poesia e retorica, che è pure un tratto che contraddistingue la tarda anti-chità. Il suo studio segna tuttavia anche una moderata reazione, che punta, secondo me, nel-la giusta direzione (p. 188): «Populonia ist aber mit seiner hohen Burg doch unabhängig vonaller Rhetorik ein Wahrzeichen der Landschaft».11 La lettera è conservata fra le Ad familiares, IV 5 (cito il testo secondo l’edizione criticaCicéron, Correspondance, tome VIII, texte établi, traduit et annoté par J. BEAUJEU, Paris, LesBelles Lettres, 1983, pp. 46 ss.). Fra i vari ragionamenti filosofici che Servio Sulpicio sviluppaper confortare l’amico – non perché ritenga che tali argomenti gli sfuggano, ma piuttosto inquanto forse, oppresso dal dolore, tende a perderli di vista – figurano queste poetiche consi-derazioni (§ 4): Quae res mihi non mediocrem consolationem attulit, volo tibi commemorare,si forte eadem res tibi dolorem minuere possit. Ex Asia rediens, cum ab Aegina Megaram ver-sus navigarem, coepi regiones circumcirca prospicere. Post me erat Aegina, ante me Megara,dextra Piraeus, sinistra Corinthus, quae oppida quodam tempore florentissima fuerunt, nuncprostrata et diruta ante oculos iacent. Coepi egomet mecum sic cogitare: «Hem! Nos homun-culi indignamur, si quis nostrum interiit aut occisus est, quorum vita brevior esse debet, cumuno loco tot oppidum cadavera proiecta iacent? Visne tu te, Servi, cohibere, et meminisse, ho-minem te esse natum?». Crede mihi, cogitatione ea non mediocriter sum confirmatus.
Paideia LIX (2004)182
liano nella categoria «monitorio-solenne», ovverossia un’evocazionedi rovine cui si riallacci una sconsolata considerazione sulla naturaprecaria dell’uomo e delle sue cose. L’archetipo del «monitorio-solen-ne» è da lui individuato proprio nella famosa lettera consolatoria diServio Sulpicio Rufo a Cicerone12.
Spero di poter tornare più diffusamente altrove sulla questione, maanticipo qui che, al di là del processo di successiva cristallizzazione re-torica dello spunto (cfr. nota 10), nutro la persuasione che la lettera diServio Sulpicio Rufo sia rimasta essa stessa, nella sua specifica indivi-dualità, un importante testo di riferimento. Arriverei addirittura a so-spettare che avesse mantenuto una certa presenza nell’insegnamentodelle scuole; che fosse divenuta, insomma, un “classico”, nonché unodei primi testi su cui un aspirante retore si avviasse all’arte di lenire ildolore. A farmelo pensare interviene un altro testo che, in epoca vici-na al viaggio rutiliano, segnala bene l’inesausta vitalità del suo model-lo. Si tratta della nota “riscrittura” in chiave cristiana che ne ha pro-curato Ambrogio nella sua epistola di consolazione a Faustino, per lamorte della di lui sorella13.
12 F. ORLANDO, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità,robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti (Torino, Einaudi, 1993). Nella categoria del «moni-torio-solenne» – per seguire i rami dell’«albero semantico» che vi mettono capo – sono ru-bricate «immagini di corporeità non-funzionale, nel cui effetto immaginario è prevalente lapercezione d’un decorso di tempo, sentito colletttivamente, a determinazione non pertinen-te (caducità), e presentata in modo serio» (cito dalla tavola fuori testo in cui l’albero è ripro-dotto; ma vd. nel suo complesso la sezione IV 1). Della consolatoria di Servio Sulpicio a Ci-cerone (pp. 81 ss.), a valere in genere per i testi che si ricondurranno a questa famiglia, vienesottolineato quanto segue (82): «Il breve racconto sorge sul filo dell’ammonizione solenne-mente consolatoria a cui serve, senza la minima insistenza descrittiva, e con appello evocati-vo misurato. Eppure non è solo nel senso della valutazione estetica che tanta sobrietà noncomporta, ovviamente, una limitazione: nemmeno quanto all’interesse per noi. La pluralitàdei nomi di luoghi visti simultaneamente e simmetricamente, la prospettiva del navigante chelo rende verosimile da un centro sito in mare, il contrasto fra celebrità dei nomi e spettaco-lo di decadenza, la spontaneità infine del trapasso alla riflessione, sono più che sufficienti asuscitare una visione vaga di grandiosa e luminosa tristezza. […] Si può avere consistenza piùche sufficiente senza insistenza descrittiva, senza lungo indugio rispetto a un filo narrativo ologico, e in un numero ridottissimo di parole».13 Ep. II 8, 3 s. (= Maur. 39, 3s.): 3. Sed doles quod dudum florentissima repente occiderit. Ve-rum hoc nobis commune non solum cum hominibus, sed etiam cum civitatibus terrisque ipsis.Nempe de Bononiensi veniens urbe a tergo Claternan, ipsam Bononiam, Mutinam, Regiumderelinquebas, in dextera erat Brixillum, a fronte occurrebat Placentia, veterem nobilitatemipso adhuc nomine sonans, ad laevam Apennini inculta miseratus et florentissimorum quon-dam populorum castella considerabas, atque affectus relegebas dolenti. «Tot igitur semiruta-rum urbium cadavera» terrarumque sub eodem conspectu exposita funera non te admonentunius, sanctae licet admirabilis, feminae decessionem consolabiliorem habendam, praesertimcum illa in perpetuum «prostrata ac diruta» sint, haec autem ad tempus quidem erepta nobis,
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 183
Queste pagine intendono invece concentrarsi sul secondo tableaudel dittico populoniese. Ecco il passo che ci interessa (I 415-428):
Laetior hic nostras crebrescit fama per aures, 415consilium Romam paene redire fuit:
hic praefecturam sacrae cognoscimus urbisdelatam meritis, dulcis amice, tuis.
Optarem verum complecti carmine nomen,sed quosdam refugit regula dura pedes: 420
cognomen versu veheris, carissime Rufi,illo te dudum pagina nostra canit.
Festa dies pridemque meos dignata penatesposte coronato vota secunda colat;
exornent virides communia gaudia rami, 425provecta est animae portio magna meae.
Sic mihi, sic potius placeat geminata potestas:per quem malueram, rursus honore fruor.
Nella modalità di approccio al tema delle rovine che, come diceva-mo, Francesco Orlando ha definito «monitorio solenne», si innescauna specie di circuito paradossale. Lo spunto «anche le città possonomorire» attecchisce soprattutto nell’ambito della topica consolatoria:l’intento è quello di attenuare la portata di un singolo lutto, dispo-nendolo come “particolare” quasi non più percepibile nell’immensodisegno dell’universale caducità delle cose del mondo. Questa consi-derazione teoricamente consolatoria ha però a sua volta di che sgo-mentare. Il nostro istinto punta a una durata, e dunque quella più va-sta e generale cancellazione che è chiamata a conforto, se forse puòsdrammatizzare una ferita, schiude contemporaneamente nuovi, di-versi fomiti di angoscia.
meliorem illic vitam exigat? 4. Itaque non tam deplorandam quam prosequendam orationi-bus reor nec maestificandam lacrimis tuis, sed magis oblationibus animam eius Domino com-mendandam arbitror.Ho citato secondo l’edizione di O. FALLER, CSEL 58, per come è riproposta in Sant’Am-brogio, Discorsi e lettere II/I: Lettere (1-35), introduzione, traduzione, note e indici diG. BANTERLE, Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova Editrice, 1988, pp. 98 ss.se ne occupa anche COURCELLE (cit. a nota 4), pp. 277-282. Sembra che Faustino fosse diBologna e, mentre Faller pensa che le distruzioni di cui si legge nella lettera siano state pro-curate da un terremoto del 394, L. CRACCO RUGGINI (Economia e società dell’«Italia anno-naria», Milano, Giuffré, 1961, p. 75) preferirebbe pensare alla calata di Massimo nella vallePadana dal 387 al 388 o alla campagna di Eugenio dal 393 al 394: vd. BANTERLE p. 101, no-ta 7. Claterna, fra Imola e Bologna, è oggi Quaderna; Brixillum è presso Parma; le virgolet-te nella traduzione sono state inserite da Banterle per sottolineare in Ambrogio la particola-re aderenza, al testo di Sulpicio Rufo, intesa come una sorta di citazione; al § 4 Banterlechiosa (p. 101, nota 8) «ritengo che con oblatio si indichi il Sacrificio eucaristico».
Paideia LIX (2004)184
A questo secondo senso di smarrimento, qualche voce impegnata ameditare sulle rovine di città aveva giustapposto una diversa consola-zione, individuando un conforto nel potere eternante della poesia14.
Rutilio non percorre una simile via. E del resto sarebbe potutosuonare come presuntuoso autoincensamento sostenere che gli sper-duti ruderi dell’antica città etrusca potessero “congelarsi” in quellaposa, lungo i secoli, e meritare una duratura persistenza nella memo-ria delle generazioni grazie al proprio minuto diario15.
Cionondimeno anche il pensoso Rutilio di Populonia avverte il pe-so psicologico del suo cupo richiamo alla transitorietà. E immediata-mente riequilibra i toni. Secondo un “regolare” procedimento antite-tico, al desolato e desolante panorama accosta in dittico un momentodi gioia. A immediato contrasto con il lugubre rintocco della parolamori, dispone a inizio del suo nuovo paragrafo il contrassegno di unafelicità che l’incremento procurato dal suffisso proprio alla formacomparativa sembra dire in cimento con l’osservazione appena con-clusa: laetior fama16.
La gioia che cancella i toni grigi ispirati dal contesto in degrado ri-guarda i successi di uno fra i migliori amici, Rufio Volusiano: la suacarriera è giunta a toccare l’alto fastigio cui già pervenne quella di Ru-tilio, la prefettura urbana17. Nel teatrino del De reditu, Rufio Volusia-no configura un “ritorno”: Rutilio aveva infatti già scritto di lui almomento in cui questi lo aveva accompagnato verso Portus, occasione
14 Il motivo affiora in alcuni epigrammi figuranti nel libro IX dell’Antologia Palatina: IX103, IX 104, IX 62, IX 28. Scrive F. ORLANDO, chiosando questi testi (p. 277): «un tale ri-scatto poetico, che non in tutti gli epigrammi si affaccia, sarebbe tornato nel futuro della ca-tegoria: è qualcosa d’altro e di più della funzionalità secondaria meditativa del monitorio-so-lenne. Consolazione e orgoglio dell’arte sono alternativi, sebbene non incompatibili, con l’u-miltà a fondo religioso della caducità umana».15 A mala pena per l’oggetto suo più cospicuo, in calce al brano più solenne e impegnato ditutto il poemetto, il cosiddetto “inno”, il poeta ha osato prendere in considerazione la pro-spettiva che, magari per riconoscenza, Roma, la dea, possa serbare una qualche memoria dilui (I 161 ss.): sive datur patriis vitam componere terris, / sive oculis umquam restituere meis,/ fortunatus agam votoque beatior omni, / semper digneris si meminisse mei.16 Inclino a ritenere che l’espressione laetior fama non configuri un’occorrenza di “compa-rativo assoluto”, ma abbia valore pienamente comparativo, con complessivo riferimento allamesta, anzi drammatica situazione appena tratteggiata ai vv. I 409 ss.17 Su Rufio Volusiano vd. PH. MARTAIN, Volusien. Une conversion au Ve siècle, «Revue Au-gustinienne», Bulletin mensuel des Maisons d’Études des Augustins de l’Assomption, 59,1907, pp. 145-172; A. CHASTAGNOL, Le Sénateur Volusien et la conversion d’une famille del’aristocratie Romaine au bas-émpire (communication présentée a la Société des Études lati-nes, séance du 11 juin 1955), «Révue d’Études Anciennes» 58, 1956, pp. 241-253; nonché na-turalmente i commenti rutiliani, specialmente quello di DOBLHOFER, ad ll.
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 185
in cui ne aveva stilato uno dei suoi caratteristici medaglioni encomia-stici (I 165-178). Ora che la nuova notizia sorprende lietamente il poe-ta nel corso del viaggio, affiora in metafora il motivo, scelto non cer-to a caso, dell’abbraccio. Ma Rutilio è lontano, e l’espansivo gesto dirito non potrà che effettuarsi in parole, articolandosi in versi e rivol-gendosi a un nome. Per questo, con caratteristica finezza, Rutilio si ri-volge alla scelta lessicale complecti. Eppure ad un pieno abbraccio delverum nomen osta – scrive Rutilio – la severa legge del metro (reguladura), che rifugge certi piedi (I 419 s.): Optarem verum complecti car-mine nomen, / sed quosdam refugit regula dura pedes.
Il nome completo dell’amico presenta due gentilizi (Rufius e Anto-nius) e due cognomina (Agrypnius e Volusianus). Fra questi, l’ultimoricusa l’inserimento in un contesto dattilico, poiché le sue prime tresillabe sono tutte brevi. Ma, a ben guardare, pure impossibilitato aproferirlo, Rutilio trova modo di evocare l’elemento onomastico chegli interessa: il cenno di I 420 ai piedi non ammessi dal metro dattili-co segnala implicitamente, per esclusione, che, tra i vari nomi della se-rie onomastica di Rufio Volusiano, è proprio a Volusianus che Rutiliosta pensando e facendo riferimento.
Se, riavvolgendo la pagina (è Rutilio stesso a presentarcela, forsemetaforicamente, in forma di volumen18), torniamo al passo cui Ruti-lio si riferisce con il proprio “rimando interno”, constatiamo che giàin quell’occasione la regula dura che quosdam refugit pedes gli avevaopposto difficoltà. L’impraticabilità dattilica, per via del tribraco, delcognomen Volusianus, aveva ispirato a Rutilio un escamotage. In quelcaso (I 167 ss.), egli aveva risolto appellandosi, perifrasticamente, al-l’antenato “mitico” di cui la famiglia di Volusiano insigniva il proprioalbero genealogico, e cioè il guerriero Voluso chiamato in causa daVirgilio nell’Eneide (XI 463 s. tu, Voluse, armari Volscorum edice ma-niplis, / duc – ait – et Rutulos):
Iamque aliis Romam redeuntibus haeret euntiRufius, Albini gloria viva patris,
qui Volusi antiquo derivat stemmate nomenet reges Rutulos teste Marone refert. 170
Ora, una precisa interpretazione del ricamo tessuto da Rutilio aproposito del nome dell’amico nel passo di Populonia richiede che
18 Vd. II 1 s. Nondum longus erat nec multa volumina passus, / iure suo poterat longioresse liber.
Paideia LIX (2004)186
ci si soffermi con un po’ di attenzione e di pazienza sul distico suc-cessivo, turbato purtroppo da un assai problematico guasto testuale19.La restituzione che ha incontrato maggiore fortuna ce lo propone nel-la forma che già sopra riportavo (I 421 s.):
Cognomen versu veheris, carissime Rufi, 421illo te dudum pagina nostra canit.
In questa sistemazione, l’unico – e leggerissimo – intervento è rap-presentato da veheris, che corregge la lezione veneris (contra metrumse intesa come forma verbale, priva di senso se intesa come nome pro-prio) del nostro migliore manoscritto, il codice V20. Questa correzio-ne fu proposta, indipendentemente l’uno dall’altro, da E. Kalinka nel1922 e da Italo Bartoli nel 193021. Rivendicò inoltre di averla propo-sta come propria anche François Préchac nella sua già ricordata revi-sione dell’edizione di Vessereau (1933, p. 22, in apparato). Paleografi-camente assai economica, è accolta, fra gli altri, da Castorina e Dobl-hofer nelle loro edizioni critiche (cui io stesso mi sono adeguato nella
19 Già V. USSANI senior (Leggendo Rutilio, «Rivista di filologia» 38, 1910, pp. 357-384) os-servava (p. 373) «questa è veramente la maggiore delle cruces che travagliano gli interpretidella poesia rutiliana». A. BARTALUCCI (recensione all’edizione commentata di DOBLHOFER,«Sileno» a. V-VI n. 14, 1979-80, pp. 403-416: p. 413) ritiene «si tratti veramente di un locusdesperatus in cui ogni tentativo di restituzione è sommamente improbabile».20 Nel codice V (Vindobonensis 277), vergato nel 1501 a Milano o nei pressi, si sono alter-nate alla copiatura le mani di Filippino Bononi (= V1: vv. I 1-242 e 415-56), di Iacopo San-nazaro (I 243-414 e 457-644, e risarcimento di lacune lasciate da V1 là dove non riuscisse aleggere l’antigrafo) e di un terzo copista non identificato (V3: vv. II 1-68). In testa alla primacolonna del foglio 88 – segnata con 87** per via di alcuni pasticci intervenuti in corso di co-piatura – la mano di Filippino Bononi scrive con nitore inequivocabile il v. 421 nella formacorrotta cognomen versu veneris carissime Rufi.Nel 1520 Giovan Battista Pio, ottenuto per via imprecisata un apografo rutiliano poi perdu-to, lo fece stampare a Bologna: è l’editio princeps (siglata con B), assai accurata, cui viene as-segnata dalla filologia rutiliana il valore autonomo di fonte manoscritta spettante al codice daessa rappresentato. In essa si legge cognomen versu Veneris carissime Rufi. Identica la letturadella cosiddetta editio Veneta, pubblicata a Venezia nel 1558 per le cure di Onofrio Panvinio(P), che afferma in prefazione di essersi servito di un codice messogli a disposizione dall’a-mico Gabriele Faerno.Di poco più tardo (1530, sebbene Castorina lo ritenga anteriore a B) sembra essere il codiceRomanus (Biblioteca Corsiniana dell’Accademia dei Lincei, fondazione Caetani 158: R), incui Rutilio è copiato con molte mende da Giovanni Andrea Cruciano Sabino: in esso il ver-so (con omissione di versu) è scritto cognomen venens carissime Rufi.21 E. KALINKA, Aus der Werkstatt des Hörsaals, «Akademie der Wissenschaften in Wien,Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte» 197. Band, 6. Abhandlung (vorgelegt inder Sitzung am 13. Oktober 1920), Wien 1922 (pp. 56-58 e 61); I. BARTOLI, De Rutilii Na-matiani carmine quaestiunculae quaedam, «Athenaeum» IX, 1931 (pp. 410-419), pp. 416-417(a p. 17 data la propria idea al 1928).
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 187
mia edizioncina einaudiana). Kalinka stesso vi scorgeva alcune diffi-coltà, a cominciare dalla durezza costituita dalla natura predicativadell’espressione (letteralmente: «sei portato dal/nel verso come cogno-men, carissimo Rufio»), che egli attenuava indicando un costrutto af-fine in I 527 s.22. Moltissime altre proposte hanno cercato di sanare illuogo altrimenti, intervenendo ora sul tràdito veneris, ora su altri seg-menti del verso23.
Personalmente, pur non essendo del tutto persuaso dalla congettu-ra Kalinka-Bartoli, resto convinto che il guasto da sanare sia circo-scritto al tràdito veneris, e svilupperò dunque una serie di osservazio-ni fondandomi sul postulato (del resto condiviso dalla gran maggio-ranza degli studiosi rutiliani) che il resto del verso ci sia stato tra-smesso in modo corretto.
Oltre alla “eccentricità” del costrutto, cui si accennava più sopra,interviene qui un secondo ordine di difficoltà a carico della restituzio-ne Kalinka-Bartoli (e di altre che muovono nella stessa direzione): co-me si ricordava, il nome completo di Rufio Volusiano è costituito dadue gentilizi (Rufius Antonius) e da due cognomina (Agrypnius Volu-sianus). Nel poemetto rutiliano, di questi quattro elementi onomasticinoi vediamo comparire due volte il gentilizio Rufius; eppure, al v. I421, Rutilio parla esplicitamente di un cognomen, e al successivo pen-tametro specifica «con quello», cioè con quel cognomen «già da tem-po la nostra pagina ti canta» (illo iam dudum pagina nostra canit). Èvero che a I 168 Rutilio aveva trovato modo di alludere per via di pe-rifrasi al secondo dei cognomina, appunto Volusianus, ma può quella
22 Vd. p. 58: «änlich steht ein Prädikatsnomen I 528: Quae latet (so) expulsis insula paenefretis»; per completezza, I 527 s. suona: inde Triturritam petimus: sic villa vocatur, / quae la-tet expulsis insula paene fretis.23 Veramente ingente la messe delle proposte di risanamento del passo. Una serie di conget-ture è in dettaglio discussa dallo stesso KALINKA e da BARTOLI pp. 416-17, nel momento incui propone veheris (poggiandosi per l’uso traslato sul confronto con Orazio c. III 29,48quod fugiens semel hora vexit). Fra gli interventi più recenti, P. FRASSINETTI (Postille rutilia-ne, «Bollettino di studi latini» 2,1972, pp. 36-48: p. 44) propone revenis o revenit. Un sinte-tico e dovizioso quadro della selva di proposte è offerto dall’apparato di CASTORINA, che quiriproduco: «421 Cognomen codd. edd.: Quod nomen Keene (in not.), Quo veniens Ussani(Quo = quo nomine) versu codd. (om. R), edd.: versans Castalio, serva Barth, Schrader, ver-sus Damm, Keene (in not.), veheris Kalinka, Bartoli, Préchac: veneris V, venens R, VenerisBMP, Barth, Zumpt Veneri Pithoeus, Castalio, Burmann, Schrader, a teneris Heinsius, servetDamm, veniat Wernsdorf, dederis Mueller, Keene, capitur Baehrens, veniet Vessereau, Hei-drich, patiens Keene (in not.), invenies Heidrich (in not.), caperis Ussani, prob. Tolkiehn, ser-vit Brakman, veneror Helm, neris Woestijne, venias dubit. Lana».
Paideia LIX (2004)188
perifrasi costituire l’effettivo referente di un rinvio tanto esplicito? Incaso negativo, come va interpretato l’uso di cognomen a I 421?
La difficoltà era già chiarissima a Kalinka nel 1922, e vale la pena diripercorrere la linea del suo ragionamento: il verum nomen che Rutiliovorrebbe abbracciare nel suo carmen e tuttavia non risulta praticabileper ragioni metriche in un contesto dattilico non può essere che Volu-sianus, le cui prime tre sillabe sono brevi; Volusianus è appunto un co-gnomen, che doveva essere adoperato effettivamente quale «Rufname»,e noi vediamo comparire invece due volte il gentilizio Rufius; sebbenesia sorprendente, tutto lascia pensare che proprio a Rufius ci si riferi-sca con la parola cognomen; la contraddizione si può spiegare solo ri-tenendo che la distinzione fra i singoli segmenti onomastici fosse vani-ta e che Rutilio intendesse dire “vorrei festeggiarti chiamandoti con iltuo nome abituale, ma il verso lo impedisce, e dovrai accontentarti del-l’altro tuo nome Rufius, con il quale già in precedenza ti ho cantato”.
Su una linea interpretativa affine muove Doblhofer accettando lacongettura Kalinka-Bartoli; a suo parere, cognomen è qui usato nelsenso generico di nomen e si riferisce proprio al gentilizio Rufius.Nella mia edizione rutiliana mi sono allineato a Doblhofer, e ho diconseguenza tradotto cognomen con «primo nome», cioè facendo ri-ferimento a quel primo elemento dell’intera serie onomastica che uni-camente si trovava da Rutilio esplicitato24.
Tuttavia, tornando sul passo, mi è parso che questa eventuale inter-pretazione incontrasse un ostacolo rilevante nel fatto che appena sopra(I 420) Rutilio ha già sfruttato, in questo senso generico, la parola no-men – come peraltro aveva fatto proprio a I 169. E ho avuto l’impres-sione che il deciso rimando di Rutilio intendesse sollecitare un nostroguardare “più sottilmente” a quella sua prima evocazione dell’amico.
Certo, non manca di colpire la circostanza che nel nuovo contestopopuloniese Rutilio insista proprio su quel cognomen che, presentan-do difficoltà prosodiche, era stato in realtà, nel primo contesto, aggi-rato. Eppure – come si ricordava – egli è assolutamente e sorprenden-temente chiaro. Nulla di quanto ora scrive sembra richiamare quellasemplice perifrasi: Rutilio segnala con esplicita sicurezza la presenza
24 DOBLHOFER II p. 195 ad. l.: «Cognomen steht in seiner allgemeineren Bedeutung für ‘Na-me’, ThLL III 1493, 12-21»; questa la sua traduzione, nel vol. I, p. 119 «ich möchte wohlgerne deinen wahren Namen im Gedicht fassen, allein die strenge Regel meidet gewisse Ver-sfüße; so trittst du uns eben mit deinem Beinamen im Vers entgegen, teuerster Rufius; unterihm besingt dich schon früher mein Buch». Quanto alla mia ed., vd. le pp. 31 e pp. 99 s.
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 189
del cognomen in quel pregresso contesto. Forse la soluzione rutilianadell’impasse era g i à n e l p r i m o c o n t e s t o scesa più nel pro-fondo di quanto a prima vista non sembrasse.
È finora sfuggita, infatti, una circostanza di fatto a mio avviso im-portante: e cioè che, nel primo dei due luoghi dedicati a Rufio Volu-siano, il suo secondo cognomen, il tanto problematico Volusianus, inrealtà f i g u r a – o per lo meno vi si affaccia “portato” dal verso –, evi figura n e l s o l o m o d o c o n s e n t i t o d a l -l ’ a r t e. Rutilio l’ha costruito “per l’occhio” – ma anche per una let-tura “consapevole” e, direi, “ammiccante” – montandolo a cavallo fraparole distinte, precisamente fra il genitivo del nome di guerriero vir-giliano Volusus e l’inizio di un aggettivo che, peraltro, è una sorta diparola-emblema nella storia della mentalità tardolatina: antiquus. Inquesta combinazione, la misurazione breve della sillaba -si- di Volu-sianus (come la misurazione lunga della sillaba -si del genitivo Volusi)perde rilevanza, risultando in ogni caso quella sillaba (divenuta espo-sta e a contatto con successivo inizio di parola vocalico) in sinalefe, edunque cassata dal computo prosodico (I 167 ss.):
qui VOLUSI ANtiquo derivat stemmate nomen.
Si tenga presente l’altissima verisimiglianza che le prime edizionidel poemetto fossero in scriptio continua, e probabilmente in capita-le25, circostanze in cui il gioco illusivo dell’intarsio avrebbe assuntoun’efficacia ancora più cospicua. L’assenza di desinenza (inserirla re-stava anche per questa via una difficoltà rilevante) costituisce un’obie-zione di portata relativa, potendo rientrare con naturalezza in unapratica cui l’occhio tardoantico era avvezzo in forza di una occasiona-le prassi epigrafica.
Come si vede, questa proposta di agnizione si ricollega strettamentealla questione del “quinto Lepido” per come ho ritenuto possibile ri-proporla. Alla crittografia POST DAR che, evocativa del nome dell’e-secrato Postumus Dardanus, ho suggerito di riconoscere cesellata nellescelte lessicali posteritas (I 308) e dari (I 310), si affiancherebbe la crit-tografia VOLUSIAN cesellata a cavallo della sequenza Volusi antiquo.
25 Vd. M. FERRARI, Frammenti ignoti di Rutilio Namaziano (in Spigolature bobbiesi, «ItaliaMedioevale e Umanistica» 16, 1973, pp. 1-41: pp. 15-30) p. 21, secondo cui l’antigrafo delcodice bobbiese di cui sono stati recuperati i due nuovi frammenti «certamente era in scrit-tura maiuscola e continua: ma questo è quasi ovvio».
Paideia LIX (2004)190
Nel caso del cognomen di Volusianus oserei affermare che il margi-ne d’incertezza è assai scarso. Innanzitutto non abbiamo a che fare conil nome di un personaggio identificato per via congetturale, ma con unben preciso cognomen che lo stesso Rutilio assevera poi di avere inprecedenza citato. Orbene, questo cognomen dell’amico, Volusianus,che Rutilio a Populonia (I 422) denunzia come «già da tempo presen-te» nel suo poemetto (con ciò rimandando a I 169), nel passo richia-mato “non figura”, e tuttavia al contempo “figura”: una lettura “nor-male” di I 169 manderebbe sostanzialmente a vuoto l’autocitazionedell’autore (ci si dovrebbe accontentare di pensare che alluda allaperifrasi); mentre la vediamo pienamente rispondente e congruau n i c a m e n t e secondo la m o d a l i t à “c r i t t o g r a f i c a”sopra puntualizzata. A meno di non volere imboccare scappatoie col-laterali (imprecisione o genericità dell’espressione rutiliana), siamo co-stretti a ravvisare in tutta la sua finezza il gioco d’intarsio. Contropro-va: l’alternativa è ritenere che – in un contesto riguardante non soloVolusiano, ma appunto il suo nome – la sillaba an-, iniziale di antiquo,sia finita in contiguità con la parola Volusi per un puro gioco del caso.E francamente questa mi appare un’ipotesi non solo ben più ardua del-la precedente, ma addirittura ai confini dell’inammissibilità.
Ma se il complesso delle circostanze testuali depone per l’intenzio-nalità crittografica della sequenza VOLUSIAN, allora ne ricaveremoun non irrilevante conforto anche alla tesi secondo cui, con analogherisorse, a I 305 ss. Rutilio ci abbia lasciato indizio, pur non nominan-dolo, del nome del suo nemico Postumo Dardano.
Alla luce di queste considerazioni, mi chiedo infine se non si pos-sa tornare a riflettere sulla giusta restituzione del verso 421; se, infat-ti, esse colpiscono nel segno, alcune proposte vengono automatica-mente a cadere, mentre altre ricevono un indiretto appoggio. Fra que-ste ultime, potrebbe forse acquistare nuovo rilievo, per esempio, lacongettura di Heidrich invenies26. Già Kalinka aveva sottolineato co-me essa venisse a restituire un senso assai apprezzabile, ma ne lamen-tava l’allontanarsi considerevolmente dalla lezione tradita27. Quest’ul-
26 Essa fu proposta in Claudius Rutilius Namatianus, mit Einleitung und kritischen Apparatherausgegeben von G. HEIDRICH, Wien-Leipzig, C. Fromme, 1912 (Berichtiger Sonder-abdruck aus dem Jahresberichte des k.k. Erzherzog Rainer-Realgymnasiums in Wien 1911, do-ve l’edizione di Heidrich era apparsa in un primo momento): a testo si legge Cognomen versuveniet, carissime Rufi, e in apparato, dopo le proposte di altri studiosi, «fortasse invenies».27 Vd. KALINKA cit., p. 57: «Und in der Tat würde invenies guten Sinn geben, aber es weichtschon bedenklich von der Ueberlieferung ab».
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 191
tima obiezione potrebbe non avere tutto il peso che in prima istanzale si accorderebbe; la genesi della corruttela potrebbe infatti aver per-corso vie per noi non più precisamente ricostruibili, come per esem-pio una falsa autodettatura mentale di una pericope mal decifrata omal memorizzata. In compenso non avremmo più l’ingombro di quel-la macchinosa costruzione predicativa e, soprattutto, il distico verreb-be a completare il movimento concettuale dei precedenti vv. 419-20 ea coronarlo con un brillante “segnale”: mentre, chiamando in causacon precisione il cognomen, sembra rinviarne al pregresso canto pervia di perifrasi, il poeta in qualche modo avvertirebbe della “effettiva”reperibilità di tale cognomen se solo Volusiano, in quella perifrasi, losappia trovare. “Vorrei abbracciare nel carme – esplicitandolo cioèpienamente – il tuo vero nome, ma la dura legge del metro rifuggecerti piedi; tuttavia proprio il tuo secondo e “impossibile” cognome tisarà comunque reperibile nel verso: già da tempo la mia pagina ti can-ta proprio con quello”.
È altresì vero che la stessa correzione Kalinka-Bartoli veherismi sembra risultare nel complesso, da questa nuova prospettiva, cor-roborata.
3. Postilla: qualche ipotesi fra Populonia e Vada
Guardando infine alla sostanza delle notizie riferiteci da Rutilio nelnuovo passo dedicato a Rufio Volusiano, mi colpiscono in particolaredue cose: la stranezza dell’enunciazione (crebrescit fama per auras) e ilfatto stesso che una notizia simile abbia potuto raggiungere Rutilionella modesta cittadina portuale in cui si è per caso fermato mezzagiornata. Nulla di a priori impossibile, beninteso, in tutto ciò. Eppureuna complessiva valutazione di varie circostanze mi spinge a chieder-mi se non sia intervenuto, nel resoconto rutiliano, un piccolo signifi-cativo adattamento dei reali dati di fatto, dettato da ragioni di equili-bri strutturali, ancora una volta da “calcoli del cemento” dell’arte.
Il giorno successivo all’arrivo a Populonia – a quanto ci è dato ca-pire –, Rutilio salpa nuovamente per fare di lì a poco tappa presso l’a-mico Cecina Decio Acinazio Albino. Entrambi i personaggi hanno inpassato ricoperto la carica di prefetto urbano, e anzi Rutilio, nell’elo-gio di Cecina Albino, mette il dato in piena evidenza: vi si ricorda co-me, a suo tempo, Albino abbia cortesemente posposto la propria can-didatura a quella di Rutilio, un episodio che non manca di rinsaldare
Paideia LIX (2004)192
il legame fra i due. Ora Rutilio scrive di Albino: «con il valore sopperìalla mancanza degli anni necessari, / … Un rispetto reciproco ha stret-to caratteri gemelli / e l’affetto è cresciuto con scambi di amicizia»(I 469 ss.: non expectatos pensavit laudibus annos, / vitae flore puer, sedgravitate senex. / Mutua germanos iunxit reverentia mores / et favoralternis crevit amicitiis). Appare probabile che anche Albino fosse inrapporti di cortesia e più probabilmente di amicizia, come con Rutilio,così pure con Volusiano; per di più fra i due intercorrevano rapporti diparentela28. In tali circostanze, è assolutamente impossibile che non siastata ampiamente commentata dai due ex prefetti una felice novità qua-le l’appena conseguita prefettura urbana da parte di Rufio Volusiano.
Ma personalmente arriverei a formulare un’ipotesi più ardita.Credo possibile che in realtà Rutilio non abbia appreso della pre-
fettura di Volusiano fra le modeste tabernae del porto di Populonia,ma che ne sia venuto al corrente – o se no, per lo meno ne abbia avu-ta decisiva conferma – il giorno successivo, proprio alla villa di Albi-no, salvo poi decidere di fare entrare in scena comunque la notizia, ole sue prime avvisaglie, nel resoconto della tappa precedente. E questoper più di una buona ragione. La sesta tappa conosceva già troppieventi da commentare. Si erano già presentate all’avventura del viaggioben cinque rilevanti unità tematiche: il passaggio di fronte alla Corsi-ca (I 429-438); quello davanti alla Capraia con la correlata invettivacontro i monaci (I 439-452); il difficile tratto delle secche di Vada, conl’improvviso maltempo e l’approdo alla villa di Albino (I 453-474); lacontemplazione delle saline (I 475-490); l’arrivo di Vittorino (I 491-510). Per di più, fra questi eventi esigevano già di trovare adeguatospazio ben due encomiastici ritratti di amici, quelli cioè dello stessoAlbino (I 465-474) e poi di Vittorino (I 493-508). Nel contempo, alladesolata descrizione di Populonia occorreva affiancare non solo mate-
28 Appartenevano entrambi ai Ceionii Rufii: vd. lo Stemma 13 in J. R. MARTINDALE, TheProsopography of the Later Roman Empire, vol. I (A.D. 260-395). Il nonno di Albino (cioèPublilius Caeionius Caecina Albinus consularis Numidiae attorno a 364/7: è l’Albinus n. 8 diMARTINDALE, Prosopography vol. I pp. 34 s.; padre a sua volta di Caecina Decius Albinus(iunior) prefetto urbano del 402, l’Albinus 10 di MARTINDALE) fu forse fratello del padre diRufio Volusiano (e cioè fratello di Ceionius Rufius Albinus prefetto urbano del 389-91 – ri-cordato dallo stesso Rutilio quando in de reditu I 168 chiama Rufio Volusiano Rufius, Albi-ni viva gloria patris –: l’Albinus 15 di MARTINDALE, Prosopography vol. I pp. 37 s., probabi-le figlio a sua volta di C. Ceionius Rufius Volusianus signo Lampadius, il Volusianus 5 diMARTINDALE vol. I pp. 978 ss.). Il «forse» dipende dalla natura congetturale della colloca-zione di Albinus 8 fra i figli di Volusianus 5 (MARTINDALE vol. I p. 35: «possibly one of thefour sons of C. Ceionius Rufius Volusianus 5»). Cfr. anche la bibliografia specifica su RufioVolusiano citata sopra, nota 17.
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 193
ria che “facesse corpo” nel resoconto di quella quinta giornata di viag-gio, ma precisamente proprio un momento di gioia che contrastasse lamalinconia ispirata dal contesto ambientale.
Di questa ipotetica, minima sfasatura nella successione degli even-ti, potrebbe a mio giudizio essere rimasta una minima traccia in quelcrebrescit del v. 415. Crebrescere era verbo ormai usato regolarmente,all’epoca di Rutilio, per il diffondersi di una notizia (vd. ThlL s.v.,coll. 1123 s.). E non è da escludersi, oltretutto, che qui Rutilio lo scel-ga – con una certa finezza di associazioni – per il gusto di sfruttare,trasferendolo dalle aurae alle aures, un tratto lessicale vivo anche inseno al linguaggio nautico: lo stesso Virgilio lo aveva impiegato perl’infittirsi dei venti (Aen. III 530 crebrescunt optatae aurae; cfr. Stat.Theb. IV 30 crebrescere ventos). Rutilio sembrerebbe alludere a unasorta di “sentito dire”; a meno che non stia travestendo da vox populiquella che era una comune aspettativa in base ad accorte manovre po-litiche sul cui buon esito aveva sempre contato. Ma nel complesso,sebbene infine Rutilio “fermi” la notizia in Populonia con un decisohic cognoscimus, mi resta l’impressione che quel tanto di incompiutez-za evocato dall’aspetto dell’incoativo-frequentativo crebrescit finiscaper schiuderci un indizio di rielaborazione strutturale. Una volta pre-sa la decisione che nell’economia del poemetto dovesse essere “antici-pata” la notizia, una specie di remora quasi inconscia ad allontanarsitroppo dal tessuto vero dei fatti, a travisarne la conformazione, avreb-be invitato Rutilio a presentare quel felice annuncio come qualcosache aveva iniziato a crescere e a diffondersi, cogliendolo poi «qui» aPopulonia – sebbene nella reale dinamica degli eventi lo avesse rag-giunto poche ore più tardi, poche miglia più a nord. Lo stesso nitorecon cui la lieta notizia è chiamata a controbilanciare il cupo monitodelle rovine, con l’esposizione della parola laetior a dichiarare subitole intenzioni, depone secondo me a favore di un’intenzione struttu-rante forte, che potrebbe essersi spinta fino a qualche minimo adatta-mento del vero corso dei fatti.
Ora, per quanto sia personalmente persuaso di questa ricostruzio-ne, mi rendo conto di non poterne produrre tangibili prove. Prescin-diamone, per considerare un differente aspetto, e cioè la configurazio-ne che assume sotto i nostri occhi l’attuale dittico di Populonia: algrave monito sulla fralità del tutto è accostato il “recupero” di unagioia tutta mondana, legata all’impegno civico e alla carriera ammini-strativa in cui questo concretamente si traduce. Una gioia derivantedalla posizione e dalla fama conquistate nella società – per quanto li-
Paideia LIX (2004)194
mitata e transeunte – dell’umano consorzio. Temi di non piccolo in-gombro nell’assetto mentale di Rutilio.
Può risultare interessante a questo punto tornare a leggere quellafamosa consolatoria di Servio Sulpicio Rufo a Cicerone (parzialmenteriportata sopra, a nota 11): il tema delle cariche e del connesso presti-gio sociale vi gioca un ruolo importante. Sulpicio sottolinea quale for-tuna abbia avuto la figlioletta dell’amico ad avere in lui un padre pre-tore, console, augure (fam. IV 5, 5); rispondendo, Cicerone confrontala propria situazione con quella di grandi uomini pubblici del passatocolpiti da analoga sventura in un momento in cui potevano trarre dalloro impegno civico qualche consolazione – cosa che a lui rimane alpresente preclusa (fam. IV 6, 1-2). Torna così a sollecitare le nostre fa-coltà critiche il sospetto che Rutilio avesse davvero immediatamentepresenti Sulpicio e Cicerone. E che non solo il motivo “anche le cittàmuoiono”, con certe sue specifiche scelte formali, ma che anche il bi-lanciamento, che registra da un lato mestizia-caducità e dall’altro suc-cessi pubblici-gioia, abbia esso stesso un suo diretto precedente nellatessitura tematica di quell’antico carteggio.
L’affermazione politica, l’assunzione di cariche a vantaggio delgrande organismo di Roma, e la gloria di meritarne di sempre più pre-stigiose: se fosse corretto il mio punto di vista, lo specifico carteggiociceroniano avrebbe cospicuamente cospirato con l’individua strutturamentale rutiliana (a sua volta in piena sintonia con quella mentalità) ascorgere in questi valori il giusto contrappeso alla precarità che ci as-sedia – con l’ineluttabile fondo di amarezze che comporta.
Se le cose fossero andate così ne spiccherebbe ancora più rilevata laconsapevolezza artistica e ideologica con cui Rutilio amministra la suamateria, specialmente in tema di rovine. Tutto è destinato a “cadere”,alla posa definitiva in terra, tutto finirà d’accordo, ma nel breve arcodella nostra esistenza v’è campo a consolazioni, al “levarsi” di forzeche se non altro campiscono un decoroso contrasto al vento da cuisiamo battuti29: la costruttiva tenacia di Roma e la carriera dei probi,encomiabili funzionari che ne sono l’anima e il nerbo. Anche le cittàpossono morire, d’accordo; cionondimeno non corrono un simile ri-schio fino a che ci saranno, ad amministrarle, uomini di tale profilo.Ed è proprio questa la migliore garanzia che un destino affine a quel-
29 Alludo al contrasto fra levarsi e cadere su cui vd. il mio commento, p. 99 e il citato (a no-ta 8) Una giornata di viaggio, pp. 257-262.
A. FO, Crittografie per amici e nemici in Rutilio Namaziano 195
lo della rocca di Populonia non toccherà mai l’aurea Roma, «eterna»per volontà dei Fati, per missione, e – più in dettaglio, lungo il con-creto tragitto dei giorni – per la tutela che le garantisce una stirpe disemina virtutum (I 9 s.) precipitati in precisi individui: i suoi uoministessi, l’aristocrazia senatoria pagana per come è rappresentata da Ru-tilio Namaziano e dai suoi amici, e sbalzata in ulteriore luce dal con-trasto con quei semina dira (I 308) sui cui costumi (e nomi) siamochiamati a giudicare noi posteritas.
ALESSANDRO FO
Università di Siena
































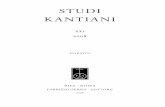




![[Quintiliano], Il ricco accusato di tradimento – Gli amici garanti (Declamazioni maggiori 11; 16), Cassino: Edizioni Università di Cassino 2014.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632670c2dff51a1950049504/quintiliano-il-ricco-accusato-di-tradimento-gli-amici-garanti-declamazioni.jpg)










