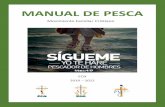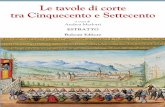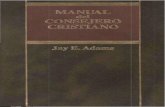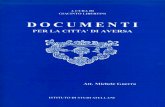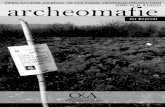Giulia Sfameni Gasparro. Bio-bibliografia (a cura di M. Monaca)
Consolazione a Polibio volgarizzata, a cura di Cristiano LORENZI
Transcript of Consolazione a Polibio volgarizzata, a cura di Cristiano LORENZI
Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano, XVII, 2012
Cristiano Lorenzi Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium
(ms. Laurenziano Plut. 76.61)∗
Il codice Laurenziano Plut. 76.61, segnalato quasi dieci anni fa da Melania Cec-canti e Lara Nicolini, è l’unico testimone noto di un antico volgarizzamento della Consolatio ad Polybium di Seneca 1. Delle altre due consolazioni senecane si cono-sceva già da lungo tempo una trasposizione in volgare, edita nel 1866 da Giuseppe Spezi 2, e conservata – oltre che nello stesso Laurenziano – in altri tre manoscritti: il Vaticano Urbinate lat. 1142, utilizzato dall’editore ottocentesco, il Vaticano Rossia-no 401 e il Casanatense 117 3.
Il Laurenziano è dunque il solo a recare i volgarizzamenti di tutte e tre le conso-lazioni, che sono certo opera di una stessa mano, come si evince anche da una som-maria analisi stilistica. Nella resa volgare dei tre Dialogi, infatti, è proposta con mo-dalità sempre analoghe una traduzione verbum e verbo, secondo una prassi ben dif-fusa nel Medioevo. I risultati sono assai modesti: l’autore – privo della necessaria conoscenza del latino e, più in generale, di basilari nozioni di cultura classica – si li-mita a seguire pedissequamente il dettato del modello, ricalcandone in modo passivo persino il lessico. La traduzione “parola per parola” finisce così per palesare spesso una mancata comprensione del senso del testo originale. Per limitarsi al volgarizza-mento della C. ad Polybium, di cui in questa sede si fornisce per la prima volta l’edi-zione, bastino un paio di esempi significativi: a 3.1 il testo latino tu certe eras di-
∗ Questo lavoro si inserisce all’intero nel progetto DiVo (Dizionario dei Volgarizzamenti), coordinato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Opera del Vocabolario Italiano di Firenze da Giulio Vaccaro e Elisa Guadagnini. Il testo del volgarizzamento qui proposto sarà incluso nel corpus, consultabile on line all’indirizzo http://tlion.sns.it/divo. 1 Cfr. Seneca: una vicenda testuale, Mostra di manoscritti ed edizioni (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 2 aprile-2 luglio 2004), a cura di T. De Robertis e G. Resta, Firenze, Mandragora, 2004, pp. 283-84 (schede a cura di M. Ceccanti e L. Nicolini). 2 Volgarizzamento inedito della Consolazione di Lucio Anneo Seneca ad Elvia ed a Marcia. Testo di lingua tratto di un codice Vaticano, pubblicato e di proemio e note illustrato dal pro-fessor Giuseppe cavaliere Spezi scrittore nella Vaticana, Roma-Torino, Poliglotta-Pontificia, 1866. 3 Per l’Urbinate e il Rossiano cfr. M. Buonocore, Seneca nei manoscritti vaticani, in Seneca. Mostra bibliografica e iconografica, Teatro dei Dioscuri, Roma, 19 gennaio-24 febbraio 1999, a cura di F. Niutta e C. Santucci, [Roma], Fratelli Palombi Editori, 1999, pp. 195-220, alle pp. 199, 201, 204; e Id., Per un iter tra i codici di Seneca alla Biblioteca Apostolica Vati-cana: primi traguardi, in «Giornale italiano di filologia», LII, 2000, pp. 17-100, alle pp. 34, 76 e 78; per il Casanatese, segnalato dalla Nicolini su indicazione di E. Stagni, cfr. l’accurata descrizione con tav. presente nel sito http://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID= 15617 (ultimo accesso 26.03.13).
222 Cristiano Lorenzi
gnissimus qui ne ex indigno quidem quicquam dolores fratre è tradotto, meccanica-mente e poco perspicuamente, «tu, per certo, eri degnissimo, il quale niente ti dolesse del fratello indegnio»; mentre a 4.1 il latino Proinde parcamus lacrimis nihil proficientibus; facilius enim nos illis dolor iste adiciet quam illos nobis reducet è reso con «Perdoniamo addunque alle lagrime niente pro faccenti, imperò che più fa-cilmente questo dolore non a quelle adgiugnerà che esso non riducerà coloro a noi», in cui si notano due incomprensioni lessicali che rendono pressoché privo di senso il passo: il verbo parco + dativo viene inteso non con il corretto valore di ‘astenersi da’, ma con quello di ‘risparmiare, aver riguardo per’ (dunque ‘perdonare’); inoltre non è colto il significato particolare di adicio (‘gettare’), contrapposto a reduco (e di conseguenza illis non è riferito ai cari estinti, ma alle lacrime) 4.
Poste queste premesse, è impossibile avanzare per la traduzione dei tre dialoghi senecani – adespota nella tradizione – la candidatura del colto Bartolomeo da S. Concordio, ventilata a suo tempo dallo Spezi per via indiziaria, ponendo a confronto estratti del volgarizzamento della C. ad Marciam e della C. ad Helviam con i me-desimi passi che si leggono negli Ammaestramenti degli antichi del frate pisano 5. Al di là di minime e fortuite concordanze, nulla ha a che fare la sintassi involuta e fati-cosa del nostro ignoto autore con la raffinata «prosa schietta e insieme sostenuta» 6 del Bartolomeo volgarizzatore; si tratterà piuttosto, come ha giustamente osservato la Nicolini, di «un personaggio minore, un traduttore scolastico non molto compe-tente, che non padroneggia in modo saldo la grammatica latina, e anzi, in molti casi, va incontro a fraintendimenti anche banali e grossolani» 7.
Quanto alla datazione del volgarizzamento (di area toscana, anzi quasi certamen-te fiorentina, come denota la facies linguistica), Spezi riteneva il testo composto «senza fallo tra il declinare del secolo decimoquarto e il sorgere del seguente» 8: ap-purato che i quattro codici citati sono tutti del Quattrocento inoltrato, pare assai più probabile che la traduzione risalga già a tale secolo piuttosto che all’ultimo scorcio del Trecento, come lascia intendere anche il ricorso al verbo tradurre (‘trasportare da una lingua a un’altra’) per la resa del lat. transfero al § 11.5 della Consolazione a Polibio 9. Inoltre, nel ms. Laurenziano si segnalano alcuni vistosi tratti del fiorentino
4 Per rilievi analoghi in relazione alle altre due consolationes, vd. le osservazioni della Nicoli-ni in Seneca: una vicenda testuale, cit., p. 284. 5 Cfr. Volgarizzamento inedito, cit., pp. XXVII-XXXI. 6 Volgarizzamenti del Due e Trecento, a cura di C. Segre, Torino, Utet, 1953, p. 18. 7 Seneca: una vicenda testuale, cit., p. 284. 8 Volgarizzamento inedito, cit., p. X. 9 Si ricordi infatti che il primo uso del significato tecnico del lat. traducere si attribuisce a Leonardo Bruni in una lettera datata 5 settembre 1400 e che le prime occorrenze volgari di tradurre con tale accezione sono quattrocentesche: cfr. G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi, 1991 (rist. Torino, Einaudi, 1994), pp. 66-75. Per la verità il nostro passo («imperò che così quegli da una in altra lingua traducesti» a fronte del lat. «sic enim illa ex
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 223
argenteo, seppure non omogeneamente diffusi; nel nostro testo spiccano l’uso degli articoli determinativi el/e’ (cfr. § 1.2, 2.1, 2.5 e passim) e del numerale dua (11.5, 15.1, 16.3), l’uscita in -no per la prima persona plurale dell’indicativo presente (2.1 habbiano, 4.1 possian, 4.3 dobbiano, 11.3 rallegrianci e rendianlo, 11.4 distendia-no), l’uscita -ono anziché -ano per la terza persona plurale del presente indicativo e quella -orono anziché -arono per la terza persona plurale del perfetto indicativo dei verbi della 1a classe (1.2 minacciono, 11.5 seguitorono, 17.2 giudicorono e soppor-torono), l’uscita in -i per la terza persona singolare del congiuntivo imperfetto (13.2 volessi, 15.5 havessi, 16.3 dovessi e potessi, 17.5 fussi), la forma drento in luogo di dentro (5.5) 10.
Prima di proporre il testo, si fanno seguire alcune indicazioni sull’aspetto mate-
riale del testimone Laurenziano, che contiene esclusivamente le tre Consolazioni in volgare: a Marcia (cc. 1r-35v); a Elvia (cc. 36r-62v); a Polibio (cc. 63r-84r) 11. Si tratta di un codice membranaceo, costituito da 84 cc., precedute da due guardie altre-sì membranacee e seguite da una. Le carte misurano mm. 195 × 129, con uno spec-chio di scrittura – con rigatura ad inchiostro – di mm. 132 × 80 ca. Sono numerate modernamente 1-84 a lapis nel margine inf. destro; nel margine sup. dx. è presente una precedente numerazione a penna saltuaria (10, 20, 30, 40, 50, 60, 64, 70, 80, 85), che includeva anche la seconda guardia anteriore. La fascicolazione è costituita da otto quinterni e un duerno; è sempre rispettata la regola di Gregory. Il testo, di-sposto su venticinque righe per pagina, è di una sola mano, in un’elegante littera an-tiqua, particolarmente accurata, come dimostra la presenza della lettera riempitiva i barrata in fine rigo. A c. 1r è presente un bordo decorativo in foglia d’oro; le lettere iniziali di ciascuna Consolazione sono in foglia d’oro (cc. 1r, 36r e 63r). Titoli ru-bricati, salvo il primo (c. 1r), che è in lettere maiuscole auree. A c. IIv si segnala un clipeo in porpora e foglia d’oro contenente la seguente dicitura: «IN QVESTO | VOLV-ME SI CONT|ENGONO TRE CONSO|LATIONI DI SENECA V|NA A MARTIA E VNA A E|LBIA E VNA A POLIONE | TRADOCTE DI LA|TINO IN VOL|GARE». Proprio l’apparato iconogra-fico sembra fornire qualche indizio utile a circoscrivere meglio la datazione del co-dice, senza dubbio quattrocentesco: se il medaglione laureato con il titolo dell’opera è particolare ampiamente diffuso nei codici umanistici soprattutto nella seconda
alia lingua in aliam transtulisti») non è inequivocabile, in quanto traducesti potrebbe avere il significato tradizionale di ‘trasportare’. 10 Per i tratti elencati cfr. in partic. P. Manni, Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fio-rentino quattrocentesco, in «Studi di grammatica italiana», VIII, 1979, pp. 115-71, rispettiva-mente alle pp. 128-29, 135-36, 161-62, 144-46, 151-54, 159-61, 166-67 (vd. anche, più sinte-ticamente, Ead., Il Trecento toscano. La lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 57-58). 11 Per un’accurata descrizione materiale del ms., con particolare riguardo per l’apparato ico-nografico, cfr. anche la citata scheda a cura di M. Ceccanti in Seneca: una vicenda testuale, cit., p. 283.
224 Cristiano Lorenzi
metà del sec. XV, ben più rara è la decorazione con bordo aureo della carta d’apertu-ra; sulla base del raffronto con i pochi altri esempi di analoghe tipologie decorative Melania Ceccanti ha dunque proposto una datazione del codice a partire dagli anni Settanta del secolo 12.
L’edizione del volgarizzamento è data in forma critico-interpretativa: si sono
quindi divise le parole secondo l’uso moderno, introducendo interpunzione, maiu-scole e diacritici; sono state tacitamente sciolte le abbrevizioni; si è distinta u da v. Le parentesi quadre segnalano eventuali integrazioni. In nota si registrano le corre-zioni di banali errori di copia e si fornisce inoltre il parallelo con il testo latino lad-dove si rilevino gravi errori di traduzione, lacune e, più in generale, in tutti quei casi in cui il latino sia ritenuto utile per la comprensione del testo volgare. A questo pro-posito, qualcosa andrà detto della tradizione latina delle Consolazioni. Come ha illu-strato Reynolds, essa si divide sostanzialmente in due rami 13: il primo è costituito dall’antico e autorevole A (Ambrosianus C 90 inf., sec. XI ex.), da cui dipende il più tardo e numeroso gruppo β (quattro sono i mss. fondamentali, del sec. XIII); il se-condo, definito γ, è invece rappresentato da alcuni recentiores (nessuno anteriore al sec. XIV), tra i quali spiccano R (Vaticanus Latinus 2215, sec. XIV in.) e V (Vatica-nus Latinus 2214, sec. XIV). E proprio alla famiglia γ sembra che appartenesse il te-stimone latino utilizzato dal traduttore, considerato che nella maggior parte dei casi in cui si ha divergenza tra il testo di β (A è privo della C. ad Polybium fino al § 17.2 per la caduta di un fascicolo, e dunque quasi di nessuna utilità) e quello di γ, il vol-garizzamento segue la lezione di quest’ultimo. Le coincidenze più significative sono state registrate in nota 14.
* * *
|63r| Qui inchomincia la consolatione di Seneca ad Polibio suo amicho.
[1.1] Riferisci le cose nostre a noi: esse ferme sono 15; se tu le riduci alla condi-tione della natura guastante tutte le cose, et ad quello medesimo luogho onde essa le mostrò richiamandole, sono caduche. Le mani mortali cosa mortale hanno facto: quelle septe cose mirabili – et se alchune altre più mirabile di queste ha hedificato
12 Cfr. Seneca: una vicenda testuale, cit., p. 283. 13 Per un quadro generale cfr. Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics, edited by L.D. Reynolds, Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 366-67, oltre alla Praefatio dell’ed. L. Annaei Senecae Dialogorum libri duodecim, Oxford, Clarendon, 1977, in partic. pp. VIII-XVII. 14 L’ed. di riferimento per il testo latino (incluso l’apparato) è quella citata alla nota preceden-te. Di tale edizione è stata adottata anche la paragrafatura, al fine di agevolare il confronto fra latino e volgare. 15 Tentativo da parte del traduttore di dare senso all’incipit del dialogo, mutilo nel testo latino («* * * nostrae compares, firma sunt»).
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 225
l’ambitione de’ seguenti anni – qualche volta saranno vedute in terra pareggiate. Im-però ch’è così: niente è perpetuo, poche cose sono di lungo tempo; altra cosa in altro modo è fragile, le distructioni delle cose si variano, ma ciò che chomincia finisce. [1.2] Alcuni al mondo minacciono el fine, et questo universo, il quale abbraccia tucte le cose divine et humane, se tu stimi essere lecito crederlo, sarà da qualche tempo dissipato e sarà sommerso nelle tenebre et nella vechia confusione. Vadia 16 hora al-chuno et piangha ciaschune anime et lamentisi per la cennere di Carthagine et di Nu-mantia et di Chorintho, per alchuna altra cosa la quale più da alto ca|63v|duta sia, quando questo ancora debba perire, el quale non ha dove egli ceda 17! Vadia alchuno et rammarichisi che e’ fati, in qualche tempo haventi havere ardire fare cosa inlecita, a sé non habbino perdonato! [1.3] Chi è di tanta superbia o arroghantia che, in questa necessità della natura tucte le cose a uno medesimo fine rivocante, voglia sé solo et i suoi essere riposti, et alchuna casa sottragha 18 alla ruina, la quale ancora al mondo minaccia? [1.4] Grandissimo sollaçço addunque è pensare che a sé accaduto sia quel-lo che inançi ogniuno ha sostenuto et ogniuno ha a sostenere. Et per questo mi pare che la natura commune habbia facto ciò che essa ha facto gravissimo, acciò che la equalità consolasse la crudeltà del fato.
[2.1] Quello ancora non poco te aiuti se tu penserai che il dolore tuo niente hab-bia a ffare pro né a colui il quale tu desideri né a te: non volere adunque quello sia lungho el quale è vano. Imperò che, se per maninconia noi habbiano a ffare pro al-chuno, io non ricuso per la tua fortuna tucte quelle lagrime spargere le quali alla mia avançano; io troverrò ancora ciò che traschorra per que|64r|sti occhi già pe’ pianti di casa vòti, pure che questo ad bene a te habbia a essere 19. [2.2] Or perché cessi? Rammarichianci, et per certo io farò questa lite mia: «Tu, o Fortuna, pel giudicio d’ogni huomo sei iniquissima! Tu ancora parevi havere contenuto quello huomo il quale per tuo dono haveva ricevuto tanta riverentia in tale modo che – quello che ra-de volte ad alchuno è adivenuto – la sua felicità fuggiva la invidia. Imperò che, ecco, tu hai dato questo dolore a colui el quale, salvo Cesare, tu potevi ricevere grandissi-mo 20; et havendo tu bene colui intorniato tu intendesti che solamente da questa parte egli a’ colpi tuoi era scoperto. [2.3] Imperò che, che altro a colui farai tu? Torresti tu a llui la pecunia? Egli a quella mai sé non obbligò; ancora hora, quanto può quella da sé rimuove et in tanta felicità dell’acquistare, da llei non addomanda fructo alchu-no maggiore che il dispreççamento di colei. [2.4] Torrestigli gli amici? Io sapevo 16 Congiuntivo presente; si tratta di forma popolare del fiorentino argenteo: cfr. G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi, 1966-69, 3 voll., III, p. 298 (§ 556). 17 L’ed. critica ha «cadat», ma in apparato si legge le lezione del ramo γ «cedat». 18 Ms. sottralgha. 19 Per il senso cfr. il lat.: «inueniam etiamnunc per hos exhaustos iam fletibus domesticis ocu-los quod effluat, si modo id tibi futurum bono est». 20 Fraintendimento (o testo latino guasto: poteras per poterat?); cfr. il lat.: «ecce eum dolorem illi, quem saluo Caesare accipere maximum poterat, impressisti».
226 Cristiano Lorenzi
ch’egli era tanto habile che facilmente egli potrebbe substituire altri in luogo de’ per-duti amici. Imperò che solo costui di coloro i quali io ho veduto po|64v|tenti nella casa del principe mi pare havere cognosciuto essere tenuto molto amico a ciaschuno: con ciò sia cosa che utile sia, ancora gli piace. [2.5] Da llui rimoveresti la corporale sanità? Questa in lui è più soda che da te medesima non potrebbe essere percossa. Torrestigli la buona oppinione? Tu sapevi che l’animo suo è sì fondato di liberali discipline, nelle quali non solamente egli è nutrito, ma ancora nato, ch’egli sta sopra a tucti e’ dolori del corpo 21. Leverestigli tu lo spirito? Quanto gli haresti tu nociuto? [2.6] L’egregia fama a llui ha promesso l’età lunghissima; esso ha facto che egli duri in migliore parte di sé et, composto con le egregie opere d’eloquentia, sé dalla mortalità liberi. Mentre che l’honore della latina lingua starà o la gratia delle greca, harà vighore con gli huomini grandissimi, agl’ingegni de’ quali egli sé decte overo, se la verghognia sua questo ricusa, sé appicchò 22. [2.7] Adunque questo solo tu pen-sasti come maximamente a colui tu nuocere potessi, imperò che quanto ciascuno è in maggiore grado, più spesso è usato sopportare te sança riguardo alchuno foribondan-te et ancora tra ’ benificii da essere |65r| temuta. Quanto piccola cosa era a te a fare libero da questa ingiuria quello huomo nel quale pareva che con manifesta ragione fussi pervenuta la indulgentia tua e non fussi chascata temerariamente secondo tuo costume?».
[3.1] Adgiugniamo a queste querele, se tu vuoi, chome il giovanetto è stato tra i primi suoi accrescimenti dalla morte tolto. Colui fu degno d’havere te per fratello: tu, per certo, eri degnissimo, il quale niente ti dolesse del fratello indegnio 23. A colui è renduta la testimonança equale di tucti gli huomini: egli è desiderato nello honore tuo et nel suo è lodato. [3.2] Niente fu in colui il quale tu volentieri non co-gnoscessi: tu ancora saresti stato buono al fratello meno buono, ma la pietà tua in co-lui, acquistata materia idonea, molto più liberamente sé ha exercitato. Nessuno sentì mai con ingiuria la potentia sua, non mai, havendo egli te fratello, alchuno minacciò; sé egli haveva formato allo exemplo della modestia tua, egli pensava quanto or-namento tu de’ tuoi fussi et quanto peso: esso a questa soma bastò. [3.3] O duri fati et a nessune virtù benigni! Inançi che il tuo fratello cognoscesse la felicità sua, |65v| esso fu rapito. Ma io so che non poco io sdegno, imperò che niente è più difficile che trovare le parole pari al dolore grande. Già hora nientedimeno, se in cosa alchuna noi possiamo fare pro, rammarichianci: [3.4] «Or che hai tu voluto fare, o 21 L’esemplare latino tradotto presentava un’inversione dei termini delle due interrogative, così come avviene in γ; cfr. infatti: «Eriperes illi bonam opinionem [ualitudinem γ]? solidior est haec apud eum quam ut a te quoque ipsa concuti possit. Eriperes bonam ualetudinem [opi-nionem γ]? sciebas animum eius liberalibus disciplinis, quibus non innutritus tantum sed inna-tus est, sic esse fundatum, ut supra omnis corporis dolores emineret». 22 Poco chiaro; il lat. ha: «Quam diu fuerit ullus litteris honor, quam diu steterit aut latinae lin-guae potentia aut graecae gratia, uigebit cum maximis uiris quorum se ingeniis uel contulit uel, si hoc uerecundia eius recusat, adplicuit». 23 Lat.: «tu certe eras dignissimus qui ne ex indigno quidem quicquam dolores fratre».
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 227
ingiusta et violenta Fortuna? Tu tacitamente ti sè pentuta della indulgentia tua? Che crudeltà è questa, a ffare impeto nel meçço de’ frategli et così sanguinosa rapina minuire la concordantissima turba? Tu hai voluto perturbare et sança chagione inde-bolire la casa degli optimi giovani bene stivata, et in nessuno fratello degenerante? [3.5] Niente addunque pro fa la innocentia secondo ogni legge facta, niente fa pro la temperantia anticha, niente la potentia della somma felicità e lla somma abstinentia observata, et niente el sincero et sicuro amore delle lectere 24, et niente la mente d’ogni viçio manchante? Piagne Polibio nel fratello solo quello che negli altri egli temere possa admonito ancora de essi inghanni teme a sollaççi suoi la scelerateça indegna 25. Polibio piagne et alquanto si duole, essentegli Cesare propitio! Tu sança dubio, o potente Fortu|66r|na, questo pigliasti a ffare che nessuno contro a te può essere difeso, né da Cesare ancora».
[4.1] Lungho tempo noi accusare e’ fati possiamo, ma non gli possian mutare: quegli stanno duri et inexorabili; nessuno quegli né per villane parole né per pianto conmuove; quegli niente mai adrieto lasciano 26. Perdoniamo addunque alle lagrime niente pro faccenti, imperò che più facilmente questo dolore non a quelle adgiugne-rà 27 che esso non riducerà coloro a noi; il perché se egli ci è contro e non ci aiuta, egli debba giù essere posto nel primo tempo et l’animo debba essere ripreso dalle vane consolationi et dalla amata libidine del dolersi, imperò che se la ragione non fa-rà alle nostre lagrime fine, non lo farà la fortuna. [4.2] Ciò che sia da ffare raguarda intorno a’ mortali 28; in ogni luogo è largha et assidua materia da piagnere: alchuno è chiamato all’opera cotidiana dalla faticosa necessità; alchuno è tormentato dall’am-bitione non mai quieta; altri teme le riccheçe le quali egli ha desiderato, et nel suo desiderio ha faticha; altri è tormentato dalla faticha o dalla sollecitudine; altri piglia passione per |66v| la turba, l’uscio suo obsediante; costui si duole havere figliuoli; quest’altro havergli perduti: a noi mancheranno le lagrime e lla cagione del dolersi. [4.3] Non vedi tu quale vita la fortuna a noi habbia promesso, la quale ha voluto che il primo sia el pianto negli huomini nascenti? Con questo principio noi fuora siamo mandati, a questo consente l’ordine di tucti gli anni seguenti. Così noi meniamo la vita, e perciò temperatamente quello da noi debba essere facto il quale spesso noi a ffare habbiamo et, raguardanti quante cose di maninchonia adrieto ci rimanghano, se noi non dobbiano finire le lagrime, almeno noi dobbiano per certo conservarle. Et
24 Ms. lectre. I pochissimi ess. in fiorentino di lettra, lettre attestati dal TLIO sono tutti in poe-sia (e vd. qui infra, § 8.2 la forma lectere). 25 Fraintendimento del testo lat., che reca: «Luget Polybius et in uno fratre quid [quicquid nel-l’archetipo] de reliquis possit metuere admonitus etiam de ipsis doloris sui solaciis timet. Fa-cinus indignum!». 26 Lat.: «parcunt nec remittunt» (ma γ omette parcunt nec). 27 Fraintendimento del traduttore (lat.: «facilius enim nos illis dolor iste adiciet»). 28 Il volgarizzatore leggeva qui il testo della famiglia γ: «quid agendum sit mortalis circumspi-ce » (ed. critica: «Omnis agedum mortalis…»).
228 Cristiano Lorenzi
non è tanto da perdonarsi a quella cosa quanto a questa l’uso della quale è tanto spesso.
[5.1] Quello ancora te non poco aiuti, se tu penserai che a nessuno è meno grato el dolore tuo che a colui al quale tu pari prestarlo: colui o e’ non vuole o e’ non in-tende che tu sia tormentato. Nessuna ragione addunque è ancora di quello ufficio il quale a colui al quale egli è dato è soprabbondante, se egli non lo sente, et, se lo sente, è ingrato. [5.2] Io dirò arditamente che in tucto el mondo non |67r| è alchuno il quale delle tue lagrime si dilecti. Perché addunque fai tu così? Quello animo il quale nessuno ha contro a te credi essere nel tuo fratello? Che egli a te con tormento nuo-cha, che te egli voglia rimuovere dalle occupationi, cioè dallo studio et da Cesare 29? Imperò che colui a te come a fratello à perdonato et hatti riverito come padre et come superiore t’à honorato: egli a te vuole essere a desiderio et non a tormento. Che giova addunque che tu nel dolore così invilischa, innel quale, se senso alchuno è del morto, el tuo fratello desidera che finischa? [5.3] Dell’altro fratello, la volontà del quale potrebbe parere incerta, tutte queste cose io non porrei et direi dubbiosamente: «Overo el tuo fratello desidera che tu sia tormentato dalle lagrime non mai man-chanti: questo è indegno dell’affecto tuo; overo esso non vuole licentia: quello all’uno et l’altro di voi accostantesi 30; né l’impio fratello così desiderare debba, né il pio così voglia». Ma in questo, la pietà del quale è tanto manifesta, come è da essere tenuto per certo, niente è a colui più acerbo 31 che se questo suo caso acerbo è a te, se te in modo alchuno tormenta, |67v| se gli occhi tuoi, indegnissimi di questo male, conturba sança fine alchuno di piangere et medesimamente gli vòta.
[5.4] Nientedimeno, niente tanto dalle disutili lagrime rimoverà la pietà tua quanto se tu penserai che tu debba a’ tuoi frategli essere l’exemplo del sostenere fortemente questa ingiuria della fortuna. Or che fanno e’ grandi duchi nelle loro cose afflicti, acciò che in pruova essi simulino allegreçça et con la adombrata letitia naschondino le loro adversità, acciò che e’ soldati loro, veggendo la mente del duca afflicta, non ancora essi invilischano 32? Questo ancora da te debba essere facto. [5.5] Vèstiti un volto simile 33 all’animo tuo et, se tu puoi, rimuovi in tucto el dolore; se tu non puoi, naschondilo drento et rattienlo ché egli non apparischa, et dà opera che i frategli tuoi sé seguitino 34, e’ quali stimeranno honesta qualunque cosa te essi vedranno faccente, e ssì el volto loro piglieranno dall’animo tuo. Tu debbi essere el
29 La frase che segue nel testo lat. non è stata tradotta: «Non est hoc simile ueri». 30 Non dà senso (probabile che il testo tradotto fosse qui guasto); cfr. il lat.: «utrique uestrum inhaerentem dolorem dimitte». 31 È tradotto il testo di γ, non quello di β: «ut [om. β] pro certo habendum est nihil illi esse [esse illi posse β] acerbius». 32 Ms. inuilaischano, con la prima a cassata. 33 Ma il lat. ha «dissimilem». 34 Errore (già nel testo latino?): cfr. il lat. «te imitentur».
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 229
sollaço, el consolatore loro; ma tu non potrai obstare al dolore loro, se al tuo non ha-rai perdonato.
[6.1] Et quella cosa ancora te può dal troppo pianto rimuovere, se a te mede-si|68r|mo tu rinumptierai che nessuna di quelle cose le quali tu fai può essere sot-tracta. El consenso degli huomini sopra te à posto la gran persona: questa debba essere difesa et guardata. Intorno a te sta tucta questa frequentia de’ consolanti et nell’animo tuo raguarda et cercha quanta forteçça in lui sia, e se tu solamente sai usare fortemente le cose prospere overo che virilmente tu ancora sopporti l’adversi-tà: gli occhi tuoi sono observati et raguardati. [6.2] Tucte le cose a coloro sono libere, gli affecti de’ quali possono essere coperti: a te nessuno segreto è libero. La fortuna te in molta luce ha posto; ogniuno saprà come in questa tua ferita tu ti sia portato: o se tu percosso subitamente l’arme habbia sottoposte, o se nell’andare tuo tu ti sia fermo. Pel passato, et la morte di Cesare et gli studii tuoi te hanno innalçato in alto ordine; a te non si confà alchuna cosa plebea o bassa. Ma che cosa è più bassa et feminile che dare sé a essere consumato dal dolore? [6.3] Non nel pari pianto a te è lecita quella medesima cosa la quale lecita è a’ fratelli tuoi; molte cose a te non concederà l’oppinione ricevuta degli |68v| studii et costumi tuoi: molto da te adoman-dano, molto aspectano gli huomini. Se tu volevi che a te fussi ogni cosa lecito, non havessi rivolto in te e’ conspecti d’ogniuno: hora da te tanto si debba fare quanto tu hai permesso. Tucti coloro sono guardie degli animi tuoi, e’ quali lodano et di-scrivono l’opere del tuo ingegno, a’ quali, con ciò sia cosa che bisogno non sia della fortuna tua, bisogno è dello ingegno tuo. Tu nessuna cosa mai così indegna fare puoi nella professione d’huomo perfecto et erudito, che molti non si pentano della admi-ratione loro inverso te. [6.4] Non è lecito a te piagnere sança modo, né questo ancora solamente 35 non t’è lecito: né ancora a te è lecito distendere el somno nella parte del dì o nel tumulto delle cose fuggire nell’otio della quieta villa o per la volontaria per-regrinatione ricreare el corpo affatichato nella assidua stança del faticoso uficio o ritenere lo animo nella varietà de’ dilectevoli giuochi o secondo l’albitrio tuo el dì disporre. Molte cose a te non sono lecite, le quali sono lecite agli huomini ancora vilissimi et plebei: la grande fortuna è grande servitù. [6.5] Non è |69r| lecito a te alchuna cosa per l’albitrio tuo fare: tante migliaia di uomini debbano essere uditi, tanti libelli debbano essere ordinati; tanta grande è l’ordinata congreghatione degli huomini 36 di tucto el mondo insieme raghunantisi che l’ufficio d’uno grandissimo principe possa essere per l’ordine suo facto, in ciaschuno luogho debba essere rilevato l’animo 37. Io ti dico a te non è lecito piagnere, acciò che le lagrime de’
35 Ms. sosolamente. 36 Il lat. ha «rerum». 37 Poco chiaro il senso; il volgarizzatore leggeva senza dubbio il testo di γ: «tantus rerum ex orbe toto coeuntium congestus, ut possit per ordinem suum principis maximi officium geri ubique erigendus est animus» (ed. critica: «…maximi animo subici, exigendus est»).
230 Cristiano Lorenzi
pericolanti et desideranti venire alla misericordia dello agevolissimo Cesare sieno admesse; le tue da te debbono essere rasciutte 38.
[7.1] Queste cose ancora te con leggieri rimedii aiuteranno: quando tu vorrai tucte le cose dimentichare, penserai in Cesare. Tu vedi di quanta fede d’indulgentia et di quanta industria tu sè debitore alla vita di colui: tu intenderai non più a te essere lecito essere pieghato che a colui, se alchuno nelle favole è posto, in su gli homeri del quale s’appoggi el mondo. [7.2] Ancora a esso Cesare, al quale ogni cosa è lecita, per questo medesimo non sono lecite molte cose: la vigilia di colui difende le case d’ogniuno et dalla fatica di |69v| colui è difeso l’otio d’ogniuno, le dilichateççe d’ogniuno sono difese dalla industria di colui, et la vachatione d’ogniuno dalla faticha et occupatione di colui è conservata. Per la quale cosa Cesare sé al mondo ha dato et a sé medesimo sé ha tolto; e, secondo el costume delle stelle 39, sempre è in corso, a colui non mai lecito è fermarsi né fare alchuna cosa sua. [7.3] Ad alchuno modo addunque a te è data quella medesima necessità: non è a te lecito raguardare alle utilitadi tue né a’ tuoi studii. Possedente Cesare el mondo, tu te non puoi com-partire a voluptà o a dolore o ad alchuna altra cosa: tu tucto a Cesare sè obbrighato. [7.4] Adgiugni hora che, dicendo tu sempre che Cesare a te è più charo che lo spirito tuo, a te non è lecito, essendo salvo Cesare, della fortuna ramaricharti. Quando es-sendo costui in salute, e’ tuoi salvi sono, tu niente hai perduto e si conviene che gli occhi tuoi non solamente secchi sieno, ma ancora lieti; in costui a te sono tucte le cose, costui a te è per tucti. Quello che da llà lungi da’ sensi tuoi prudentissimi et pietosissimi si dischosta, |70r| tu inverso la tua felicità poco sè grato, se tu, essendoti costui salvo, a te alquanto piagnere concedi.
[8.1] Io ti mostrerrò ancora rimedio non per certo più fermo, ma più familiare. Se mai tu ad casa vai, allora debba da te essere temuta la maninchonia, imperò che mentre che tu raguarderai la deità tua, colei non troverrà venuta alchuna ad te, Cesare ogni cosa in te terrà; quando colà tu andrai, allora, come data l’occasione, el dolore insidierà alla passione tua et a poco a poco entrerrà nell’animo tuo riposato. [8.2] Addunque non patire che tempo alchuno vacuo sia dagli studii: allora le lectere, da te tanto lungo tenpo et così fedelmente amate, a te la gratia rendano; allora quelle liberino te, loro principe et cultivatore; allora teco molto dimorino Homero et Virgilio, tanto bene portati sì inverso l’humana generatione, quanto tu ti sè bene portato inverso ogniuno, et inverso coloro i quali tu hai voluto essere noti a più che
38 Di nuovo il testo tradotto è quello di γ: «ut <preces> [integrazione degli edd. moderni] periclitantium et ad misericordiam mitissimi Caesaris peruenire cupientium, lacrimae admittantur [om. β] tibi tuae adsiccandae sunt». La proposizione latina che precede, invece, non è tradotta: «ut multos flentes audire possis». 39 Si traduce γ: «siderum more» (ed. critica: «siderum modo»).
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 231
non havevano scripto 40: tucto quello tempo sarà sicuro, el quale tu a coloro in difen-sione commetterai. Allora tu quanto potrai comporrai l’opere del tuo Ce|70v|sare, ac-ciò che per tucti e’ secoli esse sieno narrate pel bando di casa 41, imperò che esso a te darà la materia et l’exemplo del formare optimamente et del comporre le cose facte. [8.3] Io non ho ardire di produrti insino ad questo, che tu ancora le favole et gli apo-logi d’Isopo, opera interpetrata 42 da’ Romani ingegni, congiunga con loro usato or-nato. Difficile è che a questi piacevoli [studi] 43 l’animo tanto vehemente percosso così presto venire potesse: nientedimeno io ho questo arghumento, che già le forçe sue inghagliardischano et a llui si rendano, se da severi scripti egli potrà procedere a questi più sciolti. [8.4] Imperò che in quegli l’austerità di quelle cose le quali egli ritractava 44 rimosse lui, benché infermo et ancora sé riluctante; questi, e’ quali sono da essere imparati con la fronte aperta, non sopporterà, se none quando già da ogni parte egli sarà costante. Addunque tu doverrai primamente lui exercitare con la ma-teria più severa, e di poi con la più piacevole temperarlo.
[9.1] Quello anchora ti farà grande allegeramento se spesso tu così te domande-rai: «Or dolghomi io a mio nome o a quello di colui il quale è morto? Se |71r| a mio, perisce el vantarsi dell’amore inverso lui, et chomincia el dolore, schusato solamente perché è honesto: quando esso vede l’utilità, dalla pietà rubellarsi 45; ma niente si confà meno al buono huomo, che nel pianto del fratello le ragioni chalchulare. [9.2] Se io mi dolgho a nome di colui, necessario è che io giudichi l’una di queste due cose essere: imperò che se a’ morti nessuno senso resta, el mio fratello è uscito di tucti gl’incommodi della vita et è stato in quello luogho restituito, nel quale egli era stato innançi che esso nascesse, et sança ogni male niente teme, niente desidera et niente patisce; or che furore è questo che io non mai manchi per colui dolermi, il quale non ha mai a dolersi? [9.3] Se egli è senso alchuno nel morto, hora l’animo del mio fratello, chome dalla divina prigione 46 licentiato, essente finalmente in sua potestà et nell’albitrio suo, ghode et usa el raguardamento della natura et tucte le cose humane da superiore luogo in giù raguarda, ma le divine cose, la ragione delle quali tanto lungho tempo invano haveva cercho, più da ppresso vede. Or perché mi macero io pel desiderio di colui il quale è |71v| o beato o nessuno? A piagnerlo beato è invidia, et a piagnere se nessuno egli è, stoltitia».
40 Lat.: «tunc Homerus et Vergilius, tam bene de humano genere meriti quam tu et de omni-bus et de illis meruisti, quos pluribus notos esse uoluisti quam scripserant, multum tecum mo-rentur». 41 Lat.: «ut per omnia saecula domestico narrentur praeconio». 42 Ma lat.: «intemptatum ... opus». 43 Lat.: «ad haec hilariora studia». 44 L’edizione critica ha «tractabit», ma in apparato si legge: «tractabat (ex retr- V) γ». 45 Traduzione poco perspicua; cfr. il lat.: «Si meo, perit indulgentiae iactatio et incipit dolor, hoc uno excusatus quod honestus est, cum ad utilitatem respicit, a pietate desciscere». 46 Si traduce la lezione di γ: «diuino carcere» (gli altri mss. «diutino carcere»).
232 Cristiano Lorenzi
[9.4] Or 47 muoveti perché egli pare havere manchato de’ beni grandi et maxima-mente circumfusi? Quando tu harai pensato che molti sono quegli beni i quali egli ha perduti, pensa che più sono quegli i quali egli non teme: l’ira lui non tormenta, non lo affrigge la malattia, non lo provocherà el sospecto, non la invidia consumatrice et inimica sempre agli altrui processi lo perseguiterà, non lo solleciterà la paura, non lo molesterà la leggereça della fortuna presto e’ doni suoi transferente. Se tu fai bene la ragione, più a llui è stato rimesso che tolto. [9.5] Egli non userà l’abbondantie et la tua insieme e lla sua gratia, egli non riceverà e’ beneficii et non gli darà. Tu stimi essere misero che egli queste cose ha perduto or non lo stimi tu beato perché egli non le desidera? Credi a me: colui è più beato al quale la fortuna è soprabbondan-te 48, che colui al quale essa è parata. Tucti questi beni, e’ quali con fallace voluptà dilectano – cioè pecunia, potentia, dignità et più altre cose |72r| alle quali la ciecha cupidità della generatione humana stupisce 49 – con faticha sono possedute, sono raguardate con invidia, et coloro medesimi sgravano et aggravano 50; più minacciano che esse non fanno pro; sono cose di giuocho et incerte, non sono mai bene tenute. Imperò che, benché pel tempo futuro niente si tema, nientedimeno essa tutela della grande felicità dà grande sollecitudine 51. [9.6] Se tu vuoi credere a coloro i quali più altamente la verità raguardano, ogni vita è tormento. Noi gittati in questo profondo et inquieto mare con le schanbievoli onde rimutantesi, et alchuna volta noi alleggerenti pei subiti accrescimenti et alchuna volta con maggiori danno habbando-nanteci et assiduamente rivoltanteci, non mai ci fermiamo in luogho alchuno stabile; noi pendiamo et ondeggiamo et l’uno nell’altro ci percotiamo et alcuna volta noi in mare rompiamo, sempre temiamo in questo alto mare. Et a tucte le tempeste di-sposto, nessuno porto habbiamo se none la morte. [9.7] Non havere addunque al tuo fratello invidia: egli, finalmente libero, si riposa; et è finalmente sicu|72v|ro et final-mente ecterno. Egli ha Cesare soprarestante et ogni sua progenie; egli ha te soprare-stante con i comuni frategli. Inançi che la fortuna del suo favore alchuna cosa mutas-se, egli colei lasciò stantesi ancora et con la piena mano e’ doni accrescente. [9.8] Egli usa hora l’aperto et libero cielo; e dal basso et infimo luogo egli è in quel luogho ito nello quale colui – chiunche si sia – l’anime da leghami sciolte nel beato seno riceve; et hora colui liberamente va vaghandosi, raguarda hora con sommo piacere tucti e’ beni della natura. Tu erri: el tuo fratello non ha perduto la luce, ma hanne acquistata una più sicura. [9.9] A noi tucti colà è il viaggio comune: perché ci
47 Qui e infra (§§ 9.5, 9.9, 11.4 e 12.4) ricorre la forma or per la congiunzione disgiuntiva (che traduce i latini an / -ne enclitico). 48 Fraintedimento del senso: qui il lat. superuacua vale invece ‘superflua’. 49 Lat.: «aliaque complura ad quae generis humani caeca cupiditas obstupescit». 50 Incomprensione del testo lat. da parte del traduttore («eos denique ipsos quos exornant et premunt»). 51 Lat.: «nam ut nihil de tempore futuro timeatur, ipsa tamen magnae felicitatis tutela sollicita est».
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 233
dolghiamo noi de’ fati? Colui non ha lasciato noi, ma egli ha facto la via innançi. A me credi: grandissima felicità è nella felicità del morire. In tucto el dì niente a me è certo: chi in tanto obschura et rinvolta varietà 52 indovina or ha la morte al tuo fratello portato invidia overo buono consiglio?
[10.1] Ancora, questo pensare si debba perché la giustitia è in tucte le cose; necessario è che essa te aiuti pensante che a te non è stata facta ingiuria, perché tu |73r| tale fratello hai perduto, ma a te è stato dato beneficio, perché tanto lungo tempo a te è stato lecito la pietà di colui usare. [10.2] Iniquo è colui il quale al dante non lascia l’albitrio del suo dono; avido è colui il quale non ha in luogo di guadagno quella cosa la quale egli ha ricevuto, la quale già renduta ha al dante 53. Ingrato è colui il quale chiama ingiuria el fine del piacere; stolto è qualunche stima non essere fructo alchuno se none de’ beni presenti, et il quale ne’ passati non si contenta et quegli giudicha essere più certi e’ quali già si sono partiti, imperò che niente è da temere che quegli manchino. [10.3] Troppo ristrigne l’allegreççe sue colui il quale usare stima solamente quelle cose le quali egli ha o vede, et perché quelle medesime egli habbia havuto per niente stima, imperò che presto noi da ogni voluptà lasciati siamo, la quale traschorre et passa et quasi innançi che essa vengha è tolta. L’animo addunque debba essere nel passato mandato et richiamato debba essere ciò che mai noi dilectò et quello con frequente pensiero ritractato: più lungha et più fedele è la memoria delle voluptà |73v| che la presentia. [10.4] Or che ci è addunque? Tu ài havuto l’optimo fratello: ponlo ne’ sommi beni. Non è il perché 54 tu pensi quanto più lungho tempo tu havere l’abbia potuto, ma quanto tempo tu havuto l’abbia. La natura colui a te chome a tucti gli altri suoi frategli non per servo ha dato, ma a te l’à prestato; quando egli è partito di poi lo raddomanda 55 et in lui essa non ha seguitato la satietà tua, ma la sua legge. [10.5] Se alchuno molestamente sopporti havere paghato la credutagli pecunia 56, et quella speçialmente l’uso della quale egli habbia havuto in dono, or non sarà egli tenuto ingiusto 57? La natura al fratello tuo ha dato la vita et àlla data a te; essa addunque ha usata la ragione sua da chi essa ha voluto, essa più presto ha rischosso el debito suo: non è colei nella colpa, la conditione della quale è nota, ma la mortale sperança dell’animo avida 58, la quale di poi ciò che sia la natura dimenticha né mai della sorte sua si ricorda, se none quando essa è ad-
52 Di nuovo si traduce il testo di γ («uarietate») e non quello di β («ueritate»). 53 Parziale incomprensione; cfr. il lat.: «auidus qui non lucri loco habet quod accepit, sed damni quod reddidit»; il testo di γ presenta qui una breve lacuna («sed ... reddidit»), assente nel volgarizzamento (anche se il testo tradotto pare qui errato, con danti in luogo di damni). 54 Lat.: «non est quod». 55 Fraintendimento; cfr. il lat.: «cum uisum est deinde repetît». 56 Lat.: «pecuniam creditam». 57 Si traduce il testo di γ: «eam praesertim cuius usum gratuitum habuerit (acceperit β), nonne iniustus (iniustus uir β) habetur (habeatur β)?». 58 Cfr. il lat.: «mortalis animi spes auida»; il volgarizzatore riferisce mortalis a spes, anziché a animi.
234 Cristiano Lorenzi
monita. [10.6] Rallegrati addunque che tu ài havuto buono fratello et l’usufructo di lui, benché breve sia stato al desiderio tuo. |74r| Pensa che giocondissimo sia stato ciò che tu hai havuto, et ciò che tu hai perduto humano, imperò che niente tra sé è meno consentiente che alchuno commuoversi che secho tale fratello poco tempo sia stato et ciò che nientedimeno sia stato non se ne rallegrare 59.
[11.1] «Ma egli è stato tolto inoppinatamente». La sua credulità ciaschuno in-ghanna et in quelle cose le quali sono amate dalla volontaria oblivione de’ mortali: la natura ha testimoniato sé a nessuno dovere fare gratia della necessità sua. Ogni dì innançi agli occhi nostri passano corpi morti di nostri noti et non noti; noi nientedimeno altro facciamo et stimiamo che quello sia sùbito, el quale a noi è dinumptiato dovere essere in tucta la vita. Non è addunque questa iniquità de’ fati, ma malignità della mente humana, insatiabile di tucte le cose, la quale di quindi uscire sdegna dove per priegho essa fu messa 60. [11.2] Quanto è colui più giusto el quale, numptiata la morte del figliuolo, fuora mandò la voce del grande huomo de-gna: «Poi che costui io generai, io seppi che egli morire doveva». Non ti maraviglia-re |74v| che di costui sia nato colui el quale fortemente morire potesse. Egli non rice-vette la morte del figliuolo come novella nuova: imperò che 61 è cosa nuova che l’huomo muoia, la vita del quale tucta niente altro è che viaggio alla morte? [11.3] «Quando io lo generai, io seppi che egli morire doveva»; di poi aggiunse cosa di maggiore prudentia et animo: «et a questo io l’ò allevato». Per questo noi nutriti siamo: chiunque alla 62 vita è mandato, alla morte è destinato. Rallegrianci di quello il quale a noi è dato et rendianlo quando ci è raddomandato. Altri in altro tempo da’ fati sarà giunto, nessuno sarà trapassato: stia l’animo parato et ciò che è necessario non tema mai, ciò che è incerto aspecti sempre. [11.4] Or che dirò io de’ duchi et della progenie de’ principi et di coloro i quali a molti consolati e triomphi chiamati furono, i quali tucti morti sono per lo inexorabile fato? Tucti e’ regni con li re et i popoli con le genti portato hanno el fato loro 63; ogniuno, ançi tucte le cose all’ulti-mo dì raguardano. Non è a tucti universalmente uno medesimo fine: alchuno dalla vita è nel meçço del corso abbandonato, |75r| alchuno in essa entrato, alchuno nella extrema vecchiaia et lasso et uscirne desiderante, chi in un tempo et chi in un altro; tucti nientedimeno in uno medesimo luogho ci distendiano. Or se più stolta cosa sia, io non so, a non sapere la legge de’ mortali o più inprudente a ricusarla. [11.5] Considera in buona hora quelle cose le quali per la molta faticha del tuo in-gegno sono celebrate; nelle tue mani piglia e’ versi di quale de’ dua auctori 64 ti pia-
59 Non dà senso; cfr. il lat.: «nec enim quicquam minus inter se consentaneum est quam ali-quem moueri quod sibi talis frater parum diu contigerit, non gaudere quod tamen contigit». 60 Lat.: «quae indignatur inde se exire quo admissa est precario». 61 Ms. perche. 62 Ms. halla. 63 Ms. looro, con la seconda o barrata. 64 Omero e Virgilio, tradotti da Polibio (cfr. anche supra, § 8.2).
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 235
ce, i quali tu così hai risoluto che, benché l’ordine loro partito sia, nientedimeno la gratia loro rimangha, imperò che così quegli da una in altra lingua traducesti, che – quello che era difficilissimo – tucte le virtù te nell’altrui lingua seguitorono. Nessu-no libro sarà in quegli scripti il quale non ti porgha moltissimi exempli della varietà humana et de’ casi incerti et delle lagrime, or per questa, or per quell’altra cagione traschorrenti. [11.6] Leggi con quanto spirito tu habbia intonato nelle grandi paro-le 65: tu ti verghognerai subitamente manchare et rubellarti da tanta grandeçça dell’o-ratione; non commetterai che qualunque nell’exemplo 66 et nel modo si maraviglerà degli scripti tuoi |75v| cerchi chome tanto fragile animo conceputo habbia cose tanto grandi et tanto sode.
[12.1] Da queste cose più tosto rivoltati, le quali ti tormentano, et a queste così grandi et tante, le quali consolano, diriççati, et raguarda e’ tuoi optimi frategli, ra-guarda la moglie, raguarda el figliuolo: per la salute d’ogniuno la fortuna teco è ca-duta con questa parte 67. Tu molti hai co’ quali tu ti riposi: libera te da questa infa-mia, che a ogniuno non paia che appresso a te più possa uno dolore che questi molti sollaççi. [12.2] Tu vedi tucti costoro techo insieme perchossi, et né a te potere sov-venire intendi, ançi di loro volontà ancora spectare che da te essi sollevati 68 sieno; et per questo quanto meno in coloro è di doctrina et d’ingegno, tanto più è necessario che tu al comune male resista. Ma questo ancora è in luogho di consolatione tra mol-ti el suo dolore dividere, el quale, quando tra più è dispensato, appresso a te in pic-cola parte rimanere debba.
[12.3] Io non mancherò a te spesse volte offerire Cesare: reggente colui le terre et mostrante quanto meglio per beneficii si reggha lo imperio che per l’armi, |76r| es-sente colui alle cose humane signore, non è pericolo che tu senta havere perduta cosa alchuna; in costui solo a te è assai d’aiuto et di sollaçço. Innalça te et quante volte gli occhi tuoi dalle lagrime sono coperti, tante volte quegli in Cesare diriçça: eglino si rasciugheranno nel cospecto della chiarissima deità 69; lo sprendore di quella gli ab-baglierà in modo che niente altro raguardare possano, et riterragli in sé accostantisi. [12.4] Costui da te debba essere pensato, el quale e’ dì e lle nocti tu vedi, dove non mai tu l’animo abbassi; costui debba essere advocato contro alla fortuna. Et non du-bito che, con ciò sia cosa che a llui sia tanta mansuetudine inverso tucti e’ suoi et tanta indulgentia, egli non habbia già questa tua ferita ricoperta con molte consola-tioni et non habbia insieme raghunato molte cose, le quali al tuo dolore si contrapo- 65 Il lat. «ingentibus [...] uerbis» messo a testo dagli editori moderni, e tradotto anche dal vol-garizzatore, si trova solo, come correzione o congettura, in alcuni dei codici recentiores indi-cati da Reynolds con la sigla complessiva ς (mentre l’archetipo latino ha «ingentibus ... re-bus»). 66 Ms. emplo; cfr. il testo dei testimoni latini: «exemplo ac modo» (mentre l’ed. critica legge, con congettura, «exempto modo»). 67 Lat.: «pro omnium horum salute hac tecum portione fortuna decidit». 68 Ms. solleuuati. 69 Lat.: «maximi et clarissimi conspectu numinis» (ma γ omette maximi et).
236 Cristiano Lorenzi
nessino. Ma ancora, benché nessuna di queste cose habbia facto, or Cesare, solamen-te pensato et raguardato, non sarà egli a te consolatione grandissima? Gl’iddii e lle ddee 70 colui alle terre lungo tempo concedano. [12.5] Questi acti dello iddio Augusto tanto tempo vin|76v|chano 71; quanto tempo egli tra ’ mortali sarà, non 72 senta della famiglia sua alchuna cosa essere mortale. Con lungha fede appruovi el figliuolo al romano imperio rectore et innançi veggha colui nella medesima sorte del padre che successore 73. Tardo 74 et finalmente a’ nostri discendenti noto sia quel dì innançi che la sua gente colui nel cielo essere affermi 75.
[13.1] Abstieni, o Fortuna, da costui le tue mani et in costui la potentia tua non mostrare, se none in quella parte dove pro gli faccia. Patisci che colui alla generatione humana, già lungo tempo afflicta et inferma, medichi; patisci che costui nel suo luogho ristituischa et ripongha ciò che commosse el furore del principe dinançi. Voglia che questa stella, la quale ha dato sprendore al mondo nel profondo trabocchato et nelle tenebre sommerso, sempremai rilucha. [13.2] Costui la Francia 76 pacifichi, apra l’Inghilterra et i paterni et nuovi triomphi acquisti; de’ quali me dovere essere raguardatore la clementia promecte, la quale delle virtù sue el primo luogo obtiene 77. Imperò che esso me non così ha abbassato che e’ non volessi me riççare, ançi non m’à abbassato, ma àmmi sostenuto cadente et dal|77r|la fortuna sospinto et l’uso della divina mano con temperantia giù me ha posto in ruina andante: egli per me el senato ha preghato et la vita non solamente a me ha data, ma ancora l’ha addomandata. [13.3] Veggha di che qualità egli vuole che io sia, stimi la mia causa 78; et overo la giustitia sua la mia causa buona raguardi, overo la clemen-tia la faccia buona: l’uno e ll’altro beneficio suo a me sarà equale, overo sappia ove-ro voglia che io innocente sia. In questo meço grande sollaçço è delle miserie mie vedere che la misericordia sua tucta la terra circumdi, la quale, havendo da questo medesimo minimo luogo, dove io fitto sono, molti con la ruina di molti anni sot-terrati fuora tacto et ad luce schanbievolmente rimenato, non dubito che me, huomo 70 Per il raddoppiamento, documentato anche infra, §§ 15.3 (lo ddio) e 15.4 (dello ddio), cfr. Rohlfs, Grammatica, cit., I, p. 203 (§ 153): «in Toscana Dio dopo vocale viene pronunciato Ddio (esempio solo Ddio), la quale forma è da identificare con Iddio». 71 Ancora si traduce il testo di γ: «Acta hic diui Augusti tam diu uincat» (ed. critica: «... diui Augusti aequet, annos uincat»). 72 Ms. nNon, con la prima n barrata. 73 Lat.: «Rectorem Romano imperio filium longa fide adprobet et ante illum consortem patris quam successorem aspiciat». 74 Ms. Tarda. 75 Lat.: «illum gens sua caelo adserat». 76 Ma in lat. «Germaniam». 77 Lat.: «quorum me quoque [om. γ] spectatorem futurum, quae ex uirtutibus eius primum op-tinet locum, promittit clementia»; in questo caso la famiglia γ presenta una lacuna (primum … locum), assente invece nel volgarizzamento (ma il testo è colmato già da una seconda mano in V: vd. l’apparato dell’ed. latina ad loc.). 78 Lat.: «Viderit: qualem uolet esse existimet causam meam».
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 237
virile, passi 79. Ma esso optimamente ha conosciuto el tempo nel quale me egli soc-correre debba, et io darò ogni opera che esso ad me pervenire non si verghogni. [13.4] Felice io chiamo la tua clementia, o Cesare, la quale fa che gli sbanditi sotto te vivono più quietamente che non vixono nuovamente e’ principi sotto Gaio! Non hanno paura et ogni hora non |77v| aspectano il coltello et non ad ogni conspecto di navi temono; per te essi hanno come il modo della crudele fortuna, così ancora la sperança della migliore fortuna et di quella presente la quiete. Lecito è che tu sappia che quelle saette finalmente sono giustissime, le quali e’ percossi ancora honorano.
[14.1] Questo principe, addunque, il quale è publico sollaço di tutti gli huomini, o io sono da tucte le cose inghannato, o egli già ha ricreato l’animo tuo et a 80 così grande ferita egli ha agiunto maggiori rimedii. Già in ogni modo te egli ha confer-mato, già a te egli con la sua tenacissima memoria ha riferito tucti gli exempli pe’ quali all’equità dell’animo costrecto fussi, egli già ha sviluppato con la sua consueta facundia e’ precepti di tutti e’ savi. [14.2] Nessuno meglio queste parti del parlare ha occupato: parlante costui, le parole, come dall’oraculo mandate, altro peso haranno; la sua divina auctorità oppresserà ogni força del tuo dolore. Stima addunque che costui a te dica: «La fortuna non solamente te ad sé ha preso, el quale essa con tanta ingiuria affectionasse: nessu|78r|na casa in tucto el mondo o è o ella fu sança qualche afflictione. Io passerò alchuni exempli volghari, e’ quali se minori ancora sono, nientedimeno sono maravigliosi: io te ridurrò alle annuali historie 81. [14.3] Tu vedi tucte queste inmagini, le quali hanno ripieno la stança di Cesare? Non è alchuna tra queste la quale non sia molto conosciuta per qualche sua incommodità; nessuno è tra questi huomini egregii, nell’ornamento del secolo risprendienti, il quale o non sia stato con desiderio de’ suoi tormentato o da’ suoi desiderato con grandissimo crucia-to dell’animo.
[14.4] Or che ti dirò io di Scipione Affricano, al quale la morte del fratello nello exilio fu numptiata? Quello fratello, il quale di prigione el fratello trasse, dal fato tòrre nol poté. Et quanto la pietà d’Affricano patiente fu della ragione et della equità a ciaschuno fu nota, imperò che in quel dì Scipione Affricano, nel quale dalle mani del numptiatore el fratello haveva tolto, privato, intercedecte ancora al tribuno della plebe 82. Qui con tanto grande animo el fratello desiderò con quanto egli difeso l’a-veva. [14.5] Che riferirò io di Scipione |78v| Emiliano, che in uno medesimo tempo quasi vide el triompho di suo padre et il mortorio di due suoi fratelli? Nientedimeno colui, giovanetto et quasi ancora fanciullo, con tanto animo sopportò quella sùbita ruina della sua famiglia, sopra il triompho di Pagolo cadente, con quanto sopportare
79 Il lat. ha: «me unum transeat»; assai probabile che l’esemplare latino utilizzato presentasse il facile scambio unum/virum. 80 Ms. ha. 81 Lat.: «ad fastus te et annales perducam publicos». 82 Lat.: «eodem enim die Scipio Africanus quo uiatoris manibus fratrem abstulerat tribuno quoque plebis priuatus intercessit».
238 Cristiano Lorenzi
la dovette l’huomo in questo nato, che o alla ciptà romana non manchasse Scipione o Cartagine soprarestasse 83.
[15.1] Che dire si debba come la concordia de’ dua Luculli per la morte si divise? Che de’ Pompei, a’ quali né questa lasciò ancora la crudel fortuna 84 che essi per una ruina chaschassino? Vixe primamente Sexto Pompeio doppo la sorella, per la morte della quale si sciolsono e’ leghami della romana pace optimamente accostantesi; vixe ancora costui medesimo doppo l’optimo suo fratello, el quale la fortuna in questo haveva rilevato, acciò che essa non meno da alto a terra gitasse che essa a terra el padre gittato haveva. Et doppo questo caso nientedimeno Sexto Pompeio non solamente al dolore fu sufficente, ma ancora alla guerra. [15.2] Innumerabili exempli di seperati fratelli da ogni parte a me occorrono, ançi pel con|79r|trario a mala pena mai alchune paia di frategli sono state cognosciute insieme invechianti. Ma io sarò contento degli exempli della casa nostra, imperò che nessuno sarà tanto sança sanità et senso 85 che egli si ramarichi che la fortuna ad alchuno habbia arrechato pianto, la quale egli saprà havere ancora desiderato le lagrime de’ Cesari.
[15.3] Lo ddio Aughusto perdé Octavia, sorella charissima, et la natura a llui per certo non tolse la necessità del piagnere al quale essa el cielo destinato aveva. Ançi, costui medesimo, per ogni modo che l’huomo è privato, per la morte de’ suoi mole-stato 86, perdé el figliuolo della sorella sua, alla successione sua preparato. Et final-mente, acciò che io racconti ciaschuni suoi pianti, colui perdé i generi et i figliuoli et i nipoti; ma nessuno di tucti gli huomini più, mentre che tra gli huomini egli era, cognobbe sé essere huomo. Tanto el suo pacifichatissimo pecto ricevette tanti et sì grandi pianti di tucte le cose, et lo ddio Aughusto vincitore fu non solamente delle genti strane, ma de’ dolori ancora. [15.4] Gaio Cesare, nipote dello ddio Augusto, tuo çio per madre 87, intorno a’ primi an|79v|ni della giovaneçça sua, essente principe della gioventù, perdé Lucio, fratello a sé charissimo, prencipe della gioventù mede-sima nell’apparato della guerra contro a’ Parthi: sono più gravi ferite dell’animo che colpi del corpo; l’uni et gli altri nientedimeno colui medesimo piissimamente sop-portò et con forteça grandissima 88. [15.5] Cesare 89, di mio padre fratello, perdé Dru-
83 Lat.: «Adulescentulus tamen ac propemodum puer tanto animo tulit illam familiae suae su-per ipsum Pauli triumphum concidentis subitam uastitatem quanto debuit ferre uir in hoc na-tus, ne urbi Romanae aut Scipio deesset aut Carthago superesset». 84 Lat.: «quibus ne [nec γ] hoc quidem saeuiens reliquit fortuna». 85 È tradotto il testo di γ («sanitatis et sensus») e non quello, con ordine inverso dei sostantivi, di β («sensus ac sanitatis»). 86 Non chiaro il senso; cfr. il lat.: «Immo uero idem, omni genere orbitatis uexatus». 87 Ma il lat.: «auunculi mei». 88 Il volgarizzatore anche in questo caso traduce fedelmente il testo tràdito dalla famiglia γ; cfr. infatti: «et grauiora [grauiore β] animi [multo animi β] uulnera [uulnere β] quam [quam postea β] corporis ictus sunt [est β]; utraque [quod utrumque β] tamen [et β] piissime idem et fortissime tulit».
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 239
so Germanico, mio padre, minore per età di lui, quando colui apriva gl’intimi luoghi della Francia 90 et fortissima 91 gente al romano imperio sottomecteva; et costui egli perdé nell’abbracciamento suo et dinançi al suo conspecto. El modo del piagnere nientedimeno non solamente a sé, ma ancora agli altri egli fece 92, et tucto lo exer-cito, non solamente maninchonoso, ma ancora spaventato et a sé attribuente el corpo del suo Druso, ridusse al costume del romano pianto et giudichò che non solamente si doveva observare la disciplina della militia, ma ancora quella del dolore. Non ha-rebbe colui potuto l’altrui lagrime raffrenare, se le sue prima non havessi oppressato.
[16.1] Marco Antonio, avolo mio, di nessuno minore se none di colui |80r| dal quale egli vincto fu, mentre che egli la republica ordinava et ripieno di triomphale honore 93 sopra sé niente vedeva et sotto sé, excepti due compagni, tucte le altre cose essere cognosceva, udì come il fratello era stato ucciso. [16.2] Fortuna potente, che giuochi a te pigli tu de’ mali humani 94! In quello tempo medesimo nel quale Marco Antonio per la vita de’ suoi ciptadini et della morte albitro sedeva, el fratello di Mar-co Antonio si vedeva essere al supplicio menato: sopportò nientedimeno Marco An-tonio questa ferita così grave, con quella medesima grandeça dell’animo con la quale egli tucte l’altre cose adverse sopportato haveva; et questo suo piagnere fu dare el sangue di venti legioni pari al fratello suo 95.
[16.3] Ma acciò che io tucti gli altri exempli passi, acciò che in me medesimo an-cora io taccia gli altrui mortorii, dua volte essa intese che io potevo essere offeso, ma non essere vinto; io perdei Germanico fratello, il quale chom’io amai lo intende per certo chiunque pensa come e’ pietosi frategli e’ fratelli suoi amano. Io nientedi-me|80v|no così l’affecto mio rexi, che niente io lasciai el quale dovessi essere dal buono fratello addomandato et non feci quello che potessi nel principe essere ri-preso».
[16.4] Stima addunque che il publico padre a te questi exempli riferischa et lui medesimo ti mostri come niente per sacra cosa a sé la fortuna stima et come nessuna cosa è la quale da llei non si tocchi; la quale ha havuto ardire di dare la morte in quella casa dalla quale essa gl’iddii haveva a ddomandare. Nessuno addunque si ma-ravigli che da llei si faccia cosa alcuna crudele o iniqua, imperò che or può costei co-gnoscere equità alchuna o alchuna modestia inverso le case degli huomini privati, la crudeltà della quale tante volte nelle case de’ principi ha la morte inferita? [16.5] Benché contro a colei noi diciamo ingiuriose parole, non solamente con la 89 In realtà si tratta di Tiberio, ma è errore d’archetipo della tradizione latina (le edd. moderne integrano «<Ti.> Caesar»). 90 Lat. «Germaniae»; cfr. nota 76. 91 Lat. «ferocissimas» (ma «fortissimas» γ). 92 Lat.: «modum tamen lugendi non sibi tantum sed etiam aliis fecit». 93 Cfr. il testo di γ: «triumphali honore» (il resto della tradizione ha: «triumuirali potestate»). 94 Lat.: «Fortuna inpotens, quales ex humanis malis tibi ipsa ludos facis!». 95 È il testo di γ: «et hoc fuit eius lugere, uiginti legionum sanguinem [errore d’archetipo: l’ed. critica sanguine] fratri parem dare [parentare β]».
240 Cristiano Lorenzi
boccha nostra, ma ancora con la publicha, essa nientedimeno non si muterà; sé essa riççerà contro a ogni priegho et contro a tucte le cerimonie. Questo nelle cose huma-ne è stata la fortuna, questo essa sarà: essa niente mai ha lasciato che essa non hab-bia havuto ardire di fare; essa andrà violen|81r|ta per tucte le cose, come sempre ella è usata; essa ha havuto ardire entrare ancora per fare ingiuria in quele case nelle qua-li si va pe’ templi, et alle laureate porte essa inducerà l’obschura veste 96. [16.6] Questo solo obtegniamo da llei con boti et publichi prieghi, se non ancora a colei è piaciuto consumare la generatione humana, se propitia raguarda ancora el ro-mano nome: voglia che questo principe, dato nelle affatichate cose degli huomini, a llei sia, come a tucti e’ mortali, consecrato et sancto; impari da colui la clementia, impari da colui piacevolissimo sopra a tucti e’ principi essere piacevole.
[17.1] Tu debbi addunque tucti coloro raguardare e’ quali poco innançi io ti riferi’ essere o al cielo chiamati o proximi, et debbi benignamente la fortuna sopportare, a te ancora le mani porgente, le quali né da coloro per certo abstiene pe’ quali noi giu-riamo 97. Tu debbi seguire la fermeça di coloro nel sopportare et vincere i dolori, et debbi, in quanto a huomo sia lecito, andare per le divine vestigie. [17.2] Benché nell’altre cose sieno grandi differentie delle dignità et delle nobilità, la virtù nel me-ço è posta: nessuno essa sdegna il quale |81v| sé di colei degno giudica. Optimamente per certo coloro tu imiterai e’ quali, non potendo essere fuori della sorte di questo male, nientedimeno nello 98 essere in questo solo aguagliati a tucti gli altri huomini giudicorono essere non ingiuria, ma ragione della mortalità, et sopportorono né trop-po acerbamente et con aspreça quello che era accaduto né effeminatamente et con molleçça; imperò che a non sentire e’ mali suoi non s’appartiene all’huomo, et non sopportargli non si appartiene all’huomo virile.
[17.3] Io non posso nientedimeno, havendo intorniato tucti e’ Cesari 99 a’ quali la fortuna ha tolto e’ frategli et le sorelle, trapassare costui, da essere tracto da ogni nu-mero de’ Cesari, el quale la natura fuori mandò nello exitio et nel nocimento della humana generatione, dal quale lo imperio insino al fondo fu rivolto e guasto, el qua-le la clementia del piatosissimo principe hora ricrea. [17.4] Cesare 100, morto la sorel-la Drusilla, io dico, quello huomo, il quale non più dolersi che rallegrarsi principal-mente potrebbe, fuggì el cospecto e lla conversatione de’ ciptadini suoi et all’exe-quie della sorel|82r|la sua non intervenne, non prestò alla sua sorella le cose giuste, ma col giuocho delle tavole dal luogho loro provochate et con altre provocationi a
96 Lat.: «eas quoque domos ausa iniuriae causa intrare in quas per templa aditur, et atram lau-reatis foribus induet uestem». 97 Lat.: «et ferre aequo animo fortunam ad te quoque porrigentem manus [manus porrigentem γ], quas ne [nec γ] ab eis quidem per quos iuramus abstinet». 98 Ms. nessllo, con ss cassate. 99 Lat.: «cum omnes circumierim Caesares». 100 Si tratta di Caligola.
Un volgarizzamento inedito della Consolatio ad Polybium 241
questo modo 101 nella sua villa Albana alleggeriva e’ mali dello acerbissimo furore. O verghognia del romano imperio! El sollaçço del principe romano piagnente la so-rella fu el giuocho delle tavole! [17.5] Quello medesimo Gaio Cesare con furiosa constantia 102 alcuna volta abbassava la barba et i capegli 103, alcuna volta errando andava per le contrade d’Italia et di Sicilia, et non mai era assai certo se egli voleva o che la sorella fussi pianta o che esssa fussi honorata. In quello medesimo tempo nel quale egli a colei ordinava e’ templi e gli altari, egli crudelissimamente coloro tormentava i quali poco maninchonosi erono stati, imperò che con la medesima intemperantia dell’animo egli sopportava e’ colpi delle cose adverse con la quale egli, innalçato per l’advenimento delle prospere, oltre al modo humano ghonfiava. [17.6] Questo exemplo da llunge sia da ogni romano huomo virile, che il pianto suo o sordidamente dia a’ giuochi non convenienti o destilo|82v| con dolore bruttissimo o dilectilo con altrui mali et non colla humana consolatione.
[18.1] Ma da te non è da mutarsi dalla consuetudine tua, con la quale tu ordinasti amare quegli studii e’ quali optimamente la felicità innalçano et facilissimamente minuischono la chalamità, et i quali medesimi sono adornamenti grandissimi degli huomini et sollaççi. Hora adunque te negli studii tuoi metti più fortemente, quegli hora a te intornia come armadure dell’animo tuo et il dolore da parte alchuna di te truovi l’entrata 104. [18.2] Distendi 105 anchora la memoria del tuo fratello con al-chuno degli scripti tuoi, imperò che questa sola opera è a’ facti humani alla quale nessuna tempesta nuocha, la quale non sia da vetustà alchuna consumata. Tucte l’al-tre opere, le quali sono per hedifichatione di pietre et per moli di marmo et per se-polcri terreni in grande alteçça rilevati, non distendono el lungo tempo, imperò tucte queste cose perischono, ma la memoria dello ingegno è inmortale. Questa memoria dona al fratel tuo, in questa colui alluogha: meglio colui tu consacrerrai con lo in-gegno da dovere sempre du|83r|rare che tu non lo piagnerai col vano dolore.
[18.3] La qual cosa a essa fortuna s’appartiene 106: anchora se hora la sua causa appresso a te non può essere tractata, imperò che tucte quelle cose le quali a noi essa ha dato, perché essa alchune di quelle ci à tolto, sono invidiate, allora nientedimeno sarà da essere tractata quando primamente el tempo te harà a colei facto più giusto giudice, imperò che allora tu potrai con lei tornare in gratia. Imperò che molte cose essa ha provvedute per le quali essa ammendasse questa ingiuria, molte cose ancora hora essa darà con le quali essa la riconperi: finalmente quello che colei a te ha tolto, 101 Il passo lat. è qui corrotto: «suo tesseris ac foro † et peruocatis [prouocatis γ] et † huiusmo-di aliis occupationibus»; possibile che il volgarizzatore leggesse loco, anziché foro. 102 Lat.: «inconstantia». 103 Lat.: «barbam capillumque summittens»; il significato di submitto è qui non quello di ‘ab-bassare’, come inteso dal volgarizzatore, ma quello di ‘far crescere’. 104 Lat.: «ne ex ulla tui parte inueniat introitum dolor». 105 Lat. : «produc». 106 Fraintedimento del lat., che recita: «Quod ad ipsam fortunam pertinet» (‘per ciò che riguar-da la fortuna’).
242 Cristiano Lorenzi
a te essa dato l’aveva. [18.4] Non volere adunque contro a te usare lo ingegno tuo, non volere essere presente al tuo dolore. Ma la eloquentia tua può le cose grandi per picchole approvare et così accresciere le picchole et a grandi ridurle: ma costei altrove serbi le forçe sue, hora sé tutta rechi 107 nella consolatione tua et nientedime-no cognosci che questo medesimo ancora non sia supervacuo, imperò che la natura alcuna cosa da noi addomanda più che la vanità si trahe. [18.5] Ma io non mai |83v| da te addomanderò che tu in tucto non ti dolgha; et cognoscho che e’ si truovano alchuni huomini di prudentia più dura che forte, i quali nieghano che il savio si dolgha: e’ non mi pare che costoro chaschassino mai in tal caso, altrimenti da coloro la fortuna harebbe schosso la superba sapientia et harebbegli costrecti venire alla vera confessione et ancora contro a lloro volontà. [18.6] Assai ci harà dato la ragione, se dal dolore sarà caduto quello solo el quale avança et soprabbonda: in modo che essa patischa che in tucto el dolore niente sia, da alchuno non si debba sperare et non si debba desiderare 108. Questo modo più tosto observi, el quale non sostengna la im-pietà e lla stoltitia et noi in quello habito tengha, il quale è della mente pia né per la morte 109: traschorrano le lagrime, ma queste medesime manchino; sieno tracti e’ pianti dall’intimo pecto, ma questi medesimi finischano. Così reggi l’animo tuo, che tu possa te approvare a’ savi et a’ fratelli. [18.7] Fa’ che spesso tu vogli che a te oc-corra la memoria del fratello tuo, et che tu di colui spesso ne’ tuoi ragionamenti parli, et a te lo ri|84r|presenti con lo spesso ricordo: or che finalmente potrai tu con-seguire 110, se a te tu la memoria sua farai più gioconda che da piagnerne, imperò che cosa naturale è che l’animo sempre da quella cosa fuggha alla quale egli con ma-ninchonia va. [18.8] Pensa la modestia sua, pensa la sua sollecitudine nel fare le cose et la industria nel mandarle ad executione et la costantia nelle promesse. Et per altre cose sponi et dischiara tucti e’ decti e facti suoi et a te medesimo gli ricorda. Pensa di che qualità egli fu, et di quale egli poté essere sperato, imperò che, che cosa non può sicuramente essere di quello fratello promessa 111?
[18.9] Queste cose come io ho potuto, rimosso et indebolito già el lungo dolo-re 112, ho composto, le quali, se parranno poco rispondere allo ingegno tuo et al 113 dolore poco medichare, pensa quanto colui non possa attendere al consolare altri, el quale è tenuto et occupato da’ mali suoi; et quanto non facilmente a quello huomo le parole latine soccorrano, intorno al quale suona el romore et la voce de’ barberi, san-
107 Ms. setu tarrechi; ma cfr. il lat.: «sed alio ista uires seruet suas, nunc tota se in solacium tuum conferat». 108 Lat.: «ut quidem nullum omnino esse eum patiatur nec sperandum ulli nec concupiscen-dum est». 109 Si tratta della lezione di γ: «qui et piae mentis est nec morte» (ed. critica: «… nec motae»). 110 Lat.: «quod ita demum consequi poteris». 111 Lat.: «quid enim de illo non tuto sponderi fratre posset?». 112 Così; cfr. il lat.: «longo iam situ obsoleto et hebetato animo». 113 Ms. ail.