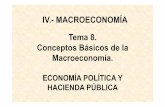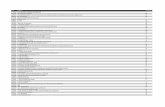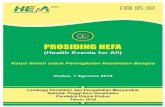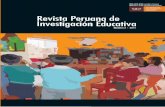T. Cevoli (a cura di), Archeomafie, IV, 2012, ISSN: 2036-4539.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of T. Cevoli (a cura di), Archeomafie, IV, 2012, ISSN: 2036-4539.
6
ARCHEOMAFIE. Rivista dell‟Osservatorio Internazionale Archeomafie. Testa-
ta registrata presso il Tribunale di Napoli n.10 del 21/02/2007. Direttore Re-
sponsabile: Tsao T. Cevoli. Coordinatore di Redazione: Lidia Vignola. e-mail:
[email protected]. Website: www.archeomafie.org. Responsabile
Redazione Web: Astrid D‟Eredità. Webmaster: Simone Massi. Edizione a cura di Liberarcheologia ([email protected]), Piazza S. Maria La Nova
12, 80134, Napoli. Proprietà letteraria riservata.
La rivista “Archeomafie” è valutata come Rivista Scientifica dall'Agenzia Na-
zionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - National A-
gency for the Evaluation of Universities and Research Institutes (DM 76/2012) ed inserita nell'Elenco delle Riviste Scientifiche di area 10.
COPYLEFT. La rivista “Archeomafie” credendo nel diritto di libero accesso alla ricerca, alla cultura e al sapere, abbraccia la filosofia dell‟open source e
dell‟open archaeology. Consente, pertanto, la libera riproduzione cartacea e
digitale di questo testo, purché per uso personale di studio e di ricerca, citando sempre la fonte. Ne è vietata, invece, la riproduzione, anche parziale e con qual-
siasi mezzo effettuata, a scopo direttamente o indirettamente commerciale o di
lucro.
Napoli 2012. Stampa in proprio. ISSN: 2036-4539.
9
Nota al quarto numero
Col passare degli anni si fanno sempre più forti ed in-
sistenti le opinioni di chi ritiene che quella che stiamo vi-
vendo non sia una crisi economica congiunturale e pas-
seggera, ma strutturale.
Pur col suo carico di drammatici problemi sociali, la
crisi costituisce però allo stesso tempo, paradossalmente,
una opportunità di cambiamento. Sopravvivere alla crisi
significa, infatti, necessariamente anche ripensare e cam-
biare i nostri schemi abituali, i modelli di cui abbiamo a-
criticamente perpetuato l‟applicazione per oltre mezzo
secolo.
Nel caso della tutela del patrimonio culturale la crisi
comporta, ad esempio, l‟abbandono quell‟idea o illusione
da qualcuno coltivata negli ultimi decenni, che lo Stato
centrale, attraverso i suoi organi competenti, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e le sue Soprintendenze
territoriali - d‟altronde mai dotate delle risorse umane ed
economiche necessarie allo scopo - potesse farsi carico da
solo di tutelare l‟immenso patrimonio culturale del nostro
Paese. L‟attuale crisi economica, con i sempre più pesanti
tagli alla spesa pubblica, rende, infatti, questa ipotesi
sempre più palesemente irrealizzabile, facendo esplodere
quella che già era una cronica contraddizione tra tutela
formale e tutela reale.
Ecco che, quindi, nel settore della tutela del patrimo-
nio culturale la crisi può rappresentare, paradossalmente,
un‟opportunità per superare procedure e schemi obsoleti
ed inadeguati alle sfide della post-modernità e all‟entità
delle attuali trasformazioni territoriali, rinnovando un
10
modello di tutela ancora fortemente legato all‟impianto
centralista e statalista disegnato tra il 1909 ed il 1939, os-
sia in epoca monarchica e fascista, il cui persistente
imprinting ideologico ha frenato e represso persino il di-
rompente potenziale innovativo del dettato della Costitu-
zione Repubblicana, il cui spirito, nonostante la frenesia
legislativa degli ultimi quindici anni, appare, al contrario,
ancora in gran parte inespresso.
Ammettere l‟inadeguatezza di un modello fino ad oggi
applicato non significa né disconoscerne i risultati positivi
ottenuti, né denigrarlo, né tantomeno denigrarne gli attori.
Significa avere il coraggio di innovare e migliorare, a-
vendo a cuore la “tutela reale” del patrimonio culturale,
non l‟acritica difesa di un mondo teoricamente ancora
perfettamente in piedi, ma nei fatti di gran lunga sorpas-
sato dalla realtà, che, ovviamente, corre più veloce dell‟a-
deguamento del quadro legislativo.
Significa prendere consapevolezza, ad esempio, del
fatto che abbiamo una tutela teoricamente e formalmente
pubblica, ma che in realtà è in massima parte delegata a
soggetti privati - professionisti, cooperative, imprese etc.
- che svolgono un ruolo ormai qualitativamente e quanti-
tativamente insostituibile, senza tuttavia che il rapporto
tra queste due entità, quella pubblica e quella privata, e la
presenza di questa seconda, siano mai stati affrontati e ri-
solti in modo aperto dal legislatore.
La scelta oggi si pone tra il rinchiudersi nell‟eburnea
torre dell‟archeologia intellettual-chic, ininfluenti rispetto
a quanto ruspe e archeomafie continuano a fare nel mon-
do reale, oppure interrogarsi apertamente, anche sulle pa-
gine di questa rivista, su quali nuovi modelli di tutela a-
dottare e metterli in pratica per fermare realmente la quo-
tidiana aggressione al nostro patrimonio culturale.
Il Direttore
11
Tsao Cevoli
Cales tra saccheggi e rifiuti:
il patrimonio archeologico nelle terre dei Casalesi.
Ricordata ed elogiata dalle fonti per il suo vino e per le
sue acque, la città romana di Cales sorgeva a 14 km a
nord di Capua sull‟antica Via Latina, attuale Strada Stata-
le Casilina, nel comune di Calvi Risorta, all‟altezza della
località Calvi Vecchia1 (fig. 1).
La tradizione attribuisce la fondazione di Cales agli
Ausoni, il popolo italico il cui nome una leggenda riporta-
ta da Festo fa derivare da Auson, figlio di Ulisse e di Ca-
lipso. Un‟altra tradizione lega il toponimo al mitico fon-
datore Calai, figlio della ninfa Orizia e di Borea, uno dei
partecipanti alla spedizione degli Argonauti. Virgilio, in-
vece, ad un Cales che avrebbe affiancato Turno nella bat-
taglia contro Enea.
I dati archeologici sembrerebbero supportare il legame
tra l‟origine della città e gli Ausoni o Aurunci2. Tra le più
antiche testimonianze di frequentazione del sito riscon-
1 Tavoletta I.G.M, foglio 172 della Carta d‟ltalia, Pignataro Maggiore, scala 1:25.000. Per
un approccio allo studio di Cales si vedano, tra gli altri: A.De Franciscis, Cales, in Enci-
clopedia dell'Arte antica, Roma 1959, p. 272; W. Johannosky, Relazione preliminare sugli
scavi di Cales, Bollettino D'Arte, XLVI, 1961, p. 258-268; R. Doncel, Nouvelles recher-
ches archéologiques en Campanie (1957-1968), in AntCl, XXXII, 1963, 2, p. 594; G.E.
Carcaiso, Storia dell'antica Cales, Capua 1980; S.R. Femiano, Linee di storia, topografia e
urbanistica dell'antica Cales, Maddaloni 1990. 2 Sulla questione del popolamento della Campania preromana si veda: E. Lepore, Gli Au-
soni e il più antico popolamento della Campania: leggende delle origini, tradizioni antiche
e realtà culturali, Archivio Storico di Terra di Lavoro, V, 1976-1977, p. 96-98; E. Lepore,
Origini e strutture della Campania antica, Bologna 1989. Su Cales in età arcaica: B. D'A-
gostino, La Campania e gli Etruschi, Atti del XXXIII Convegno di Studi sulla Magna Gre-
cia, Taranto 1993, Taranto 1994, p. 431-448.
12
triamo dei frammenti ceramici dell‟Età del Bronzo e oltre
centoquaranta tombe dell‟Età del Ferro. La nascita dell‟a-
bitato è documentata, oltre che dalle sepolture, da alcune
capanne circolari, risalenti al X-VIII sec. a.C. in località
Pezzasecca. Scarsi dati abbiamo sulla presenza etrusca e
sannitica. Tra questi il cosiddetto Ponte delle Monache3
che attraversa il Rio Pezzasecca: un ponte risalente al IV
secolo a.C., scavato nel banco di tufo grigio per consenti-
re il passaggio della strada che conduceva verso l‟ager
Falernus, una struttura che ha come unico confronto il
Ponte Sodo di Veio.
Dalle fonti sappiamo che poi nel 334 a.C. la città fu
conquistata dal console Marco Valerio Corvo e l‟anno
successivo vi fu dedotta una colonia romana4, ove furono
inviati circa 2.500 uomini per assicurarsi il controllo di
questo un‟importante punto strategico lungo la via di co-
municazione tra Sannio e Lazio. Il rapporto con Roma
rimase, tuttavia, conflittuale: perduta in seguito alla scon-
fitta alle Forche Caudine, fu riconquistata dai Romani nel
315 a.C., devastata durante la Terza Guerra Sannitica e
durante la Seconda Guerra Punica, nel 204 a.C. pagò a
caro prezzo, con pesanti imposizioni, il non aver fornito
cinque anni prima aiuto a Roma contro Annibale, che si
era accampato proprio nel territorio di Cales. Ad attestare
lo sviluppo economico di Cales nel III sec. a.C. è anche il
conio di una moneta propria, sui cui appare la dicitura
CALENO (fig. 5). Dopo la caduta dell‟Impero Romano,
come appare ovvio, Cales conobbe un declino. Tuttavia
l‟abitato continuò a vivere ed a rivestire una certa impor-
3 Cfr. L. Quilici, S. Quilici Gigli, Strade romane: Ponti e viadotti, Roma 1996, pag. 7. 4 Sul tema della colonizzazione romana e della gestione delle acque si veda tra gli altri: M.
Pagano, Note sulla bonifica romana in Campania, Atlante tematico di topografia antica, 4.
Interventi di bonifica agraria nell‟Italia romana, Roma 1995, p. 215; K. Ødegärd, Draina-
ge and colonization: the case of Cales, in S. Quilici Gigli, Uomo acqua e paesaggio: Atti
dell‟Incontro di Studio sul Tema Irreggimentazione delle Acque e Trasformazione del Pae-
saggio Antico, S. Maria Capua Vetere, 22-23 novembre 1996, Atlante tematico di topogra-
fia antica, II suppl. 1997, pp. 213-224.
13
tanza, come testimonia la sua elevazione a sede vescovile
nel V sec. d.C. Nell‟879 fu distrutta dai Saraceni, finché
più tardi fu inglobata dal Ducato longobardo di Beneven-
to.
Caratteristica peculiare di Cales è la sua produzione
ceramica, i cosiddetti “vasi caleni”: vasi di argilla ben de-
purata e ben cotta, coperta di vernice nera lucente o tal-
volta bruno-fulva, con sovrapposizione di caratteristiche
decorazioni plastiche5.
La posizione strategica di Cales lungo la Via Latina
favorì senz‟altro il successo di questa ceramica, che, so-
prattutto tra la metà del III e gli inizi del II secolo a.C., si
diffuse in Etruria, Magna Grecia, Sicilia e persino aree
esterne alla penisola italiana. L‟arco cronologico della
produzione di tali ceramiche va dalla seconda metà del III
sec. a.C. ai primi decennî del II sec. a.C., quando il mer-
cato è conquistato dalle più raffinate produzioni di Arez-
zo, la cd. ceramica aretina.
La questione del luogo di produzione dei cosiddetti
“vasi caleni” è tuttavia complessa. Se, infatti, per alcuni
vasi la presenza di firme come L. Canoleios L. f. fecit Ca-
lenos6, C. Gabinio L. f. T. n. Caleno
7, Retus Gabinio C. s.
5 Sulla questione dei cd. vasi caleni e della produzione ceramica di Cales si veda: H.B.
Walters, History of ancient pottery, I, Londra 1905, p. 502; R. Pagenstecher, Die Caleni-
sche Reliefkeramik, Berlino 1909; R. Paribeni, Caleni, Vasi, in Enciclopedia Italiana,
1930; P. Mingazzini, Tre brevi note di ceramica ellenistica, in ArchCl, X, 1958, pp. 224-
226; G. M. A. Richter, Calenian Pottery and Classical Greek Metalware, in AJA, LXIII,
1959, pp. 240-250; M. T. Falconi Amorelli, Patera mesomphalica fittile proveniente da
Vulci firmata da L. Canoleio Caleno, in ArchCl, XVII, 1965, pp. 130-132; L. Sanesi,
Frammenti inediti di ceramica calena, in RendAccNapoli, n.s., LI, 1976 (1977), pag. 191-
198; M. O. Jentel, Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens, Leida 1976 (recensi-
to da F. Gilotta, in StEtr, XLVII, 1979, pp. 552-553); L. Sanesi, Sulla firma di un ceramista
caleno e sulla questione dei «vici», in PP, XXXIII, 1978, p. 74; L. Sanesi, Nuovi frammen-
ti a rilievo da Cales, in RdA, III, 1979, pp. 59-64; L. Pedroni, Ceramica a vernice nera da
Cales, vol. I, Napoli 1986; J.-P. Morel, Artisanat et colonisation dans l'Italie romaine aux
IVe et lile siècles av. J.-C., in DArch, s. III, VI, 1988, 2, pp. 55-61; L. Pedroni, Ceramica a
vernice nera da Cales, vol. II, Napoli 1990; S. Ciaghi, Le terrecotte figurate da Cales del
Museo Nazionale di Napoli: sacro, stile, committenza, Roma 1993. 6 Corp. Inscr. Lat., I2, 406 segg.; X, 8054.
14
Calenus fecit8 attestano certamente un legame con Cales,
nulla ci garantisce l‟esclusività della sua produzione da
parte di Cales. Quella di “vasi caleni” è, dunque, una de-
finizione che nella bibliografia ha finito per travalicare le
ceramiche effettivamente prodotte a Cales, includendovi
anche le analoghe ceramiche provenienti da altri luoghi di
produzione. Un aspetto, questo, puntualmente chiarito dal
Morel: «Il termine vasi caleni ha acquistato nel corso del
tempo un'accezione sempre più ampia, finendo per indi-
care in maniera affatto indiscriminata tutte le produzioni
ceramiche a vernice nera con decorazione a rilievo dell'I-
talia, ovvero del Mediterraneo occidentale. Tali produ-
zioni sono in realtà molto numerose e diverse tra loro [...]
È chiaro che i vasi c., quali che siano i loro legami - in-
contestabili - con l'ellenismo, rappresentano una produ-
zione che si potrebbe definire “etruschizzante” [...] È i-
noltre ben chiaro che i vasi caleni sono stati, almeno in
parte, eseguiti a Cales, come dimostrano i nuovi rinveni-
menti in questo sito (in particolare nelle località Pezza-
secca e Ponte delle Monache) di matrici per patere ombe-
licate (trionfo di Eracle, scene navali dell'Odissea, fregio
di Vittorie che sorreggono una corona) e per medaglioni
di coppe o gutti e, più recentemente, la scoperta di uno
scarico di gutti a vernice nera [...]»9.
Accanto a quella dei “vasi caleni” è attestata a Cales
anche un‟importante produzione di coroplastica, attestata
da numerosi ritrovamenti, tanto che Amedeo Maiuri scri-
veva: «si rinvengono negli scavi più scarichi di fornaci
che di templi, e Cales appare come il gran dispensario di
tutti i santuari all‟intorno, di Capua e di Teano, delle cit-
tà rurali del Massico».
7 Corp. Inscr. Lat., I2, 410. 8 Corp. Inscr. Lat., I2, 412; X, 8054. 9 J-P. Morel, Caleni, Vasi, in Enciclopedia dell'Arte Antica, II Supplemento, 1994, vol. II,
pag. 271.
15
In epoca romana la città di Cales conobbe, dunque, un
periodo di grande fioritura, diventando uno dei più impor-
tanti centri della Campania: contava circa sessantacin-
quemila abitanti e occupava un pianoro tufaceo di circa
64 ettari, pressappoco le stesse dimensioni di Pompei, de-
limitato dai valloni dei torrenti Rio Pezzasecca e Rio dei
Lanzi. Scrive Johannosky: «La città era a circa 100 m.
sul livello del mare, su un pianoro (di tufo nero e bigio
ritagliato tutt'intorno come un isolotto) leggermente de-
gradante verso la pianura lunga da nord a sud circa
1600 m. e dalla larghezza costante di circa 400 m. Era
delimitata dal rio dei Lanzi verso nord-ovest, est e nord,
invece dal rio di Pezasecca o „d‟o Malotiempo‟ ad o-
vest»10
.
Come abbiamo accennato, la ragione fondamentale
della fioritura di Cales fu la sua posizione strategica lun-
go la Via Latina, che la collegava da un lato a Casilinum,
l‟odierna Capua, e dall‟altro lato a Teanum e a Roma11
,
come attestato anche dalla Tabula Peutingeriana (fig. 3 e
4).
Di poco più antica della Via Appia, la Via Latina fu la
prima strada romana ad essere pianificata per un collega-
mento sulla lunga distanza12
(circa 216 km.), con Capua e
con le colonie fondate lungo il tragitto alla fine delle
Guerre latine. Partendo dalla Porta Capena delle Mura
Repubblicane e più tardi dalla Porta Latina delle Mura
Aureliane, la Via Latina toccava Compitum Ernicum, o-
dierno Crocevia di Anagni, passava sotto Anagnia, Feren-
tinum, Frusino, poi per Fregellae, Fabrateria Nova, A-
quinum, Interamna, Casinum, Teanum, Cales, Casilinum,
ossia l‟attuale Capua dal cui nome latino la strada odierna
10 Johannosky, op. cit. 11 Per il tracciato della Via Latina cfr. Strabone, Geografia, V, 3, 9-11. 12 R. A. Staccioli, Strade romane, Roma 2010, pag. 49 e sg.
16
prende il nome di Via Casilina, ed infine Capua, corri-
spondente all‟attuale Santa Maria Capua Vetere.
Proprio come oggi il sito archeologico è brutalmente
tagliato dalla strada statale e dall‟autostrada (fig. 2), in
antico lo era dalla Via Latina, che nell‟attraversare la città
ne costituiva la via principale. Ricorda Strabone: «Oltre a
quelle di cui si è detto, sono città campane anche quelle
prima ricordate: Cales e Teanum Sidicinum, i cui confini
sono delimitati da statue della Fortuna poste su entrambi
i lati della Via Latina»13
.
Oltre alla Via Latina, una serie di altri assi viari mette-
va, poi, in comunicazione Cales con altri centri della
Campania, come Calatia (Maddaloni), Sinuessa (Mon-
dragone), Forum Popilii (Carinola) e Forum Claudii
(Ventaroli)14
.
Considerata l‟importanza della città di Cales, ci aspet-
teremmo che tale superfice sia stata oggetto di ampie ed
esaustive ricerche archeologiche. Al contrario, purtroppo,
la maggior parte della città e del suo territorio, comprese
le aree funerarie, paradossalmente non è stata mai oggetto
di scavi archeologici regolari, benché sia nota da oltre due
secoli: le prime indagini a Cales, promosse da Ferdinando
IV di Borbone, risalgano, infatti, addiruttura al 1792. Ne-
gli oltre due secoli trascorsi Cales è stata oggetto delle
ricerche, tra gli altri, del Barone de Renzis e di Mattia
Zona (1814), di Francesco Carafa (1820), principe di Co-
lubrano, poi alla metà del XIX secolo del Novi (1858) e
del Minervini ed infine nel XX secolo del Chianese
(1938). Il primo scavo archeologico con metodologie
13 Strabone, Geografia, V, 4, 11. 14 Sulla viabilità romana si vedano tra gli altri: L. Quilici, S. Quilici Gigli, Tecnica Stradale
Romana, Roma 1992; L. Quilici, S. Quilici Gigli, Strade romane: Percorsi e infrastrutture,
Roma 1994; A.M. Tazzi, Le strade dell'antica Roma: dal IV secolo a.C. al V secolo d.C. in
Europa, Asia e Africa, Roma 1998; L. Quilici, S. Quilici Gigli, Viabilità e insediamenti
nell'Italia antica, Roma 2004; P. Basso, Strade romane: storia e archeologia, Roma 2007.
17
moderne fu, tuttavia, intrapreso solo nel 1960 da Werner
Johannosky, che contribuì alla conoscienza della topogra-
fia, dell‟assetto urbanistico e della storia della città. Le
conoscenze sulla storia del sito in epoca preromana sono
state poi integrate grazie alle indagini archeologiche effet-
tuate negli anni ‟90 in relazione ai lavori di ampliamento
dell‟Autostrada del Sole e, più di recente, grazie agli scafi
effettuati preventivamente per salvare alcune aree dagli
scavi clandestini15
.
Tra le evidenze più significative sino ad ora emerse ci-
tiamo i resti dell‟antica cinta muraria, di cui si può ancora
individuare il tracciato, che si distinguono due tipologie,
appartenenti a fasi differenti: ad est un tratto in opera
quadrata, di epoca preromana, ed il resto del tracciato, in
opus incertum ed in opus quasi reticulatum, datato al II e
al I secolo a.C. Testimonianze epigrafiche attestano
l‟esistenza di almeno sei porte: Porta Somma, Porta Mar-
ziale, Porta Gemina, Porta Stellatina, Porta Leva e Porta
Domestica.
Dell‟anfiteatro, invece, risalente al I sec. a.C. con suc-
cessivi interventi in età imperiale, delle dimensioni di 110
x 72 metri, dotato di quattro porte monumentali e la cui
15 Sulle ricerche di Johannosky oltre ai contributi già citati si veda anche: W. Johannowski,
Gli Etruschi in Campania, Klearchos, XIX, 1963, p. 62 e sg.; W. Johannosky, Problemi di
classificazione e cronologia di alcune scoperte protostoriche a Capua e Cales, SE, 33, 1965,
p.103-116; W. Johannosky, Scavi e scoperte a Cales, Fasti Archeologici, Annual Bulletin
of Classical Archaeology, XVIII-XIX, 1968, n.4114, p. 299. Per gli scavi effettuati negli
anni ‟90 si veda: L. Crimaco, L.M. Proietti, Calvi Risorta (Caserta). Località Calvi vecchia.
I risultati degli scavi, Bollettino di Archeologia, 22, 1991, p. 51-52; C. Passaro, Calvi Ri-
sorta (Caserta). Località Ponte delle Monache. Cales. Il santuario di Ponte delle Monache,
Bollettino di Archeologia, 22, 1991, p. 56; E. Chiosi, Calvi Risorta (Caserta), Localita
Pezzasecca, Saggio 4, Bollettino di Archeologia, 11-12, 1991, p. 147; S. De Caro, L'attività
archeologica in Campania, Atti del XXXII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto
1993, Taranto 1994, p. 650-651; S. De Caro, L'attività archeologica in Campania, Atti del
XXXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1995, Taranto 1996, p. 576-578.
Per una sintesi: R. Compatangelo-Soussignan, Sur les routes d'Hannibal. Paysages de
Campanie et d'Apulie, Parigi 1999.
.
18
cavea fu realizzata scolpendo direttamente il sottostante
banco tufaceo, resta visibile la superficie dell‟arena ad
una quota inferiore rispetto al piano di calpestio
all‟esterno dell‟edificio ed alcune strutture murarie, tra
cui alcune semicolonne in laterizio.
Tra gli edifici più importanti si annoveravano anche
due complessi termali: le Terme centrali e quelle setten-
trionali. Le prime, risalenti agli inizi del I sec. a.C., sono
costruite in opera quasi reticolata e sono decorate con se-
micolonne a basi attiche e capitelli ionici. La struttura ci è
pervenuta in ottimo stato: si conservano, infatti, degli
ambienti quasi integri, alcuni persino con la decorazione
originale, come l‟apodyterium con semicolonne, dove re-
stano tracce degli affreschi in II stile, delle decorazioni a
rilievo e dei mosaici pavimentali a tessere bianche e nere.
Attiguo vi è il tepidarium con nicchie alle pareti, da cui si
accede ad un calidarium absidato, ad un ambiente quadra-
to con volta a botte e ad un ambiente circolare con nic-
chie, alle spalle dei quali era il praefurnium.
Delle Terme settentrionali, databili al I-II secolo d.C. e
situate lungo il cardo maximus di Cales, che costituisce il
tratto urbano della via Latina, parziali esplorazioni hanno,
invece, portato alla luce delle strutture murarie su tre li-
velli, in opera mista con finestroni e nicchie.
Uno degli edifici più monumentali di Cales è il teatro
(fig. 6). Il suo primo impianto si data all‟età repubblicana,
al II secolo a.C., epoca alla quale risalgono alcuni muri in
opus incertum nelle parodoi. L‟edificio fu poi interessato
da rifacimenti ed ampliamenti tra il I sec. a.C. ed il I sec.
d.C. che lo portarono a raggiungere un diametro di oltre
70 metri. Una sua peculiarità è lo sdoppiamento delle vol-
te della cavea, costruita su gallerie a doppia arcata in opus
reticulatum, che costituisce un unicum. Si tratta di una
delle poche evidenze archeologiche di Cales che negli
19
anni scorsi ha avuto la buona sorte di essere interessato da
regolari lavori di scavo e di restauro.
Tra gli edifici a carattere religioso ricordiamo un tem-
pio su podio, periptero-esastilo, lungo 26 metri e largo 15,
con colonnato esterno di ordine corinzio, risalente proba-
bilmente al I sec. d.C., che forse costituiva il Capitolium
del Foro di Cales, ed un santuario urbano con stipe voti-
va.
Una palestra risalente al I secolo d.C. e dotata al cen-
tro di una grande natatio, è stata scoperta sempre a Cales
in località Pezzasecca, dove era situata anche una necro-
poli.
Infine la più straordinaria risorsa archeologica di Cales
è costituita, appunto, dalle sue necropoli, che coprono un
vasto arco cronologico, dall‟VIII secolo a.C. alla tarda età
imperiale romana. La loro ricchezza, attestata già da di-
versi ritrovamenti sporadici, è stata dimostrata dalle cam-
pagne di scavo condotte nel 1995 ed il 1996, che hanno
portato alla luce oltre un centinaio di tombe. Tra queste,
alcune ad inumazione in cassa di tufo, risalenti all‟età ar-
caica, con ricchi corredi comprendenti vasi, in particolare
bucchero e ceramica a vernice rossa, ornamenti personali,
come fibule di bronzo ed armille, ed armi in ferro, come
spade, pugnali e lance, che attestano rapporti con l‟area
etrusca e medio-adriatica. Le tombe risalenti alla fase
sannitica, scavate nel tufo e dotate di una copertura a la-
stre di tufo o a doppio spiovente, presentano ricchi corre-
di con ceramica a vernice nera e a figure rosse. Per quan-
to riguarda l‟epoca romana, lungo i tratti extraurbani della
viabilità di Cales sono stati individuati diversi mausolei,
uno dei quali, databile al III secolo a.C., appartenente alla
gens Calpurnii, come attesta un‟iscrizione. Sotto la chiesa
di San Casto Vecchio è stata, inoltre, individuata una ca-
mera sepolcrale che ha restituito quattro sarcofagi, uno
dei quali decorato con una rappresentazione di amorini,
20
lepri e vittorie, risalente alla fine del III secolo d.C. Come
la città, anche le necropoli di Cales sono state interessate
da indagini archeologiche regolari solo in minima parte,
divenendo, di conseguenza, un‟appetibile e facile preda
per gli scavatori clandestini.
Le evidenze archeologiche (fig. 4) - tra cui abbiamo
rapidamente citato la cinta muraria, due complessi terma-
li, un teatro, un anfiteatro e alcuni spazi di culto - ma an-
che le importanti testimonianze di età medievale e rina-
scimentale, come la Cattedrale romanica e il Castello ara-
gonese, così come le citazioni nelle fonti, le vicende sto-
riche, le dimensioni, la topografia del sito, nonché la sua
strategica collocazione geografica: tutto ciò ci permette di
affermare che Cales costituisce uno dei siti di interesse
culturale più rilevanti della Campania.
Eppure questo sito non mai ha ricevuto da parte delle
istituzioni, della politica e persino del mondo accademico
un‟ attenzione proporzionata alla sua importanza. Una si-
tuazione che contrasta persino con altri siti minori che
nella stessa Campania, che, grazie anche ad una diversa
attenzione da parte del mondo politico ed istituzionale lo-
cale per motivi congiunturali e alla conseguente attiva-
zione di più adeguate progettualità e finanziamenti, oggi
sono aree archeologiche custodite ed aperte al pubblico.
La cronica disattenzione nel caso di Cales ha portato
alla mancata adozione delle necessarie strategie di cono-
scenza, di protezione e di fruizione: la maggior parte del
sito, ovvero della città di e del suo territorio circostante,
comprese le aree funerarie, come abbiamo detto non è
stata mai oggetto di scavi archeologici regolari; l‟area ar-
cheologica non è attualmente provvista né di un servizio
fisso di custodia né di videosorveglianza; la recinzione,
anche laddove in teoria esiste, come nella zona del teatro,
è ampiamente lacunosa, tanto da non ostacolare di fatto
21
minimamente l‟accesso al sito (fig. 7); in ogni caso gran
parte del sito archeologico, le cui dimensioni sono note-
voli, si estende fuori della ristretta area recintata.
D‟altronde lo Stato non ha sinora nemmeno provvedu-
to ad acquisire tutto il sito di Cales nel patrimonio pub-
blico, per farne un‟area archeologica e naturalistica. Non
sono mai stati stanziati i fondi per acquistare i terreni do-
ve sorgono, ad esempio, l‟anfiteatro o le terme centrali,
cosicché questa parte della città è assediata, talvolta inva-
sa, dalle coltivazioni.
Ma, ben al di là dell‟uso agricolo, a dare un‟immagine
di abbandono e di degrado di Cales contribuiscono so-
prattutto le condizioni generali dell‟area, con rifiuti di o-
gni genere abbandonati vere e proprie discariche abusive
all‟interno del sito archeologico (fig. 8), compreso il co-
siddetto Ponte delle Monache, nonché i cartelli arrugginiti
e crivellati di proiettili, immagine simbolicamente eviden-
te dell‟assenza dello Stato e segno di una criminalità che,
qui come altrove, marca spavaldamente il suo territorio.
La nefasta congiuntura di tali fattori, ossia l‟assenza di
efficaci misure di protezione, la ricchezza del sito, la qua-
lità artistica e la conseguente appetibilità sul mercato
clandestino dei suoi manufatti archeologici, nonché, non
da ultimo, il territorio ad alta densità criminale in cui il
sito viene oggi a trovarsi, ha reso Cales oggetto di una in-
tensa attività di scavi clandestini16
(fig. 10), trasforman-
dola in una sorta di miniera da depredare per le organiz-
zazioni criminali dedite ai traffici illeciti di reperti ar-
cheologici. Reperti che finiscono, come sempre, non solo
16 Sugli scavi clandestini e i traffici illeciti di reperti archeologici provenienti da Cales la
bibliografia scientifica è stata sinora alquanto lacunosa, mentre numerosi sono stati gli
articoli e le inchieste giornalistiche, in particolar modo da parte della stampa locale. Si
vedano in particolare :Il Mattino, Il Corriere del Mezzogiorno, calvirisortanews.it, calviri-
sorta.com, Cales Channel.
22
in tutta Italia nelle case di privati collezionisti, ma anche
all‟estero nelle grandi case d‟asta e, da qui, nelle sale dei
purtroppo numerosi musei che non si pongono troppi
scrupoli sulla provenienza di quanto espongono.
Particolarmente bersagliate dagli scavi clandestini so-
no state, come appare ovvio per la presenza di corredi fu-
nerari intatti, le necropoli. Necropoli per le quali, pur es-
sendo note da lungo tempo (e certo non solo agli archeo-
logi, ma forse ancor prima e meglio agli scavatori clande-
stini) e benché fosse palese il fatto che si trovassero in un
territorio particolarmente esposto all‟azione criminale, le
istituzioni hanno adottato solo in piccola parte l‟unica
strategia di tutela risolutiva in un caso del genere, vale a
dire intraprenderne un sistematico scavo archeologico e-
stensivo per prevenire gli scavi clandestini, e neppure al-
cuna efficace, fisica, misura di protezione e di vigilanza
del sito.
Che spesso i reperti archeologici di Cales finiscano nei
ben noti circuiti dei trafficanti d‟arte internazionali lo ha
dimostrato, ad esempio, l‟operazione internazionale de-
nominata “Grotta delle Formelle”, che prende il nome da
una delle due grotte, insieme alla “Grotta dei Santi”, sca-
vate nel banco tufaceo di Cales, decorata con affreschi
bizantini del X-XI secolo17
. Alcuni affreschi, barbaramen-
te strappati dalle pareti della grotta nel 1982 (fig. 12), so-
no stati ritrovati in Grecia e sono rientrati in Italia grazie
alla documentazione fotografica e alla collaborazione tra
autorità greche e italiane (fig. 13). Le autorità greche li
avevano sequestrati alla sorella di Christos Michailidis,
socio di Robert Symes: due personaggi ben noti alle auto-
rità giudiziarie di diversi paesi per i loro traffici illeciti18
.
17 D.Salazaro, Studi sui monumenti dell‟ltalia Meridionale dal IV al XIII sec., Napoli,
1871, pag. 57; E.Bertaux, L'art dans l'ltalie Meridionale, Parigi 1904, pag. 243. 18 Cfr. T. Cevoli, Il Getty Museum e l‟esportazione illecita di antichità dall‟Italia e dalla
Grecia, Archeomafie I, 1(2009), pag. 21 e sg.
23
L‟entità della continua emorragica devastazione del
patrimonio archeologico di Cales ancora ci sfugge, ma
già dai sequestri effettuati e dai reperti recuperati (fig. 9 e
10) dalle forze dell‟ordine negli ultimi tempi, ossia dalla
piccola percentuale di crimini che essi sono riusciti ad in-
tercettare, talvolta fortuitamente con i controlli ordinari,
talvolta con vere e proprie operazioni programmate, pos-
siamo renderci conto della frequenza e della facilità con
cui la città è stata sistematicamente depredata in questi
anni.
Nel 2012, ad esempio, un giorno all‟alba una pattuglia
dei Carabinieri della stazione di Calvi Risorta, casual-
mente di passaggio, ha notato un‟auto che si allontanava
velocemente dalla zona dell‟area archeologica. I militari,
insospettiti, hanno bloccato l‟auto e perquisendone il ba-
gagliaio vi hanno trovato nascoste circa cinquanta monete
del II sec. a. C. ed alcune statuette appena trafugate dal
sito. B.L. quarantenne proveniente da Sparanise, in pro-
vincia di Caserta, essendo incensurato è stato solo denun-
ciato a piede libero alla Procura della Repubblica per fur-
to ai danni dello Stato. La refurtiva è stata consegnata alla
soprintendenza archeologica. C‟è da chiedersi quante al-
tre volte lui, e tanti come lui, se la siano cavata, non a-
vendo avuto la sfortuna di incrociare un‟auto dei Carabi-
nieri proprio all‟uscita dal sito archeologico.
Tuttavia a Cales, come in molti altri territori che ve-
dono una nefasta coincidenza tra elevata densità archeo-
logica ed elevata densità criminale, appare chiaro che gli
scavi clandestini non sono opera soltanto di semplici ed
isolati tombaroli, ma costituiscono una delle attività ille-
cite controllate dalle locali organizzazioni criminali di
stampo mafioso.
Sempre nel 2012 le indagini dei Carabinieri del Nu-
cleo Tutela Patrimonio Culturale sugli scavi clandestini a
Cales e sui traffici di reperti archeologici hanno coinvolto
24
51 persone e portato all‟emissione di diverse ordinanze di
custodia cautelare. I Carabinieri hanno utilizzato delle te-
lecamere ad infrarossi per riprendere i movimenti notturni
degli scavatori clandestini, registrati in azione non solo
mentre sondavano il sottosuolo con i tradizionali “spillo-
ni” da tombarolo, ma anche con più moderni metal
detector.
Delle 51 persone indagate per traffico illecito di reper-
ti archeologici, molte provenivano da Casal di Principe.
Alcuni degli arrestati avevano precedenti penali ed erano
considerati legati al clan dei Casalesi, multiforme orga-
nizzazione criminale di stampo camorristico che ha il
cuore del suo territorio nell‟area intorno Casal di Princi-
pe, Casapesenna e San Cipriano d‟Aversa, un fazzoletto
di 16 soli chilometri quadrati, dove - per dare qualche ci-
fra significativa - vivono circa 50.000 persone, da cui
provengono ben 1.200 condannati per mafia al regime di
carcere duro 41bis, ma è allo stesso tempo registrata la
più alta concentrazione di aziende edili e il maggior nu-
mero di auto di lusso in Europa.
Appare inverosimile che un‟organizzazione del gene-
re, che ha un controllo capillare del territorio e i cui tenta-
coli avvinghiano tutti i comparti leciti e illeciti dell‟eco-
nomia locale e nazionale, lasci a isolati tombaroli indi-
pendenti i profitti degli scavi clandestini e del traffico il-
lecito di reperti archeologici.
Ma a palesare ancora meglio il legame tra scavi clan-
destini a Cales e criminalità organizzata, si è aggiunto il
ritrovamento da parte dei Carabinieri di alcuni reperti ar-
cheologici nelle case dei boss. Oggetti che in alcuni casi
pare fossero stati offerti dagli scavatori clandestini come
segno di ossequio. Quattro vasi sono stati scoperti dai Ca-
rabinieri in casa di Gesualda Zagaria, sorella di Michele
Zagaria, uno dei più noti boss dei Casalesi, considerato
nella criminalità organizzata il re del cemento, a capo di
25
affari criminali nel settore del cemento e dell‟edilizia in
tutta Italia, dal sud al nord. È stato catturato il 7 dicembre
2011, dopo una latitanza di oltre 16 anni, nel suo bunker a
Casapesenna, a pochi chilometri da Casal di Principe.
Una cattura frutto dei tre anni di indagini coordinate dal
quarantenne magistrato napoletano Catullo Maresca.
In conclusione l‟antica Cales, situata lungo un impor-
tante asse viario di comunicazione tra Lazio e Campania,
nonostante sia considerata una delle più importanti città
della Campania romana, non mai ha ricevuto da parte del-
le istituzioni, della politica e persino del mondo accade-
mico un‟attenzione proporzionata alla propria importan-
za. Non vi sono, infatti, state adottate né misure di sicu-
rezza, né iniziative di conoscenza, né di fruizione adegua-
te al suo potenziale archeologico. Alla scarsa attenzione
da parte dello Stato fa da contraltare la troppa attenzione
ricevuta da parte degli scavatori clandestini, che hanno
sistematicamente depredato Cales a fini di lucro. Non si
tratta di tombaroli isolati, ma di personaggi spesso legati
alla criminalità organizzata, come hanno dimostrato fedi-
ne penali e sequestri di reperti archeologici nelle abita-
zioni di esponenti di spicco dei Casalesi.
I fatti sembrano, insomma, indicare che l‟area archeo-
logica di Cales, e soprattutto le sue necropoli, sia diventa-
ta in questi decenni una delle “miniere” dove la criminali-
tà organizzata del casertano si procura reperti archeologi-
ci da vendere sul mercato clandestino. Eppure l‟area ar-
cheologica è vincolata e buona parte di essa teoricamente
è persino recintata: questo significa che vi è vietato acce-
dere senza permesso e, ovviamente, effettuare scavi non
autorizzati.
Cales costituisce, dunque, un tipico esempio delle cro-
niche contraddizioni della tutela dei beni culturali nel no-
stro Paese e della schizofrenica distanza che si è prodotta
26
tra piano normativo e amministrativo, da un lato, e piano
reale, dall‟altro, ossia tra tutela formale e tutela sostanzia-
le19
.
In Italia oggi abbiamo, infatti, una tutela del patrimo-
nio culturale che si esplicita (e spesso si esaurisce) in ot-
time leggi, in vincoli ferrei ed in severissimi divieti impo-
sti dallo Stato e dai suoi apparati centrali e periferici: atti
legislativi ed amministrativi che, tuttavia, anche nelle zo-
ne di competenza dei funzionari più efficienti e solerti,
per un difetto strutturale di fondo di concezione del si-
stema, restano spesso confinati ad un piano puramente
formale, teorico, che si esplicita in atti burocratici, senza
19 Preziosa inedita testimonianza diretta delle croniche condizioni di abbandono e degrado
dell‟area archeologica costituisce il racconto fatto a chiusura della propria tesi di laurea da
Costanza Limata nel 1967 (C. Limata, Le grotte sul territorio di Benevento e Caserta.
Culto rupestre con tavole decorazione Pîttorica delle Grotte Fornelle e dei Santi presso
Calvi Risorta (Caserta), Caserta 1967): «Visitando poi il territorio dell'antica città mi sono
resa conto anche delle emergenze archeologiche: ho trovato infatti, ancora, quasi integro
l'anfiteatro, inoltre tracce di un tempio, il teatro e la rete viaria. Per me scoprire queste
antiche meraviglie del passato è stata una grande emozione; nel contempo è subentrata
anche una profonda delusione nel constatare in quali condizioni di abbandono esse si
trovano: ormai quasi tutto è ricoperto di erbacce di ogni tipo, rifiuti e sterpaglie. Ma la
situazione interessa soprattutto le grotte di cui mi sono principalmente occupata. Per rag-
giungerle bisogna munirsi di stivali alti fino al bacino, inoltrarsi tra le piante alte, attra-
versare un piccolo fiume (rio dei Lanzi) e raggiungere una collinetta, dove tra la folta
vegetazione, sono nascoste le stesse. Per entrare in esse vi sono dei cancelli che, attual-
mente, sono aperti per cui tutti possono accedervi; gli affreschi ancora conservati sono
quasi completamente ricoperti di una patina biancastra provocati dalla umidità e quindi
difficilmente identificabili. Nella grotta dei Santi, addirittura, parte di essi sono stati sel-
vaggiamente asportati da balordi; altri sono stati recuperati in America e attualmente si
trovano nei depositi della Soprintendenza di Caserta, altri sono dispersi. La situazione,
infine, dei reperti ancora esistenti è davvero precaria, e non sembra aver attirato l'atten-
zione delle autorità locali o degli organi preposti alla tutela e salvaguardia dei beni arti-
stici e ambientali (musei, soprintendenze, comune regione provincia), forse perché essi si
trovano a Calvi Risorta e non a Roma, Firenze, Venezia, ecc. Io penso che ogni testimo-
nianza del passato, anche se di genere diverso o situata in località di minore importanza,
non deve essere trascurata perché in ogni caso fa parte di un percorso storico durato mil-
lenni e come tale dev'essere valorizzata, conservata e sviluppata. Mi auguro, proprio, che
in un futuro prossimo le autorità competenti prendano visione della situazione di degrado
in cui versa la zona di Calvi (prima che sia troppo tardi ! !) e possano così attuare un
progetto di recupero del territorio, di restauro e valorizazione delle opere superstiti, con la
finalità, anche, di creare le premesse per la nascita di progetti che possano occupare al-
cuni giovani in cerca di lavoro e spinta importantissima alla crescita delle attività locali e
dei paesi limitrofi. Ciò facendo avremo conosciuto un‟altra “fetta" della nostra bella Ita-
lia, ripulito una parte del territorio e dato speranza a qualche giovane che avrebbe imboc-
cato strade pericolose e senza uscita. A me, infine, la gioia di essere giunta ad un traguar-
do e all'inizio di un altro lavoro molto piu lungo e impegnativo: il futuro».
27
sostanziarsi in misure e azioni concrete di tutela in grado
realmente di impedire scavi clandestini, sterri, vandali-
smi, mala gestione e attività di ogni genere che quotidia-
namente obliterano un pezzo del patrimonio culturale ita-
liano.
Per tutela reale qui non si intende, beninteso, una que-
stione di recinzioni sempre più invalicabili, di telecamere,
di allarmi o di uomini armati. Innanzitutto perché qualsia-
si sistema di sicurezza ha in ogni caso i suoi punti deboli,
ma soprattutto perché non è immaginabile poter delegare
tutto esclusivamente all‟inibizione fisica e alla repressio-
ne dei reati.
Occorre, invece, fare molto sul piano della prevenzio-
ne, costruire un diverso modello di tutela, una “tutela atti-
va”, che non si accontenti solo di vietare o di perseguire i
crimini, ma sia capace di prevenirli, che non ponga solo
vincoli e divieti, ma sia capace di elaborare e attivare
proposte.
Un modello di tutela che si fondi, innanzitutto, sulla
costruzione di un legame identitario e di una stretta rela-
zione tra sito archeologico e territorio, inteso come tessu-
to vivo, come rete fluida di relazioni che include non solo
le istituzioni di tutela e le amministrazioni del territorio,
ma anche tutti quei soggetti che ne costituiscono il corpo
sociale vivo, come scuole, cittadinanza attiva, organizza-
zioni, associazioni, professionisti, cooperative e imprese
attive sul territorio.
Solo creando questo legame identitario vivo tra il pa-
trimonio culturale e la comunità locale - soprattutto in a-
ree ad alto degrado socio-culturale e ad alta densità cri-
minale come quella di Cales - e producendo grazie ad es-
so cultura e, fattore fondamentale, reddito sul territorio
sotto forma di opportunità di lavoro lecito, si può, infatti,
sperare di sottrarre manovalanza, connivenze e addirittura
consenso alle organizzazioni criminali che dal patrimonio
28
archeologico traggono (e anche distribuiscono) reddito in
modo illecito e devastante. Solo così lo Stato può ricon-
quistare all‟antistato il terreno perduto.
In un modello del genere le Soprintendenze archeolo-
giche non costituirebbero più l‟attore unico sul quale il
Paese, come oggi di fatto avviene, delega e scarica qual-
siasi responsabilità in materia di tutela del patrimonio cul-
turale (senza d‟altronde, come abbiamo detto, provvedere
né i mezzi né le risorse umane e finanziarie affinché que-
sta responsabilità abbia modo di tradursi in azioni concre-
te), ma il fulcro di un più ampio “sistema di tutela” o di
una “rete di tutela”, ossia il garante, il supervisore ed il
controllore delle politiche, iniziative e concrete azioni di
tutela attivabili tramite la cooperazione tra soggetti diver-
si. Insomma l‟istituzione a cui in materia di tutela spetta
sempre la parola definitiva, ma in un dialogo tra più atto-
ri, non in un monologo ad attore unico.
Quello che qui si propone non è, dunque, una sottra-
zione di funzioni e di competenze alle Soprintendenze,
ma un allargamento del fronte della tutela, sotto il con-
trollo delle Soprintendenze, in un‟ottica di positiva coo-
perazione che possa determinare l‟ormai improrogabile
passaggio da un modello di tutela magari impeccabile
nelle carte (tanto da sentire ancora ogni tanto qualcuno
dire che l‟Italia ha la migliore legislazione di tutela dei
beni culturali del mondo), ma assolutamente sganciato
dalla realtà, ad un nuovo modello partecipativo, insomma
da una tutela formale ad una tutela effettiva che parta dal
territorio come soggetto attivo.
Sarebbe questo, del resto, lo spirito della Costituzione,
che all‟articolo 9 affida alla Repubblica il compito di tute-
lare il Patrimonio artistico della Nazione, lo affida ossia
non solo allo Stato centrale, ma anche ai Comuni, alle
Province e alle Regioni, ossia in definitiva ai territori.
29
Abstract
Tsao Cevoli, Cales tra saccheggi e rifiuti: il patrimonio
archeologico nelle terre dei Casalesi.
Situata in età romana lungo una strategica via di co-
municazione tra Roma e Capua, il sito archeologico di
Cales, una delle città più importanti ed archeologicamen-
te più ricche della Campania, si trova oggi collocato in
un‟area ad alta densità criminale.
La concomitanza tra diversi fattori, tra cui la ricchez-
za del giacimento archeologico, l‟assenza di efficaci mi-
sure di protezione del sito ed il capillare controllo del
territorio da parte della criminalità organizzata, nello
specifico da parte dei Clan Casalesi, ha fatto dell‟antica
Cales una miniera sistematicamente depredata a vantag-
gio del mercato clandestino internazionale.
Il caso di Cales, come molti altri, dimostra il fallimen-
to, nella concreta quotidianità, del sistema di tutela dei
beni culturali in vigore nel nostro Paese. Un sistema che
si basa su un apparato legislativo teoricamente perfetto,
ma assolutamente sganciato dalla realtà ed inapplicato.
La soluzione proposta per migliorare i livelli di tutela
effettiva del patrimonio archeologico italiano deve parti-
re dal superamento dell'attuale modello centralista e sta-
talista di tutela, ormai cronicamente strutturalmente ina-
deguato per mancanza di risorse economiche ed umane,
ed adottare un nuovo modello partecipativo, che parta
dal coinvolgimento di tutte le componenti del territorio in
una rete attiva di tutela.
32
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fig.3: Tabula Peutingeriana, dettaglio (rielaborazione grafica), in evidenza la Via Latina da Roma a
Capua. Fig. 4: Tabula Peutingeriana, dettaglio (rielaborazione grafica), in evidenza la localizzazione
di Cales.
33
Fig. 5: moneta della città di Cales, III sec. a.C., con la dicitura “CALENO” (Collezione Friedrich Po-
pken). Fig. 6: Il Teatro di Cales, risalente al II sec. a.C., con rifacimenti ed ampliamenti tra il I sec. a.C.
ed il I sec. d.C.
34
Fig. 7: Cales, lacune nella recinzione metallica dell'area archeologica. Fig. 8: Cales, una discarica
abusiva nel sito archeologico (www.calvirisortanews.it).
35
Fig. 9: Un vaso di pregevole fattura artistica, proveniente da Cales, recuperato dai Carabinieri.
36
Fig. 10: Scavatori clandestini in azione di notte a Cales con spilloni e metal detector, filma-
ti di nascosto dai Carabinieri con telecamere ad infrarossi. Fig. 11: Cales, zona sottoposta a
sequestro giudiziario dai Carabinieri all‟interno dell‟area archeologica.
37
Fig. 12: Cales, Grotta delle Formelle, dipinti barbaramente depredati. Fig. 13: il recu-
pero di frammenti di dipinti provenienti da Cales da parte delle autorità italiane.
38
Diego Favero
Lex rei sitae e traffico illecito
di reperti archeologici.
Sin dall‟antichità il nostro Paese ha rappresentato una
fonte di reperti archeologici per collezionisti e mercanti
d‟arte stranieri, tant‟è che l'esigenza di una loro protezio-
ne sorse molto presto: già nel XV sec. fu emanata una
bolla papale che vietava l‟esportazione di reperti archeo-
logici al di fuori dello Stato Pontificio.
Nel momento in cui le norme di tutela falliscono ed un
rinvenimento fuoriesce dal territorio nazionale per pren-
dere la via dei grandi Paesi importatori di beni culturali, si
pone il problema della suo recupero, ovverosia della resti-
tuzione allo Stato od al privato che ne siano proprietari.
Per far fronte al traffico internazionale di beni culturali
sono state predisposte apposite discipline, sia a livello in-
ternazionale (la Convenzione UNESCO del 1970, con-
cernente le misure da adottare per interdire e impedire
l‟illecita importazione, esportazione e trasferimento di
proprietà dei beni culturali, e la Convenzione dell‟ Uni-
droit del 1995 sui beni culturali rubati od illecitamente
esportati) che a livello europeo (in particolare il regola-
mento (CE) n. 116/2009 e la direttiva 93/7/CEE).
L‟efficacia di questi strumenti è piuttosto ridotta a
causa di limiti intrinseci ed estrinseci, pertanto i casi in
cui gli organi giudiziari dovranno ricorrere ai comuni cri-
39
teri di collegamento internazionalprivatistici saranno an-
cora numerosi.
I resti immessi nel traffico internazionale sono eviden-
temente beni mobili, o per loro natura (vasellame, statue
etc.) o perché divenuti tali a seguito della disgiunzione
dall‟immobile cui pertinevano (mosaici, bassorilievi etc.),
perciò una corte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
della loro circolazione dovrà risolvere in via preliminare
la questione dell‟individuazione della disciplina applica-
bile al diritto reale controverso.
Va rimarcato che, rispetto al passato, gli Stati risolvo-
no in modo più uniforme il punto della legge applicabile a
situazioni che presentino un elemento di collegamento tra
vari ordinamenti. Anticamente, infatti, beni mobili ed
immobili erano sottoposti a norme differenti: mentre i
primi erano soggetti alla legge personale del proprietario
in ossequio al principio mobilia sequuntur personam, i
secondi erano regolati dalla legge del luogo in cui gli
stessi erano situati secondo il principio immobilia regun-
tur lege loci. La maggior parte degli odierni sistemi giuri-
dici, invece, sia di civil law che di common law, conver-
gono nella scelta d‟accogliere il criterio della lex rei sitae
come principio applicabile ad entrambe le categorie di
beni. In Italia esso trova il suo referente normativo
nell‟art. 51 della L. 31 maggio 1995, n. 218.
L‟incidenza del criterio della lex rei sitae sulla circo-
lazione internazionale di reperti archeologici può essere
compreso solo avendo ben chiare due variabili fondamen-
tali: la disciplina del possesso ed i limiti posti dal diritto
pubblico al commercio di tali beni.
Con riferimento alla prima di esse, si ricorda che gli
ordinamenti degli Stati accordano all‟istituto del possesso
livelli di tutela molto diversificati. Già in via di prima ap-
prossimazione si può tracciare una distinzione fra sistemi
di common law e di civil law: i primi applicano il princi-
40
pio romanistico nemo plus iuris transferre potest quam
ipse habet, permettendo quindi al proprietario originario,
seppur con limitate deroghe, di rivendicare il bene anche
presso il possessore di buona fede; i secondi si ispirano al
principio en fait de meubles la possession vaut titre, per-
mettendo l‟acquisto a non domino.
Nel quadro dei Paesi di civil law un caso pressoché i-
solato al mondo ci è offerto proprio dall‟Italia, dove in
forza dell‟art. 1153 c.c. il soggetto in buona fede acquista
validamente anche dal non proprietario, sempre che sussi-
sta un titolo idoneo al trasferimento di proprietà.
Fu proprio tale disciplina ad essere applicata dai giu-
dici inglesi quale lex rei sitae nel caso Winkworth v. Chri-
stie, Manson & Woods Ltd.20
, nel quale si controverteva
sulla proprietà di una raccolta di netsuke rubati ad un col-
lezionista inglese e trasferiti in Italia.
Durante la loro permanenza sul territorio nazionale es-
si furono venduti da una terza parte al Dr. P. Dal Pozzo
D‟Annone, il quale li riportò a sua volta a Londra per
venderli all‟incanto presso Christie‟s. Il Sig. W. W. Win-
kworth, riconosciuta la collezione, agì in giudizio contro
la casa d‟aste ed il collezionista italiano per ottenerne la
restituzione.
La Corte, accertato che, almeno fino alla vendita in I-
talia, non si era verificato nulla che estinguesse il diritto
del Winkworth, s‟accinse a valutare se l‟effetto della
compravendita in Italia fosse quello di trasferire al Dr. P.
Dal Pozzo D‟Annone un diritto di proprietà opponibile
all‟attore, il che si risolveva nello stabilire quale fosse la
normativa applicabile fra quella italiana e quella inglese.
Qualora la scelta fosse ricaduta sulla normativa italiana,
la disciplina applicabile sarebbe stata quella degli artt.
20 Winkworth v. Christie Manson & Woods Ltd., [1980] Ch. 496.
41
1153 e 1154 c.c., relativi all‟acquisto di buona fede di be-
ni mobili mediante il possesso. Se, al contrario, il giudice
inglese avesse dovuto risolvere la controversia confor-
memente al diritto britannico, il convenuto sarebbe pre-
vedibilmente risultato soccombente. Egli, invero, non ec-
cepì l‟acquisto “in market overt”, quindi a mente della
section 22 del Sale of Goods Act del 1893 non avrebbe
validamente acquistato le opere data la loro provenienza
furtiva.
La difesa sostenne che la lite andasse decisa secondo
la legge dell‟Italia, luogo di situazione dei beni al mo-
mento della compravendita. La stessa inoltre ammetteva
l‟esistenza di cinque eccezioni al criterio della lex rei si-
tae, ma ne constatava la non invocabilità nel caso di spe-
cie. Per di più le norme di conflitto inglesi erano fatte sal-
ve dal Sale of Goods Act del 1893. Conseguentemente, il
difensore deduceva l‟obbligo, incombente sulla Corte in-
glese, d‟applicare la legge italiana al fine di valutare se il
convenuto avesse realmente conseguito la proprietà dei
beni.
La linea dell‟attore, posto dinanzi ad una giuris-
prudenza che da Cammel v. Sewell21
in poi accettava co-
me regola generale che la validità dei trasferimenti di beni
mobili fosse governata dalla lex situs, non poteva che ri-
conoscere tale principio e sostenerne l‟inapplicabilità al
caso sottoposto al giudizio della Corte. Asserì pertanto
che fosse il diritto nazionale a dover regolare la contro-
versia in ragione dei numerosi collegamenti che essa pre-
sentava col Regno Unito.
Ovviamente la tesi della parte attrice venne respinta, la
Corte nel caso di un suo accoglimento avrebbe introdotto
un grado di incertezza intollerabile nel diritto e ciò soltan-
to per sostenere una competenza totalmente artificiosa.
21 Cammel v. Sewell, (1853) 3 H.& N.617.
42
L‟accusa non ebbe maggior fortuna nel proporre una
nuova eccezione al precedente Cammel v. Sewell. Secon-
do la parte attrice, nel caso in cui il bene venga volonta-
riamente riportato nel Paese dove fu rubato, sarebbe la
legge di detto Stato a decidere se il proprietario originario
abbia perso la proprietà sul bene. Nell‟opinione del giudi-
ce, però, il fatto che i beni si trovassero già in territorio
inglese avrebbe soltanto eliminato un ostacolo pratico
all‟esecuzione della sentenza.
L‟ultima considerazione svolta dal giudice rispecchia
un ragionamento molto simile a quello che indusse il no-
stro legislatore ad introdurre nel Codice Civile gli artt.
1153 e 115422
. La Corte si disse cosciente del fatto che
l‟applicazione della lex rei sitae potrebbe talvolta rivelarsi
perniciosa per gli interessi del proprietario originario, ma
la pretesa dell‟attore non era accoglibile, essa introdur-
rebbe ulteriori variabili nell‟individuazione della legge
che regola la validità degli atti d‟acquisto di beni mobili,
ed il risultato sarebbe l‟introduzione di una sommamente
indesiderabile incertezza nel mondo del commercio.
La Corte, appurata la non riconducibilità dei fatti di
causa a nessuna delle eccezioni di cui sopra, respinse la
domanda dell‟attore, poiché ai sensi della normativa ita-
liana, la lex situs, il convenuto aveva validamente acqui-
stato in buona fede le opere d‟arte.
Il caso analizzato è emblematico dei problemi causati
dall‟eterogenea regolamentazione dell‟istituto del posses-
so nei vari Paesi e dell‟importanza della scelta del diritto
applicabile. Si noti però che i beni culturali, nella maggior
parte dei casi, sono forieri di ulteriori e ben più complesse
questioni giuridiche.
22 Si veda F. Galgano, Diritto Privato, Padova 2006, p. 155
43
I beni culturali, sono definiti dalla dottrina “beni im-
materiali”, ossia oggetti fisici portatori di un valore ulte-
riore, la culturalità, che è immateriale. Essi sono dunque
latori di un messaggio che si modula variamente a secon-
da del gruppo d‟interesse cui esso è diretto, per tale ra-
gione pressoché ogni Stato si è preoccupato di tutelarli
limitandone, chi più chi meno, la circolazione ed il com-
mercio, in particolar modo per quanto riguarda i reperti
archeologici.
Tali norme sono di diritto pubblico e mutano nei vari
ordinamenti: si va dall‟affermazione di una riserva di
proprietà in capo allo Stato su determinate categorie di
oggetti, all‟imposizione di restrizioni più o meno severe
alla libertà dei privati di disporne, all‟incondizionato di-
vieto d‟esportazione e così via. La loro violazione è ido-
nea ad incidere sulla liceità e per conseguenza sulla vali-
dità degli atti d‟alienazione di tali beni. Ad esempio, se in
Italia Tizio vendesse a Caio un cratere di fattura greca,
proveniente dal corredo funerario di una tomba picena
scavata illegalmente, spacciandolo per un pezzo di una
collezione nordeuropea ritrovato in Turchia nel XIX seco-
lo, Caio non ne acquisterebbe la proprietà a dispetto della
situazione soggettiva di buona fede. Affinché operi il di-
sposto degli artt. 1153 e 1154 c.c. le cose oggetto di com-
pravendita devono essere suscettibili di proprietà privata,
ed i beni archeologici, in quanto appartenenti al patrimo-
nio indisponibile dello Stato ex art. 826 c. 2° c.c., sono
res extra commercium. Ma cosa accade se tali beni esco-
no dal territorio dello Stato?
Storicamente, giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto
inapplicabili nell‟ordinamento interno le norme di diritto
pubblico straniere, il che però non è privo di indesiderabi-
li conseguenze.
La prima vertenza da analizzare per meglio compren-
dere il problema è la causa Repubblica dell‟Ecuador - Ca-
44
sa della cultura ecuadoriana c. Danusso, Matta e altri23
,
relativa a reperti archeologici di origine ecuadoriana ille-
citamente importati in Italia.
G. Danusso nell‟aprile del 1975 espose, sotto pseudo-
nimo, una serie di reperti archeologici ecuadoriani
nell‟ambito della manifestazione “Estate archeologica mi-
lanese”. L‟autorità consolare dell‟Ecuador, venuta a co-
noscenza del fatto, sporse denuncia alla Procura della Re-
pubblica di Milano. Ne seguì un‟indagine dalla quale e-
merse che il Danusso comprava tali oggetti da cittadini
ecuadoriani, per la maggior parte “scavatori”, con il sup-
porto di un antiquario di Quito, tal J. Judge, e dipoi li im-
portava in Italia in tempi diversi (dal 1972 al 1975) con
l‟ausilio di cittadini italiani suoi conoscenti.
Il procedimento penale si concluse il 10 novembre
1978 a Torino senza alcuna condanna. Nel 1979 la Re-
pubblica dell‟Ecuador agì in giudizio in sede civile presso
lo stesso tribunale di Torino per rivendicare la proprietà
di detti rinvenimenti.
Nella sentenza, datata 25 marzo 1982, il Tribunale, es-
sendo fuor di dubbio che gli oggetti fossero stati ritrovati
nella zona Andina dell‟Ecuador, s‟accinse a verificare il
regime giuridico dei reperti archeologici nel diritto ecua-
doriano, la lex originis. L‟analisi della normativa ecuado-
riana prese le mosse dal dettato costituzionale, dal quale
emergeva la volontà statale di esercitare un forte controllo
su una categoria di beni reputata di notevole importanza
per la cultura del popolo ecuadoriano. Il combinato dispo-
sto degli artt. 623 e 660 dell‟allora vigente Código Civil e
gli artt. 4 e 13 della Ley de Patrimonio Artístico (LPA)
del 1945 stabilivano un regime giuridico caratterizzato
dal dominio eminente dello Stato sui beni culturali, ovve-
rosia il diritto del privato su di essi non era negato, ma
23 Tribunale di Torino, sentenza del 25 marzo 1982, in Riv. dir. internaz. priv. proc.,
,(1982), pp. 652 e sg..
45
veniva ad essere decisamente circoscritto dalla preminen-
te posizione delle autorità, cui compete la loro tutela. Tale
regime pubblicistico comporta, in primo luogo,
l‟esclusione del libero commercio di detti beni, ogni atto
di trasferimento deve essere infatti autorizzato dalla Casa
de la Cultura Ecuatoriana.
L‟autorizzazione è altresì richiesta per ogni tipo di
scavo o ricerca, per tale ragione, come rilevò l'organo
giudicante, a far corso dall‟entrata in vigore della LPA in
Ecuador non è più possibile divenire proprietari di reperti
archeologici a titolo originario mediante “occupazione”.
La ratio di tale disciplina è evidentemente quella di
impedire l‟attività dei tombaroli, o huaqueros secondo la
denominazione sudamericana, sul territorio ecuadoriano.
Non potendo tali beni fuoriuscire definitivamente dal ter-
ritorio nazionale, la República dell‟Ecuador vantava su di
essi un valido diritto reale dinanzi al Tribunale torinese.
Al giudice spettava, quindi, l‟onere di distinguere preli-
minarmente se la controversia vertesse sul titolo o sul
contenuto del diritto. Se infatti la contesa avesse avuto ad
oggetto il contenuto del diritto sui reperti, il cui luogo di
situazione attuale era l‟Italia, la legge cui il Tribunale a-
vrebbe dovuto dare applicazione sarebbe stata quella ita-
liana. Nella causa in oggetto, però, era il titolo dal quale
discendeva il diritto ad essere messo in discussione ed i-
noltre i beni, sui quali il convenuto vantava il suo diritto,
furono trasferiti in Italia in un momento successivo a
quello in cui lo stesso era sorto. Il contenuto del diritto
reale può variare a seconda del luogo in cui si trovi il be-
ne mobile fino ad azzerarsi, nel caso in cui nel luogo di
situazione il titolo da cui sorse non sia conosciuto, ma
quest'ultimo non viene meno. Anzi, nel caso in cui il bene
tornasse nel situs precedente, il diritto si espanderebbe
nuovamente, “[d]a quanto sopra discende che, mentre il
contenuto attuale del diritto reale sul bene, trasferito al-
46
trove, va apprezzato in base alla nuova legge di «situa-
zione», le controversie relative al modo in cui il titolare
del diritto ne ha usufruito allorché il bene era in un altro
Stato (controversie sul titolo o sulla titolarità) continue-
ranno a cadere sotto la legge alla quale il bene era sotto-
posto”24
. La legge ecuadoriana era quindi competente a
valutare la legittimità del diritto di proprietà esercitato in
Italia, giacché i beni al momento dell‟acquisto si trovava-
no in territorio ecuadoriano.
A questo punto alla Corte rimaneva il solo onere di
appurare la compatibilità della normativa dell‟Ecuador a
tutela del patrimonio culturale con l‟ordine pubblico ita-
liano, verifica che ebbe esito positivo, essendo la stessa
sostanzialmente coincidente a quella italiana. In ossequio
alla legge ecuadoriana, la lex rei sitae, il Tribunale dichia-
rò i reperti sequestrati di proprietà piena ed esclusiva del-
la Repubblica dell‟Ecuador e ne ordinò l‟immediata resti-
tuzione.
Il secondo caso giurisprudenziale rilevante è la nota
causa Ministero francese dei beni culturali c. Ministero
dei beni culturali e ambientali e De Contessini25
, che tut-
tavia non tratta di reperti archeologici. Le opere disputate
erano due arazzi rubati nel 1975 dal Palazzo di giustizia
di Riom che a mente di una legge del 1913 furono catalo-
gati come beni di proprietà statale inalienabile. La refurti-
va giunse in Italia dove fu venduta all'antiquario milanese
De Contessini, il quale a sua volta ne dispose verso terzi.
Dopo un processo penale che vide il proscioglimento
dell'antiquario, il dicastero francese nel giugno del 1983
convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Mi-
nistero dei beni culturali, il sig. L. De Contessini ed uno
dei suoi due aventi causa per la restituzione degli arazzi
24 Ibidem, p. 631. 25 Cassazione civile sez. I, 24 novembre 1995, n. 12166, in http://dejure.giuffre.it.
47
(il secondo cliente, venuto a conoscenza delle indagini
penali, aveva risolto il contratto e restituito l‟arazzo
all‟antiquario).
Dal momento che i beni disputati erano stati trasferiti
da uno Stato all‟altro, il Tribunale di Roma dovette stabi-
lire preliminarmente quale fosse la legge applicabile. Sin
dal primo grado fu chiaro che, conformemente all‟art. 22
delle preleggi, il diritto cui dare applicazione era quello
italiano, in quanto l‟acquisto degli arazzi avvenne sul ter-
ritorio nazionale, circostanza che implicava per lo Stato
francese la perdita del proprio diritto sulle opere qualora
fosse stata provata la buona fede dei due acquirenti.
L‟attore, al fine d'evitare l‟applicazione dell‟art. 1153
c.c., sostenne che per la risoluzione del caso di specie si
dovesse aver riguardo non al menzionato articolo, ma agli
artt. 826 e 828 c.c. Si argomentava che il particolare re-
gime di indisponibilità, e quindi di incommerciabilità,
sancito dagli articoli del Codice si riferisse non solo ai
beni appartenenti allo Stato italiano, ma anche ai beni di
Stati esteri, per tale ragione su di essi non avrebbe potuto
operare l‟istituto di cui all‟art. 1153. La Corte, tuttavia,
rifiutò una simile lettura del dettato codicistico, poiché “la
norma riguarderebbe i beni di proprietà dello Stato italia-
no e degli altri enti pubblici territoriali”26
. Si ritenne
quindi che gli arazzi fossero stati validamente acquistati a
non domino dai due acquirenti di buona fede. In appello
la pronuncia di primo grado venne confermata ed avverso
di essa venne interposto ricorso per Cassazione.
La Francia nei suoi ricorsi asserì l‟irrilevanza dell‟ac-
certamento della buona fede negli acquirenti degli arazzi,
poiché l‟acquisto sarebbe comunque risultato inefficace
trattandosi di beni indisponibili, ergo fuori commercio,
secondo lo stesso ordinamento italiano. Il ricorrente avva-
26 Ibidem.
48
lorò la sua interpretazione facendo riferimento anche alla
disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, intitolata
"Tutela delle cose d'interesse artistico o storico", la quale,
a detta della parte, sarebbe stata del tutto indifferente alla
titolarità italiana o straniera del bene, rilevando ai fini
della sua applicazione solo la presenza dello stesso sul
territorio nazionale.
La Suprema Corte non accolse tale argomentazione ed
in riferimento all‟applicabilità della disciplina codicistica
a beni di altri Stati enunciò che: “il carattere di indisponi-
bilità del bene mobile in oggetto, non deriva sic et simpli-
citer dalla disciplina degli artt. 826 e 828 C.C. Infatti le
disposizioni qualificative e precettive di una norma inter-
na ineriscono essenzialmente a categorie giuridiche rico-
nosciute come proprie da quello stesso ordinamento, non
necessariamente a quelle tipiche di un ordinamento stra-
niero"27
. Il legislatore facendo riferimento al patrimonio
“dello Stato delle province e dei comuni”, ha a mente i
beni degli enti pubblici territoriali disciplinati nel nostro
ordinamento e nient'altro. Lo stesso venne detto con ri-
guardo alla l. n. 1089/1939, se in essa non si disciplinava-
no le importazioni definitive da altri Stati era proprio per
il fatto che tale sistema di tutela era unicamente orientato
alla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale.
L‟ostilità per l‟applicazione all‟interno dello Stato di
norme di diritto pubblico straniere è palesato dalla Su-
prema Corte laddove dichiara che dal nostro ordinamento
non sorge quell'indisponibilità che caratterizza i beni di
interesse storico ed artistico d'appartenenza dello Stato
francese e la conseguente irrilevanza della situazione
soggettiva dell'acquirente. Come osserva Frigo, “in man-
canza di precisi obblighi internazionali, è alquanto im-
probabile che l‟esportazione illecita di un bene culturale
27 Ibidem.
49
dal territorio di uno Stato in violazione delle sue norme
interne di tutela sia considerata di per sé un atto illecito da
parte dello Stato nel cui territorio il bene viene trasferi-
to”28
.
La Corte di Cassazione nella sentenza del 24 novem-
bre 1995 ritenne quindi applicabile il combinato disposto
degli articoli 1147 e 1153 c.c. e rigettò il ricorso. Nel giu-
dizio di legittimità le norme di diritto internazionale pri-
vato italiane vennero applicate correttamente, cionono-
stante la pronuncia appare alquanto deludente sotto una
prospettiva che abbraccia il principio della conservazione
e della tutela dei beni culturali nel luogo d‟origine. Come
si può vedere, a seconda della legge applicabile cause
pressoché identiche hanno esiti diametralmente opposti.
In conclusione, bisogna ribadire che l‟idea secondo la
quale le norme di diritto pubblico a tutela del patrimonio
culturale hanno un‟efficacia meramente interna non è af-
fatto persuasiva, ciò in particolare alla luce della sempre
più intensa evanescenza dei confini che separano diritto
pubblico e diritto privato. Invero, nel momento in cui una
norma di carattere pubblicistico pone dei limiti alla di-
sponibilità di un bene, essa incide sulla capacità dei priva-
ti di porre in essere negozi che lo abbiano per oggetto. Per
questo motivo, nel momento in cui il giudice dello Stato
A, in forza delle norme di diritto internazionale privato
del proprio Paese, applica le norme sulla compravendita
dello Stato B, darà indirettamente applicazione pure alle
norme di diritto pubblico straniere che dichiarano inalie-
nabili certi beni. Ciò è esattamente quanto s‟è palesato
nella seconda causa analizzata.
Come rileva l‟autore citato, in molti casi per lo Stato
richiedente l‟ultima speranza di ottenere la restituzione di
28 M. Frigo, “La Convenzione dell‟Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esporta-
ti”, in Riv. dir. internaz. priv. proc., III, (1996), p. 451.
50
un reperto archeologico o di un opera d‟arte trafugata si
fonda sull‟accertamento della violazione di norme nazio-
nali sull‟importazione da parte del giudice dello Stato di
destinazione del bene29
. Al riguardo i giudici statunitensi,
interpretando il diritto vigente, hanno elaborato una dot-
trina di grande interesse per i Paesi, loro malgrado, espor-
tatori di beni culturali, ci si riferisce alla “McClain doc-
trine”. Nel caso United States v. McClain30
la corte fu
chiamata a pronunciarsi sulla natura furtiva di reperti pre-
colombiani importati dal Messico, la cui normativa li di-
chiarava ex lege di proprietà statale. La disciplina statuni-
tense rilevante era contenuta nel National Stolen Property
Act (NSPA), la cui Sec. 2314 vieta l‟importazione di mer-
ci la cui origine furtiva è nota al momento dell‟ importa-
zione. La questione era, quindi, definire se un bene ille-
galmente scavato ed esportato potesse rientrare nella no-
zione di “stolen goods” di cui alla Section 2314 NSPA.
La Corte ritenne che tali beni potessero essere considerati
rubati ai sensi della citata normativa, ma soltanto nel caso
in cui lo Stato richiedente provasse: I) che l‟opera è stata
ritrovata all‟interno dei propri confini; II) che la normati-
va ivi vigente conferisca inequivocabilmente la proprietà
di detti beni allo Stato, pur in assenza della disponibilità
materiale degli stessi; III) che la legge straniera non viola
i principi del giusto processo così come concepiti negli
Stati Uniti. Provata la concorrenza di tutti i requisiti sopra
esposti la Corte condannò diversi antiquari per traffico di
antichità messicane rubate.
Il precedente venne ripreso dal successivo caso United
States v. Schultz31
, deciso nel 2003 dalla Corte d‟Appello
federale del Secondo Circuito. Questa causa, sotto il pro-
29 M. Frigo, “Caratteri e metodi di soluzione delle controversie in tema di proprietà e di
autenticità di opere d‟arte”, in Riv. dir. internaz. priv. proc., I, (2001), pp. 321 e sg.. 30 United States v. McClain, 593 F2d 658 (5th Cir. 1979). 31 United States v. Schultz, 333 F.2d 393 (2d Cir. 2003).
51
filo fattuale, si presentava pressoché identica alla prece-
dente, F. Schultz, con l‟ausilio di J. Tokeley Parry e A.
Farag, importava negli USA reperti archeologici sottratti
in violazione della “Legge 117”, emanata dall'Egitto nel
1983 a tutela del patrimonio culturale. Schultz e Parry in-
ventarono la “Thomas Alcock Collection”, una collezione
degli anni '20 dalla quale facevano provenire le opere
messe in vendita al fine di dar loro una nuova ed insospet-
tabile identità. Come tocco di classe, al fine di rendere la
messinscena della vecchia collezione ancor più plausibile,
il secondo restaurò i reperti impiegando tecniche comuni
negli anni ‟20 e gli etichettò con marche d‟annata contraf-
fatte. La risultante epoca di ritrovamento avrebbe immu-
nizzato la merce dalla “Legge 117”, poiché, a mente di
detto atto normativo, qualsiasi antichità ritrovata in Egitto
dopo il 1983 è inderogabilmente di proprietà statale. L‟11
giugno 2002 Schultz fu condannato in primo grado a 33
mesi di reclusione. Nel processo d‟appello l‟antiquario
impostò la propria difesa principalmente su due argomen-
tazioni: la “Legge 117” sarebbe una norma di controllo
delle esportazioni, e non un precetto sancente un diritto di
proprietà; la normativa statunitense ed in particolare
l‟NSPA non terrebbero conto di oggetti presi in violazio-
ne di norme sull‟esportazione di altri Stati. La Corte spese
molto tempo nell‟analisi della legge egiziana e furono ad-
dirittura chiamati a testimoniare due alti funzionari egi-
ziani. Se infatti, conformemente alla tesi dell‟imputato, la
“Legge 117” fosse stata una norma di controllo delle e-
sportazioni sotto mentite spoglie, i beni culturali non si
sarebbero potuti caratterizzare come merci rubate ai sensi
della Sec. 2314 NSPA. In forza delle risultanze probato-
rie, il giudice americano concluse che la legge egiziana
era chiara ed inequivocabile e che “the antiquities that
52
were the subject of the conspiracy in this case were o-
wned by the Egyptian government”32
. La Corte, prose-
guendo nel suo ragionamento, statuì che l'NSPA trova
applicazione anche nel caso in cui il bene sottratto pro-
venga dal territorio di uno Stato la cui legge sancisca la
proprietà statale sullo stesso, infatti non v‟è ragione per
cui i beni sottratti a Stati sovrani debbano essere trattati
diversamente da quelli rubati a privati o istituzioni mu-
seali.
Com‟era da immaginarsi, la causa destò l‟interesse di
tutto il mercato antiquario americano, che è uno dei più
importanti al mondo. In grado d‟appello furono presentati
ai giudici due amici curiae a sostegno della posizione di
Schultz, essi, fondamentalmente, sostenevano che la con-
ferma di un simile verdetto di colpevolezza avrebbe se-
riamente compromesso la possibilità dei collezionisti e
dei commercianti d‟antichità americani di svolgere i pro-
pri affari. Merita riportare al riguardo la risposta della
Corte in merito alle preoccupazioni manifestate negli a-
mici curiae dell‟accusa. “Although we recognize the con-
cerns raised by Schultz and the amici about the risks that
this holding poses to dealers in foreign antiquities, we
cannot imagine that it „creates an insurmountable barrier
to the lawful importation of cultural property into the
United States.‟ […] The mens rea requirement of the
NSPA will protect innocent art dealers who unwittingly
receive stolen goods, while our appropriately broad read-
ing of the NSPA will protect the property of sovereign na-
tions”33
. Alla luce della replica della Court of Appeals la
posizione assunta dalle associazioni che li produssero
sembra quantomeno imbarazzante, potrebbe quasi appari-
re come un‟ammissione di colpevolezza. Non si ha un
mercato dell‟arte senza commercio di opere trafugate?
32 Ibidem. 33 Ibidem.
53
In conclusione, come osserva la dottrina, la Court of
Appeals for the Second Circuit, confermando la sentenza
di primo grado, ha ribadito la vigenza della “McClain
doctrine” nella regione di New York, il cuore del mercato
antiquario americano. Questo precedente, anche se non
immediatamente vincolante per le corti di altri circuiti,
costituirà sicuramente una giurisprudenza autorevole e
persuasiva. Inoltre, non è privo di significato che la Uni-
ted States Supreme Court abbia rigettato la richiesta di
Schultz di riesaminare la decisione.
È ora necessario accennare al rapporto fra patrimonio
culturale sottomarino ed il criterio della lex rei sitae. Le
acque del mediterraneo sono ricche di vestigia del passa-
to, tant‟è che reperti archeologici sono stati letteralmente
“pescati” dal mare, si pensi al Melqart di Sciacca,
all‟Atleta vittorioso o al Satiro danzante. I primi due, in
particolare, furono protagonisti di vicende giudiziarie di
grande interesse ai fini del presente scritto.
Nel 1955 le reti del peschereccio Angelina Madre sal-
parono una statua fenicia, ascrivibile ad un arco tempora-
le che va dal XI al IX secolo a.C., raffigurante il dio del
mare Melqart. Uno dei marinai tenne per sé la statua col
pieno consenso dei colleghi, poiché al momento del ritro-
vamento, presentandosi ricoperta di incrostazioni marine,
non apparse agli occhi dei pescatori come un oggetto di
gran valore. L‟opera successivamente fu venduta a tal G.
Tovagliari, che fu il primo a sospettare che sotto le con-
crezioni vi fosse qualcosa di ben più importante d‟un
semplice relitto. Questi pertanto la consegnò ad un esper-
to di archeologia, che identificò il soggetto raffigurato
con la divinità marittima fenicia e ne intuì la preziosità. Il
Tovagliari donò la statua al Comune di Sciacca perché
rimanesse nel patrimonio cittadino, tuttavia il Soprinten-
dente delle antichità e belle arti di Agrigento richiese che
54
venisse affidata alla Soprintendenza, in quanto, a mente
dell‟art. 49 dell'allora vigente l. n. 1089/1939, i reperti ri-
trovati fortuitamente sono di proprietà statale. Nella causa
che contrappose lo Stato ed il Comune intervennero an-
che gli eredi del Tovagliari, i quali sostenevano che il de
cuius non avrebbe mai inteso cedere la proprietà della
scultura al municipio, ma l‟avesse soltanto affidata in de-
posito, e l‟armatore del peschereccio, il quale sosteneva
d‟esserne l‟unico proprietario in quanto fu recuperata dai
flutti da un suo natante oltre le sei miglia marine, ossia
fuori dal territorio nazionale.
La vertenza si concluse il 9 gennaio 1963 con una sen-
tenza che vide l‟accoglimento della pretesa dello Stato ai
sensi degli artt. 44 e 49 della legge citata34
. La Corte, par-
tendo dall‟assunto che a mente dell‟art. 4 del Codice della
navigazione un'imbarcazione battente bandiera italiana in
alto mare vada considerata per fictio iuris come territorio
italiano, formulò nella sua decisione il sottile principio
del “prolungamento del prolungamento”. Del natante, in-
fatti, farebbero parte anche tutti i complementi, da ciò
consegue che “per nave deve intendersi non soltanto uno
scafo natante ma anche tutti i suoi accessori, dal pennone
più alto alla rete più profonda che esso trascina, sicché
appena una cosa mobile del fondo marino s‟impiglia in
tale rete, ed ancor prima che possa dirsi avvenuto qua-
lunque atto di occupazione o possa dirsi tale cosa „scoper-
ta‟, essa deve ritenersi entrata nel territorio italiano, il
che, già da tale momento, rende operante la norma di leg-
ge italiana e, quindi nella specie, acquisita la proprietà
della statuetta contesa da parte dello Stato”35
. I marinai, in
sostanza, nello svolgere le reti integrarono la fattispecie di
scoperta fortuita di cui agli artt. 48 e ss. l. n. 1089/1939.
34 Tribunale di Sciacca, sentenza 9 gennaio 1963, in Foro it., I, (1963), pp. 1317. 35 Ibidem, p. 1319.
55
La pronuncia siciliana è stata richiamata espressamen-
te dall‟ordinanza del 12 giugno 2009 del Tribunale di Pe-
saro36
, che si inscrive nel quadro della decennale vicenda
giudiziaria che circonda l‟Atleta di Fano, del quale questa
rivista ha già parlato37
. Nella fase attuale, essendo già so-
pravvenuto un giudicato sulle vicende del trafugamento,
la questione fu affrontata sotto una prospettiva completa-
mente diversa rispetto a quella adottata nel processo cele-
bratosi fra gli anni „60 e „70. Il 12 luglio 2007 il P.M.
domandò l‟archiviazione (per intervenuta prescrizione e
morte del reo) e la confisca della scultura. Il G.I.P. accol-
se la richiesta d'archiviazione ravvisando in astratto la
configurabilità dei reati, riconobbe, infatti, la natura di re-
perto archeologico della statua salpata dal peschereccio
Ferruccio Ferri e la identificò col Giovane vittorioso e-
sposto nel J. Paul Getty Museum. Il giudice tuttavia non
ne ordinò la confisca, per cui il P.M. promosse l‟incidente
d‟esecuzione che si concluse con due ordinanze: quella
del 2009 sulla giurisdizione e una del 10 febbraio 201038
,
con la quale si stabiliva la confisca del Lisippo detenuto
dal Getty Museum ovunque esso si trovi. La decisione del
giudice pesarese, definita dal J. Paul Getty Trust “flawed
both procedurally and substantively”39
, fu impugnata per
Cassazione. La Suprema Corte, con decisione del 18 gen-
naio 2011, ritenute le impugnazioni interposte irritual-
mente qualificate e proposte, trasmise gli atti al G.I.P. di
Pesaro senza annullare la confisca.
36 Tribunale di Pesaro, ordinanza 12 giugno 2009, in Riv. dir. internaz. priv. proc., I,
(2011), pp.149 e sg.. 37 Si veda: T. Cevoli, “Il Getty Museum e l‟esportazione illecita di antichità dall‟Italia e
dalla Grecia”, in Archeomafie, I, (2009), pp. 11 e sg.. 38 Tribunale di Pesaro, ordinanza 10 febbraio 2010, in Riv. dir. internaz. priv. proc., I,
(2011), pp.175 e sg.. 39 In “Statement About The Ruling in Pesaro on The Getty Bronze” dell‟11 febbraio 2010,
in http://news.getty.edu.
56
L‟ordinanza di maggior interesse ai nostri fini è quella
del 2009, in quanto lo scioglimento del nodo della giuri-
sdizione avrebbe permesso al giudice di individuare in
primo luogo la legge applicabile ed il giudice competente,
in secondo luogo il regime d‟appartenenza del bene e la
sussistenza di un diritto di proprietà in capo allo Stato, de-
terminazione senza la quale non si potrebbe ovviamente
procedere ad una confisca. Il luogo preciso di ritrovamen-
to del bronzo non era noto, ma le risultanze probatorie
rendevano assai verosimile la sua provenienza da acque
non territoriali. Dalle perizie effettuate sulle concrezioni
dei molluschi che ricoprivano la statua e da quelle relative
alla morfologia dei fondali marini confluite negli atti del
processo, nonché dalle dichiarazioni dei pescatori proce-
deva un quadro probatorio sufficiente per escludere la
provenienza della scultura da acque territoriali. Cionon-
dimeno, il G.I.P. affermò che, diversamente dal procedi-
mento dinanzi ai magistrati di Perugia, nel caso in esame
il dato del recupero nel mare libero non influiva
sull‟ipotesi accusatoria, per cui venne affermata non solo
la giurisdizione delle corti italiane, ma anche la compe-
tenza territoriale del Tribunale di Pesaro.
Al G.I.P. rimaneva da dirimere la questione più pro-
blematica, quella relativa al regime giuridico d‟apparten-
enza del reperto. Egli dunque, partendo dal principio di
territorialità di cui all‟art. 3 c.p., s'accinse a descrivere co-
sa debba intendersi per territorio nazionale ai fini del caso
in esame, distinguendo quello effettivo e reale di cui agli
artt. 2 e 3 del Codice della navigazione, da quello indivi-
duato come tale per fictio iuris nelle navi e negli aeromo-
bili battenti bandiera italiana dall‟art 4 comma 2° c.p., in
ossequio al c.d. “principio della bandiera”. Nelle acque
extraterritoriali cessano la tutela spaziale della sovranità e
la potestà punitiva del singolo Stato e concorre la libertà
di tutti gli Stati, ciò vuol dire che non è più presente
57
l‟ostacolo della sovranità. Tale libertà d‟utilizzo del mare
internazionale è garantita dal fatto che ogni Stato vigila e
regola la vita della propria comunità navale senza interfe-
rire sul quella delle società marittime di altri Stati. Pertan-
to, chi sta su di un naviglio battente bandiera italiana in
acque internazionali si trova, giuridicamente parlando, in
territorio italiano. All‟esito dell‟analisi della disciplina
nazionale ed internazionale il G.I.P. statuì che: “in caso di
rinvenimento in alto mare di relitti marini di pregio stori-
co ed artistico da parte di una nave battente bandiera ita-
liana, come avvenuto nel caso di specie, si applica la leg-
ge italiana ed, in particolare, le norme nazionali in mate-
ria di beni culturali". Il Lisippo dunque appartiene allo
Stato italiano.
Entrambe le pronunce vedono l‟applicazione della
legge italiana quale legge del luogo di situazione del bene
controverso, situs costruito giuridicamente in forza del
“principio della bandiera”. Il Tribunale di Sciacca, pur di
non permettere che trovasse applicazione il principio
“primo arrivato, meglio servito”, creò, in assenza di pre-
cedenti appigli giurisprudenziali, il geniale principio “del
prolungamento del prolungamento”, che permise
l‟applicazione delle nostre norme di tutela. Il problema,
tuttavia, sorge proprio dalla modalità attraverso la quale
tali norme hanno prevalso. Corre l‟obbligo di domandarsi
cosa sarebbe accaduto, se si fosse dovuta applicare una
diversa lex situs, magari di un Paese il cui atteggiamento
nei confronti dei beni culturali sia meno protettivo.
Si prenda come esempio la legge statunitense, le cui
norme eventualmente applicabili sarebbero stato quelle
del “venerable law of the sea”, l‟admiralty law. Tale dirit-
to consuetudinario in fatto di relitti appronta due distinte
discipline: il law of salvage ed il law of finds. Ai nostri
fini rileva il secondo, in quanto applicabile nel caso in cui
il proprietario del relitto sia ignoto o non conoscibile, in
58
tale evenienza chi ne consegue il possesso acquisisce ipso
facto anche la proprietà sullo stesso.
L‟istituto denominato law of find si applicherà anche
al patrimonio archeologico sommerso in acque interna-
zionali. Nel caso R.M.S. Titanic Inc. v. Haver40
venne in-
fatti chiarito che l‟admiralty law non disciplina soltanto
fattispecie verificatesi all‟interno delle acque territoriali
statunitensi, ma è atto ad essere applicato a fatti accaduti
in ogni mare, ciò, tuttavia, senza violare la giurisdizione
di altri Stati. Con riguardo ai beni portatori di un valore
storico ed archeologico il law of find si risolve nell‟in-
accettabile attuazione del principio “primo arrivato, me-
glio servito”, circostanza che finisce per favorire le ope-
razioni private di ricerca e di recupero dei cacciatori di
tesori il cui fine non è scientifico, ma lucrativo. Non si
dimentichi, infatti, che i resti di navigli antichi contengo-
no oggetti di notevole valore economico, oltre che storico
ed artistico. Ad esempio, durante un asta curata da Chri-
stie‟s ad Amsterdam fu venduto all‟incanto il carico del
vascello Gendermalsen della Compagnia olandese delle
Indie Orientali affondato nel 1752 vicino all‟isola di Bin-
tan (Indonesia), scoperto e recuperato nel 1985 da Micha-
el Hatcher, un esperto “marine salvor”. Le cinque tonnel-
late di lingotti d‟oro e porcellane cinesi battute all‟asta
produssero un ricavo di 15,255,102 $, dei quali ben 13,5
milioni provenivano dalla vendita del vasellame.
Oggigiorno non può più ritenersi giustificata una di-
sciplina che, permettendo di impossessarsi liberamente di
beni culturali custoditi dai fondali marini e conseguente-
mente di venderli o utilizzarli, agevola spoliazioni perpe-
trate da avventurieri senza scrupoli. Proprio per questa
ragione le pronunce italiane sono problematiche, i criteri
40 Titanic Incorporated v. Haver 43 32 56 49, US 4th Circuit, in http://caselaw. fin-
dlaw.com.
59
utilizzati portano ad una soluzione accettabile nell‟ambito
italiano, ma se per avventura fosse stata su una nave bat-
tente bandiera americana a salpare il Melqart o l‟Atleta di
Fano?
In conclusione, va ribadito che l‟applicazione del co-
mune principio internazionalprivatistico della della lex rei
sitae rende, per i motivi sopra evidenziati, altamente alea-
torie le pronunce degli organi giudiziari chiamati a diri-
mere cause in materia di illecita circolazione di reperti ar-
cheologici, ma non solo.
Abstract
Diego Favero, Lex rei sitae e traffico illecito di reperti
archeologici.
La restituzione dei reperti archeologici trafugati con-
tinua ad essere un problema dati i numerosi limiti interni
ed i casi di inapplicabilità delle convenzioni internazio-
nali in materia (si pensi alla Convenzione UNESCO del
1970 ed alla Convenzione dell‟Unidroit del 1995), per
tale ragione nella risoluzione di simili controversie i giu-
dici dovranno ricorrere ai comuni criteri di collegamento
internazionalprivatistici.
Il traffico internazionale di reperti archeologici si
configura quale commercio di beni mobili, conseguente-
mente laddove un giudice venga chiamato a dirimere una
causa che li abbia per oggetto, egli, al fine di individuare
la disciplina applicabile, dovrà far ricorso al comune cri-
terio di collegamento della lex rei sitae, principio ricono-
sciuto sia dai sistemi di civil law che da quelli di common
law. In forza di tale criterio la proprietà, il possesso e gli
altri diritti reali sul bene mobile sono disciplinati dalla
legge del luogo di situazione del bene stesso.
60
I beni illecitamente fuoriusciti da uno Stato e venduti
all‟estero sono dunque soggetti a discipline nazionali che
possono differire di molto dalla lex originis, la legge del-
lo Stato d‟origine. In primo luogo, il possesso può godere
di una tutela più o meno stringente a seconda dell‟or-
dinamento preso in considerazione. In merito possono di-
stinguersi i Paesi di common law, i quali consentono al
proprietario spossessato di rivendicare i bene anche
presso il possessore di buona fede, dai paesi di civil law
ove vige il principio “possesso vale titolo”. Un caso ecla-
tante a tal riguardo è la causa “Winkworth v. Christie,
Manson & Woods Ltd.”, nella quale il giudice britannico
applicando la disciplina codicistica italiana, in quanto
legge del luogo di situazione delle opere rubate al mo-
mento della compravendita, giudicò a favore del conve-
nuto decretando che in forza della lex rei sitae egli acqui-
stò validamente la proprietà degli oggetti in buona fede.
In secondo luogo, gli Stati manifestano approcci deci-
samente diversificati rispetto alla questione della tutela
del patrimonio culturale, ve ne sono alcuni liberali ed al-
tri più protezionisti, come l‟Italia. Nella maggior parte
dei casi le norme di tutela hanno natura di diritto pubbli-
co, in conseguenza di ciò assai di rado, in assenza di un
strumento pattizio internazionale, esse saranno prese in
considerazione dalle autorità dello Stato di destinazione
del reperto trafugato. Conseguentemente la loro applica-
zione dipenderà dal gioco dei comuni criteri di collega-
mento e, quindi, dalla lex rei sitae. Esemplari a tal ri-
guardo sono la causa “Repubblica dell‟Ecuador - Casa
della cultura ecuadoriana c. Danusso Matta e altri” e la
vertenza “Ministero francese dei beni culturali c. Mini-
stero dei beni culturali e ambientali e De Contessini” le
cui pronunce sono diametralmente opposte.
In ambito statunitense si evidenziano alcuni tentativi
d‟accogliere il diritto pubblico straniero, ci si riferisce in
61
particolare alla cd. “McClain doctrine”, anche se pur
sempre attraverso il filtro di norme interne, quali l‟NSPA.
La problematica della lex rei sitae si pone anche in re-
lazione al patrimonio culturale subacqueo. In Italia una
corrente giurisprudenziale risalente al caso del Melqart
di Sciacca, ha ribadito che i reperti archeologici “pesca-
ti” in acque internazionali appartengono allo Stato ita-
liano qualora la nave batta bandiera italiana, in quanto il
bastimento è per fictio iuris, territorio italiano.
Per queste ragioni gli esiti di azioni giudiziarie volte
alla restituzione di reperti archeologici trafugati sono
tutt‟altro che scontati.
62
Antonella Rosa Saponara, Azzurra Scarci
Le grandi scoperte del passato, le piccole realtà “dimen-
ticate”: il caso della corona aurea di Armento (PZ).
Nel cuore della Basilicata, in un suggestivo paesaggio
di calanchi, montagne e valli, sorge un piccolo borgo di
poche centinaia di abitanti: Armento. Il territorio comuna-
le di Armento è situato tra le sponde di due fiumi che per-
corrono la Basilicata interna e che, incontrandosi, creano
un unico letto e sfociano nel Mar Ionio: il fiume Agri e il
fiume Sauro. In antico il fiume Agri, già citato da Strabo-
ne41
, era un‟ottima via di comunicazione fluviale sia tra le
coste del Mar Ionio e del Mar Tirreno sia con la Basilica-
ta interna centro-settentrionale (fig. 1).
Il centro di Armento, che si ipotizza fosse ubicato sul-
lo sperone collinare, sede dell‟abitato moderno, control-
lava uno strategico punto di snodo delle vie della transu-
manza e di collegamento tra la costa ionica, Pontecagna-
no e Poseidonia42
.
I dati emersi dalle ricerche archeologiche hanno con-
fermato un suo ruolo significativo nell‟ambito enotrio a
partire dalla metà del VII - inizi del VI sec. a.C., come
dimostrerebbero i resti di corredi tombali. Tali testimo-
nianze confermano l‟emergere di élites a controllo degli
itinerari fluviali, secondo modalità già note per altri siti
41 Strabone, Geografia, 5.1.14. 42 A. Russo Tagliente, ARMENTO. Archeologia di un centro indigeno, BA 35-36 (1995)
[2000], supplemento monografico, pp. 5-7.
63
enotri come Chiaromonte, Roccanova ed Aliano.
Alla fine del VI - inizi del V sec. a.C. si assiste ad un
processo di trasformazione per il quale l‟abitato subisce
uno spostamento verso nord-est, in una zona di basse col-
line; si registra, inoltre, la presenza di sepolture di notevo-
le rilievo. La fase che coincide con la fine del V e gli inizi
del IV sec. a.C. corrisponde al passaggio da Oinotria a
Leukanìa ed è testimoniata da alcuni siti, non distanti dal
centro abitato, quali Serra Lustrante e Campo Scavo (fig.
2).
In quest‟ultime due località si concentrano le testimo-
nianze riferibili alla fase di IV sec. a.C., attestata dalla
presenza di un santuario, dalle tracce di abitato e di ne-
cropoli. È probabile che per l‟insediamento di IV sec. a.C.
e per il suo sviluppo sia stato scelto il sito collinare più
prossimo all‟area di produttività agricola, favorito da
un‟abbondante presenza di acqua43
.
Proprio presso il santuario di Serra Lustrante, vi era
uno snodo di una serie di tratturi minori seguiti dalla pa-
storizia transumante tra i pascoli appenninici e quelli di
fondovalle. Dall‟area più interna e montuosa della Luca-
nia, una serie di percorsi portava verso le vallate dell‟Agri
e del Sinni passando per Serra Lustrante. Tali vie si con-
giungevano con il tracciato che da Herakleia giungeva fi-
no a Poseidonia passando per Grumentum, via di colle-
gamento che in età romana sarà denominata Via Hercule-
a.
L‟importanza di Serra Lustrante e del territorio di Ar-
mento era legata all‟abbondanza di sorgenti perenni, lì
dove convergevano le greggi al pascolo. Per questo moti-
vo si è ipotizzato che l‟area sacra si sia sviluppata in se-
guito al consolidarsi di una precedente area di sosta44
.
43 Ivi, pp. 123-124. 44 R. J. Buck, “The ancient roads of southeastern Lucania” in BSR XLIII, (1975), pp. 110-
111; Russo Tagliente 2000, p. 11.
64
Il centro antico di Armento è divenuto importante a
partire dal 1814 a seguito di eccezionali rinvenimenti
quali la statuetta bronzea del satiro in lotta e la famosa co-
rona aurea di Critonio (figg. 3-4), oggi conservati nelle
Antikensammlungen di Monaco di Baviera.
Il nome di Armento si lega alle vicende del Regno di
Napoli e alle figure di Gioacchino Murat e della consorte
Carolina Bonaparte, ai quali si deve la formazione delle
raccolte del Museo di Napoli con materiali provenienti
dalle principali aree archeologiche dell‟Italia meridiona-
le45
.
Nel 1814, in località Serra Lustrante, il colonnello
Diodato Sponsa46
, ufficiale dell‟esercito murattiano, con-
dusse una serie di scavi non autorizzati, incurante dei de-
creti reali relativi alla politica di tutela del patrimonio ar-
cheologico portata avanti dal Regno di Napoli47
. A segui-
to di questi interventi, molti reperti andarono dispersi, al-
tri furono venduti a Napoli, l‟allora capitale del Regno, e
successivamente acquisiti nelle raccolte dei principali
musei del mondo.
45 S. De Caro, “La Magna Grecia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli” in I Greci
in Occidente. La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli (cat.
Mostra), Napoli 1996, 13-14; A. Pontrandolfo, “Armento” in I Greci in Occidente. La
Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli (cat. Mostra), Napoli
1996, 43. 46 Non si hanno notizie precise sulla figura del colonnello Diodato Sponsa. Le poche in-
formazioni riguardano la sua carica, meramente consultiva, di consigliere provinciale in
Basilicata durante il governo murattiano, carica che, come tanti altri suoi compagni “ex-
giacobini”, aveva assunto a causa della riluttanza dei grandi proprietari terrieri dovuta sia
per le onerose spese di viaggio da affrontare per la partecipazione ai consigli e sia, soprat-
tutto, per i pericoli dovuti all‟imperversare del brigantaggio. Il colonnello detenne tale
carica grazie alla linea politica del ministro delle Finanze Luigi De Medici, che tentò di
mantenere in vigore alcune riforme legislative modernizzatrici attuate dal regime francese,
anche dopo la caduta del regime murattiano e il ritorno di Ferdinando di Borbone. Cfr. L.
Calabrese, “L'amministrazione provinciale (1806-2006)” in AA. VV., Potenza Capoluogo
(1806-2006), Caserta, Spartaco, 2008, pp. 438, 440-441. 47 A. Lombardi, “Saggio sulla topografia e sugli avanzi delle antiche città italo-greche,
lucane, daune e peucezie, comprese nell‟odierna Basilicata” in Memorie dell‟Instituto di
corrispondenza archeologica, 1832, p. 243. T. Pedio, “Di uno scavo eseguito in Armento
nel 1814” in ArchStorCal 12, 1942, 53-59.
65
Oltre agli elenchi di rinvenimenti archeologici redatti
durante gli scavi del 1814, si deve ad un erudito dell‟
„800, tale Andrea Lombardi, un resoconto dettagliato di
tre sepolture a camera scavate a Serra Lustrante48
: la pri-
ma tomba, pertinente ad un guerriero, restituiva una lu-
cerna in bronzo su alto piede, un complesso sistema di
vasi da simposio in bronzo e a figure rosse, armi da parata
e una statuetta bronzea raffigurante un satiro, possibile
trofeo di guerra sottratto ad una città magnogreca49
.
La seconda sepoltura, poco distante dalla prima, dalle
pareti intonacate e dipinte, accoglieva un defunto di sesso
femminile con parure composta da collana e fibule in oro,
un fermaglio in bronzo e tre gemme figurate; il corredo
comprendeva inoltre numerosi vasi in argento e ceramica
a figure rosse.
Infine, fu messa in luce una terza sepoltura relativa ad
un defunto cremato, probabilmente un bambino; il corre-
do si costituiva di un candelabro in bronzo, della famosa
corona d‟oro di Critonio, collocata sopra ad una graticola,
e di vasi in argento, bronzo e ceramica a figure rosse50
(fig. 5).
Sempre nella stessa area furono individuate altre se-
polture con ricchi corredi ceramici e vasi metallici. Molti
di questi oggetti, finiti sul mercato antiquario, vennero
acquistati da Carolina Bonaparte che li portò successiva-
mente in Austria durante gli anni del suo esilio51
. Parte
della sua raccolta, acquistata successivamente da Ludwig
I di Baviera nel 1826, confluì nella collezione d‟antichità
48 A. Lombardi (ed. 1836), La corona di Critonio. Viaggio tra antiche città in Lucania,
Venosa 1987. 49 G. Pugliese Carratelli (a cura di), I Greci in Occidente, Monza 1996, p. 721, scheda n.
267. 50 P. G. Guzzo, Oreficerie dalla Magna Grecia. Ornamenti in oro e argento dall‟Italia
meridionale tra l‟VIII e il I secolo, Taranto 1993, nota 53, pp. 113-114, 301. 51 A. Lipinsky, “La corona aurea votiva di Armento. Un capitolo di oreficeria lucana del IV
sec.a.C. e i suoi problemi” in P. Borrano (a cura di), Antiche civiltà lucane: Atti del conve-
gno di studi di archeologia, storia dell‟arte e del folklore, Oppido Lucano, 5-8 aprile 1970,
Galatina 1975, p. 65.
66
del museo di Monaco alla morte del regnante52
.
I reperti finiti sul mercato antiquario erano in verità
regolamentati dal decreto n. 86 del 15 febbraio 1808 se-
condo il quale chiunque avesse voluto effettuare scavi
d‟antichità avrebbe dovuto presentare una petizione al
ministro dell‟Interno descrivendo il sito interessato. La
licenza veniva accordata solo se i monumenti presenti
non fossero stati messi in pericolo; in caso di scavi in ter-
reni non di proprietà del ricercatore bisognava stipulare
una convenzione di scavo che prevedeva l‟osservanza
delle condizioni dettate dai proprietari dei terreni.
Una volta ottenuta la licenza, veniva data comunica-
zione agli intendenti delle rispettive province e al diretto-
re generale degli scavi, il quale aveva l‟obbligo di incari-
care un addetto alla vigilanza. Terminati gli scavi, l‟Ac-
cademia di storia ed antichità avrebbe determinato gli og-
getti da lasciare a disposizione del proprietario e quelli
che avrebbero potuto essere acquistati dai musei reali.
L‟inosservanza, che alle volte si tramutava in esportazio-
ne dei reperti al di fuori del regno, comportava la confisca
degli oggetti stessi53
.
A partire dal maggio 1814, i sacerdoti di Armento Pa-
olo Nicola Sassone e Domenico Siniscalchi e Baldassarre
Zito di Anzi autorizzarono scavi nelle loro proprietà re-
candosi successivamente a Napoli per vendere i reperti.
Nel luglio dello stesso anno il colonnello Diodato
Sponsa, sprovvisto di autorizzazioni e avvalendosi dell‟
autorità del suo ufficio, assoldò quattro scavatori di Anzi
52 J. De La Geniére, “Épire et Basilicate. A propos de la couronne d‟Armento” in MEFRA
101 (1989), 2, p. 691; M. Mazzei, “Documenti per lo studio del collezionismo antiquario:
l‟atto di vendita sulla raccolta di Carolina Bonaparte a Ludwig di Baviera” in Taras XI, 1,
1991, pp. 115-130. 53 Russo Tagliente 2000, p. 165; A. Russo, V. Verrastro (a cura di), Alla ricerca della Co-
rona di Critonio. Catalogo della mostra, Lavello 2007, p. 7.
67
recandosi nel territorio di Armento dove effettuò scavi
dall‟8 al 10 luglio54
.
Il ministro dell‟Interno, Giuseppe Zurlo, informato sui
fatti chiese spiegazioni all‟intendente di Basilicata Nicola
Santangelo, il quale ne risultava all‟oscuro. Continuando i
lavori di scavo, Diodato Sponsa, il 2 agosto 1814, rinven-
ne la preziosa corona aurea portata alla luce dallo scava-
tore Giacomo Lobraico. Un alone di mistero circonda il
rinvenimento della corona, i documenti infatti non men-
zionano l‟esatta localizzazione della tomba a camera.
Il rapporto del rinvenimento della corona venne spedi-
to l‟8 agosto al direttore del Museo di Napoli, in questo si
riferiva che «Il Sig. Colonnello Sponsa [...] trovò in fine
una corona o sia una ghirlanda d‟oro [...] in detta ghir-
landa vi sono pampini, uve e sei Geni alati di uno straor-
dinario disegno [...] Questo luogo è lontano da Armento
tre miglia e si chiama la Serra d‟Oro», la zona indicata
nei documenti ufficiali corrisponderebbe a Serra Lustran-
te, i due toponimi parlanti indicherebbero una zona ricca
di importanti reperti archeologici55
.
Giacomo Racioppi56
, in uno dei suoi scritti, descriveva
così l‟importante rinvenimento: «É una ricca intrecciatu-
ra di nodi e frondi di quercia, con un gran rigoglio di fio-
ri a corolle e calici aperti e smaltati in blu - turchese. A-
lati insetti pare si appoggino sulle estremità oscillanti per
i delicatissimi gambi dei fiori e alcune figure di donne a-
54 Quelli di Anzi, esperti scavatori, prestarono il loro servizio anche nei numerosi scavi
abusivi praticati nel territorio di Armento già a partire dalla fine del XVIII secolo. Cfr. F.
Rossi, Anzi. Notizie storico-statistiche, Potenza, Santanello, 1876. 55 Lipinsky 1975, p. 63; Russo Tagliente 2000, p. 166; Russo, Verrastro 2007, pp. 8-10. 56 Giacomo Racioppi fu uno storico, politico ed economista lucano, vissuto alla fine
dell„800, originario di Moliterno; di famiglia dichiaratamente antiborbonica, con la caduta
del Regno si schierò con i garibaldini e fu nominato segretario provinciale, carica che gli
permise, in assenza del governatore, di ritrovarsi spesso a capo della regione. Tra i vari
scritti, riguardanti anche la storia religiosa, nel 1889 pubblicò due volumi intitolati “Storia
dei popoli della Lucania et della Basilicata”. Cfr. S. Baschirotto, “Grumentum: Storia delle
Ricerche” in A. Mastrocinque, Grumentum romana: convegno di studi, Grumento Nova
(Potenza), salone del castello Sanseverino, 28-29 giugno 2008, Moliterno 2009, p. 16.
68
late poggiano sui rami che formano il serto, il tutto in o-
ro. Meraviglioso gioiello in cui la libera leggerezza
dell'esecuzione, l'avvisato scompiglio dell'insieme e il
ricco intreccio della vegetazione danno al tutto l'espres-
sione della natura viva e reale. Porta scritto in greca let-
tera dell'alfabeto enclideo: Critonio dedicò questa coro-
na. E se costui fosse l'artefice o possessore non so: ne so
decidere, tra gli opposti pareri, se opera a destinazione
funebre o se piuttosto a destinazioni civili solenni, prima
dell'inumazione. La grafia dei caratteri indicherebbe i
principi del VI secolo a. C. Probabile opera grecanica
della civiltà italiota»57
.
L‟importanza dell‟oggetto e l‟enigmatico sito di rin-
venimento suscitarono narrazioni frutto della fantasia di
scrittori e poeti contemporanei. Ne è un esempio il capito-
lo intitolato “Lo scheletro cinto d‟oro” tratto dal libro
“L‟albero bianco” del poeta Leonardo Sinisgalli58
di cui
si riporta un estratto: «Fu una mattina del 1813 che un
pastore di Armento, tal Nicola Dimastrorocco, conduceva
al pascolo la sua scrofa e dodici porcellini, in una con-
trada, la Serra Lustrante, a mano destra del torrente Fa-
valeto [...] Nicola Dimastrorocco aveva poco più di quin-
dici anni quel giorno di maggio del 1813. A quindici anni
si ha tanta voglia di dormire e di stendersi. E la primave-
ra è ingannatrice, ti arrotola nei suoi lacci, ti fiacca le
membra. Nicola si svegliò, [...] Si stropicciò gli occhi, in-
filò la giacchetta, si guardò intorno. Non trovò nulla e
pensò che la luce del sole gli avesse abbagliata la vista.
Cominciò dolcemente a chiamare le sue bestie [...] Non
57 G. Racioppi, Storia dei popoli della Lucania et della Basilicata, Roma 1889. 58 Leonardo Sinisgalli, intellettuale originario di Montemurro, paese a ca. 15 km da Armen-
to, visse nel secolo scorso. Laureato in matematica, ebbe sempre una forte ascendenza
verso la sfera umanistica; autore di numerosi scritti in prosa e versi, anche di carattere
scientifico, mantenne sempre un forte legame con la sua terra d‟origine. Infatti, morto nel
1981, fu sepolto secondo le sue volontà nel cimitero del piccolo paesino a ridosso della
valle dell‟Agri. Cfr. L. Sinisgalli, L‟albero bianco, Venosa 1991.
69
vedeva, non udiva nulla. Era disperato. Scese giù, provò
a zufolare con il suo fischietto. E stava rivolto in
tutt‟altro verso, quando un piccolo grugnito, il grugnito
di un maialetto così simile al pianto ed al riso di un bam-
bino in fasce, lo fece trasalire di gioia. Uno dietro l'altro
i dodici porcellini gli corsero incontro e [...] lo trascina-
rono ad una cinquantina di metri da quel sito, presso una
tomba dove la scrofa col muso duro e frenetico faceva
scempio di uno scheletro. Il ragazzo non ebbe paura di
quell‟apparizione. Aveva visto giocare tante volte i maiali
con una tibia, con una scapola, con un teschio su quella
pianura.Tuttavia non aveva mai incontrato uno scheletro,
le ossa delle mani, le ossa dei piedi. Uomo o donna, egli
non sapeva dire: stava supino, le palme delle mani aper-
te, i grappoli delle ossa e dei piedi appiattiti. Stretta
all‟inguine, offuscata dalla polvere scura, vibrava mira-
colosamente intatta una piccola corona di metallo. Il ra-
gazzo si avvicina e tenta di afferrare con la mano il ma-
gnifico serto. Ma si ritrae, di scatto: gli è parso di sentire
scricchiolare le ossa del morto. Che voglia ghermirlo?
Non è accaduto qualcosa di simile al ladro del tesoro del-
la Vergine Nera di Viggiano? Non è rimasto il ladro at-
taccato alla gabbia della Padrona? Pure quell‟oggetto
meraviglioso lo attira. Allunga il braccio, chiude gli oc-
chi, sente tinnire i calici di oro. Fugge. Ed eccolo sotto la
quercia caduto il sole, circondato dai dodici porcellini e
dalla scrofa irrequieta. Eccolo in piedi che zufola, il capo
incoronato della mitria scintillante. Le api di oro che
succhiano il miele dai calici ronzano aggrovigliate ai
suoi riccioli bruni. Splendono le maiuscole euclidee a ri-
cordo di una amicizia millenaria. Dicono: ΚΡΕΙΘΩΝΙΟΣ
ΗΘΗΚΗ ΤΟΕΙ ΣΤΗΦΑΝΟΝ, Critonio dedicò questa co-
rona»59
.
59 Sinisgalli 1991, pp. 85-87. Per l‟iscrizione cfr.: M. Guarducci, “In Margine alle Corone
d‟oro. Armento e Grumentum” in Epigraphica 37 (1975), pp. 209-212; Lipinsky 1975, pp.
70
La corona misura un‟altezza massima di 37 cm ca., in-
teramente in oro quasi puro. La conservazione è quasi
perfetta, se non per una rottura all‟altezza della parte oc-
cipitale. Sul cerchio, dal diametro di 19 cm., sono saldati
otto cannelli, quattro coppie per lato, ai quali sono ulte-
riormente fissati mazzetti di fiori e di fronde; sulla parte
frontale sono altri tre cannelli a sostegno della figura cen-
trale principale e di quelle alate maggiori disposte sui lati.
Direttamente al cerchio sono saldate tre rose per lato e
fili a costole con fronde, viticci e grappoletti di frutti. Ai
mazzetti conservati sono uniti viticci a spirale, rametti di
quercia con una, due o tre foglie e ghiande, e piccole rose
a coppie. In cima sporgono due foglie lanceolate che ri-
cordano probabilmente fronde di castagno, tra queste fuo-
riescono fiori di convolvolo ed altri fiori a forma di sco-
della, forse fiori di malva. Nei convolvoli sono riprodotti
sei stami, mentre la corolla è coperta di uno smalto azzur-
ro inteso, smalto che con diverse colorazioni si ritrova
anche su altri fiori. Alla decorazione vegetale, si associa-
no le api riprodotte a sbalzo e in perfetta proporzione con
la grandezza dei fiori.
La figura centrale, forse una divinità femminile60
, si
erge sulla parte frontale della corona ed è cesellata e fusa
a tutto tondo; alata, indossa un chitone, un pesante hyma-
tion decorato a granulazione, che le scende a grosse pie-
ghe sulla spalla e sul braccio sinistro, e calzari; è ornata
da una corona a punte che poggia su una chioma ricca-
mente acconciata e da una sottile collana terminate in un
pendaglio in granulazione61
; nella destra recava un ogget-
92-95; R. Lullies, “Abermals: zur Bedeutung des Kranzes von Armento” in JdI 97 (1982),
pp. 91-92. 60 Lipinsky 1975, p. 81. 61 Resti di due buchi nei lobi delle orecchie fanno ipotizzare la presenza di orecchini, andati
perduti. Lipinsky 1975, p. 68.
71
to, forse uno scettro, mentre sulla mano sinistra tiene una
patera.
Affiancano la figura centrale alternativamente due Ni-
kai dalle vesti decorate a granulazione svolazzante, di di-
mensioni minori e collocate tra i fiori e le fronde, e due
coppie di Erotes, di cui uno andato perduto, di stile ar-
caizzante. A completare la descrizione è la base su cui sta
la figura alata maggiore, che reca l‟iscrizione di cui sopra
(fig. 6) 62
.
Due problematiche legate a questo delicato oggetto di
oreficeria sono la datazione e l‟attribuzione ad una preci-
sa officina. Per quanto riguarda la datazione, la corona è
solitamente ricondotta ad una fase di IV sec. a. C.; mentre
per l‟officina di produzione si ipotizza una manifattura
tarantina ovvero lucana per la resa dei calzari che differi-
sce dalle coeve produzioni magnogreche63
.
Appena la corona di Armento apparve sul mercato an-
tiquario, Carolina Bonaparte, appassionata di oggetti
d‟arte, la acquistò insieme al satiro di bronzo e ad altri
oggetti provenienti dallo stesso territorio64
. Un‟altra tradi-
zione vuole invece la vendita della corona per sessantami-
la ducati al Museo Archeologico di Napoli e da qui, come
dono di nozze, dai Borbone agli Asburgo, e da ultimo al
Museo Statale di Monaco di Baviera dove costituisce tut-
tora il pezzo più ragguardevole65
.
La corona venne ufficialmente presentata da Michele
Arditi, per ordine della Regina, nella seduta dell‟Accade-
mia di Storia e Belle Lettere di Napoli il 10 gennaio 1815
anche con l‟intento di entrare a conoscenza del sito preci-
62 Lipinsky 1975, pp. 65-69; Lullies 1982, pp. 92-97. 63 Lipinsky 1975, pp. 68-69, 71-85. 64 Ivi, p .64. 65 Quest‟ultima versione si deve al contributo del defunto parroco di Armento don Dome-
nico Angerosa. Cfr. http://www.basilicata.cc/chiese/testo.php?id=1&com=Armento&est=
armento.php
72
so del rinvenimento. Michele Arditi incaricò che fossero
compiuti accertamenti presso lo Sponsa e l‟intendente di
Basilicata; il 24 gennaio, in una nuova seduta dell‟Acca-
demia, venne richiesto lo studio della corona al Cavaliere
Francesco Maria Avellino66
, il quale si avvalse anche del
contributo del Prof. Briganti67
, esperto di piante e fiori.
Le informazioni ottenute dal ministro Zurlo sul sito di
rinvenimento della corona furono imprecise e insoddisfa-
centi, mentre lo Sponsa stentava nella risposta. Il figlio
dello stesso aveva specificato che «la corona fu ritrovata
in un sito distante due miglia da Armento presso ad una
torre diruta, ed in distanza di 30 miglia a vista del mare
Ionio».
Il ministro Zurlo sollecitò una risposta dello Sponsa
anche attraverso l‟intervento del Ministro della Guerra ma
non si è a conoscenza se il colonnello abbia mai risposto,
è solo certo che chiese il permesso di eseguire nuovi scavi
nella provincia senza specificare precisamente dove68
.
Con la caduta della monarchia e la fucilazione di Gio-
acchino Murat, Carolina dovette lasciare Napoli portan-
dosi via le sue collezioni archeologiche. Sotto il nome di
Contessa Lipona cercò rifugio in Austria, dove gli Asbur-
go le offrirono esilio; qui prese possesso di una villa nei
pressi di Wiener-Neustadt dove sistemò le sue raccolte.
Poiché priva di risorse, Carolina vendette la sua colle-
zione disperdendola. Nel 1826 Ludwig I di Baviera ac-
quistò dalla regina una serie di antichità tra le quali la co-
66 Francesco Maria Avellino, cavaliere dell‟Accademia di Storia e Belle Lettere di Napoli,
ebbe l‟incarico di studiare la corona aurea e di redigerne una memoria, di cui una copia fu
donata a Carolina Bonaparte, una seconda venne pubblicata solamente nel 1822 nelle Me-
morie della Reale Accademia Ercolanense di Archeologia. Cfr. Lipinsky 1975, pp. 64-65. 67 Vincenzo Briganti, professore e collega dell‟Avellino presso l‟Accademia di Storia e
Belle Lettere di Napoli, fu chiamato dall‟Accademia stessa, in quanto esperto di piante e
fiori, affinché potesse dare una sua opinione in merito alle specie vegetali che componeva-
no la corona aurea. Cfr. F. M. Avellino, “Osservazioni sopra una corona di oro trovata in
un antico sepolcro” in Memorie della Reale Accademia Ercolanense di Archeologia, vo-
lume I, Napoli 1822, pp. 208-213. 68 Russo Tagliente 2000, pp. 166-167; Russo, Verrastro 2007 , p. 12.
73
rona ed il satiro bronzeo; alla morte del sovrano, mecena-
te e uomo di grande cultura, la raccolta privata passò al
Königliches Antiquarium trasformato succes-sivamente
nel Museum Antiker Kleinkunst. Attualmente la corona è
esposta nelle Antikensammlungen di Monaco costituen-
done il pezzo principale69
.
Il primo promotore di una vera e propria ricerca ar-
cheologica ad Armento, il quale aveva proposto una si-
stematizzazione topografica delle aree d‟interesse, fu il Di
Cicco, archeologo attivo in Basilicata nei primi anni del
„900. Egli aveva individuato due aree secondo criteri cro-
nologici: la prima in corrispondenza del centro abitato
moderno con presenze di materiali tra la prima età del
Ferro ed il VI sec. a.C., la seconda zona comprendente il
territorio da Serra Lustrante fino alle rive del fiume Sauro
con attestazioni di IV-III sec. a.C.70
Dopo la fervida fase ottocentesca e le ricerche del Di
Cicco, la storia archeologica di Armento conosce un peri-
odo di stasi. Non si hanno notizie di beni trafugati ille-
galmente e venduti sul mercato antiquario provenienti dal
territorio posteriori a quelli sopra esposti.
La ribalta avuta con gli scavi e le importanti scoperte
effettuate grazie al lavoro della Soprintendenza, in primis
nella figura del compianto Prof. Dinu Adamesteanu, tra
gli anni „70 e „90 del secolo scorso, ha avuto sicuramente
un doppio effetto: quello positivo, di mettere in evidenza
l‟importanza del centro di Armento come uno dei punti
focali nei percorsi che attraversavano la regione in antico
e che collegavano lo Ionio, il Tirreno e la Basilicata inter-
na. Quello negativo, di attirare scavatori clandestini che
69 Lipinsky 1975, p. 65; Mazzei 1991, pp. 115-130. 70 V. Di Cicco, “Armento. Fiumarella - Serra Lustrante”, in NSc 1901, pp. 266-269. Russo
Tagliente 2000, p. 13.
74
hanno potuto agire e agiscono tuttora indisturbati in un
territorio incontrollato, sia nell‟accezione di non sottopo-
sto a controllo e verifica sia in quella di non poter essere
dominato. Il territorio, ricco di calanchi e pendii scoscesi,
di folta vegetazione e di boschi, è infatti l‟ideale per chi
vuole agire indisturbato.
Non si entrerà qui in merito all‟indiscusso dibattito ri-
guardante la mancanza di controllo da parte degli Enti
preposti alla tutela e, di conseguenza, l‟assenza di fondi
per poter sopperire a suddette mancanze; ma corre
l‟obbligo almeno di mettere in evidenza come, in una re-
gione dalle tante manifestazioni culturali, da quelle ar-
cheologiche a quelle storico-artistiche, manchi un reparto
di Tutela dei Carabinieri, che sicuramente potrebbe agire
sul danno non solo patrimoniale ma soprattutto culturale
che le popolazioni lucane subiscono.
In ultimo, sarebbe opportuno, in territori così ricchi di
testimonianze archeologiche, organizzare opportuni dibat-
titi e/o convegni per sensibilizzare le masse all‟impor-
tanza della denuncia sia di ritrovamenti di oggetti sotto-
ponibili a tutela, sia di atti di trafugamento illecito, poiché
solamente vivendo e amando un territorio si può giungere
alla salvaguardia e alla tutela dello stesso.
75
Abstract
Antonella Rosa Saponara, Azzurra Scarci, Le grandi sco-
perte del passato, le piccole realtà “dimenticate”: il caso
della corona aurea di Armento (PZ).
Nel cuore della Basilicata, in un suggestivo paesaggio
di calanchi, montagne e valli, sorge un piccolo borgo di
poche centinaia di abitanti: Armento, probabilmente ful-
cro di un fiorente insediamento enotrio, tra VII-V sec.
a.C., e successivamente lucano.
Oggetti di grande pregio sono venuti alla luce nella
prima metà del XIX secolo, sotto il regno di Gioacchino
Murat e della consorte Carolina Bonaparte, spesso nel
corso di scavi clandestini condotti sia dagli abitanti del
piccolo centro che da alcune figure di spicco del regno di
Napoli, come il colonnello dell‟esercito murattiano Dio-
dato Sponsa. Molti “tesori” trafugati finirono sul merca-
to antiquario napoletano. Taluni furono acquistati dalla
stessa Carolina Bonaparte e portati successivamente a
Monaco, sede del suo esilio.
Emblematico il caso della corona aurea cd. di Crito-
nio, di probabile produzione tarantina, ritrovata nel 1814
all‟interno di una ricca tomba lucana del IV sec. a. C.,
comprata dalla sovrana del Regno di Napoli, venduta a
Ludwig di Baviera nel 1826 e ora pezzo principale delle
Staatliche Antikensammlungen di Monaco.
Solo con l‟istituirsi della Soprintendenza Archeologica
della Basilicata (1964) e grazie all‟intervento di Dinu
Adamesteanu vennero condotti i primi scavi e ricerche
sistematiche. Tale territorio, tuttavia, a causa della sua
morfologia e della mancanza di una sorveglianza ade-
guata, continua ad essere oggetto dell‟azione di scavatori
clandestini.
83
Indice
Nota al quarto numero
p. 9
T. Cevoli
Cales tra saccheggi e rifiuti: il patrimonio arche-
ologico nelle terre dei Casalesi.
p. 11
Diego Favero
Lex rei sitae e traffico illecito di reperti archeologici.
p. 38
Antonella Rosa Saponara, Azzurra Scarci
Le grandi scoperte del passato, le piccole realtà “di-
menticate”: il caso della corona aurea di Armento (PZ).
p. 62