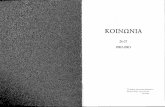"La Lotta". Un giornale intransigente in Provincia di Reggio Calabria agli inizi del '900
Considerazioni tettoniche della Nuova Zelanda successivamente agli eventi sismici del 3 settembre...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Considerazioni tettoniche della Nuova Zelanda successivamente agli eventi sismici del 3 settembre...
GeoResearch Center Italy - GeoBlog
Pub. n° 001
Anno 2011
Prot. n° 030 Anno 2011
Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License
1
CONSIDERAZIONI TETTONICHE DELLA NUOVA ZELANDA
SUCCESSIVE AGLI EVENTI SISMICI DEL 3 SETTEMBRE 2010 E DEL 21 FEBBRAIO 2011
Paolo Balocchi1 - Giorgio De Luca2
Riassunto: Il terremoto del 21 febbraio 2011 mette in luce un diverso assetto tettonico
dell’area di Christchurch, rispetto al quadro globale. Il sisma sembra essere correlato con un evento precedente del 3 settembre 2010, e quindi interpretato come aftershocks. Il meccanismo focale mostra una cinematica da faglia inversa che non può essere correlato al meccanismo focale da faglia trascorrente destra dell’evento sismico precedente. Analizzando i meccanismi focali, e mettendoli in relazione alla principale Faglia Alpina è possibile definire i due sismi come indipendenti, e causati da due strutture cinematicamente differenti ma comunque subordinate alla Faglia Alpina. Tali strutture sono collocate nel quadro tettonico globale della Nuova Zelanda, proponendo un modello tettonico appropriato. Anche il quadro dello stress tettonico non cambia, mostrando un regime di spinta tettonica costante e immutato nel tempo.
Parole chiave: Faglia Alpina, Faglie secondarie, Faglia inversa, Tettonica, Nuova Zelanda. Introduzione Nella giornata del 21 febbraio 2011 alle ore 12.51 locale (23.51 UTC), si è verificato un forte evento sismico di M 6.3 (fig. 1), nella città di Christchurch (43.6° S, 172.7° E), Nuova Zelanda (USGS, 2010; 2011; BALOCCHI, 2011; PIOMBINO, 2011). Tale sisma, ad una prima analisi sembra correlarsi all’evento del 3 settembre 2010 (fig. 2)(mainshock), e quindi interpretabile come aftershocks di una sequenza sismica migrante da ovest ad est. Da un’analisi più approfondita dei meccanismi focali, sembra non essere presente una struttura tettonica che possa mettere in relazione i due eventi, e quindi il sisma del 21 febbraio dovrebbe esse considerato come mainshock di una struttura secondaria (USGS, 2011) ma comunque correlata alla Faglia Alpina (BALOCCHI, 2010). Lo studio condotto dagli autori, vuole focalizzare l’attenzione sull’assetto tettonico e le probabili faglie che hanno generato il sisma del 21 febbraio 2011, visto che nell’area di Christchurch sembra mancare una struttura tettonica attiva (ISTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES – GNS, 2004; USGS, 2011) che giustifichi un evento sismico. Inoltre si vuole proporre un modello tettonico alla scala globale, che metta in relazione le faglie sismogenetiche e il campo di stress tettonico.
1 Geologo del GeoResearch Center Italy – GeoBlog (sito internet: www.georcit.blogspot.com; mail: [email protected]). 2 Geometra collaboratore del GeoResearch Center Italy – GeoBlog (sito internet: www.ricercasperimentale.blogspot.com).
GeoResearch Center Italy - GeoBlog
Pub. n° 001
Anno 2011
Prot. n° 030 Anno 2011
Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License
2
Figura 1: Ubicazione dell’evento sismico del 21 febbraio 2011 (da: USGS, 2011).
Figura 2: Ubicazione dell’evento sismico del 3 settembre 2010 (da: USGS, 2010).
Inquatramento tettonico e sismologico della Nuova Zelanda
Da un punto di vista tettonico, alla scala globale (fig. 3), la Nuova Zelanda si trova in corrispondenza di un margine di placca di tipo trasforme destro con una direzione NE-SW e che mette in contatto la placca Australiana a NW e quella Pacifica a SE. La faglia trasforme viene descritta da diversi autori e denominata Faglia Alpina (WELLS, 1999; ROBINSON, 2003); ZACHARIASEN e al., 2006; UNIVERSITY OF OTAGO). L’evento del 21 febbraio può essere interpretato come parte di una sequenza inizia con il terremoto del 3 settembre 2010 con M 7,0 (fig. 1 e 2), solo sulla base di numerose scosse di assestamento avvenute secondo una direzione W–E, a partire dall’evento del 3 settembre ed estendendosi verso est (USGS, 2011; PIOMBINO, 2011). Analizzando i meccanismi focali dei due eventi sismici precedentemente descritti (USGS, 2010,
Figura 3: Contesto tettonico della Nuova Zelanda (da: MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT).
GeoResearch Center Italy - GeoBlog
Pub. n° 001
Anno 2011
Prot. n° 030 Anno 2011
Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License
3
2011), si nota come l'evento del 3 settembre (fig. 4) mostra un asse principale di massima compressione (asse P) a direzione NW–SE e un asse principale di massima estensione (asse T) a direzione NE–SW. Tale assetto dell’ellissoide degli sforzi è compatibile con un piano di faglia principale con direzione W–E a cinematica trascorrente destra e un piano di faglia ausiliario e coniugato al precedente, con direzione N-S a cinematica trascorrente sinistra. L'evento del 21 febbraio (fig. 5), invece, mostra un asse principale di massima compressione (asse P) a direzione NW–SE e un asse principale di massima estensione (asse T) a direzione N 19° e inclinazione 45°. Tale assetto dell’ellissoide degli sforzi è compatibile con un piano di faglia principale con direzione ENE–WSW a cinematica obliqua–inversa e un piano di faglia ausiliario e coniugato al precedente, con direzione NNW–SSE e anch’esso a cinematica obliqua–inversa. Entrambe gli eventi mostrano la medesima direzione dell’asse principale di massima compressione (asse P), ma differente direzione per quanto riguarda l’asse principale di massima estensione (asse T). Inoltre i due meccanismi focali rappresentano due tipologie di faglie cinematicamente differenti, il sisma del 3 settembre mostra un movimento da faglia trascorrente, mentre l’evento del 21 febbraio mostra un movimento da faglia inversa.
Figura 4: Meccanismo focale dell’evento sismico del 3 settembre 2010: P = asse principale di massima compressione; T = asse principale di massima estensione (da: USGS, 2010).
Figura 5: Meccanismo focale dell’evento sismico del 21 febbraio 2011: P = asse principale di massima compressione; T = asse principale di massima estensione (da: USGS, 2011).
Conclusioni Dallo studio dei due meccanismi focali (fig. 4 e 5) si può notare come i due eventi sismici presentano una compatibilità nella direzione dell’asse principale di massima compressione (asse P, massimo stress tettonico di compressione) mentre non
GeoResearch Center Italy - GeoBlog
Pub. n° 001
Anno 2011
Prot. n° 030 Anno 2011
Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License
4
presentano compatibilità sia per quello che riguarda l’asse principale di massima estensione (asse T, massimo stress tettonico di estensione), sia dal punto di vista cinematico. Infatti, mentre l’evento del 3 settembre è caratterizzato da una cinematica dovuta ad una faglia trascorrente, l’evento del 21 febbraio è caratterizzato da una cinematica da faglia inversa. I due eventi devono essere perciò imputati a due mainshock distinti e legati a due strutture geologiche differenti. Dal confronto tra i due meccanismi focali con quelli storici (fig. 6)(CMT, 2006) è possibile definire una corrispondenza con la Faglia Alpina per il primo evento sismico. Il meccanismo focale mostra il piano di faglia principale con una direzione W–E e inclinato ad alto angolo. Tale assetto strutturale può essere descritto come faglia secondaria trascorrente destra (sintetica) di tipo R
(fig. 7a), orientata a basso angolo (intorno ai 15/20°)(DAVIS, REYNOLDS, 1996) rispetto alla direzione della Faglia Alpina (fig. 8). Per l’evento del 21 febbraio 2011, il quadro strutturale cambia. Il meccanismo focale
mostra un tipo di faglia cinematicamente differente rispetto all’evento sismico precedente (fig. 4 e 5). Pertanto è possibile affermare che la struttura geologica che ha causato i due eventi sismici non sia la stessa, ma per il sisma del 21 febbraio si deve trattare di una struttura compressiva. Anche questa struttura può essere messa comunque in relazione alla Faglia Alpina. Infatti in corrispondenza di zone di taglio (fig. 7b) si possono generare delle faglie di thrust o faglie inverse, con un angolo di 45° circa rispetto alla direzione del taglio principale (DAVIS, REYNOLDS, 1996). L’assetto del piano di faglia principale a direzione ENE–WSW può essere, appunto, descritta come faglia secondaria a cinematica inversa e
Figura 6: Carta della soluzioni dei meccanismi focali (da: USGS, 2011).
Figura 7: Modello delle strutture tettoniche secondarie associate a faglie trasformi destre: a) faglie trascorrenti secondarie tipo R, R’, P; b) faglie inverse secondarie.
GeoResearch Center Italy - GeoBlog
Pub. n° 001
Anno 2011
Prot. n° 030 Anno 2011
Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License
5
orientata secondo la Faglia Alpina (taglio principale) di un angolo corrispondente a circa 45° e il piano di faglia immerge verso SE con inclinazione di circa 63° (fig. 5 e 8). Quindi le due strutture tettoniche minori sono associate alla struttura principale della Faglia Alpina, rappresentando una struttura traspressiva destra. La struttura individuata sulla base dell’analisi del meccanismo focale inerente all’evento sismico del 21 febbraio, non mostra evidenze di tipo geomorfologico, se non quelle successive al terremoto e quindi deve considerarsi sepolta al di sotto dei depositi alluvionali. Nell’area di Christchurch non vengono, però cartografate strutture tettoniche sepolte
e attive (ISTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES – GNS, 2004), e pertanto tale struttura sismogenetica (attualmente attiva) potrebbe essersi formata e avere prodotto il forte evento sismico del 21 febbraio, e numerose fenditure nel terreno tagliando i depositi superficiali, oppure si tratta di una faglia antica e sepolta sotto i depositi alluvionali, che riattivata ha prodotto la scossa sismica (LE SCIENZE, 2011), giustificando l’elevata inclinazione del piano di faglia. Entrambe le strutture descritte sono compatibili con il medesimo asse principale di massima compressione (asse P) a direzione NW–SE. Tale assetto dello stress tettonico in entrambe i casi con la stessa direzione è comunque concorde con il paleostress tettonico alla scala globale (fig. 6). Tale situazione mostra come il regime di spinta tettonica tra le due placche non è cambiato nel tempo, mantenendo la medesima direzione di spostamento relativo delle
due placche. Bibliografia BALOCCHI P., (2011); Terremoto in Nuova Zelanda (news – comunicazione). GeoResearch Center Italy –
GeoBlog, consultabile all’indirizzo internet: http://geobalocchi.blogspot.com/2011/02/terremoto-in-nuova-zelanda.html.
Figura 8: Modello tettonica: Rosso: Faglia Alpina; Verde: faglia secondaria sintetica di tipo R; Blue: faglie inversa probabile, sepolta; Frecce: asse principale di massima compressione (asse P).
GeoResearch Center Italy - GeoBlog
Pub. n° 001
Anno 2011
Prot. n° 030 Anno 2011
Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 2.5 Italia License
6
CMT (2006); Global Centroid Moment Tensor. Consultabile all’indirizzo internet: http://www.globalcmt.org/CMTsearch.html.
DAVIS G.H., REYNOLDS S.J. (1996); Structural geology of rocks and regions. John Wiley & sons, Inc. (seconda edizione).
ISTITUTE OF GEOLOGICAL AND NUCLEAR SCIENCES (2004); New Zealand Active fault database. Consultabile all’indirizzo internet: http://maps.gns.cri.nz/website/af/viewer.htm.
LE SCIENZE (2011); Il terremoto di christchurch preoccupa i geologi statunitensi. Gruppo editoriale L’Espresso. Consultabile all’indirizzo internet: http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/articolo/1346871.
Ministry for the Environment (web); The nature of New Zealand's land environment. Consultabile all’indirizzo internet: http://www.mfe.govt.nz/publications/ser/ser1997/html/chapter8.5.html.
PIOMBINO A. (2011); Il terremoto di Christchurch del 21 febbraio 2011. Scienzedintorni. Consultabile all’indirizzo internet: http://aldopiombino.blogspot.com/2011/02/il-terremoto-di-christchurch-del-21.html.
ROBINSON R. (2003); Potential earthquake triggering in a complex fault network: the northern South Island, New Zealand. Geophysical Journal International, 159(2), pp. 734-748.
UNIVERSITY OF OTAGO (web); Tectonic setting of New Zealand: astride a plate boundary which includes the Alpine Fault. Department of Geology, University of Otago , New Zealand. Consultabile all’indirizzo internet: http://www.otago.ac.nz/geology/research/structural_geology/alpinefault/index.html.
USGS (2010); South Island of New Zealand del 3 settembre 2010 – M 7,0. Consultabile all’indirizzo internet: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/us2010atbj.php#details.
USGS (2011); South Island of New Zealand del 21 febbraio 2011 – M 6,3. Consultabile all’indirizzo internet: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usb0001igm.php#details.
WELLS A., YETTON M.T., DUNCAN R.P., STEWART G.H. (1999); Prehistoric dates of the most recent Alpine fault earthquakes, New Zealand. Geology, 27(11), pp. 995-998. Consultabile all’indirizzo internet: (abstract) http://data.gns.cri.nz/bib/abstract.jsp?type=template&id=83344.
ZACHARIASEN J., BERRYMAN K., LANGRIDGE R., PRENTICE C., RYMER M., STIRLING M., VILLAMOR P. (2006); Timing of late Holocene surface rupture of the Wairau Fault, Marlborough, New Zealand. New Zealand Journal of Geology and Geophysics 49, pp. 159–174. Consultabile all’indirizzo internet: http://www.royalsociety.org.nz/media/publications-journals-nzjg-2006-013-lo.pdf.