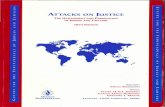M. Bedello Tata,Osservazioni in margine agli stucchi da S.Angelo in Formis, ATTA 2012. Suppl...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of M. Bedello Tata,Osservazioni in margine agli stucchi da S.Angelo in Formis, ATTA 2012. Suppl...
«Sulla dritta della strada che conduce al fon-te di S. Angelo, ho trovato numerosi bassorilievifatti con bellissimo stucco e appartenenti a ba-gni pubblici e privati, che rivelano la magnifi-cenza che presedette alla loro costruzione. E po-sciaché fra quei ruderi rinvenni delle monete diargento di Pescennio Nigro, che tenne l’imperol’anno 193 dell’era volgare, si può dedurre chequei bagni erano in esercizio in quel torno ditempo…»i(1).
Così si esprimeva Giuseppe Novi, tenentecolonnello di artiglieria e dotto ricercatore di“antichità tifatine”, sullo scorcio dell’800 aproposito del ritrovamento presso S. Angelo inFormis del nucleo di stucchi, che corrispondo-no probabilmente a quelli catalogati da HaraldMielsch nel suo Römische Stuckreliefs, sotto lasigla k 112i(2).
Si tratta di circa novanta frammenti rac-colti, forse contestualmente o poco dopo ilritrovamento, ed allettati, secondo un vec-chio criterio di carattere estetico, su unaventina di pannelli incorniciati, come erauso tra la fine dell’Ottocento e gli inizi delNovecentoi(3).
Il sistema, se permetteva un tipo di mu-sealizzazione allora in voga ed evitava lo “sfa-rinamento” del materiale, reca forte intralcioalla sua interpretazione. Lo priva infatti dileggibilità per l’ammassarsi, sui “moderni”supporti, di soggetti diversi, forse anche perprovenienza. Uniche soluzioni da adottare re-stano, oggi, quando possibile, il prelievo deiframmenti dai vecchi supporti, l’analisi stra-
tigrafica, la ricerca degli attacchi (comunquecomplicata dal l’alterazione dei bordi, conse-guenza dell’allettamento) e la ricostruzionegrafica.
Nel caso in oggetto la totale perdita deimanufatti, distrutti nel corso delle ultime vi-cende belliche che investirono anche il MuseoCampano, vanifica ogni tentativo di ricostru-zione.
Di notevole impegno e difficoltà è da rite-nersi dunque lo studio, affrontato dal Miel-sch sulla base della sola documentazione fo-tografica conservata presso l’Istituto Archeo-logico Germanico di Roma che, in parte dalui pubblicata, viene riproposta in questasede e completata. L’analisi tipologica e stili-stica fu effettuata da Mielsch con il supportodell’esperienza a lui derivata dall’esame dellagrande quantità di stucchi, che costituisce la materia prima del suo catalogo, punto diriferimento per lo studio di questo tipo dimateriale.
Sarà dunque mia cura rapportarmi al la-voro già effettuato dallo studioso, cui aggiun-gerò qualche puntualizzazione che ritengoutile alla futura contestualizzazione del mate-riale nell’ambito della realtà territoriale diappartenenza. L’attuale ripresa degli studinel territorio di S. Angelo in Formis, basatasu ricognizioni sul campo, in biblioteca e, inarchivio, sulla raccolta di dati inediti, induce aconsiderare non lontana la ricostruzione dellosviluppo del vicus presso il tempio di DianaTifatina, la cui storia sembra correre ininter-
OSSERVAZIONI IN MARGINE AGLI STUCCHI DA S. ANGELO IN FORMIS
(1) G. NOVI, «Delle acque minerali dei monti di Palom-bara e Tifata e delle utilità di una stazione balnearia pres-so il Ponte di Annibale», in Atti Accademia PontanianaXVI, 1884, p. 13.
(2) H. MIELSCH 1975, Römische Stuckreliefs, Mittei-lungen des deutschen Archaeologischen Instituts, Erg 21,1975, pp. 87-89, 168-170, tavv. 78-81, indicato in se guito come MIELSCH. Altre notizie sull’acquisizioneal Museo Campano del materiale si ricavano dal Cata -
logo Mantese, richiamato, assieme ad uno schizzo di un gruppo di stucchi, in: R. SIRLETO, «Il Museo Cam-pano durante l’ultima guerra», in Per la conoscenza deibeni culturali. III. Ricerche del Dottorato in metodolo-gie conoscitive per la conservazione e la valorizzazionedei beni culturali 2005-2010, Napoli 2010, pp. 157-181,fig. 179.
(3) MIELSCH, tavv. 17, 23, 68, passim.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 241
rotta fino al medioevoi(4), e del sistema di vil-le alle pendici del Tifatai(5).
I frammenti, qui riportati alle figg. 1-19i(6),sono riferibili alla decorazione di pareti, lu-nette e soffitti. Non si può stabilire se essi ap-partenessero a un unico ambiente, rimanendosconosciute la tipologia, le dimensioni e la de-stinazione d’uso dell’edificio di provenienza.In relazione a ciò ho dubbi circa l’attribuzio-ne a un edificio termale, prospettata dal Novi,benché non si possa escluderne la prossimità,che giustifichi la mescolanza, da lui riferita,dei frammenti di stucco con resti di strutturetermali.
Il Mielsch riconosce negli insiemi siglatik 112, 1 e k 112, 2 (figg. 1-2) elementi pertinen-ti a un soffitto con volta a botte, decorato conlacunari esagonali definiti da cornici multiple,interpolati da campi quadrati. Teste a rilievo,come nel caso della testa femminile alata dik 112, 2, ed armi rientravano nella decorazio-ne dei lacunari, come peraltro documentato in
242 M. BEDELLO TATA
Fig. 1. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 1: fram-menti di soffitto.
Fig. 3. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 5: pro-babili frammenti di soffitto.
Fig. 2. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 2: fram-menti di soffitto.
(4) A. DE FRANCISCIS, Templum Dianae Tifatinae,Caserta 1956.
(5) ST. QUILICI GIGLI, «Tifata, imminentes Capuacolles, nella Tabula Peutingeriana», in Orizzonti VII, 2006,
pp. 85-93; cfr. inoltre la documentazione presentata daST. QUILICI GIGLI, in questo stesso fascicolo.
(6) Le tavole illustrative a corredo di questo contri-buto seguono la numerazione di catalogo del MIELSCH.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 242
k 112,1. Lo stesso dicasi almeno per la rosettaa quattro petali e bottone centrale della fig. 3,la cui collocazione al centro di cassettoni qua-drati è ipotizzabile in base ai confronti consoffitti a lacunari del II sec. d.C., ove in genereal fiore sono destinati spazi in alternanza amotivi figuratii(7). La divisione del soffitto in
campi poligonali intervallati da quadrati, giànota nei soffitti di I secolo d.C., ricorre in for-me più massicce anche nel periodo medio impe-rialei(8).
Il resto del materiale, in base alla sua tipo-logia, è ritenuto pertinente a spazi con retropiatto: lunette o pareti.
STUCCHI DA S. ANGELO IN FORMIS 243
(7) M. BEDELLO TATA, «Restare di stucco: la decorazio-ne del soffitto del Tepidarium delle terme dei Cisiarii adOstia», in Atti del X Congresso Internazionale AIPMA (a curadi I. BRAGANTINI), AION ArchStAnt 18, II, 2010, pp. 489-498.
(8) Capisaldi in: MIELSCH, tav. 73, b, p. 156; R. LING,
«Stucco Decoration at Baia», in PBSR 45, 1977, pp. 24-51,fig. 4, tavv. VIII, IX, a; P. GROS, «Un décor d’époque an-tonine et sa signification: les stucs du “Temple de Cérèset de Faustine”», in MEFRA LXXXI, 1969, pp. 161-193,figg. 3, 4.
Fig. 4. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 4: due frammenti di soffitto e un frammento pertinente forse a k 112, 7.
Fig. 5. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 6: frammenti di cornici varie.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 243
244 M. BEDELLO TATA
Fig. 6. S. Angelo in Formis.Stucchi Mielsch k 112,7: frammento di parete(edicola).
Fig. 7. S. Angelo in Formis.Stucchi Mielsch k 112,8: frammento di parete(edicola).
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 244
Alla decorazione parietale facevano caponumerosi frammenti ricollegabili a elementiarchitettonici, disposti a formare articolatiprospetti scanditi da colonne lisce e decoratecon incisioni, scanalate e tortili, rilevate suuno sfondo campito da ghirlande tra le quali,o addossati ad esse, si dispongono soggettiumani ed animali: una vittoria sacrificante(fig. 12), eroti, uccelli (figg. 8, 11), cavalli fan-tastici (fig. 14). Nell’ambito di queste architet-ture potrebbero inserirsi due edicole con co-lonne binate prospicienti un pergolato consoffitto a cassettoni, campiti da rosette, e fron-toncino con delfini affrontati (figg. 6, 7). Alleedicole sembrerebbero pertinenti anche ilframmento, montato in k 112, 10 con colonnebinate (fig. 9) e il secondo frammento sul latosinistro del pannello k 112, 14 (fig. 13).
Il repertorio appare nel suo complesso ric-chissimo: tra i frammenti si annoverano pila-stri sormontati da esseri o animali favolosi, ink 112, 15 (in alto) e in k 112, 18, a (figg. 14,17), colonne con fusti decorati da teste ani -mali e sormontate da elementi fantastici, capi-telli di foglie, capitelli corinzi (figg. 8, 9, 13) eghirlande, allacciate a nastri penduli (figg. 9,11 e 13).
Troppo poche, anche se confermano la va-rietà dei temi decorativi presenti, sono le indi-cazioni utili a collocare i numerosi frammen-tii(9), privi di riferimenti alle misure, pertinen-ti a teste scontornate e a figure maschili efemminili intente in azioni non ricostruibili(figg. 12, 16, 17, 18, 19). Alcune di esse, comela figura in k 112, 16 (fig. 15) potevano posizio-narsi negli spazi o specchiature tra le colonne,come si propone anche per gli elementi di pan-neggio visibili a sinistra in k 112, 9, e a destradella colonna tortile in k 112, 15 (figg. 8, 14).In alcuni casi sono proprio le caratteristichepiù decise a renderne problematica la colloca-zione, come per le due massicce figure ma-schili di k 112, 18 (fig. 17). Per altre concordocon Mielsch, per una collocazione sui registri
più alti di una parete, come il centauro su pie-distallo k 112,18 a (fig. 17) e le due figure incornice a listello in k 112,19 i, j (fig. 18).
L’insieme, compreso il repertorio riferibilealle cornici, denuncia una derivazione dallepiù antiche decorazioni pittorichei(10) e astuccoi(11) di quarto stile. Le forme più pe-santi e l’affollarsi dei temi sembrano essereper Mielsch indizi per una datazione più tar-da, da porsi intorno o poco dopo il 150 d.C.,
STUCCHI DA S. ANGELO IN FORMIS 245
Fig. 8. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 9: dueframmenti di parete, uno dei quali (in alto), colle-gabile a k 112, 11 (lunetta?).
(9) MIELSCH, k 112, 13 c,d; k 112, 17; k 112, 18, b-d,k 112, 19; k 112, 20.
(10) M. PAGANO, «L’edificio in località Murecine aPompei», in Romana Pictura. La pittura romana dalle ori-gini all’età bizantina (a cura di A. DONATI), Roma 1998,pp. 281-283, tavv. 36, 37. Il repertorio di I sec. d.C. a noiben noto grazie alle città vesuviane continua a essere allabase della produzione artistica sia pittorica che a stucco:N. BLANC, «Entre voûte et paroi: le décor des lunettespeintes et stuquées de l’Italie romaine», in Plafond et voû-tes à l’époque antique, Actes du VIIIe Colloque internationa-
le AIPMA (a cura di L. BOHRY), Budapest 2004, pp. 37-44,figg. 10, 11; IDEM, «La transcription des schémas architec-turaux sur les parois stuquées du Ier au IIIéme siècle ap.J.C.», in Circulatión de temas y sistemas decorativos en lapintura mural antigua, Actas del IX Congreso InternacionalAIPMA (a cura di C. GUIRAL PELEGRÍN), Lausanne 2007,pp. 129-136.
(11) MIELSCH, k 53, tavv. 47-49; LING, art. cit., pp. 24-51, fig. 4, tav. IX, b; M.A. TOMEI, «La villa imperiale diArcinazzo e il triclinio della Domus Flavia», in BdA 1993,pp. 17-27.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 245
non in contrasto con analoghe tendenze eclet-tiche, che fondendo elementi di repertorio diII e IV stile si sviluppano, in effetti, in età an-tonino-severianai(12). Un esempio calzante,in questo senso, sarebbe fornito dal confrontotra i frammenti che fanno capo a k 112, 12(fig. 11) ed un elemento in stucco apparte-nente alla decorazione parietale (lunetta?) deltepidarium delle terme dei Cisiarii ad Ostia,anch’esso debitore alla tradizione di età fla-
via, ma databile ad età severianai(13). Altresuggestioni in tal senso si potrebbero coglierenelle figure di volatili sulle ante in k 112, 9 ek 112, 12 (figg. 8, 11)i(14) e nell’immaginefemminile volante k 112,16 (fig. 15), parentestretta di una menade danzante di età fla-viai(15). Gli studi più recenti, d’altro canto,sono concordi nel confermare la dipendenzadegli stucchi di età medio-imperiale dallatradizione precedente di età flavia e tardo
246 M. BEDELLO TATA
(12) I. BALDASSARRE, A. PONTRANDOLFO, A. ROUVE-RET, M. SALVADORI, Pittura romana, Milano 2006, p. 327.
(13) BEDELLO TATA, art. cit., fig. 7, p. 496.
(14) S. DE CARO, «Villa rustica in località Petraro», inRIASA, X 1987, figg. 11, 19-20, 22.
(15) MIELSCH, tav. 45.
Fig. 9. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 10: frammenti di parete non localizzabili. Quello al centro è collegabile ak 112, 7.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 246
flavia, che vengono tradotti in forme più ri-gidei(16).
Qualche spunto di riflessione può esserefornito da un insieme di frammenti raccolti ink 112, 11 (fig. 10), dei quali uno piega ad an-golo ad indicare ancora una volta un’articola-zione in senso prospettico. La tipologia deitemi rappresentati, di carattere puntuale e cir-coscritto, fa pensare a una diversa collocazio-ne, forse una lunetta. I due frammenti piùgrandi, che occupano buona parte del pannel-lo sono limitati in alto da una fascia con kyma
ionico (ovoli distinti negli sgusci e freccettecon cuspide rilevata), cui seguiva una fasciaad anthemion, la cui continuità è interrotta dauna corazza anatomica sorretta da un palo,appoggiata di sghembo e sovrapposta ad unoscudo rettangolare. Nella parte sottostantepende una ghirlanda, cui è sospeso un oscil-lum. Una colonna posta sulla destra è sormon-tata da un elmo a calotta con paraguance, ditipo italico, cui si appoggia un elemento a di-sco. La colonna è decorata con la rappresenta-zione di un Pegaso alato avviluppato al fusto.
STUCCHI DA S. ANGELO IN FORMIS 247
(16) BLANC 2007, art. cit., fig. 7, p. 135.
Fig. 10. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 11: frammenti di parete e di lunetta (?).
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 247
Sullo stesso supporto sono allettati altri fram-menti, certamente pertinenti, da cui si desumela presenza di altri soggetti militari: ci si riferi-sce, in particolare, a due elmi a calotta, cui sideve aggiungere un altro elmo quasi identico,allettato nel pannello k 112, 9 (fig. 8).
Quanto descritto sembra fare riferimentoad un fregio con armi, di cui si conservano po-chi, ma non generici elementi, il che portereb-be, tra l’altro, ad escludere la pertinenza diquesti stucchi ad una terma, come prospettatodal Novii(17).
La presenza della corazza e degli elmi, rie-vocativi del mestiere delle armi o memori di
qualche impresa militare, ricorre nel più rigi-do fregio in stucco all’imposta della volta a la-cunari della chiesa di S. Urbano alla Caffarel-la, già sepoltura o tempio, legato alle figure diAnnia Regilla, moglie di Erode Attico e diFaustina e datato ad età antoninai(18). Manon si possono negare, altresì, i confronti conmateriale più antico ove ricorrono armi e co-razze poste disordinatamente, così come ap-paiono, ad esempio, su di un’urna cinerariada Anagni, di età giulio claudiai(19) e, ingrande, sul fregio del basamento della Colon-na Traianai(20). Vero è che il tema delle armie, in particolare quello del trofeo, di diffusio-
248 M. BEDELLO TATA
(17) Vedi note 1 e 2.(18) GROS, art. cit., pp. 161-193, figg. 3, 9, 11.(19) E. CAETANI LOVATELLI, «Urna marmorea con rap-
presentazione di trofei», in BC, XXVIII, 1900, pp. 241-265;C.A. PICON ET AL., Art of classical world in the Metropoli-tan Museum of Art, New York 2007, pp. 376, 491.
(20) S. SETTIS, A. LA REGINA, G. AGOSTI, V. FARINEL-LA, La colonna Traiana, Torino 1988, figg. 20-23. Sui dise-gni restitutivi si può cogliere meglio il confronto: A.S. SI-MON, «Il regno dei Geti e dei Daci», in Roma e i Barbari (acura di J.-J. AILLAGON), Ginevra-Milano 2008, p. 132.
Fig. 11. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 12, a-f: frammenti di parete.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 248
ne ben più remotai(21), metaforicamente evo-cato in monete, marmi, terrecottei(22), appa-re di frequente nei più tardi sarcofagi con sce-ne di battaglia, la cui produzione si intensifi-ca nel trentennio compreso tra il principato diMarco Aurelio e la prima età severianai(23).Ciò in accordo con la datazione proposta dalMielsch che, comunque riconosce, specie neiframmenti pertinenti alle pareti scompartitedalle colonne, una derivazione dalle temati-che pittoriche di età tardo flavia, ma rivisitatein età antonina.
STUCCHI DA S. ANGELO IN FORMIS 249
Fig. 12. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 13 a-d:frammenti di parete e frammenti figurati nonlocalizzabili.
Fig. 13. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 14:frammenti di parete e teste non localizzabili.
(21) G.C. PICARD, Les trophées romains: contributionà l’histoire de la religion et de l’art triomphal, Paris 1957, da p. 103.
(22) Trionfi Romani (a cura di E. LA ROCCA, ST. TOR-TORELLA), Roma 2008, passim.
(23) Recentemente con bibliografia: Y. RIVIÈRE, «Isarcofagi con scene di battaglia», in Roma e i Barbari,cit., pp. 166-169. A titolo di esempio si vedano il sarcofa-go di Portonaccio con trofei su pilastro sormontati daelmo facciale e quello dal vicolo Malabarba, con trofeicon elmo, corazza ed altre armi (L. MUSSO, in Museo Na-zionale Romano, Le Sculture I, 8, Roma 1985, pp. 177-193, 273-279).
Fig. 14. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 15:frammenti di parete.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 249
Tutto ciò premesso chi scrive rimane indubbio tra una datazione più vicina al model-lo tardo-flavio e quella più recente propostadal Mielsch. Entrambe le posizioni sono ac-
cettabili e certo non aiutano a chiarire i dubbisia la frammentarietà del complesso, aggrava-ta da un montaggio deviante, che l’insufficien-za dei dati di riferimento (concernenti soprat-
250 M. BEDELLO TATA
Fig. 17. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 18, a-d: frammenti di parete e figure non localizzabili.
Fig. 15. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 16:frammento figurato pertinente a parete.
Fig. 16. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 17,a-h: frammenti di parete e figure non localizzabili.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 250
tutto le misure e la stratigrafia dei singoliframmenti) e lo stato di fatto, che non per-mette più, ormai, la conoscenza concreta diun materiale, difficile ed ingannevole di persé, se non esaminato anche dal punto di vistamaterico. Inoltre, al fine di una precisa defini-zione dei manufatti, c’è da tenere presentel’impossibilità di posizionare i singoli fram-menti e la varietà delle tematiche presenti chefanno pensare ad una loro possibile prove-nienza da ambienti o addirittura complessidiversi, non necessariamente allestiti in con-temporanea.
Da qui la necessità di proseguire nell’impe-gno intrapreso con la raccolta dei dati e delleindagini nell’ambito del territorio, che ha ilsuo fulcro a Capua e nell’area di S. Angelo inFormis, con il suo secolare santuario dedicatoa Diana Tifatina, con le ville e gli edifici di etàimperiale, testimoniati da opere marmoree emusive di grande qualità, che restano in parteancora da contestualizzare.
MARGHERITA BEDELLO TATASoprintendenza Speciale per i Beni Archeologici
di Roma
STUCCHI DA S. ANGELO IN FORMIS 251
Fig. 18. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 19, a-j: frammenti figurati non localizzabili.
Fig. 19. S. Angelo in Formis. Stucchi Mielsch k 112, 20: frammenti figurati non localizzabili.
Mentre questo articolo era già pronto perla stampa, la Professoressa Maria Luisa Nava,Direttore del Museo Provinciale Campano, miha informato di avere ritrovato uno degli stuc-
chi di S. Angelo in Formis, nel corso della revi-sione dei materiali conservati nei magazzini.Si tratta dello stucco con immagine femminilevolante, qui presentato alla fig. 15. La foto che
ADDENDUM
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 251
pubblico, cortesemente fornitami, rende evi-dente il precario stato di conservazione e i
danni subiti dal pannello forse in seguito albombardamento del 1943 (fig. 20).
252 M. BEDELLO TATA
Fig. 20. S. Angelo in Formis.Stucco con immagi-ne femminile volante(Mielsch k 112, 16)nello stato attuale diconservazione.
07 BEDELLO TATA 241-252_ATTA suppl. xv, 6 06/03/12 10.54 Pagina 252