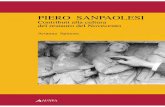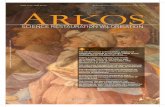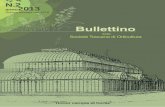«Ci ho pensato tutta la vita». Piero Chiara e Manzoni
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of «Ci ho pensato tutta la vita». Piero Chiara e Manzoni
325
«Ci ho pensato tutta la vita». Piero Chiara e Manzoni
Pietro Montorfani
In un’antica villa sul Lago Maggiore una nobildonna fissa ogni sera su carta le impressioni suscitate in lei da un
interlocutore eccezionale: «c’intrattiene tutto il giorno» − scrive − «con la sua sapiente e dilettevole conversazione». In un’altra pagina lo descrive come «l’anima» della festa e ammette di aver fatto tardi, una sera, per godere fino all’ul-timo della sua affabilità e della sua ironia. Difficile trovare un ritratto più calzante di Piero Chiara, eppure qualcosa non quadra: le date, innanzitutto, poiché il diario di Mar-gherita Provana di Collegno è del 1855 (le pagine citate sono del 14, 15 e 21 ottobre) quando il futuro narratore di Luino era ancora soltanto in mente Dei.1 Alessandro Man-zoni dunque, e non Piero Chiara, fu il facondo protagonista di quella stagione e di quella compagnia, riunitasi a Lesa in anni che ancora attendevano l’unificazione italiana. Ricor-dare che Manzoni fu, nonostante le nevrosi, la timidezza e le piccole fobie, un abile e generoso conversatore è forse il modo più indicato per iniziare a tracciarne le convergenze con la figura e l’opera di Piero Chiara. Tra i due, a distanza di un secolo, non c’è soltanto la devozione del narratore di successo nei confronti di un classico della letteratura italia-na, perché le affinità si giocano su diversi piani, dalla co-mune appartenenza alla civiltà lombarda al confronto mai risolto con il passato, dalle implicazioni autobiografiche alle tormentate riflessioni su femminilità e purezza.
Il rapporto di Chiara con l’autore dei Promessi sposi non è di quelli che si possano archiviare in poche righe, tanta fu la consuetudine che lo costrinse, sull’arco di una vita, al co-
1 Margherita Provana di Collegno, Caro Manzoni, cara Ghita, a cura di Lorenzo Mondo, Palermo, Sellerio, 2013, pp. 127-135.
326
stante confronto con l’archetipo ottocentesco. Lo ammette egli stesso in più di un’occasione: «Il Manzoni è tutt’ora per me un continuo oggetto di studio e di riflessione» (così in una puntata di Sale & Tabacchi del 1976),2 oppure: «Sono un cultore, uno studioso segreto del Manzoni. Non ho pubblicato più di un centinaio di righe su di lui, ma tutta la mia attenzione alla letteratura è piena del Manzoni».3 Questa seconda citazione, tratta da un intervento letto pro-prio a Lesa nel 1985, ci dà ragione della vera natura di questo rapporto: un cultore «segreto», dice Chiara, che è quasi come ammettere una colpa, un errore di gioventù, una passione clandestina e misteriosa. La confessione più disarmante si trova però in uno scritto che Chiara abbozzò nei primi anni Settanta a mo’ di prefazione per la riscrittura televisiva del romanzo manzoniano: «Ho letto I Promessi Sposi un paio di volte in tutto, a cominciare dall’età di tre-dici anni, ma ci ho pensato tutta la vita. Tutto ciò che mi è venuto alle mani, praticando per quarant’anni i libri, sul Manzoni o sulle sue opere, l’ho letto e meditato».4
Chiara dovette avere fama di manzonista, anche sol-tanto di lettore-esperto dei Promessi sposi, se è vero che fu spesso invitato a parlarne in pubblico in varie sedi. A tale dinamica non è estraneo il fatto che l’apice della sua carriera di narratore si situi tra due importanti anniversari manzoniani: il 1973, per i cento anni dalla morte (Chiara ne parlò anche in Svizzera, a Massagno, il 26 novembre),5 e il 1985, a duecento anni dalla nascita di Don Lisander.
2 Si legge oggi in Piero Chiara, Sale & Tabacchi. Appunti di varia umanità e di fortuite amenità scritti nottetempo, con una nota introduttiva di Federico Roncoroni, Milano, Mondadori, 1989, pp. 128-130.3 P. Chiara, Divagazioni manzoniane, in Colloqui a Lesa sul Manzoni, a cura di Andrea Gonzi, Intra, Alberti, 1988, pp. 56-63.4 Questo testo è stato reso noto in parte da Ferruccio Parazzoli nella sua intro-duzione a I promessi sposi di Piero Chiara, Milano, Mondadori, 1996, p. XI. 5 Ne dà testimonianza una cronaca del «Giornale del Popolo», La dimensione umana di Manzoni vivisezionata da Piero Chiara, apparsa senza firma due gior-ni più tardi a p. 4 del quotidiano di don Leber.
327
Nell’arco temporale tra queste due date la sua passione “se-greta” trovò insomma il modo di affiorare in superficie con regolarità, su quotidiani, riviste o raccolte miscellanee, con soddisfazione di molti e anche, è da credere, del diretto in-teressato. Colpisce in questi interventi la competenza con cui Chiara si muove non solo tra le pagine del romanzo, ma anche tra i versi delle tragedie e delle poesie giovanili, mostrando dimestichezza addirittura con il Fermo e Lucia, all’epoca tutt’altro che una lettura consueta. Non solo, la sua curiosità fu tale da spingerlo a consultare le postille manzoniane al Vocabolario della Crusca, nell’edizione cura-ta da Dante Isella nel 1964, o a recensire un precoce saggio di Mina Gregori sui ricordi figurativi dei Promessi sposi.6
L’intera opera di Manzoni fu dunque per Chiara un patrimonio dal quale attingere alla bisogna, come quan-do, nell’almanacco popolare Il gran pescatore di Chiaraval-le del 1983, cita sia Aprile 1814 sia l’inno sacro dedicato al Natale, cui doveva essere particolarmente affezionato.7 Persino nella biografia di D’Annunzio, che poco avrebbe avuto a che spartire con Manzoni, si ricorda di un verso del giovane Alessandro:
Trincerato nel suo appartamento di rue Kléber, dopo la breve uscita per l’incontro di pugilato, era intento a curarsi l’«entor-se», che non era al ginocchio, come si apprende da una lettera all’ottantottenne Treves nella quale gli dice d’essere ammalato «d’un male giovanilissimo», forse la malattia venerea che il giovane Manzoni aveva adombrato poeticamente sotto l’im-magine d’una «ciprigna febbre» e che D’Annunzio non pre-cisò mai.8
6 P. Chiara, Manzoni e la cultura lombarda del Seicento, «Corriere del Ticino», 27 novembre 1962, p. 5.7 P. Chiara, Dodici mesi, un anno, in Il gran pescatore di Chiaravalle. Almanacco popolare 1984, Torino, Arneodo, 1983 (poi in Il verde della tua veste e altri racconti, a cura di F. Roncoroni, Milano, SE, 2008, pp. 88-98).8 P. Chiara, Vita di Gabriele D’Annunzio, Milano, Mondadori, 1978 (la cita-zione è a p. 264 nell’edizione 2013).
328
La citazione, fatta a memoria, è dal Sermone XVI, noto con i titoli non d’autore di Sulla poesia e Contro i poetastri: «Se alcun da furia d’irritato nervo / o da grave Ciprigna o da loquace / tosse dannato a l’odiosa coltre / me sanator volesse».
La passione di Chiara per Manzoni partiva da lonta-no, se già nel dicembre del 1952 aveva recensito il Saggio sui Promessi sposi (Firenze, Le Monnier) dell’amico Remo Fasani.9 Qualche anno più tardi, tra il 1955 e il 1958, il nome di Manzoni sarebbe apparso più volte nei reporta-ges sulla poesia e la narrativa d’Italia stilati annualmente per i «Quaderni grigionitaliani», sotto forma di citazione, ad esempio, dalla Colonna infame («il momento in cui si lavora a rovesciare un sistema non è il più adatto a farne imparzialmente la storia»).10
A partire dal 1959 e fino al 1966, fu la rivista «Ceno-bio», di cui era condirettore assieme a Pier Riccardo Fri-geri, ad ospitare la maggior parte dei suoi contributi man-zoniani. Basterà dare una scorsa ai titoli, accolti per lo più nella rubrica Il divano occidentale, per sincerarsi del teno-re di quegli interventi: Sorte del Manzoni, La monaca di Monza, Ma tutta la colpa è del Manzoni, Il Manzoni non è certo un pornografo, Il Manzoni proibito.11 Aneddotica e ironia, spesso al limite dello sberleffo, erano le armi con cui
9 Cfr. P. Chiara, Studi manzoniani, «Giornale del Popolo», 3 dicembre 1952, p. 17.10 P. Chiara, Poesia italiana 1954, «Quaderni grigionitaliani», XXIV, 1955, 4, pp. 241-253 (la citazione è tratta dalle Opere manzoniane curate da Riccardo Bacchelli per l’editore Ricciardi nel 1953). Queste e altre pagine grigionesi sono state raccolte da Tania Giudicetti Lovaldi e Giancarlo Sala in I candidi amici. Piero Chiara e il Grigioni italiano, Locarno, Pro Grigioni Italiano / Ar-mando Dadò editore, 2006 (qui alla p. 139). 11 Tutti gli scritti di Chiara per la rivista di Frigeri sono stati ripubblicati in P. Chiara, Il divano occidentale e altri scritti per «Cenobio» (1959-1966), a cura di P. Montorfani, Lugano, Edizioni Cenobio, 2011 (per i riferimenti precisi alle singole puntate manzoniane si rimanda alla bibliografia in calce al presente contributo).
329
Chiara tentava di forzare il chiuso sistema della psicologia di Manzoni, uno scrittore la cui trasparenza «è faticosa da raggiungere; e di un uomo di cui si sa tanto, e che conservò quasi tutto quello che scrisse, si può ben dire che conta fra i più misteriosi della nostra letteratura».12 Che la posizione di Chiara non dovesse essere molto diversa da quella del celebre filologo è testimone un foglietto manoscritto, con-servato oggi nell’archivio privato di Federico Roncoroni e intitolato proprio Manzoni:
Non è facile parlare e meno ancora scrivere sul Manzoni. Le imprese della Astaldi e quella più recente della Ginzburg, entrambe melense intromissioni nell’intimità di un grande, insegnerebbero a tacere e a lasciar parlare solo i filologi, che almeno lavorano sulle sue opere e non su di lui.13
Le «imprese» per le quali Chiara spendeva parole così seve-re erano Manzoni ieri e oggi di Maria Luisa Astaldi, apparso nel 1971, e La famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg, pub-blicato nel 1983 (il foglietto sarà quindi di poco successi-vo).14 Eppure, nonostante questa ferma presa di posizione, a conti fatti Chiara non seppe trattenersi dallo sbirciare egli stesso, con voluttà, tra le pieghe della biografia manzonia-na, alla ricerca di quegli elementi che avrebbero potuto ga-rantirgli un accesso più diretto alla reale natura dell’autore dei Promessi sposi. Pensiamo a scritti come Il Manzoni sulla porta, un elzeviro pubblicato sul «Corriere della Sera» l’8 marzo 1973 e stimolato dalla lettura dei resoconti di viag-
12 Gianfranco Contini, Alessandro Manzoni, in Id., Letteratura italiana del Risorgimento (1789-1861), Milano, Sansoni, 1986.13 Il manoscritto è conservato, con altri di medesimo argomento, in una cor-posa cartella denominata «Manzoni». Grande è la gratitudine di chi scrive nei confronti di Federico Roncoroni, che con generosità ha messo a disposizione per questa ricerca il suo archivio personale e la sua vastissima competenza in materia.14 Maria Luisa Astaldi, Manzoni ieri e oggi, Milano, Rizzoli, 1971; Natalia Ginzburg, La famiglia Manzoni, Torino, Einaudi, 1983.
330
gio di Théophile Gautier;15 oppure al racconto postumo I pantaloni del Manzoni, sulle piccole «debolezze dei grandi» e sui «rifugi mentali» di cui non vanno esenti i maggiori scrittori;16 o ancora alla vexata quaestio della paternità del piccolo Alessandro, di cui parla in un’altra puntata di Sale & Tabacchi del 1976, nella quale avanza l’ipotesi, già del giornalista ticinese Eligio Pometta, che si trattasse di un cuoco di Locarno...17
Al di là del gossip, che ha sempre toccato le corde meno alte di Piero Chiara, due mi sembrano le motivazioni prin-cipali dietro questi affondi nell’aneddotica manzoniana. La prima, che con i suoi soggiorni a Lesa negli anni Quaranta e Cinquanta, nella villa della famiglia Stampa, Alessandro Manzoni ha legato indissolubilmente il suo nome a quello del Verbano – del quale Chiara lo elegge quasi a nume tu-telare, parte integrante di quel «patrimonio indistruttibile» di cui parla nell’omonimo scritto del 1984.18 Per il figlio di una nativa di Comnago questa appartenenza alle comuni sponde del Lago Maggiore non deve essere stata di minore momento, anche perché gli forniva il destro per togliere l’autore dei Promessi sposi, se non gli stessi protagonisti del romanzo, dall’usurato paesaggio lariano, per riposizionarli in un mondo a lui assai più familiare.
15 Il contributo è stato in seguito raccolto, con altri apparsi sul quotidiano di Via Solferino, in P. Chiara, 40 storie negli elzeviri del «Corriere», Milano, Mondadori, 1983, pp. 131-136 (poi in Id., Racconti, a cura e con un saggio introduttivo di Mauro Novelli, Milano, “i Meridiani” Mondadori, 2007, pp. 1145-1148).16 P. Chiara, I pantaloni del Manzoni, in Gli anni e i giorni, Pordenone, Studio Tesi, 1988, pp. 171-174. L’aneddoto è ricordato anche nel citato contributo per i Colloqui di Lesa (1983), il cui dattiloscritto si conserva nell’Archivio Roncoroni.17 Id., Sale & Tabacchi, cit., pp. 131-132.18 Id., Un patrimonio indistruttibile, già Care dolci acque non vi riconosco più: qui è finito il sogno della mia infanzia, «Gente», 21 dicembre 1984, poi in Se non qui, dove?, a cura di F. Roncoroni, Varese, Nicolini, 1997.
331
Che la continua messa a fuoco del suo rapporto con Manzoni avesse per Chiara i tratti di una questione pri-vata e imprescindibile (e con questo veniamo alla seconda motivazione) traspare dalla sua interpretazione dei Promessi sposi, che erano per lui esempio sommo di «autobiografia indiretta e dissimulata» nella quale «è possibile trovare tutti i problemi morali, estetici, teologici o storici che furono dell’autore, insieme alle sue manie, ai suoi vizi segreti, se pure ne ebbe, alla storia medesima della sua formazione intellettuale e spirituale».19 Il pensiero non può non correre alle numerose dichiarazioni dello stesso Chiara sulla natura essenzialmente autobiografica della sua scrittura; cosa che, almeno dal suo punto di vista, lo accomunava al più grande narratore della nostra storia letteraria.20
Era inevitabile, data la familiarità con gli scritti manzo-niani, che questi trasparissero qui e là nella prosa narrati-va del luinese. Si prenda ad esempio La stanza del Vescovo (1976), all’inizio del capitolo XVI, là dove si descrive il curioso suicidio dell’Orimbelli:
«Impiccagione alla Condé» spiegò il medico venuto in serata col Procuratore della Repubblica per le constatazioni di legge. «Rara, ma non eccezionale. Il principe di Condé, non quello del Manzoni che dormiva la notte prima della battaglia di Ro-croy, ma l’ultimo dei Condé, Luigi, si impiccò alla maniglia di una finestra e diede il suo nome a questa tecnica».21
19 P. Chiara, Impegno europeo di Giancarlo Vigorelli, «Corriere del Ticino», 12 novembre 1977, p. 29 (l’articolo è una recensione di Manzoni pro e contro e del Diario europeo dell’amico manzonista).20 Stimolato da un’intelligente domanda, lo ammette anche in Davide Lajolo, Parole con Piero Chiara. Conversazione in una stanza chiusa, Milano, Frassinelli, 1984, pp. 42-43: «cito spesso come maestro [...] il Manzoni. Non solo perché è lombardo come me. Soprattutto perché è un uomo combattuto, un cuore tenebroso, un impasto di speranza palese e di disperazione segreta che offre uno spettacolo singolare e ammonitore».21 Le citazioni dai romanzi sono tratte da P. Chiara, Tutti i romanzi, a cura di M. Novelli, Milano, “i Meridiani” Mondadori, 2006 (questa è alla p. 800).
332
Il riferimento è naturalmente all’incipit – anche quello un incipit – del capitolo II dei Promessi sposi, alla tormentata notte di don Abbondio dopo l’incontro con i bravi. Il me-desimo passo ritorna, con poche modifiche, anche in Vedrò Singapore? (cap. XII), come ha notato Mauro Novelli nella sua recente prefazione al romanzo.22
Nel Cappotto di astrakan (1978) l’allusione a Manzoni è più breve ma ugualmente esplicita, a metà del capitolo III, a corollario del primo incontro tra il protagonista e Valentine:
Mi aveva certamente notato più volte lungo la sua strada sen-za darne segno, e vedendomi di fronte con quella domanda in bocca, degna di un Renzo Tramaglino che arriva a Milano dalla campagna, mi doveva aver classificato tra i gonzi.23
Nemmeno la misura breve del racconto è esente da questi omaggi letterari; il più personale e sentito (per questioni di laghi e di fiumi) è in Tutto s’accomoda, volendo, pubblicato nel Capostazione di Casalino (1986):
Dal finestrino del treno vedevo scorrere l’Adda, il grande fiume di Lombardia confratello del Ticino, avventurato anche lui a traversare un lago e a uscirne, a Lecco, con tutte le conseguenze letterarie che il Manzoni ne doveva trarre, sia nel lecchese che più a valle, verso Trezzo, quando l’Adda luccica sotto la luna e Renzo la guarda dall’alto di una ripa, riservandosi di passarla al mattino, traghettato dal cauto barcaiolo o passatore che lo deporrà, salvato dalla forca, in terra di san Marco.24
22 Dei molti «riferimenti parodici ai Promessi sposi disseminati nel romanzo» Novelli ricorda, oltre a quello segnalato, anche la «voce del Natisone» (in luogo dell’Adda) e soprattutto le intersezioni tra il finto interrogatorio del maresciallo Coniglio («“Siete voi” disse “Lorenzo Tramaglino”») e la scena dell’arresto all’o-steria della Luna Piena. Cfr. P. Chiara, Vedrò Singapore?, a cura di M. Novelli, Milano, Mondadori, 2013, pp. XIII-XIV.23 P. Chiara, Tutti i romanzi, cit., p. 830.24 Id., Racconti, cit., p. 1291.
333
E si potrebbe continuare a lungo, come quando, nella medesima raccolta, in Gli Arnaboldi alla porta paragona l’espressione dell’anziano architetto a quella del padre Cri-stoforo di fronte all’indecente proposta di don Rodrigo di affidare Lucia alla sua “protezione”.
Il caso più elaborato di riutilizzo di materiali manzonia-ni è però in Vedrò Singapore? (1981), nel quale, oltre alle citazioni individuate da Novelli e pertinenti per lo più alle velleità letterarie del maresciallo Coniglio, ve n’è una abil-mente dissimulata e, credo, particolarmente significativa. È alla fine del capitolo VII, là dove il protagonista, un piccolo impiegato giudiziario molto simile all’autore, subisce un improvviso quanto insolito trasloco:
Da qualche giorno ero stato spostato, col mio ufficio, sul retro del palazzo, dentro un locale che sembrava un posto di vedetta tanto era alto […]. Sotto di me e oltre l’ombroso cortiletto del carcere che occupava il pianterreno del palazzo, si stendevano i tetti e i fabbricati del monastero, sui quali posavo lo sguardo, curioso di un segno che mi rivelasse, dietro i muri, la presenza delle monache.25
Invano si cercherebbe nei Promessi sposi, dove non man-cano sguardi furtivi tra le mura di un chiostro, l’antece-dente diretto di questo passo. Eppure è senz’altro Manzoni la causa involontaria di questo trasloco, se è vero che nel Fermo e Lucia, in uno dei cinque capitoli dedicati alla Mo-naca di Monza, il «giovane scellerato» Egidio sfrutta per i propri fini la particolare conformazione architettonica del monastero: «in uno di quei tetti v’era un pertugio, un abbaino, che dava luce ad un solajo, e adito a passare su quei tetti, e dal quale si poteva guardare nel cortiletto delle
25 Id., Tutti i romanzi, cit., p. 1162.
334
educande» (Fermo e Lucia, II, 5).26 La scena è praticamen-te identica nei due romanzi, ma la conclusione cui giunge il personaggio di Manzoni è tanto cinica e spregiudicata da battere sul campo i più navigati dongiovanni chiaria-ni: «Un consorzio di donzellette, le quali non eran tutte bambine, parve a colui uno spettacolo da non trasandarsi quando lo aveva così a portata». Possiamo immaginare lo stupore e l’entusiasmo di Piero Chiara di fronte ad una frase come questa, che, seppure indirettamente, lascia in-travedere un altro Manzoni. Che le monache non siano diverse da tutte le altre donne è un’intuizione che ebbe per primo il Boccaccio, nella novella di apertura della giornata terza del Decameron, ma in Manzoni tutto si era ridotto presto – come è noto – ad un implicito quanto fulmineo «la sventurata rispose».
Il sospetto che l’autore dei Promessi sposi avesse fatto della sua stessa opera oggetto di censura, magari omettendo par-ticolari piccanti che pure figuravano nel manoscritto dell’a-nonimo, è la vera matrice delle numerose riscritture manzo-niane di Piero Chiara. Che Manzoni non la racconti giusta è in realtà un’obiezione meno sterile di quanto possa sem-brare a prima vista, poiché tocca nel vivo la struttura stessa del romanzo: il suo essere un racconto riportato, da Renzo all’anonimo al trascrittore ottocentesco, come si afferma nel capitolo XXXVII. A questo si aggiunga che i personaggi principali, prima e indipendentemente dalla straordinaria fortuna della loro storia, iniziano a vivere di vita propria già nelle pagine del libro, per il modo in cui essi stessi si raccon-tano e si concepiscono: «La mattina seguente, don Rodrigo si destò don Rodrigo» (cap. VII), oppure «“Non mi chiamo più Renzo, io? Non siete più Lucia, voi?”» (cap. XXXVI). «Un personaggio una volta creato» – scrive Chiara in un
26 Si cita da A. Manzoni, Fermo e Lucia. Prima minuta (1821-1823), a cura di Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni, edizione critica diretta da Dante Isella, Milano, Casa del Manzoni, 2006, tomo I, pp. 180-189.
335
altro appunto manoscritto di argomento manzoniano, con-servato nell’Archivio Roncoroni – «sfugge alle mani dell’au-tore, come il burattino Pinocchio dalle mani del falegname Geppetto, e si comporta secondo la sua natura». Su queste basi teoriche è costruita la sua riscrittura dei Promessi sposi, che nelle intenzioni di Chiara non era da ritenersi una paro-dia in senso stretto (cioè un torto volontario fatto all’auto-re), semmai un atto di giustizia nei confronti dei personaggi e della loro più intima natura.
Parte dell’essenza dei protagonisti manzoniani è, natu-ralmente, anche l’erotismo, cioè quella «larga e uniforme fascia di fisicità sottostante in ogni tempo alle atmosfere del sentimento».27 Le «grazie brianzole» di Lucia, degne di una Lollobrigida, non saranno certo passate inosservate, anzi, sono in fondo il vero motore di tutta la storia, come scrive in una puntata del Divano occidentale del marzo 1962, dimenticandosi forse che la cosa era ben presente anche a Manzoni:
[…] il frate riprese: «bene; io vi conduco subito al monastero della signora. State però discoste da me alcuni passi, perché la gente si diletta di dir male; e Dio sa quante belle chiacchiere si farebbero, se si vedesse il padre guardiano per la strada, con una bella giovine... con donne voglio dire.»Così dicendo, andò avanti. Lucia arrossì; il barocciaio sorri-se, guardando Agnese, la quale non poté tenersi di non fare altrettanto.28
Si potrà poi discutere se, secondo la vera natura del perso-naggio, sia ragionevole che la timida Lucia non si neghi non solo a Renzo, ma anche a don Rodrigo e persino a padre Cristoforo, come avviene nella riscrittura chiariana; oppure
27 P. Chiara, Prefazione a Id., Proverbi erotici lombardi, a cura di F. Roncoroni, Milano, ES, 2006, p. 7.28 A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di Teresa Poggi Salani, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2013, p. 260.
336
che Renzo, appena giunto a Milano in quella terribile gior-nata, trovi il tempo e la voglia di passare la notte con una prostituta. Però la sostanza non cambia, e la domanda posta all’inizio rimane valida e interessante: Come sono andate ve-ramente le cose? La riscoperta della sensualità dei “promessi sposi” è insomma un aspetto non secondario di una que-stione ben più vasta che va sotto il nome di realismo.
La trascrizione in forma dialogata, stesa nel corso dell’inverno 1970-71, risponde al medesimo interrogati-vo, in un periodo molto fecondo per Chiara dal punto di vista della scrittura televisiva (la RAI aveva da poco prodotto I giovedì della signora Giulia e sulla scrivania dello scrittore stavano prendendo forma sia una versione di Ti sento, Giuditta adattata per il piccolo schermo, sia il soggetto di Homo Eroticus per il regista Marco Vicari). La mancata divulgazione di questo testo – reso noto da Federico Roncoroni soltanto nel 1993 e pubblicato da Mondadori nel 1996 – credo non sia da imputarsi esclusi-vamente alla cancellazione del progetto cinematografico. Per Chiara, a quell’altezza cronologica, la questione Man-zoni non era ancora chiusa, tanto è vero che ci pensò per tutti gli anni Settanta e ancora nei primi anni Ottanta confessava a Davide Lajolo (nell’intervista citata) «vor-rei scrivere un romanzo. La storia di un tale che studia il Manzoni e la sua opera fino a scoprire, sotto il romanzo troppo conosciuto, un romanzo nascosto».
Il protagonista di questo romanzo inedito rimasto allo stadio di abbozzo – il «tale» che studia Manzoni – ha cambiato nome più volte negli appunti preparatori, da Malabrega a Gilardoni a Torniamenti, ma sempre è rima-sta costante la sua qualifica di avvocato; perché un avvo-cato – ricorda Chiara – è «abituato a cercare il vero anche dietro le bugie dei clienti». Il cliente mendace, in questo caso, sarebbe nientemeno che lo stesso Manzoni. Poco si è conservato, o poco è stato scritto, a partire da questa in-tuizione, eppure l’intenzione fu limpida e coerente sin dal
337
principio, come attestano alcuni fogli manoscritti tratti dal medesimo faldone d’archivio:
Esaminare in Fermo e Lucia e negli Sposi promessi l’evoluzione del racconto che riguarda il primo incontro tra Lucia e Don Rodrigo e i successivi. Perché Renzo non ha sospetti [?] Nep-pure dopo il rapimento a Monza si può dubitare della sincerità di Lucia? Possibile che Don Rodrigo fosse tanto incaponito? Queste sono le manifestazioni di uno al quale è stato tolto di bocca la preda, non di uno che non sa ancora che gusto abbia.
E ancora, riprendendo il discorso qualche tempo dopo:
– Visita al filatoio di Fermo e Lucia– Ma come? L’avrebbe vista una volta sola? Per la strada? Il M[anzoni] mente. Nel manoscritto c’era la visita al filatoio e chissà che altro. Il M[anzoni] l’ha lasciata cadere, ha fatto sua la menzogna di Lucia.
Lucia: ecco la vera pietra di scandalo dei Promessi sposi, nella versione edulcorata ed ufficiale di Alessandro Man-zoni. Punto sul vivo, Chiara non è mai riuscito a persua-dersi fino in fondo della sua purezza, un attributo che non le si attaglierebbe se non per illudere e depistare il povero Renzo, tesa a ben altri fini.
Per questa caratteristica di cantiere aperto, plurienna-le, non è possibile giungere ad una conclusione, finanche provvisoria, sull’articolato rapporto tra Chiara e Manzoni. Resta il sospetto che il cuore della sua passione segreta passi proprio da qui, da questa figura di Lucia ritratta in chiaro-scuro: un’anti-Lucia salace e maliziosa, pura soltanto nella mente del suo giovane innamorato. Non sono forse così tutte le protagoniste dei romanzi di Chiara degli anni Set-tanta? Non è così Valentine nel Cappotto di astrakan, Ma-tilde nella Stanza del Vescovo e soprattutto Caterina di Una spina nel cuore? Di simili “spine” di gelosia retroattiva, di si-mili dubbi di purezza negata sono piene le pagine di Chiara a partire almeno dalla signora Giulia, colei che, forse non
338
a caso, condivide il nome con un emblema settecentesco dell’infedeltà coniugale: Giulia Beccaria Manzoni.
La lezione di Chiara è semplice: ogni uomo, posto di fronte ad una donna, non è che un povero Renzo illuso dalla sua Lucia. Nella Stanza del Vescovo, dove persino la proverbiale fedeltà di Penelope viene messa in dubbio (cap. X), leggiamo la più degna conclusione di questa storia:
Pensavo che le donne, quando ammettono, con un uomo ap-pena conosciuto e già amato, dei rapporti precedenti, pare sempre che parlino di inchini, di sorrisi, di baciamani o tutt’al più di carezze superficiali, semplici prove o simulazioni in-nocenti di quello che faranno nel corso del vero amore che hanno finalmente scoperto. Ma dietro tanta discrezione e prudenza, che spesso è anche pudore e riguardo, come non pensare alle tremende vendemmie degli altri?29
BIBLIOGRAFIA
I. Catalogo delle citazioni manzoniane di Piero Chiara
Si indicano di seguito, in ordine cronologico, i luoghi del-la bibliografia di Piero Chiara nei quali è citato esplicita-mente Manzoni, siano essi saggi o articoli a lui dedicati, risposte ad interviste o semplici allusioni all’interno di testi narrativi. Si riportano per esteso i passi più significativi o di difficile reperibilità.
1952Studi manzoniani, «Giornale del Popolo», 3 dicembre 1952, p. 17 [recensione di Remo Fasani, Saggio sui Pro-messi sposi, Firenze, Le Monnier, 1952].
29 P. Chiara, La stanza del Vescovo, Milano, Mondadori, 1976 (Id., Tutti i romanzi, cit., pp. 803-804).
339
1955Poesia italiana 1954, «Quaderni grigionitaliani», XXIV, 1955, 4, pp. 241-253, poi in I candidi amici. Piero Chiara e il Grigioni italiano, Locarno, Pro Grigioni Italiano / Ar-mando Dadò editore, 2006, p. 139.
Una rassegna annuale della poesia italiana quale è quella che ormai per la seconda volta si va facendo su questa rivista, non può avere altro compito se non quello di proporre all’attenzione dei lettori le opere nuove dei poeti già noti e i nomi dei nuovi poeti che via via si affac-ciano al giudizio della critica e del pubblico; ma senza pretendere che ad una generica ed implicita classificazione, e tenendo presente – come avvertiva il Manzoni – che «il momento in cui si lavora a rovesciare un sistema non è il più adatto a farne imparzialmente la storia».
1958Narrativa italiana 1957 [recensione di Alberto Moravia, La ciociara, Milano, Bompiani, 1957], «Quaderni grigioni-taliani», XXVIII, 1958, 1, pp. 2-16, poi in I candidi amici. Piero Chiara e il Grigioni italiano, cit., p. 158.
Sembrerà strano il rapporto, ma viene da pensare al Manzoni, al sen-timento col quale egli ricompone nell’ordine e nella norma comune il gran travaglio dei suoi protagonisti travolti dalla rivoluzione e dall’in-vasione, dalla violenza e dal sopruso dei potenti. A distanza di un seco-lo torna, nella coscienza di uno scrittore italiano, questo grande tema degli umili offesi, dell’umana dignità calpestata che risorge nel dolore e riprende volto di fronte alla vita: una povera vita, ma purtroppo la sola che è possibile vivere. Ed è un segno dei tempi, oltre che un dato fondamentale dell’etica moraviana, il fatto che gli umili appaiano oggi “turbati” non per una gioia più grande, che è il compenso ultraterreno, ma solo perché “così va il mondo” (come in fondo pensava anche il Manzoni), e perché questa è la dura legge che solo all’umana pietà è dato qualche volta di spezzare.
1959Sorte del Manzoni, «Cenobio», VIII, maggio-giugno 1959, poi in Il divano occidentale e altri scritti per “Cenobio” (1959-1966), a cura di Pietro Montorfani, Lugano, Edi-zioni Cenobio, 2011, p. 10.
340
La già nutrita bibliografia manzoniana sta per arricchirsi di una nuova opera, frutto del lavoro di un appassionato di studi manzoniani. Presto verrà data alle stampe la traduzione in dialetto milanese de I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Ne è autore un ex ufficiale giudiziario, Alfredo Gadini, residente a Bellano. La traduzione gli ha richiesto due anni di tempo! Il Gadini ha dichiarato che si è trattato di un lavoro non facile, avendo egli voluto imprimere alla sua versione in vernacolo milanese la stessa purezza di idioma che si riscontra ne I promessi sposi.
1961La madre di Paolo Mantegazza, «Cenobio», X, luglio-ago-sto 1961, poi in Il divano occidentale, cit., p. 64.
La madre di Paolo Mantegazza, donna insigne per benemerenze pa-triottiche, durante l’assedio di Varese del 1859 fece un pellegrinaggio per recare all’eroica città un soccorso in danaro. Racconta appunto il Mantegazza che l’intrepida donna fece con estrema rapidità il giro di raccolta e tra l’altro passò per Lesa dov’era il Manzoni. «Appena essa gli ebbe esposto le ragioni della visita, il Manzoni si mise le mani nei capelli e si diede a correre come un matto da una parte all’altra della ca-mera picchiando il capo nelle pareti. “Si calmi don Alessandro” andava ripetendo mia madre “mi duole di essere venuta in cattivo momento”.Don Alessandro intanto correva sempre e si picchiava il capo; poi si firmò per 5 lire, e se ne scusò: “In questi momenti, nei quali si vorrebbe essere milionari, per poter fare qualcosa per il nostro paese, il sapersi povero fa perder la testa... Mi perdoni”».Spilorceria di don Lisander? si chiede il Mantegazza. Oppure, pa-radossale ma verisimile situazione di un ricco senza denaro liquido? Così è, se vi pare.
(P. Mantegazza, Nervosismo di alcuni uomini illustri, Milano 1905)
La monaca di Monza e Simili ragguagli manzoniani, «Ceno-bio», X, settembre-ottobre 1961, poi in Il divano occiden-tale, cit., pp. 68-69.
La monaca di Monza è tornata all’onore della cronaca (nera) con le puntate che Salvator Gotta ha pubblicato sul «Corriere d’Informazio-ne». Ci siamo così accorti che la vicenda reale della Monaca non è che un volgare episodio di psicopatia sessuale, un riflesso monzese delle pazzie degli enluminados spagnoli dell’epoca. E l’Osio è all’altezza di un qualunque calzolaio siciliano che compie le solite stragi e getta i soliti cadaveri nel Lambro. Il Manzoni è fuori discorso: della Monaca di Monza, intuendo la banalità orrenda dell’episodio, ha fatto tutt’al-
341
tra cosa, restituendo gli atti del processo che non lo interessavano per nulla. Il processo era roba da Salvator Gotta, Gertrude doveva restare una creazione manzoniana.Simili ragguagli manzoniani sono meno interessanti di quelli che ha pubblicato Ennio Flaiano sull’Almanacco del Pesce d’oro 1960 di Vanni Scheiwiller: «Sai chi ho incontrato a Ponza? / La Monaca di Monza. / Era col suo amico / Cardinal Federico».
1962Manzoni e la cultura lombarda del Seicento, «Corriere del Ticino», 27 novembre 1962, p. 5 [recensione tardiva di Mina Gregori, I ricordi figurativi di Alessandro Manzoni, «Paragone», I, settembre 1950, 9, pp. 7-20].
Ma tutta la colpa è del Manzoni e Il Manzoni non è certo un pornografo, «Cenobio», XI, maggio-giugno 1962, poi in Il divano occidentale, cit., pp. 81-83.
Ornella Sobrero, sull’ultimo numero de «Il Caffè» ha esaminato nuovi motivi del successo eccezionale che sta avendo La Monaca di Monza del Mazzucchelli, un libro che ha eguagliato o quasi la vendita de Il Gat-topardo pur non essendo che una banale e scurrile cronaca di antiche porcherie. Tra le ragioni citate dalla Sobrero con molta erudizione ne manca tuttavia una, dimenticata anche da altri che hanno esaminato il caso. È quella allegata dal Boccaccio per spiegare, nella prima novella della giornata terza del suo Decamerone, la ragione per cui le monache non sono diverse dalle altre donne. Dice il Boccaccio che «assai sono di quegli uomini e di quelle femine che sì son stolti, che credono troppo bene che, come ad una giovane è sopra il capo posta la benda bianca et indosso messole la nera cocolla, che ella più non sia femina né più senta de’ femminili appetiti se non come se di pietra l’avesse fatta divenire il farla monaca: e se forse alcuna cosa contra questa lor credenza n’odono, così sì turbano come se contra natura un grandissimo e scellerato male fosse stato commesso, non pensando né volendo avere rispetto a sé medesimi, li quali la piena licenza di potere far quel che vogliono non può saziare, né ancora alle gran forze dell’ozio e della sollecitudine».Ma tutta la colpa è del Manzoni, che ha messo nel suo Promessi Sposi la carica esplosiva (a scoppio ritardato) di Gertrude. Infatti il successo del Mazzucchelli, cioè del fortunato concessionario delle carte processuali, è direttamente proporzionale alla divulgazione dei casi della Monaca di Monza fatta dal Manzoni; e più ancora, a quella morbosa curiosità che il dire e non dire del Manzoni ha suscitato.
342
Il Manzoni non è certo un pornografo, come non lo sono il Boccaccio, l’Ariosto e molti altri fino ai nostri giorni che hanno trattato nei loro libri la materia viva del peccato. Non è un pornografo, ma è certamente più eccitante del Boccaccio e più addentrato di molti altri nel gorgo della sessualità. Essa infatti domina il suo libro. Un libro che è im-postato in buona parte sul sesso eccitato e stravolto dei signori e delle monache, vera materia viva del racconto che per il resto è un grande esempio di lingua, di tecnica del romanzo storico e anche un tentativo di critica all’assolutismo.Dalla scommessa di riuscire a possedere una bella contadina nasce infat-ti la storia manzoniana. Scommessa corsa tra Don Rodrigo e suo cugino il Conte Attilio, per una strada di campagna, al passaggio di Lucia che doveva esibire all’evidenza delle grazie brianzole degne della Lollobrigi-da. Dunque in principio erano le forme. Poi venne il verbo, per bocca dei bravi: «Questo matrimonio non s’ha da fare». Oibò! Il matrimonio avrebbe tolto la primizia a Don Rodrigo per farla delibare al tessitore. La gara ad arrivare primi che si impegna tra Don Rodrigo e Renzo è l’argomento della prima parte del romanzo. Renzo cerca scorciatoie per giungere al matrimonio e quindi alle forme contestate, Don Rodrigo organizza addirittura il ratto della Tettona. Entrambi falliscono. Ed è qui il suspense! Quei volumi tanto concupiti da far muovere cappuccini, padri provinciali, preti e cardinali, intanto vanno in barca e in carretto e finiscono nelle mani della Monaca di Monza. Qui, il giallo s’incastra nel rosa. La fosca figura di Marianna, i delitti, la psicopatia sessuale e gli altri ingredienti dei quali Manzoni fu manipolatore maestro; compresa la punizione e la triste fine dei colpevoli. Ma la Tettona continua la sua lunga strada. Agguantata dai bravi dell’Innominato che debbono averne saggiata la consistenza, va in Castello. Tutti pensano già alla consegna della quaglia al cacciatore Don Rodrigo. Invece arriva la conversione del bandito visconteo; e le forme, tuttora indelibate, tornano in lettiga verso porti più sicuri e sotto l’occhio (nel viaggio) di Don Abbondio.Donna Prassede custodirà i «preziosi» a tempo indeterminato, fino a che la peste avrà vinto davvero la scommessa e lo sparuto Renzo riap-parirà dal Bergamasco a raccogliere i beni sparsi in una unità familiare che andrà dalla vigna alla casa alla moglie. Il romanzo finisce col far figli dei due protagonisti, come era nei voti di tutti. Pensieri irriverenti. Ma doveva venire proprio il Mazzucchelli, con quel bel tipo di biblio-tecario ingenuo dell’Ambrosiana, a suscitarli in tempi come questi!
1963«Il Caffè politico e letterario», XI, 1, gennaio-maggio 1963, pp. 93-95, poi in I bei cornuti d’antan e altri scritti del “Caf-
343
fè”, a cura di F. Roncoroni, Luino, Francesco Nastro Edi-tore, 1996, pp. 60-62; con il titolo Il Manzoni proibito è stato ripreso in «Cenobio», XII, luglio-agosto 1963, poi in Il divano occidentale, cit., pp. 101-103.
Una complessa interpretazione freudiana-umoristica dei Promessi Spo-si consente a Umberto Eco in Diario minimo (Mondadori, Torna-sole 1963), di considerare il cappone (alludendo a quelli che Renzo portava al dottor Azzeccagarbugli) animale emblematico, segno di impotenza e castrazione. Afferma l’Eco che in Renzo vi era, necessa-riamente, questo complesso di impotenza e castrazione. E al di fuo-ri di ogni divertissement, pare questa una verità. Impedito, infatti, al matrimonio da Don Rodrigo, abbindolato dal latino di Don Abbon-dio e minacciato alle costole dai bravi, è chiaro che il povero Renzo dovette rinfoderare. Era alla vigilia delle nozze, nell’imminenza dello sfogo represso, da «buon figliolo», durante tutta l’adolescenza, e si vede rinviare sine die e forse contendere per sempre l’estrinsecazione. Rinfodera. Ma il fuoco represso gli va al cervello e «fo uno sproposito» dice subito, poi a Milano fa spropositi uno dopo l’altro fino a rischiare la forca. Effetti della castrazione, sfoghi della impotenza in cui era confinato dalla prepotenza spagnola e dall’acquiescenza ecclesiastica.Il Renzo che nelle ultime pagine del romanzo si mette a far figlioli in abbondanza sembra infatti un altro individuo, quasi una reincarna-zione del Renzo ante castrazione, o meglio una specie di Bruneri che riappare in veste di Cannella, il prof. Cannella, e riprende – o finge di riprendere e in effetti inizia – un rapporto coniugale, autenticato da chiare facoltà riproduttive. Ma il vero Renzo resta colui al quale fu impedito di compiere la copula preordinata; e il romanzo pare incen-trarsi sulle vicende del rinvio, per finire col realizzo, forzato, dell’azio-ne interrotta. È infatti più che evidente il dissapore, la delusione, il diverso gusto dell’accoppiamento di Renzo e Lucia dopo la peste, il voto e la lunga separazione. Il vero momento per Renzo era la notte di quel giorno in cui andò, di prima mattina, dal suo Curato, «con la lieta furia di un uomo di vent’anni» (e non rileva l’Eco l’immagine del gallo in contrasto con quella dei capponi di qualche tempo dopo) «con penne di vario colore al cappello», senza contare il «pugnale del manico bello, nel taschino de’ calzoni» che farebbe gridare di gioia, per il suo chiaro valore di simbolo, anche il più freddo seguace di Freud. Vedasi in Gadda (Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, pag. 81): «Il coltello... sulla panza degli eroi funebri, dove si esibiva, ora, estromesso in gloria, come un genitale nichelato, argentato». Che è sempre il pugnale «del manico bello» di Renzo, assurto, in altra epoca storica, a divisa.
344
Dopo il Manzoni «progressista» e il Manzoni «reazionario» eccoci dunque a un nuovo aspetto, anche questo tale da indurre, benché in tempi di poca censura, a bandire il Manzoni dalle scuole, se già non fosse da bandire per altre ragioni come scriveva il Cases non molti anni fa: «Il cattolico Manzoni invita alla rassegnazione», dice il Cases, «però solo dopo aver spietatamente smontato l’atroce meccanismo che produce la Monaca di Monza, con una così rara e ammirevole mancanza di rispetto per certe istituzioni, a cominciare dalla fami-glia, che si lascia addietro Diderot e che dovrebbe bastare a bandir-lo dalle nostre scuole se ci si accorgesse del velen dell’argomento» (Cesare Cases, «I Promessi Sposi» e la critica progressista, in bollettino editoriale Einaudi, a proposito del volume di scritti manzoniani del De Sanctis). A quale proposito il Cases dice addirittura che «c’è nel Manzoni qualche cosa di quella borghesia milanese che fa un gran baccano assicurando che se andasse a Roma instaurerebbe subito il laburismo inglese e il paradiso elvetico, mentre in realtà a Roma ci va, ma soltanto per cambiare l’indirizzo coi latifondi meridionali». Aggiunge poi che il Manzoni, «il suo intrallazzo col Dio del Padre Bresciani lo combinò a Milano, e si chiamò nientemeno che I pro-messi sposi».Punti di vista. Forse più fondati quelli di Umberto Eco. E quelli del Gadda che reagisce alla prefazione di Moravia per il Promessi Sposi di Einaudi difendendo il Manzoni, il milanese figlio di un patrizio sto-lido e cornuto (sempre parole del Cases), dall’accusa di paternalismo e vedendolo invece come un rivoluzionario.Come un rivoluzionario, guardandolo da uno dei suoi tanti lati, lo vede del resto anche il Cases quando riconosce nel figlio del cornuto «qualche cosa che è assolutamente nuovo e originale nella lettera-tura italiana: il senso della responsabilità della società nei confronti dell’individuo» (stesso scritto sopra citato).In tanto allegro festino manzoniano, bene sta l’invenzione di Umber-to Eco, allegoria nell’allegoria o gioco nel gioco che sempre si intesse sulle cose serie, come per dire «cose serie nessuna» o forse di serio, solo il Manzoni, con l’opera sua e con la sua condizione di letterato, di uomo che dalle materne irrequietezze dedusse quel severo emble-ma delle corna sul quale, anche col mutar dei tempi, c’è poco da scherzare per tutti.
1966L’arte della caccia, «Corriere del Ticino», 4 giugno 1966, p. 7 [cita Francesco Birago, don Ferrante e il XXVII capi-tolo dei Promessi sposi]
345
«Ave o rima», «Cenobio», luglio-agosto, 1966, poi in Il di-vano occidentale, cit., p. 120.
Nemmeno gli studenti delle scuole commerciali hanno mai perdonato al Manzoni la rima «lui – nui» che figura nel Cinque maggio: «... Ai po-steri / l’ardua sentenza: nui / chiniam la fronte al Massimo / fattor, che volle in lui / del creator suo spirito / più vasta orma stampar».Ma pare che il Manzoni avesse innanzi, in quel frangente, un esempio confortante: il sonetto dantesco «Deh peregrini che pensosi andate». In-fatti l’ultimo verso di tale sonetto, «hanno vertù di far piangere altrui» rima col quart’ultimo: «che lagrimando n’uscireste pui».Probabilmente ci saranno altri esempi tra Dante e il Manzoni, ma que-sto è decisivo. Resta a chiedersi perché il Manzoni non abbia invertito la forzatura, scrivendo correttamente noi e adattandovi per necessità di rima un loi: «che volle in loi / del creator suo spirito / più vasta orma stampar». Ma lo confortava l’esempio di Dante che non si era lasciato tentare da un corretto poi per non essere costretto a «far piangere altroi».
1970I promessi sposi [abbozzo di riscrittura televisiva], poi Mila-no, Mondadori, 1996.
Ho letto I Promessi Sposi un paio di volte in tutto, a cominciare dall’età di tredici anni, ma ci ho pensato tutta la vita. Tutto ciò che mi è venuto alle mani, praticando per quarant’anni i libri, sul Manzoni o sulle sue opere, l’ho letto e meditato... Non pretendo di far credere che Ales-sandro Manzoni mi sia apparso in sogno o nel silenzio del mio studio e mi abbia chiesto di riscrivere il suo libro come l’avrebbe scritto lui oggi, o appena una trentina d’anni dopo. Ma è come se lui mi fosse apparso, perché l’ho sentito parlare fra le righe delle diverse versioni e le varianti del suo romanzo. Soprattutto l’ho sentito parlare dal fondo del suo essere. Credo di averlo immaginato, biologicamente, con una certa precisione; o meglio, di essermi introdotto con sufficiente aderen-za nella sua pelle, cioè nel suo essere fisico e nella sua struttura psichica, che è, come dire, per estensione, nella sua anima. O, almeno, in una delle sue due anime, quella peggiore, se vogliamo, ma indubbiamente la più sua, la più naturale.
1973Il Manzoni sulla porta, «Corriere della Sera», 8 marzo 1973, poi in 40 storie negli elzeviri del «Corriere», Milano, Monda-dori, 1983, pp. 131-136, poi in Racconti, cit., pp. 1145-1148.
346
La peste di Milano, «Corriere della Sera», 31 agosto 1973, poi in Un bel viaggio, a cura di F. Roncoroni, Cava dei Tir-reni, Avagliano, 1997, pp. 87-92.
In occasione del centenario manzoniano, è forse il caso di riprendere in mano quell’operetta minore ma tanto impegnata, per cogliervi l’ac-ceso animo del Manzoni e la sua alta indignazione di fronte all’abuso della legge, benché sia certo che i due infelici mandati al supplizio non avrebbero potuto, in quel misero tempo, avere altra sorte. [p. 87]
Nel calore polemico suscitato dalle opere del Verri e del Beccaria, al Manzoni venne naturale prendere le difese degli untori, bollare un’e-poca e un costume che era in contrasto coi lumi del suo secolo, ma che aveva avuto, nell’intimo delle sue dolenti e tragiche evenienze, a lottar col buio, ad affrontare coi suoi poveri mezzi teologici e giuridici il mi-stero dell’eterna e ineluttabile presenza del male. [p. 89]
Fu probabilmente non giustizia, ma esorcismo o sacrificio d’innocenti inteso a placare una divinità irritata, fu l’offerta dell’ignoranza e dell’in-consapevolezza a un dio feroce, ma fu tutto quello che poteva fare, e non poteva omettere, una povera società di uomini oppressi dalla sven-tura. Questa larga interpretazione dei fatti si sarebbe potuto aspettarse-la dal Manzoni, ed egli l’avrebbe certamente accolta, senza quel rigore morale del quale si era fatto un abito e soprattutto senza la suggestione di una nuova e moderna concezione del diritto. [p. 92]
Sale & Tabacchi [puntata non ristampata nel volume Mondadori del 1989], «Corriere del Ticino», 22 dicem-bre 1973, p. 35.
Ai grandi stitici come Martin Lutero, Oliviero Cromwell e il Cardinale di Richelieu, va aggiunto il Manzoni. Scrive infatti il Cantù nelle sue Reminiscenze, che il Manzoni dopo la colazione fumava «con un pipino di gesso», e che domandatogli come mai si concedesse quel vizio, si sentì rispondere che «ciò gli rendeva obbediente il corpo». Manzoni comunque era fumatore e amante del tabacco, perché fiutava, fumava la pipa turca e quella di gesso, non disdegnando, in vecchiaia, anche le sigarette.
1974Sale & Tabacchi [non ristampato nel volume Mondadori del 1989], «Corriere del Ticino», 27 luglio 1974, p. 27.
347
[...] a chi si è potuto risolvere a ripubblicare quel libro che il tempo aveva pietosamente affondato nell’oblio [Clelia di Garibaldi], capiterà forse di riesumare un altro bel prodotto dell’ingegno: I promessi sposi di Guido da Verona (Società Editrice Unitas – Milano, 1930), degno di ritornare in luce a dimostrazione di quanto fu ignobile, volgare e in-sulsa la letteratura popolare in Italia, nelle mani degli eroi e dei piccoli borghesi [...].Quando nel 1807 il Fauriel si fece mediatore d’un possibile matrimo-nio tra Alessandro Manzoni e mademoiselle de Tracy, figlia di Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, il Manzoni in una lettera all’illustre amico, ricalcando e facendo sua la descrizione della probabile fidan-zata che lo stesso Fauriel gli aveva fatta, traccia questo ritratto della de Tracy che non aveva ancora vista: «... un animo retto, dolce e sensibile, che possiede una virtù che tutte le comprende, la Carità; uno spirito giusto e ornato, delle abitudini semplici, un carattere calmo e costante, nessun gusto per piaceri rumorosi, e al contrario molto gusto per la campagna, per le cure e i piaceri veri della casa, un aspetto interessante, dei gradevoli talenti...».Sull’autografo di questa lettera, scritta dal Manzoni in francese e conser-vata nella Biblioteca dell’Istituto di Francia a Parigi, vi è un’annotazione a matita di mano ignota (ma attribuita alla signora Mohl Clarke) di que-sto preciso tenore: «Fu per farle sposare la signora di Laubespin (nome che la de Tracy assunse quando più tardi sposò un Laubespin) che vidi nel 1827 e nel 1828, molto bella, molto leziosa, assai volgare di spirito, bella donna e donna di mondo quanto si può esserlo: quale contrasto!».Il Manzoni aveva tracciato il ritratto ideale della donna che desiderava, ma col suo identikit era andato a quanto pare assai lontano dal vero. Per fortuna, fallito il matrimonio con la de Tracy, venne la volta di Enrichetta Blondel, più conforme al suo ideale muliebre.
Sotto la Sua mano, Milano, Mondadori, 1974, pp. 39-41, poi in Tre racconti, Milano, Mondadori, 1979, pp. 51-53.
1976Sale & Tabacchi [non ristampato nel volume Mondadori del 1989], «Corriere del Ticino», 14 febbraio 1976, p. 35.
Forse, l’unico inedito di Alessandro Manzoni è in un’epigrafe posta nel cimitero di Travedona (Varese), sulla tomba di un giovane, An-tonio Garavaglia, parente del Manzoni, morto prima dei vent’anni: «5 gennaio 1869 / Qui giace / Tognino Garavaglia / O angelo già su questa terra / il lutto dei tuoi genitori / dei congiunti che t’amarono
348
tutti qual figlio / che non potrà essere compreso da chi non conobbe / quali gioie e quali speranze / i saggi precoci e singolari / del tuo cuore e della tua mente / tennero vive / ahi per quanto breve tempo / negli animi loro (Manzoni)». Rinaldo Corti, uno scrittore travedonese che la ricopiò più di cinquant’anni fa, è del parere che la lapide sia scom-parsa durante un allargamento del cimitero.
Sale & Tabacchi, poi in Sale & Tabacchi. Appunti di va-ria umanità e di fortuite amenità scritti nottetempo da Piero Chiara, Milano, Mondadori, 1989.
Quella «bellezza molle ad un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo», come scrive il Manzoni nel suo romanzo e che forse in parte brilla ancora, brillava certo più ai tempi del Manzoni che all’e-poca in cui si svolge il Promessi Sposi, perché era il residuo dell’occu-pazione spagnola della Lombardia, che nel Seicento non aveva ancora potuto agire sulle discendenze. Attraverso connubi legittimi e illegitti-mi, il sangue spagnolo lasciò in quello lombardo un segno di mollezza e insieme di maestà, che caratterizzò certe figure femminili alla Hayez: volti pallidi, incorniciati da capelli neri e lisci, dallo sguardo vellutato e caldo. Un tipo di bellezza totalmente nuovo in Lombardia, diverso dall’antico, consacrato dal Luini nelle sue figure femminili, anch’esse in atteggiamento di calma e quasi di abbandono, ma dai volti rosei, dai capelli biondi, dalle ciglia chiare, ferme sopra i limpidi occhi a moderare un dolce sorriso. Forse segni, nel sangue, di residuati celtici o longobardi, sui quali andò a sovrapporsi l’eredità moresca degli oc-cupatori iberici. [pp. 123-124]
Il Manzoni è tutt’ora per me un continuo oggetto di studio e di rifles-sione. [p. 129]
Non c’è storico della vita del Manzoni che non gli attribuisca come padre naturale il superluetico Giovanni Verri. Eppure, un pomerig-gio d’estate del 1944, seduto a un tavolo sotto le piante davanti a un “grotto” di Mendrisio, lo storico ticinese Eligio Pometta sosteneva, parlando con Pio Ortelli e con me, che il Manzoni era figlio di un cuoco di Locarno, del quale citava il nome. Un bellissimo e aitante cuoco che lavorava in casa Manzoni a Milano e che era conteso a suon di scudi dalle amiche di Giulietta, non tanto come cuoco, ma come prestatore di più riservati servizi. Proprio nove mesi prima della nasci-ta di Alessandro, sosteneva il Pometta, il cuoco era attivo in casa Man-zoni. Tutto può darsi, ed anche che Alessandro fosse figlio di Pietro Manzoni, suo padre legale. Non sarebbe il primo caso. [pp. 131-132]
349
La stanza del Vescovo, Milano, Mondadori, 1976, poi in Tutti i romanzi, cit., p. 800.
«Impiccagione alla Condé» spiegò il medico venuto in serata col Pro-curatore della Repubblica per le constatazioni di legge. «Rara, ma non eccezionale. Il principe di Condé, non quello del Manzoni che dor-miva la notte prima della battaglia di Rocroy, ma l’ultimo dei Condé, Luigi, si impiccò alla maniglia di una finestra e diede il suo nome a questa tecnica».
Incontro con Piero Chiara, intervista a cura di Franco Pool, trasmessa dalla Radio Svizzera di lingua italiana nel 1976, poi nei «Quaderni grigionitaliani», XCV, 1976, 4, pp. 291-294, e ancora in I candidi amici, cit., pp. 217-222.
Lo sfondo [dei miei romanzi] è realistico così come nei Promessi sposi è vero e autentico il paesaggio del Lago di Como, del Lecchese. Così per me è Luino. La verità dei fatti è una verità probabile, possibile, verosimile.
1977Sale & Tabacchi [non ristampato nel volume Mondadori del 1989], «Corriere del Ticino», 30 luglio 1977, p. 23.
Carlo Dossi, che è spesso citato come un fenomeno delle lettere, alme-no in Lombardia, è interessante soprattutto come pettegolo. Si deve a lui infatti se veniamo a sapere che negli altissimi colloqui di Stresa tra il Rosmini e il Manzoni, il filosofo, che credeva ciecamente nella mi-racolosità di una certa “acqua della Madonna”, si era fatto promettere dal Manzoni di spruzzarlo con quell’acqua dopo morto. Dal canto suo il Dossi si sentiva almeno terzo in Italia, come scrittore, dopo il Manzoni e il Rovani. «Questi – scriveva nel 1870 – in Italia son tem-pi di somma ignoranza, in cui si disconosce Rossini, disconoscendo naturalmente anche Manzoni e Rovani. Prevedo tra un mezzo secolo la necessità che sorga, per questi tre nostri grandi contemporanei, uno scopritore e un rivendicatore, come più volte abbisognarono a Dan-te». Il Rovani peraltro aspetta ancora.
Sale & Tabacchi [non ristampato nel volume Mondado-ri del 1989], «Corriere del Ticino», 12 novembre 1977, p. 31.
350
Esempio sommo di queste autobiografie indirette e simulate è il Pro-messi Sposi di Alessandro Manzoni, nel quale è possibile trovare tutti i problemi morali, estetici, teologici o storici che furono dell’autore, insieme alle sue manie, ai suoi vizi segreti, se pure ne ebbe, alla storia medesima della sua formazione intellettuale e spirituale.
Sale & Tabacchi, «Corriere del Ticino», 8 ottobre 1977, p. 25, poi in Sale & Tabacchi, cit., pp. 131-132.
«Secondo il Manzoni» conclude Venosta «l’unità d’Italia era inevitabi-le come il freddo d’inverno e il caldo d’estate». [...] Fra i pettegolezzi che corsero sul Manzoni e che il figliastro Stampa confutò con poca efficacia, ce n’è uno al quale vien voglia di credere, tanto va di misura al grande scrittore, che era, come si sa, alquanto nevrotico e un po’ fissato. Pare che la di lui madre, Giulietta Beccaria, gli passasse due lire al giorno per i minuti piaceri, come a un ragazzo, anche quando era già maggiorenne, e che il Manzoni tenesse da conto quelle monete, portandosene fino a dieci e più indosso, nei taschini del panciotto, ma avendo cura di metterne metà a destra e metà a sinistra, per mantene-re, diceva agli amici, l’equilibrio della persona.
Don Abbondio al confino, «Corriere della Sera», 9 febbraio 1977, poi in Un bel viaggio, cit., pp. 141-146.
Impegno europeo di Giancarlo Vigorelli, «Corriere del Tici-no», 12 novembre 1977, p. 29 [recensione di Manzoni pro e contro (1975) e Diario europeo (1977)].
1978 Sale & Tabacchi, cit., p. 176.
Ogni epoca rilegge a modo suo il passato, cioè la storia e anche le opere letterarie delle età precedenti. Ci sono, generazione per generazione, modi diversi per leggere i grandi libri del passato, dall’Odissea alla Bib-bia al Vangelo a Platone a Vico e perfino a Casanova. In poco più di un secolo, quante letture non ha sopportato lo stesso Manzoni.
Il cappotto di astrakan, Milano, Mondadori, 1978, poi in Tutti i romanzi, cit., p. 830.
Mi aveva certamente notato più volte lungo la sua strada senza darne segno, e vedendomi di fronte con quella domanda in bocca, degna di
351
un Renzo Tramaglino che arriva a Milano dalla campagna, mi doveva aver classificato tra i gonzi.
Vita di Gabriele D’Annunzio, Milano, Mondadori, 1978 [nell’edizione 2013 la cit. è a p. 264]
Trincerato nel suo appartamento di rue Kléber, dopo la breve uscita per l’incontro di pugilato, era intento a curarsi l’entorse, che non era al ginocchio, come si apprende da una lettera all’ottantottenne Treves nella quale gli dice d’essere ammalato «d’un male giovanilissimo», forse la malattia venerea che il giovane Manzoni aveva adombrato poeti-camente sotto l’immagine d’una «ciprigna febbre» e che D’Annunzio non precisò mai.
1981La notte che cambiò il mondo, «Corriere della Sera», 24 di-cembre 1981, poi in I popoli chi nato sia non sanno, Ro-ma-Napoli, Benincasa, 1981 [cita Il Natale degli Inni sacri di Manzoni: «I popoli chi nato sia non sanno / ma il dì verrà che l’umile retaggio suo saranno»]
Vedrò Singapore?, Milano, Mondadori, 1981 [le indicazioni di pagina si riferiscono all’edizione di Tutti i romanzi].
Qualcuno gli aveva detto che per imparare a scriver bene bastava legge-re il Manzoni e mandarselo in testa. Infatti il Coniglio si portava sem-pre sotto il braccio una copia dei Promessi Sposi che andava leggendo e rileggendo con grande ostinazione.«Senti, senti» mi diceva «come gliele canta il padre Cristoforo a Don Rodrigo!» E mi recitava tutto il colloquio dei due personaggi ad alta voce, mettendosi ora nella parte del frate e ora in quella del signorotto spagnolo invaghito di Lucia.Un altro dei suoi pezzi preferiti era la serata di Renzo all’Osteria della Luna Piena e l’arresto mentre era ancora a letto la mattina successiva.«Renzo Tramaglino!» gridava. «Animo dunque. Levatevi e venite con noi... il perché lo sentirete dal signor capitano di giustizia». [p. 1195]
Come il principe di Condé la notte avanti la battaglia di Rocroi, e certi condannati a morte la notte prima dell’esecuzione, quella sera mi ad-dormentai profondamente nella mia stanzetta ben riscaldata. [p. 1225]
Un uomo incappottato e col cappello in testa venne fin davanti al mio letto.
352
«Siete voi» disse «Lorenzo Tramaglino?»«Sono io» risposi balzando a sedere.L’uomo si tolse il cappello e scoppiò in un grande risata.«Coniglio!» esclamai.Il maresciallo Coniglio si accomodò sulla sedia dov’era appesa la mia giacca.«Ti ricordi» disse «a Sant’Osvaldo, quando ti leggevo I Promessi Sposi?». [p. 1237]
1982Sale & Tabacchi [non ristampato nel volume Mondadori del 1989], «Corriere del Ticino», 13 marzo 1982, p. 35.
Nel Fermo e Lucia il Manzoni, al capitolo secondo, fa capire chiara-mente che Don Rodrigo, nonostante il nome spagnolo, è lombardo, milanese o forse brianzolo, benché infarcisca i suoi discorsi di parole e di “cerimoniacce spagnole”.Quando va dal conte del Sagrato a chiedergli appoggio per venire a capo del suo progetto amoroso e si scusa di dargli infado, cioè fastidio, si sente rispondere: «Intendiamoci fra noi da buoni patriotti, senza spa-gnolerie». Ma nella redazione definitiva del suo romanzo il Manzoni sopprime questi passaggi, rendendosi conto che l’Innominato non po-teva nutrire sentimenti patriottici. La battuta «patriottica e antispagno-la», come dice anche il Russo (Personaggi dei Promessi Sposi, Laterza, 1981), era evidentemente stonata. I due erano dunque lombardi, e mal si appone chi, come me, si ostina a credere spagnolo Don Rodrigo, il quale essendo creatura immaginaria, potrebbe tuttavia venir supposto tale, non solo per il nome, ma anche per gli atteggiamenti che sono quanto mai da hidalgo. Don Rodrigo aveva infatti un conte zio a Mi-lano, ben introdotto nell’apparato di potere spagnolo e in grado di ottenere il trasferimento d’ufficio di un Fra Cristoforo.Sulla nazionalità di Don Rodrigo ho avuto modo di discutere con un amabile contraddittore, che mi contestava, e a ragione, l’arbitrio di rite-nere spagnolo un personaggio dal Manzoni pensato, almeno in un pri-mo tempo, come un lombardo spagnoleggiante per piaggeria e per darsi arie da dominatore. Ho dovuto dargli ragione, stando alle carte scritte, ma non del tutto convinto, vorrei sostenere che se il Manzoni ci avesse meglio “pensato su”, l’avrebbe fatto spagnolo, il suo Don Rodrigo: un castigliano o un mancego lombardizzato, pieno d’albagia iberica, con una certa parte di sangue arabo e un concetto alquanto mussulmano della sua giurisdizione amorosa. Con una simile caricatura del signo-rotto spagnolo, poteva dare sfogo al suo antispagnolismo facendo fare al personaggio una cattiva figura dopo l’altra, fino a portarlo, da ultimo,
353
al Lazzaretto, per farlo morire come un reprobo. Ne sarebbe uscito una specie di Don Giovanni. Ma Don Rodrigo è destinato a rimanere un personaggio imperfetto. Infatti, un tipo di tal genere non poteva essere senza donne, come appare nel Promessi Sposi e nelle prime redazioni, dove lo vediamo, dopo lo scorno del mancato rapimento, andare a Lec-co in una casa di tolleranza. Diamine! Don Rodrigo doveva aver buona compagnia al castello. Invece Fra Cristoforo lo trova a banchetto con soli uomini, quasi fosse un misogino. Non ha donne in casa, o solo qualche vecchia serva, come l’Innominato, anche lui misogino a quanto pare e neppur tentato dalla giovane e bella Lucia, che pure ha nelle mani. Strani personaggi e strani comportamenti, nei quali è forse da leggere in chiave freudiana il non detto, ciò che è taciuto e lasciato intendere più di quan-to è spiegato e precisato con apparente scrupolo e nascosta reticenza.
1983Sale & Tabacchi [non ristampato nel volume Mondadori], «Corriere del Ticino», 28 maggio 1983, p. 35.
Nelle sue Postille al Vocabolario della Crusca (Edizioni Riccardo Ric-ciardi, Milano-Napoli-MCMLXIV) il Manzoni nota, al vocabolo ab-bassato, che «Si usa dire, il tale è accacchiato, per intendere ch’egli sia abbassato e rifinito, o nella sanità, o nella roba». Che si usi accacchiato in tal senso, ne fa fede anche il Tommaseo nel suo dizionario, ma è un bene che il Manzoni non abbia fatto tesoro di quel modo nel suo ro-manzo, altrimenti Padre Cristoforo, mostrando a Renzo nel lazzaretto Don Rodrigo morente, invece di dire: «Da quattro giorni è qui come tu lo vedi, senza dar segno di sentimento», avrebbe detto: «Da quattro giorni è qui, accacchiato come tu lo vedi», ecc. ecc.Dove per abortare, e abortire, la Crusca cita «Non abortare, o disper-dersi, come dite voialtri, ma sconciarsi», il Manzoni annota, ammirato: «Bella citazione!» E si può star certi che gli era piaciuto il termine per quel che conteneva di spregio, di riprensione e per l’assonanza con sconcezza.Al vocabolo bordello il Manzoni è del parere che la locuzione “andare a Bordello” per andare a male sarebbe meglio ometterla nei dizionari «per amore della decenza».Alla voce Cresci, nota che «è un gergo disonesto». E cita la Novella 7. della Giornata 2. del Decameron. «Ma Marato col santo Cresci in mano, che Iddio ci dié, la cominciò per si fatta maniera a consolare, che...» ecc. Aggiunge infine, come suo giudizio: «Modi che, per dirla alla Milanese, è meglio perderli che trovarli». Ma intanto li aveva tro-vati e certamente con qualche gusto.La voce doppione, accrescitivo di doppia, sembrerebbe innocentissima,
354
ma purtroppo può venir usata «in sentimento turpe». E allora ecco il Manzoni avvertire che «le voci che indicano cose vergognose (non tur-pi) non sono da omettersi perché necessarie, ma quando indichino que-ste cose in modo scherzoso e disonesto devono intralasciarsi affatto».
Tra le piccole miserie che Natalia Ginzburg è andata spilluzzicando per mettere insieme il suo grosso libro sulla famiglia di Alessandro Manzo-ni vi è anche un accenno ai fratelli Verri e in particolare a quel Giovan-ni Verri, ultimogenito della famiglia, al quale si fa risalire normalmente la paternità di Alessandro Manzoni, in quanto avrebbe iniziato alla vita amorosa Giulia Beccaria prima che costei diventasse moglie del conte Pietro Manzoni, padre legale di Alessandro. È noto che il Giovanni, benché disamorato della Giulia, la frequentasse ancora saltuariamente dopo sposata. Prima della Ginzburg, un’altra scrittrice, Donata Chio-menti Vassalli, aveva indagato dentro una vita familiare, quella dei fra-telli Verri, dando alle stampe un libro che aveva appunto per titolo I fratelli Verri che, stando all’attentissimo Giampaolo Dossena, «sembra scritto da una signora inglese sulle vicende di una famiglia del Sette-cento inglese». Il libro della Ginzburg è invece evidentemente scritto da un’italiana appassionata di storie casalinghe e di intimità familiari. Il Giovanni Verri, stando al bel libro della Chiomenti Vassalli, quando ancora frequentava Giulia Beccaria, era diventato l’amante della moglie di un albergatore di Asso, vicino a Como: un trattore, più che un al-bergatore. La donna, Bambina Curioni per la storia, finì col dominare completamente il povero Verri, malato e indebitato, che nonostante i suoi guai, nel febbraio 1793 volle dare un gran ballo alla buona società di Como con l’intento di presentare in pubblico la propria amante. Non trovando dame disposte ad accogliere il suo invito, vi supplì con «altrettante figlie di Eva democratiche all’ultimo confine».
Sale & Tabacchi [non ristampato nel volume Mondadori], «Corriere del Ticino», 11 giugno 1983, p. 31.
Il Baffo, l’esecrato Baffo, il più lubrico poeta d’ogni tempo ma grande nel suo genere, l’amico del Casanova, è tornato in gloria nella sua Ve-nezia, dove si è formato una società di Amici del Baffo che ha ottenuto per prima cosa l’apposizione di una lapide a ricordo «del gran poeta del c... e della mona» sulla facciata del palazzo sansoviniano di Campo San Maurizio nel quale il poeta visse e morì. Su quella facciata, a un lato del balcone, una lapide ricorda il soggiorno veneziano di Alessandro Man-zoni. La lapide del Baffo è all’altro lato del balcone, a sufficiente altez-za per sottrarsi alle scritte della canaglia. Nel palazzo, che ora è sede di associazioni cattoliche, si aggiravano da tempo, nelle ore notturne, le ombre dei due poeti, cercando di evitarsi. Il Manzoni, accigliato e
355
scontroso, trovava imbarazzante la presenza del priapesco Baffo mentre al vecchio patrizio, benché padrone di casa, non dava alcun fastidio il Manzoni, che al tempo in cui viveva in quelle stanze era giovane e scostumato come lui avrebbe voluto essere e non fu mai, nonostante la sua musa lubrica [...]. «Dietro il volto – scrisse un autore francese – c’è sempre la maschera», o viceversa.
Sale & Tabacchi, cit., p. 276.
Mi pareva che il vero Natale fosse solo quello di Gesù, in fondo a una grotta, d’inverno, nel caldo delle braccia materne, avvolto nel fiato dell’asino e del bue, con San Giuseppe di guardia sull’entrata, in attesa dei pastori, che svegliati da un angelo e vedendo la stella scesa sopra la grotta, correvano a vedere. Trovarono solo un bambino appena nato.«Tutto qui?» si chiedevano. Ma intanto il cielo si riempiva di angeli «per l’ampia – notte calati a stuolo», come dice il Manzoni, che canta-vano «come si canta in cielo».Quello sì che era un Natale, il solo che poteva contare e al quale mi rimettevo anch’io, povero bambino nato a mezzogiorno, di Pasqua, proprio quando Gesù, giustamente scontento di noi, ritornava a casa sua, in Cielo.
Aprile, in Il gran pescatore di Chiaravalle. Almanacco popo-lare 1984, Torino, Arneodo, 1983 (poi in Il verde della tua veste e altri racconti, a cura di F. Roncoroni, Milano, SE, 2008, pp. 88-98).
«Or s’udrà» scrive il Manzoni nella sua canzone Aprile 1814 «ciò che sotto il giogo antico / sommesso appena esser potea discorso / al cau-to orecchio di privato amico». Poteva finalmente, lo scrittore, partiti i francesi, gridare forte contro il dispotismo napoleonico. Ma il 28 aprile di quell’anno, al posto dei francesi arrivarono in Lombardia gli austriaci, altrettanto dispotici, e il Manzoni dovette discorrere ad orecchi ancor più cauti.
Dicembre, in Il gran pescatore di Chiaravalle, cit., p. 219 (poi in Il verde della tua veste, cit., pp. 97-98).
La data del 25 dicembre per la nascita di Gesù, fu stabilita approssi-mativamente verso il IV secolo, partendo dalla data di morte. Prima si era ritenuto che fosse nato il 28 marzo, il 18 aprile, il 29 maggio, a Betlemme secondo Matteo e Luca, a Nazareth secondo Marco e Gio-
356
vanni. Comunque sia stato, «Ecco ci è nato un pargolo / ci fu largito un figlio» ci dice il Manzoni. «I popoli chi nato sia non sanno / ma il dì verrà che l’umile retaggio suo saranno».
1984Davide Lajolo, Parole con Piero Chiara. Conversazione in una stanza chiusa, Milano, Frassinelli, 1984, pp. 42-43.
Hai ragione di osservare che cito spesso come maestro, accanto al Boccaccio, il Manzoni. Non solo perché è lombardo come me. So-prattutto perché è un uomo combattuto, un cuore tenebroso, un impasto di speranza palese e di disperazione segreta che offre uno spettacolo singolare e ammonitore. Inoltre è ironico, amaro e spesso scettico come il Boccaccio. Su di lui, o meglio con lui nello sfondo, vorrei scrivere un romanzo. La storia di un tale che studia il Manzoni e la sua opera fino a scoprire, sotto il romanzo troppo conosciuto, un romanzo nascosto. D’improvviso la storia di quel tale comincia a correre sui binari di quella del Manzoni, perché la vita si ripete. Se il resto non te lo dico non è perché voglio mantenere il segreto sul mio lavoro, ma solo perché non so ancora come la storia finirà.
Sale & Tabacchi [non ristampato nel volume Monda-dori], «Corriere del Ticino», 10 dicembre 1984, p. 35 [recensione di Aldo Buzzi, Andata e ritorno, Milano, Scheiwiller, 1984].
Ma il libro di Buzzi parla anche di Kafka, di Lucio Mastronardi e di una splendida lattaia di Crescenzago, dalle carni di latte e burro, che fa pensare come poteva essere Lucia se il Manzoni avesse avuto il corag-gio di descrivercela un po’ meglio, anche violando la regola del Buzzi, secondo la quale nei romanzi bisogna evitare «la meticolosa enumera-zione dei caratteri fisici».
Un patrimonio indistruttibile, già Care dolci acque non vi riconosco più: qui è finito il sogno della mia infanzia, «Gen-te», 21 dicembre 1984, poi in Se non qui, dove?, a cura di F. Roncoroni, Varese, Nicolini, 1997.
Quando il Manzoni stava a Lesa nella villa della sua seconda moglie Teresa Borri vedova Stampa, la strada del Sempione che passava tra il lago e la casa era una modesta carrozzabile, tenuta a rispettosa distanza
357
da un giardino. La strada automobilistica ha divorato il giardino e la Cassa di Risparmio ha occupato i locali della villa, come era inevitabile. A quei tempi il Manzoni si preoccupava per la ferrovia, che sarebbe passata sul fianco della collina a solo qualche decina di metri sopra la sua testa. Oggi, poco più avanti e proprio sopra Stresa si progetta di far uscire un tratto dell’autostrada Voltri-Sempione!
1985Divagazioni manzoniane [conferenza letta a Lesa nel 1985], poi in Colloqui a Lesa sul Manzoni, a cura di Andrea Gonzi, Intra, Alberti, 1988, pp. 56-63.
Sono un cultore, uno studioso segreto del Manzoni. Non ho pubblicato più di un centinaio di righe su di lui, ma tutta la mia attenzione alla let-teratura è piena del Manzoni. Persino la mia attività di narratore, secon-do alcuni critici, cominciando da Vigorelli, è stata vista come influenza-ta dal Boccaccio e dal Manzoni. Questo binomio Boccaccio-Manzoni, assai intrigante, meriterebbe di essere studiato a fondo.Ho avuto tra le mani le note marginali del Manzoni al Vocabolario della Crusca curate da Dante Isella e mi sono accorto che, nelle ag-giunte che il Manzoni fa a margine, ci sono frasi tolte dal Decameron che non esistono nel Vocabolario della Crusca. [...] Non poteva, un uomo del suo gusto e della sua intelligenza, non sentire la forza di que-sto esemplare narrativo, fondamentale per la lingua italiana. Di questa fratellanza del Manzoni col Boccaccio mi sono molto interessato, non tanto per cercare delle prove documentali quanto per rintracciare nello spirito manzoniano qualcosa di quella gioia di vivere che c’è nel Boc-caccio e che manca nel Manzoni, non perché egli non l’avesse capita, ma perché non rientrava nel suo piano morale il mondo boccaccesco. Nella sua mente entrava invece la tecnica narrativa del Boccaccio.Leggo spesso il Fermo e Lucia, la prima stesura dei Promessi Sposi, e mi accorgo e mi convinco sempre più che il Manzoni è un filosofo [...], la personalità del Manzoni è pressoché insondabile, ma la personalità del narratore è perfettamente identificabile, perfettamente riconoscibi-le fin dal Fermo e Lucia. Basterebbe pensare al viaggio, già nel Fermo e Lucia, di frate Cristoforo dalla casa di Lucia al castello di Don Rodrigo, al suo avvicinamento a questa dimora, ai due avvoltoi inchiodati sulla porta, ai passi che fa per raggiungere la sala del banchetto, il rumore delle posate, dei bicchieri, dei piatti. Il distendersi di questo episodio è degno, degnissimo del Boccaccio, al quale Manzoni rende omaggio con la descrizione aggiornata di una grande calamità, la pestilenza, omaggio alla grande descrizione della peste fiorentina del Boccaccio.
358
Questo legame del Manzoni con il Boccaccio rende il Manzoni ancora più complesso, ancora più interessante; tanto più che io sono origi-nario di questa terra dove lui ha vissuto, perché mia madre è nata a Comnago, dove il Manzoni chissà quante volte è andato passeggian-do velocemente con il figliastro Stefano, indossando pantaloni leggeri. Quando tornava metteva quelli più pesanti perché era un po’ più suda-to. Stefano gli diceva, vedendolo litigare con i sei bottoni delle bretelle: «Ma io ho tante bretelle, papà, ve ne regalo tre o quattro paia, quanti calzoni avete tante bretelle vi regalo, di modo che poi non avete da tribolare». Il Manzoni si seccava moltissimo di queste osservazioni che gli sembravano irriverenti...
1986Tutto si accomoda, volendo, in Il capostazione di Casalino e altri 15 racconti, Milano, Mondadori, 1986; poi in Raccon-ti, cit., p. 1291.
Dal finestrino del treno vedevo scorrere l’Adda, il grande fiume di Lombardia confratello del Ticino, avventurato anche lui a traversare un lago e a uscirne, a Lecco, con tutte le conseguenze letterarie che il Manzoni ne doveva trarre, sia nel lecchese che più a valle, verso Trezzo, quando l’Adda luccica sotto la luna e Renzo la guarda dall’alto di una ripa, riservandosi di passarla al mattino, traghettato dal cauto barcaiolo o passatore che lo deporrà, salvato dalla forca, in terra di san Marco.
Gli Arnaboldi alla porta, in Il capostazione di Casalino e altri 15 racconti, cit.; poi in Racconti, cit., p. 1355.
L’architetto Arnaboldi cambiò faccia, come il padre Cristoforo quando don Rodrigo gli dice che se gli preme tanto Lucia non ha che metter-la sotto la sua protezione, mandargliela in casa. Da una certa aria di superiorità iniziale era passato prima al tono implorante e da ultimo all’atteggiamento severo dell’accusatore, del creditore.
1988I pantaloni del Manzoni, in Gli anni e i giorni, Pordenone, Studio Tesi, 1988, pp. 171-174.
Molti biografi del Manzoni, fra i quali alcune donne inclini al pette-golezzo più che alla storia, hanno scritto sulle manie, le fissazioni e le stranezze del grande scrittore. Non si nega che a un vero e proprio saggio psicologico Manzoni potrebbe dar materia, e che allora acqui-
359
sterebbero importanza anche i tic, le ossessioni e le fissazioni. Ma anche il rapporto del Manzoni col proprio abbigliamento è degno di studio: «Dimmi come vesti e ti dirò chi sei».
1989Il Sancarlone, in Tre racconti, presentazione di Giovanni Tesio, Mondovì, Boetti & C., 1989, pp. 13-19, poi in Il rispetto della legge e altri racconti, a cura di F. Roncoroni, Milano, SE, 2007, pp. 25-30.
Un suo fascino, insomma, san Carlo ce l’ha, e io, nonostante tutto, non sono mai riuscito a liberarmene. Spesso, leggendo i Promessi sposi e incontrandovi il suo cugino Federigo, mi è capitato di chiedermi perché il Manzoni non abbia portato più indietro nel tempo la storia di Renzo e Lucia, in modo da poter parlare di Carlo e non di Federigo, che ne ripete molto debolmente i tratti e il carattere. San Carlo, nelle mani del Manzoni e non in quelle del Bascapè, avrebbe preso ben altro volo. Lo vedo al cospetto dell’Innominato e della monaca di Monza. Federigo incassa, abbozza, anche quando fa la predica a don Abbon-dio: «Avrò torto io,» dice il povero curato «ma il coraggio, uno non se lo può dare». Fa poi notare a Federigo che quelle facce, quei ceffi dei bravi, li ha visti lui. Come dire che era facile rimproverare senza aver provato quello spavento, senza aver sentito quelle minacce. Il cardinale tenta di travolgere con le sue parolone le difese del curato, ma non può non sentirne il peso. Tanto è vero che non prende alcun provvedimento contro di lui e si contenta di una sua reticente ammissione di colpa. San Carlo l’avrebbe, a dir poco, sospeso a divinis.
II. Volumi e articoli manzoniani letti, citati o recensiti da Piero Chiara
Théophile Gautier, Voyage en Italie, Paris, G. Charpentier, 1876.
Cesare Cantù, Alessandro Manzoni. Reminiscenze, Milano, Tre-ves, 1882.
Un curioso processo (Per le fonti dei Promessi Sposi), «Corriere del Ticino», 25 settembre 1905, p. 2 [poi in «Bollettino Storico della Svizzera Italiana», 10-12, 1905, pp. 134-136].
360
Guido da Verona, I promessi sposi, Milano, Società Editrice Unitas, 1930.
Alessandro Manzoni, I promessi sposi, con prefazione e com-mento di Francesco Chiesa, disegni di Aldo Crivelli, Locarno, Carminati, 1944.
Mina Gregori, I ricordi figurativi di Alessandro Manzoni, «Para-gone», I, 1950, 9, pp. 7-20.
Remo Fasani, Saggio sui Promessi Sposi, Firenze, Le Monnier, 1952.
Alessandro Manzoni, Opere, a cura di Riccardo Bacchelli, Mi-lano-Napoli, Ricciardi, 1953.
Cesare Cases, “I promessi sposi” e la critica progressista, «Notizia-rio Einaudi», V, marzo 1956, 3, pp. 5-6.
Alberto Moravia, Alessandro Manzoni o l’ipotesi di un realismo cattolico, introduzione a A. Manzoni, I promessi sposi, con di-ciassette disegni di Renato Guttuso, Torino, Einaudi, 1960.
Giovanni Getto, Echi di un romanzo barocco nei “Promessi Spo-si”, «Lettere italiane», 2, 1960, pp. 141-167.
Giorgio Pecorini, Questo perdono non s’ha da dare. Abbiamo fotografato i pochi luoghi superstiti che videro la tragedia della Mo-naca di Monza, «L’Europeo», 1 ottobre 1961, pp. 40-45.
Donata Chiomenti Vassalli, I fratelli Verri, Milano, Ceschi-na, 1960.
Carlo Emilio Gadda, Manzoni diviso in tre dal bisturi di Mo-ravia, «Il Giorno», 26 luglio 1960.
Mario Mazzucchelli, La monaca di Monza. Suor Virginia Ma-ria de Leyva, Milano, Dall’Oglio, 1961.
Umberto Eco, Diario minimo, Milano, Mondadori, 1963.
361
Alessandro Manzoni, Postille al vocabolario della Crusca nell’e-dizione veronese, a cura di Dante Isella, Milano-Napoli, Ricciar-di, 1964.
Giancarlo Vigorelli, Manzoni pro e contro, Milano, Istituto di Propaganda Libraria, 1975.
Luigi Russo, Personaggi dei Promessi Sposi, Roma-Bari, Laterza, 1981 [19651].
Natalia Ginzburg, La famiglia Manzoni, Torino, Einaudi, 1983.
Pietro Prini, Terra di Belgirate. Quasi una storia, Intra, Alberti, 1984.
III. Volumi manzoniani conservati nella biblioteca di Piero Chiara a Varese
Italo De Feo, Manzoni, l’uomo e l’opera, Milano, Mondadori, 1971.
Cinque lettere inedite di Alessandro Manzoni, Casciago, [s.n.], 1973.
Alessandro Manzoni, La monaca di Monza, Reggio Emilia, Città armoniosa, 1982.
Natalia Ginzburg, La famiglia Manzoni, Torino, Einaudi, 1983.
Maurizio Corgnati, Alessandro Manzoni «fattore di Brusuglio», prefazione di Giancarlo Vigorelli, Milano, Mursia, 1984.
Ferruccio Ulivi, Manzoni, Milano, Rusconi, 1984.
Guido Bezzola, Giulia Manzoni Beccaria, Milano, Rusconi, 1985.
Giancarlo Vigorelli, Manzoni pro e contro, Milano, Istituto di Propaganda Libraria, 1975-1976, 3 voll. Con dedica autogra-fa dell’autore.
362
IV. Articoli e studi critici su Chiara e Manzoni
D.A., La dimensione umana di Alessandro Manzoni vivisezionata nel discorso di Piero Chiara, «Giornale del Popolo», 28 novembre 1973, p. 4.
Giancarlo Vigorelli, Piero Chiara, in Nel sangue lombardo, Samedan, Munt Press, 1975, pp. 120-127.
Enrico Ghidetti, Invito alla lettura di Piero Chiara, Milano, Mursia, 1977, pp. 8, 24, 62, 85-86.
Gli scrittori d’oggi e il Manzoni, a cura di Claudio Toscani, Mila-no, Marzorati, 1977, p. 31.
Giovanni Tesio, Piero Chiara, Firenze, La Nuova Italia, 1983, pp. 4, 111, 120.
Aldo Vallone, Il romanzo impiegatizio e Piero Chiara, «Nuova Antologia», CXX, gennaio-marzo 1985, 2153, pp. 342-356.
Il meglio dei racconti di Piero Chiara, a cura di Federico Ronco-roni, Milano, Mondadori, 1989, pp. 9-10.
Ferruccio Parazzoli, Introduzione a P. Chiara, I promessi spo-si, Milano, Mondadori, 1996, pp. VII-XV.
Giancarlo Sala, Piero Chiara e la sua sentenziosa affabulazione allegorico-picaresca. Intendimenti artistici, didascalici e iniziatici, Poschiavo, Tipografia Menghini, 1996, p. 30.
Pasquale Marzano, Il male che coglie Napoli e altre note di ono-mastica letteraria, Pisa, ETS, 2003, pp. 68-69 e altre.
Mauro Novelli, Introduzione a P. Chiara, Tutti i romanzi, Mi-lano, Mondadori, 2006, pp. LXXV e XC.
Silvia Borghesi, Il Manzoni illustrato, Milano, Biblioteca di via Senato, 2006, p. 44.
363
Fabio Del Busco, La storia e la favola. Il modello manzoniano nel romanzo storico contemporaneo, Ravenna, Longo, 2007, p. 26.
Stefano Giannini, La Musa sotto i portici. Caffé e provincia nel-la narrativa di Piero Chiara e Lucio Mastronardi, Firenze, Poli-stampa, 2008, pp. 85-86.
Luciano Parisi, Alessandro Manzoni’s “I promessi sposi”: a chaste novel and an erotic palimpsest, «Modern Language Review», 103, 2008, pp. 424-440.
Luciano Parisi, Come abbiamo letto Manzoni. Interpreti nove-centeschi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, p. 139.
Giovanni Tesio, “I Promessi Sposi” tra parodia e rimaneggiamen-to. I casi di Guido da Verona e di Piero Chiara, in L’antimanzoni-smo, a cura di Gianni Oliva, Milano, Bruno Mondadori, 2009, pp. 349-360.
Mauro Novelli, La valigia d’Oriente, introduzione a P. Chia-ra, Vedrò Singapore?, Milano, Mondadori, 2013, pp. V-XVI.
Matteo Milani, Manzoni, Bassani, Chiara: variazioni onoma-stiche sui “Promessi sposi”, in Nomina. Studi di onomastica in onore di Maria Giovanna Arcamone, a cura di Donatella Bremer, Davi-de De Camilli e Bruno Porcelli, Pisa, ETS, 2013, pp. 423-443.
Matteo Milani, Inserzioni dialettali nei Promessi Sposi di Piero Chiara, in Dal manoscritto al web: canali e modalità di trasmissio-ne dell’italiano, Atti del XII Congresso della Società Internazio-nale di Linguistica e Filologia Italiana (Helsinki, 18-20 giugno 2012), a cura di Enrico Garavelli ed Elina Suomela-Härmä, Fi-renze, Franco Cesati, 2014, pp. 249-256.
Matteo Milani, Luoghi manzoniani in Bassani e Chiara, tra realtà e finzione, «Il Nome nel testo», XV, 2013 [in corso di stampa].