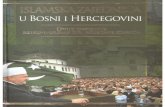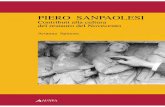RAPPORTI FORZE ARMATE SOCIETÀ IN ITALIA: Cosa è cambiato con la fine della guerra fredda? In...
-
Upload
davidpublishing -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of RAPPORTI FORZE ARMATE SOCIETÀ IN ITALIA: Cosa è cambiato con la fine della guerra fredda? In...
H. HEYRIÈS322
réhabilitation nationale, au nom d�une réconciliation mémorielle et d�une solida-rité interclassiste, retrouvant ainsi l�exaltation unitaire néo-risorgimentale que les acteurs politiques mirent en avant au lendemain de la Grande Guerre. Ce n�est pas un hasard si le 4 novembre 2008, lors du 90e anniversaire de la victoire de 1918, le président de la République Giorgio Napolitano rendit un hommage appuyé au Soldat inconnu: �La Grande Guerra, déclara-t-il, contribuì a dare il senso della Unità Nazionale�. Son discours insista sur la première grande expérience collec-tive de la Nation, sur l�identi! cation de la Nation et du peuple et sur le fait que le �ventennio� fasciste n�avait pas détruit les valeurs de l�unité nationale45. Plus que jamais, le Soldat Inconnu restait le mythe fondateur d�une Italie devenue Répu-blique une et indivisible dans sa dimension spatiale et diachronique.
45 �Il Messaggero�, 5 novembre 2008, p. 9.
RAPPORTI FORZE ARMATE SOCIETÀ IN ITALIA
Cosa è cambiato con la ! ne della guerra fredda?
Giuseppe Caforio
Introduzione
La ! ne della Guerra fredda ha portato in Occidente prima e poi in tutti i paesi industrializzati la speranza che si aprisse ! nalmente un periodo di pace e di esau-rimento dei con" itti. Tale speranza si è manifestata sia attraverso studi teorici che attraverso decisioni politiche. Tra i primi basta ricordare la tesi di Fukuyama1 sulla �! ne della Storia�, che ha avuto larga risonanza nel mondo, e più ancora quella del �dividend of peace�2 che ha poi portato alle decisioni politiche di numerosi governi di ridurre sia le spese militari sia l�entità delle proprie forze armate (vedi Fig. 1).
Fig. 1. Spese militari mondiali 1988-2010
1 Francis Fukuyama, The End Of History?, in �The National Interest�, a. 1989, pp. 3-18.2 Alan Tonelson, The end of internationalism, in �The New Republic�, 13 febbraio 1989.
G. CAFORIO324
L�Italia ha seguito l�andamento generale dei paesi industrializzati, come è evi-denziato, per quanto riguarda le spese militari, dalla Fig. 2 che segue.
Fig.2. Percentuale delle spese militari sul PNL 1985-1999 (a prezzi costanti)
1985 1990 1995 1999
Fonte: North Atlantic Treaty Organization, Defence expenditures as % of GDP
(Brussels: NATO, 2003).
(Qui si è preferito usare la percentuale delle spese militari sul PNL a prezzi co-stanti per dare una visione reale del fenomeno).
Ed anche il numero dei militari alle armi ha seguito lo stesso trend generale, come documentato dalla Fig. n. 3.
Fig. 3. Italia: variazione della forza alle armi
Fonte: North Atlantic Treaty Organization, Armed forces (Brussels, NATO, 2003). In centinaia di migliaia.
Rapporti Forze armate società in Italia 325
Ma su questo fenomeno di riduzione numerica degli eserciti non ha in" uito sol-tanto la ricerca del �dividend of peace�. Erano infatti state le esigenze militari a su-bire un rapido cambiamento negli anni �90, per un impiego delle forze armate assai diverso da quello del periodo precedente. Durante la Guerra fredda i paesi dell�Eu-ropa Occidentale avevano la funzione di costituire un argine temporaneo all�avan-zata delle truppe del Patto di Varsavia, in caso di con" itto, onde dare tempo alla potenza leader del blocco di sviluppare le proprie risorse strategiche in battaglia, fossero esse connesse all�impiego dell�arma nucleare, tattica o strategica, oppure allo sviluppo di una poderosa azione convenzionale attraverso uno spostamento massiccio di forze al di qua dell�Atlantico. Per far questo occorrevano eserciti di massa, così come ai paesi del Patto di Varsavia servivano eserciti di massa per dare una poderosa spallata offensiva alle forze dei paesi NATO. Per l�Italia il compito strategico delle forze armate era difendere la cosiddetta �Soglia di Gorizia�.
E nel resto del mondo ogni possibile con" ittualità locale era soffocata ed inibita dalle potenze leader dei due blocchi, ciascuna nella propria area di in" uenza. Sol-tanto la grande partita Est-Ovest era ammessa, tutte le altre dovevano aspettare.
Con la simbolica, ma anche materiale, caduta del muro di Berlino, tutto cambia, e, come scrivevo in altro mio lavoro3,
La ! ne della Guerra Fredda e la conseguente sparizione dei due blocchi di stati, il cui equilibrio era stato tuttavia la garanzia della conservazione di uno status quo, hanno aperto un vaso di Pandora dal quale sono progressivamente e tumultuosamente emersi guerre re-ligiose, con" itti etnici, la disintegrazione di stati e la nascita di nuove entità statuali spesso l�un l�altra in con" itto, tutti fenomeni fortemente contrari con le necessità di globalizzazione e di libero commercio dei vincitori delle Guerra Fredda. Molti di questi con" itti sono asim-metrici ed il mondo occidentale (in senso ampio) si è trovato a fronteggiare una differente e peculiare forma di guerra, caratterizzata da una situazione dove una parte debole (statuale o non statuale) si oppone ad una forte potenza militare.
La guerra asimmetrica
Si sviluppa e si afferma così nel mondo un nuovo tipo di con" itto, la �guerra asimmetrica� che si contrappone ai con" itti dell�era precedente, chiamati �guerre convenzionali�.
Tutte e due le terminologie sembrano esprimere piuttosto bene la natura dei rispettivi con" itti rappresentati.
La guerra concepita ed attuata sino alla ! ne degli anni �80 del secolo scor-so può ben essere chiamata �convenzionale� perché regolata da diverse conven-zioni, da quelle morali a quelle giuridiche (trattati di Ginevra): essa si muoveva
3 Giuseppe Caforio, The asymmetric warfare: In search of a symmetry, in G. Caforio, B. Puarkayastha, G. Kümmel (a cura di), Armed forces and con! ict resolution: sociological per-spectives, Bingley, Emerald Group, 2008, pp. 7-23.
G. CAFORIO326
all�interno di regole che, quando violate portavano poi a giudizi di carattere pe-nale (Corte Internazionale dell�Aja), particolarmente a carico dei vinti. La guerra asimmetrica prende invece questo nome perché vede, come già detto, il confronto tra una parte debole ed una parte forte, secondo il contesto convenzionale, talchè un tradizionale con" itto armato tra le due parti non avrebbe storia. Ecco allora che la parte debole inventa nuove tattiche, fondate sulla deliberata inosservanza delle regole convenzionali, non solo, ma anche dell�etica propria dei paesi indu-strializzati dominanti, ricorrendo, senza remore, su larga scala, al terrorismo4. La strategia è quella di conquistare il potere politico diffondendo paura e odio, creando un generale clima di terrore, eliminando le voci moderate e scon! ggendo ogni tolleranza5. Per svolgere ef! cacemente tale azione la parte debole sfrutta poi il contesto globalizzato creato dalla evoluzione tecnologica dei paesi industrializ-zati che vuole colpire.
Occorre infatti puntualizzare che, sebbene il processo di globalizzazione abbia prodotto un progresso generale delle società coinvolte, gli stessi strumenti da cui dipende la globalizzazione possono anche venire usati per produrre effetti distrut-tivi nelle medesime società.
Si tratta di una vulnerabilità soprattutto �occidentale� perché gli strumenti della moderna tecnologia � e soprattutto quelli di comunicazione � hanno larghe possi-bilità di essere usati contro e all�interno delle società democratiche. Tali strumenti sono infatti disponibili anche per gruppi terroristici, abilitandoli a diffondere pro-paganda ed informazioni tramite Internet, fornendo diffusi e sicuri mezzi di comu-nicazione (posta elettronica, telefoni cellulari e/o satellitari), possibilità di divulga-re tecniche di guerriglia e terrorismo attraverso la distribuzione di DVD o Internet stesso. In sintesi, la globalizzazione di Internet ha creato un retroterra strategico, od un santuario virtuale, disponibile anche per il terrorismo.
Un fenomeno collaterale, che diversi autori6 chiamano �ombre della guerra�, (shadows of war) costituisce il supporto economico della guerra asimmetrica. In-fatti questa forma con" ittuale ha prodotto (e si sostiene con) un nuovo genere di economia, fondata sulla violenza. I mezzi ! nanziari vengono raccolti tramite rapi-ne, contrabbandi vari (droga, sigarette, alcool), obbligando gli emigranti a versare parte dei loro salari, tassando gli aiuti umanitari. È questo il lato oscuro della glo-balizzazione.
4 Osserva in merito Mary Kaldor: �Le violazioni della legislazione umanitaria e dei diritti uma-ni non sono un effetto collaterale della guerra, ma il metodo principale con cui le nuove guerre vengono combattute�. Mary Kaldor, Le nuove guerre, in Nicola Labanca (a cura di), Guerre vec-chie, guerre nuove: comprendere i con! itti armati contemporanei, Milano, Bruno Mondadori, 2009, p. 74.
5 Giuseppe Caforio, The asymmetric warfare: In search of a symmetry, cit.6 Cfr., ad esempio, Carolyn Nordstrom, Shadows of War. Violence, Power, and International
Pro" teering in the Twenty-First Century. Berkeley, University of California Press, 2004; David Kilcullen, The Accidental Guerrilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One, Oxford, Ox-ford University Press, 2009.
Rapporti Forze armate società in Italia 327
Sul piano operativo militare il con" itto asimmetrico produce alcune concrete conseguenze:1. Le operazioni di combattimento sul terreno non possono più essere condotte
con il solo e semplice scopo di distruggere le forze avversarie, ma devono tener conto del loro effetto sia sulle popolazioni coinvolte nel con" itto, sia sulla opi-nione pubblica in generale
2. Dette operazioni hanno luogo non nella �terra di nessuno�, bensì prevalen-temente in mezzo a popolazioni civili. Come ha scritto un autore americano7, �L�impegno militare avviene oggi dappertutto, in presenza di civili, contro dei civili, in difesa di civili. I civili sono l�obiettivo da conquistare oppure, in alcuni casi, le forze da contrastare�
3. I militari impiegati in tali operazioni sono soggetti ad una serie signi! cativa di pressioni esterne (i mass media, le opinioni pubbliche dei paesi di origine, la differenza di valori con l�avversario, la scarsa tollerabilità di perdite umane)
4. La necessità di acquisire una forte interoperabilità con i paesi delle coalizioni che normalmente cooperano in operazione (48 paesi oggi in Afganistan)
5. La necessità di portare avanti una molteplicità di operazioni, spesso estranee alla funzioni militari tradizionali (assistenza umanitaria, ricostruzione, adde-stramento di forze locali, missioni di peacekeeping, di intelligence) simultanea-mente piuttosto che in sequenza.
Il mutamento del reclutamento
Di fronte alle caratteristiche di questo tipo nuovo di impiego l�esercito di mas-sa, fondato sulla coscrizione, tradizionale prodotto della Rivoluzione Francese, non serve più. Servono unità leggere (anche per il peso logistico di operazioni che sono sempre più spesso oltremare) composte da professionisti8, con un più alto livello di preparazione e più spendibili, in quanto volontari, con minori ripercussioni presso le opinioni pubbliche nazionali per eventuali perdite.
È ciò che sperimenta l�America dopo la guerra del Vietnam, e ciò che sperimen-tano i diversi paesi industrializzati europei e non europei nel ventennio seguito alla caduta del muro di Berlino.
7 Bengt Abrahamsson, Restraint, unbridled emotion and war amongst the people, in A. Wei-bull, B. Abrahamsson (a cura di), The Heritage and the Present: From Invasion Defence to Mis-sion Oriented Organisation, Karlstad, Swedish National Defence College, 2008, p. 148.
8 Appare cioè sempre più necessaria una divisione funzionale del lavoro basata sulla specia-lizzazione e quindi professionalizzazione del singolo soldato. Anche lo sviluppo della istituzione militare ha infatti seguito i criteri di differenziazione ed economizzazione tipici delle grandi orga-nizzazioni civili, quali, in Italia, le grandi organizzazioni come la SIP e poi Telecom. Ciò signi! ca una più spinta divisione del lavoro, una specializzazione appunto che rende necessaria una pro-fessionalizzazione dei soldati, non compatibile con un servizio di leva sempre più ridotto in durata per evidenti ragioni politico-sociali.
G. CAFORIO328
A ciò si aggiungono fattori politico-sociali, quali il calo demogra! co in atto nel nostro paese (e in altri) e la crescente insofferenza dei giovani al peso del servizio di leva, testimoniato anche dall�aumento nel tempo degli obiettori di coscienza (vedi Fig. 4), più diffuso nelle regioni più sviluppate del Nord Italia.
Fig. 4. Numero di obiettori per area geogra" ca, 1996-1998 (migliaia)
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Uf! cio nazionale per il servizio civile, �Relazione sulla organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile�,
30 giugno 1999.
In Italia il dibattito tra esercito professionale ed esercito di leva si fa pressan-te negli anni �90 e tre posizioni sostanziali si confrontano: quella favorevole alla conservazione di un esercito di leva, che si basa su una lettura letterale del dettato costituzionale, quella favorevole a forze armate miste, inizialmente prevalente, e quella decisamente orientata ad una forza tutta volontaria e professionale. Il muta-re del favore della pubblica opinione nel tempo verso i tre tipi di scelta è ben docu-mentato dalla Fig. 5 che segue.
Rapporti Forze armate società in Italia 329
Fig. 5. Consenso popolare a forze armate basate sulla coscrzione,
sul voontariato, su un modello misto
Fonte: �Italy�s All-Volunteer Army: An Analytical Framework for Understanding theKey Policy Issues and Choices During the Transition�, Support for alternative
approaches to military manpower procurement (California: Rand, 2002)
Come si vede dai dati riportati gra! camente nella ! gura, con il tempo si con! -gura il più netto favore verso un esercito professionale che viene poi adottato, con il ritmo dei nostri tempi legislativi, a partire dal 20059.
Il trend, come ben documentato nel suo saggio da Karl Haltiner10, è generalizza-to negli stati industrializzati. Dalla Tab. 1 che segue si vede il progressivo allinearsi nella tendenza di un gruppo signi! cativo di paesi: al 2011 infatti in Europa soltanto Danimarca, Grecia, Israele, Norvegia, Svizzera e Turchia11 restano con un esercito in tutto o in parte di leva.
9 Con la legge 14 novembre 2000, n. 331 �Norme per l�istituzione del servizio militare pro-fessionale�, approvata a larghissima maggioranza il 24 ottobre 2000, e pubblicata sulla Gazzetta Uf! ciale n. 269 del 17 novembre 2000.
10 Karl Haltiner, The de" nite end of the mass army in Western Europe?, in �Armed Forces + Society�, a. 1998, n. 1, pp. 7-36.
11 Anche la Turchia ha sentito il bisogno per le operazioni contro i ribelli del PKK di servirsi di professionisti. A tal uopo il Gen. Ilker Basbug, comandante delle forze turche di terra, ha creato nel 2008 una brigata speciale composta tutta di volontari a lunga ferma.
G. CAFORIO330
Tab. 1. Diffusione degli eserciti professionali nei maggiori Paesi europei (2011)
Paesi Volontari dal
Regno Unito Da sempre
Belgio 1994
Olanda 1997
Francia 2001
Spagna 2001
Sud Africa 2002
Ungheria 2004
Slovenia 2004
Italia 2005
Romania 2007
Bulgaria 2008
Germania 2011
Svezia 2011
Fonte: Caforio 2011
La scomparsa del dovere del cittadino maschio di effettuare il servizio militare appare come un signi! cativo cambiamento politico e sociale, tale da portare, come ef! cacemente espresso sempre da Karl Haltiner12 ad una demilitarizzazione della società.
L�abbandono, infatti, della coscrizione riduce i settori della società coinvolti nella difesa nazionale. A livello di opinione pubblica innanzitutto diminuisce for-temente il numero di cittadini che hanno avuto una conoscenza della istituzione militare attraverso la propria diretta esperienza. Ma anche a livello degli opinion leaders e opinion makers nazionali, politici e non, tendono a scomparire coloro che hanno avuto una diretta esperienza militare, magari come uf! ciali di complemento e cioè con un ruolo militare in qualche modo direttivo.
Nelle Europa continentale, infatti, la Rivoluzione Francese aveva portato alla affermazione del servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini come diritto e come dovere al tempo stesso, connaturato con la concezione della partecipazione del cittadino alla vita pubblica democratica.
Il passaggio a forze armate professionali, composte interamente da volontari e la scomparsa del dovere di ogni cittadino (almeno in tempo di pace) di dedicare
12 Karl Haltiner, The de" nite end of the mass army in Western Europe?, cit., e Id., The Decline of the European Mass Armies, in Giuseppe Caforio (a cura di), Handbook of the Sociology of the Military, New York/ Boston/ London, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2003, pp. 361-384.
Rapporti Forze armate società in Italia 331
parte del suo tempo di vita all�esercizio della funzione militare, non è dunque sol-tanto un passaggio tecnico-organizzativo, ma un signi! cativo passaggio politico e sociale, gravido di conseguenze sui rapporti tra società civile e forze armate.
Le conseguenze in Italia
Una prima conseguenza di forte impatto sociale del passaggio dalla coscrizione al volontariato è stata l�apertura delle forze armate al reclutamento femminile (le due misure appaiono collegate). Ad onta del fatto che essa abbia costituito anche il superamento di una discriminazione ! no ad allora usata nei confronti delle donne, la motivazione principale della scelta appare essere stata la necessità di ampliare una base di reclutamento che si presentava per sé insuf! ciente, sia quantitativa-mente che qualitativamente (vedi anche l�aumento della obiezione di coscienza). Scelta d�altronde operata anche in altri paesi (quantomeno come allargamento del-le ipotesi di impiego delle donne) per i medesimi motivi.
Nell�immediato numerose sono state le opposizioni, anche interne, a tale tipo di reclutamento13.
Opposizioni e preoccupazioni a parte, si può però concludere che oggi l�arruo-lamento volontario femminile nelle forze armate è un fatto largamente accettato in Italia14: resta una divisione tra coloro che vorrebbero escludere le donne dalle funzioni combattenti e coloro che vorrebbero dare loro accesso a tutti i ruoli15.
In linea più generale poi anche in Italia il passaggio dalla coscrizione al volonta-riato ha portato ad una demilitarizzazione della società e ad una rimilitarizzazione della istituzione militare, almeno in talune sue componenti.
13 Cfr. Valdo Spini, Fabio Isman, Naia? No, grazie. Un esercito di mestiere, con le donne, e non una leva obbligatoria, Milano, Dalai, 1997; Gerhard Kümmel, When Boy Meets Girl: The Femini-zation of the Military, in �Current Sociology�, a. 2002, n. 50, pp. 615-639; Marina Nuciari, Guido Sertorio. Nuovi soldati per nuove missioni. Studio di un caso, Torino, Giappichelli. 2003; e Ead., Women soldiers in a transcultural perspective, in G. Caforio (a cura di), Social Sciences and the Military. An interdisciplinary Overview, Routledge, Taylor + Francis Group, London and New York, 2007, pp. 238-60; Giuseppe Caforio (a cura di), Cultural differences between military and parent society in democratic countries, Oxford e St. Louis, Elsevier, 2007.
14 Mi è parsa molto signi! cativa la testimonianza apparsa sul blog di un soldato (http://it.an-swers.yahoo.com/question/index?qid=20100915080815AAN0MNG), che scrive: �Le donne in Esercito sono un elemento positivo da un certo punto di vista e negativo dall�altro. Positivo perchè fanno parte del rinnovamento delle FF.AA. e in alcuni casi sono meglio di tanti uomini, soprat-tutto di chi parla e basta. Negativo perchè in alcuni casi sono un elemento destabilizzante, soprat-tutto se sono belle donne. Noi siamo maschi italiani, e siamo sempre e comunque attratti dalla bellezza femminile, non c�è niente da fare. Bisogna però stare attenti a come si parla e a come ci si muove perchè la molestia sessuale è sempre dietro l�angolo. A parte questo però ci stiamo abi-tuando alla presenza delle donne in mezzo a noi e col ricambio generazionale si arriverà a vederle come militari e basta, o quasi�.
15 Giuseppe Caforio (a cura di), Cultural differences between military and parent society in democratic countries, cit.
G. CAFORIO332
La esperienza infatti di un sacri! cio personale a favore della comunità naziona-le, congiunta ad una esperienza di vita comunitaria per molti unica nella vita, ha costituito in epoca contemporanea un potente fattore di acquisizione di valori co-munitari e nazionali nei cittadini maschi nel nostro paese. Ciò è ben presente nella coscienza collettiva del paese, come mostrato dal sondaggio effettuato nel 2010 dal-lo studio Ferrari Nasi + Associati, riportato nella Tab. 2 che segue. Da esso si rileva come un complessivo 53% degli intervistati ritenga tuttora che un servizio pubblico allo stato fosse utile per la crescita delle giovani generazioni.
Tab. 2. Può dirci se è molto, abbastanza, poco, per nulla d�accordo
con la seguente affermazione? �Fare il servizio obbligatorio, militare o civile,
aiutava parecchio i giovani a diventare adulti�
Accordo % % cumulatamolto 37 53abbastanza 16poco 22 43per nulla 21non so 4 4
Fonte: Ferrari Nasi + Associati, Milano (Analisi Politica),campione di 800 casi, rilevazione 22-24 Marzo 2010
La scomparsa di tale esperienza non può restare senza conseguenze sugli at-teggiamenti e sui valori dei cittadini, a meno di sostituirla con valide esperienze alternative, quali il servizio civile.
Al tempo stesso la effettiva capacità militare si concentra in nuclei organizzati-vi sempre più ridotti e sempre più specializzati (paracadutisti, marines, incursori ecc.) che vengono a costituire una sub-cultura caratterizzata da uno spirito elitistico e guerriero (militarizzazione della istituzione). I famosi topgun americani, i rambo, spesso presi di mira dalla caricaturistica europea, sono un prodotto di questo pro-cesso. Il resto della istituzione militare assume sempre più funzioni logistiche e di supporto civil-simili.
Il passaggio dalla coscrizione al volontariato ha poi fatto perdere i particolari connotati sociodemogra! ci ad alcune unità. Il caso più clamoroso è stato quello de-gli alpini, che venivano quasi esclusivamente reclutati tra i giovani delle valli alpine, mentre il passaggio al volontariato ha prodotto una loro forte meridionalizzazione, come anticipato dalla ricerca di Sertorio e Nuciari16 da cui ho tratto i dati della ta-bella che segue.
16 Marina Nuciari, Guido Sertorio. Nuovi soldati per nuove missioni. Studio di un caso, cit.
Rapporti Forze armate società in Italia 333
Tab. 3. Consistenza degli alpini volontari 2° Rgt.,
Cuneo (estate 2001), per provenienza geogra" ca
% Nord Centro Sud Isole
Volontari (V.S.P. E V.F.B.)
9 11 51 29
Fonte: Sertorio e Nuciari 2003, (op.cit., pag. 111)
Ma se il nuovo sistema di reclutamento ha fatto perdere la regionalizzazione di alcuni reparti, l�ha invece ricreata per altri. L�esempio più evidente è dato dalla Bri-gata Sassari, che, dislocata in Sardegna e potendo attingere ad un bacino di reclu-tamento locale ben consistente, si è dotata di uno spirito di corpo e di una coesione tipicamente isolana e capace di far rivivere il mito della omonima unità della Prima guerra mondiale.
Il tradizionale divario esistente tra le due culture, quella civile e quella militare17, ed in parte funzionale alla divisione del lavoro, rischia dunque di approfondirsi, con conseguenze sia sotto l�aspetto della necessaria cooperazione tra i due ambiti, sia della stessa ef! cienza delle forze armate, le quali, in un regime democratico, neces-sitano di una larga condivisione di obiettivi e di metodi sia con l�opinione pubblica che con il potere politico.
Questi sono gli aspetti, le dimensioni, i problemi che il passaggio dalla coscrizio-ne al volontariato presenta. È un passaggio epocale, non soltanto per la istituzione militare.
Atteggiamento della opinione pubblica italiana
Per completare il discorso sul mutamento dei rapporti Forze Armate società dopo la ! ne della Guerra Fredda appare opportuno vedere i mutamenti (se ve ne sono) nell�atteggiamento della opinione pubblica italiana verso le proprie forze ar-mate.
Appare interessante fare questa valutazione in ambito europeo (vedi Tab. 4 che segue) dalla quale si rileva in primo luogo una sensibile crescita della ! ducia nel nostro paese, particolarmente dal 1997 al 2003. In secondo luogo si può anche rile-vare come sia il livello che la crescita di tale ! ducia siano superiori alla media degli altri paesi della UE.
17 Giuseppe Caforio (a cura di), Cultural differences between military and parent society in democratic countries, cit.
G. CAFORIO334
Tab. 4. Fiducia nella istituzione militare nei paesi europei 1981-2003
Country 1981 1990 1997 2000 2003
Belgio 43 33 33 67 56
Danimarca 40 46 74 82 74
Germania 53 40 60 66 62Grecia - - 85 87 81Spagna 63 42 56 65 53
Francia 55 56 54 68 62
Irlanda 76 61 83 85 75
Italia 56 48 55 67 69
Lussemburgo - - 61 74 63
Olanda 43 32 53 74 61Austria - - 59 49 62Portogallo - 47 58 78 76
Finlandia 71 - 88 91 87
Svezia 61 49 64 72 63Regno unito 82 81 74 83 79
Media EU - - 61 71 66
Fonte: 1981 and 1990: European Values Survey 1981 and 1990 in Listhaug and Wiberg (1995: 304-5); 1997 and 2000: Eurobarometer 48, 54.1 and 59.
Data partially token by Manigart, 2001)
Più o meno negli stessi anni si veri! ca una crescita del prestigio delle professione militare presso la opinione pubblica italiana, come evidenziato dalla tavola che segue:
Tab. 5. Classi" cazione delle principali professioni secondo il prestigio
Professione 1994 posizione 2004 posizioneMedicoDiplomatico Professore universitarioAvvocato Dirigente pubblicoIngegnere Uf! ciale Imprenditore Professore scuola secondariaGiornalista Commissario poliziaSacerdote Farmacista Pilota civile
12345678910111213>
1265384714119131210
> non incluso nel sondaggio 1994 Fonte: Caforio 2005
Rapporti Forze armate società in Italia 335
Valutazione che trova un preciso riscontro nella crescita percentuale delle do-mande di ammissione alle accademie militari rispetto ai posti a concorso (vedasi Fig. 7 che segue).
Fig. 6. Numero di domande per posto a concorso alle accademie militari
per le quattro forze armate: periodo 1990-2007
Fonte: Dati forniti dalle Accademie Militari: elaborazione dell�autore.
Tracciando la retta di regressione si vede come, nel periodo in esame, si veri! chi un sensibile incremento delle domande per tutte le forze armate, meno sensibile per la Marina Militare che rimane quasi stabile.
Come si spiega questa crescita di popolarità e di ! ducia? Le ragioni sono più di una, ma la principale sembra essere da più rilevamenti incrociati18 il mutato impie-go delle nostre forze armate e, tra esse, particolarmente dell�Esercito e dei Carabi-nieri.
La funzione delle nostre forze si basava sino agli anni �90 sul concetto strategico di dissuasione. Cioè l�insieme delle forze armate NATO aggiunto al potenziale mili-tare americano ed alla minaccia nucleare dovevano dissuadere il blocco contrappo-sto da qualsiasi iniziativa militare. La cosa ha effettivamente funzionato, sino a che la mutata situazione internazionale ha portato alla ! ne della Guerra Fredda. Tutta-via nessun vaglio concreto di capacità militare veniva dato alle nostre forze armate (esercitazioni a parte), talchè risultava dif! cile per il cittadino medio valutare detta capacità e persino comprendere appieno la necessità delle spese militari.
Ma partire dagli anni �90 le forze armate italiane sono state progressivamente e crescentemente impegnate in una serie di operazioni militari raggruppate allo-
18 Giuseppe Caforio, La professione militare nell�Italia repubblicana, in Nicola Labanca (a cura di), Le armi della Repubblica, vol V di Mario Isnenghi (a cura di), Gli italiani in guerra. Con! itti, identità, memorie, Torino, Utet, 2010.
G. CAFORIO336
ra sotto la etichetta di Military Operationes Other Than War (MOOTW), la cui componente fondamentale è stata costituita dalle operazioni di supporto della pace (PSOs). A questo iniziale mutamento si è aggiunta poi la partecipazione ad opera-zioni di combattimento vere e proprie, seppure sempre con ! nalità di paci! cazione di territori, nel quadro della cosiddetta �Guerra al Terrore� (War to Terror).
Sono così diventate evidenti a tutti le ! nalità paci! catrici delle nostre forze ar-mate19, nonché la loro capacità di condurre tali operazioni con non minor successo degli altri paesi coinvolti. Questo è stato il maggior fattore di crescita della ! ducia popolare delle forze armate italiane che dal 1990 al 2003 risulta cresciuta di ben 21 punti percentuali (vedi Tab. 4). Ha inoltre anche contribuito a questa crescita l�ab-bandono della coscrizione, fardello pesante per i giovani e sempre meno accettato, come già evidenziato.
Alcune conclusioni
Molto è dunque cambiato nei rapporti forze armate società in Italia dopo la ! ne della Guerra Fredda. Sono mutate, innanzitutto, le forze armate, nel loro recluta-mento, nella loro struttura, nella funzione. Chiamate ad operare prevalentemen-te in un contesto di guerra asimmetrica hanno dovuto cambiare il reclutamento, l�addestramento, la formazione, specie dei quadri20, e in parte anche l�armamento e l�equipaggiamento. Sono cambiate anche al loro interno nella importanza dei sin-goli servizi21.
È mutata anche la loro apertura verso la società civile, assai più accentuata ri-spetto al passato, probabilmente frutto di una maggiore accettazione del loro (nuo-vo) ruolo da parte della opinione pubblica nazionale. La stessa tradizionale dif! -denza dei militari verso la stampa risulta oggi assai diminuita.
Sull�altro versante, come si è visto, la ! ducia della opinione pubblica nazionale verso le proprie forze armate è considerevolmente aumentata nel tempo e sembra aver meglio compreso la necessità per il nostro paese di contribuire alla pace mon-diale in maniera adeguata alla sua potenzialità economica ed alla sua posizione nel concerto delle nazioni. La stessa politica estera non appare più di �basso pro! lo�22
19 Occorre anche tener presente la forte in" uenza pubblica dal popolo cattolico, da sempre schierato su posizioni paci! ste.
20 Giuseppe Caforio, La professione militare nell�Italia repubblicana, cit. Ma cfr. anche Id., The ! exible of" cer, Gaeta, Artistic + Publishing Company, 2001; ed Id., Aspetti e problemi del passaggio dalla coscrizione al volontariato, in Piero del Negro e altri (a cura di), Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d�Italia, Milano, Unicopli, 2005, pp. 369-382.
21 Ad esempio nell�esercito è assai aumentata l�importanza dei corpi speciali e diminuita quel-la della artiglieria; nell�aeronautica è aumentata l�importanza dei trasporti e diminuita quella dei caccia intercettori.
22 Così veniva de! nita la politica estera italiana durante la prima repubblica. Cfr. in merito Giuseppe Caforio, La professione militare nell�Italia repubblicana, cit.
Rapporti Forze armate società in Italia 337
ed anche i maggiori partiti politici appaiono d�accordo sugli impegni miliitari inter-nazionali presi dal paese.
Sono questi aspetti assai importanti perché possono in qualche modo contra-stare quella �demilitarizzazione della società� che Haltiner23 aveva evocato come rischio connesso all�abbandono della coscrizione.
L�inserimento delle donne nelle forze armate, avvenuto senza maggiori proble-mi di altri paesi, ha contribuito ad allargarne la rappresentatività, oltre ad ampliare la base di reclutamento.
D�altro canto il passaggio dalla coscrizione al volontariato, senza una parallela istituzione di un ampio e valido servizio civile, ha privato le nuove generazioni di una forte opportunità di crescita e maturazione, ruolo che forse dovrebbe essere ricoperto dalla Scuola che, tuttavia, pare avere in Italia già i suoi problemi.
Le nuove unità costituite da volontari hanno dimostrato alla prova dei fatti di saper reggere onorevolmente il confronto con i più quotati eserciti di altri paesi.
23 Karl Haltiner, The Decline of the European Mass Armies, cit.

















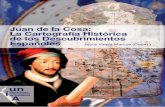




![Ugo ZANETTI, L'Église Copte, dans Seminarium, 38 [= N.S. 27, 3] (1987), p. 352-363.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317feafd93a162f9c0e5f64/ugo-zanetti-leglise-copte-dans-seminarium-38-ns-27-3-1987-p-352-363.jpg)