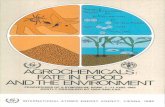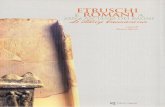Baratti G (2009). La necropoli. (ipogea di Buche delle Fate).
Transcript of Baratti G (2009). La necropoli. (ipogea di Buche delle Fate).
MATERIALI DA COSTRUZIONE E PRODUZIONE DEL FERROStudi sull’economia populoniese
fra periodo etrusco e romanizzazione
a cura di Franco Cambi, Fernanda Cavari, Cynthia Mascione
Bari 2009
E S T R A T T O
Bibliotheca ArchaeologicaCollana di archeologia
a cura di Giuliano Volpe
20
1
Le indagini effettuate alla cava antica di Panchina diBuche delle Fate hanno permesso di acquisire anche in-teressanti dati e spunti di ricerca relativi alla necropoliipogea, già oggetto di indagini nell’Ottocento e soggettada allora a una massiccia e devastante opera di scavoclandestino 1.
Nel 2003 era stato effettuato, da chi scrive con LuciaMordeglia dell’Università degli Studi di Milano, un ri-lievo generale dell’area volto alla georeferenziazionepreliminare delle evidenze emergenti sul terreno, conparticolare attenzione alle tracce ancora in situ di strut-ture tombali ipogee; il rilievo era stato programmato invista di un intervento di scavo a cura della Cattedra diArcheologia dell’Italia preromana dell’Ateneo milanesein collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Ar-cheologici della Toscana. In tale circostanza, oltre al po-sizionamento preliminare dei principali fronti di cava, èstata eseguita anche una battuta di punti topografici fi-nalizzata alla rappresentazione digitale della morfologiadel versante occupato dalla necropoli 2. Ulteriori motividi interesse per l’area cimiteriale ipogea sono peraltroemersi dalle nuove ricerche che, per una sopraggiuntaemergenza di tutela, l’équipe dell’Università di Milano,in collaborazione con la Soprintendenza toscana, ha con-centrato nell’area direttamente sottostante, disposta inprossimità della linea di costa (nota convenzionalmentee contrassegnata anche dalla cartografia ufficiale con ilmedesimo toponimo “Buche delle Fate”) 3. Qui la sco-perta di una necropoli con sepolture a fossa, rinvenuteperlopiù intatte, con corredi riferibili cronologicamenteal III-II sec. a.C., ha spinto a interrogarsi inevitabilmentesul rapporto che legava questa zona con quella ipogea,indiziando la possibilità che tutto il versante, dalla fa-scia caratterizzata dall’emersione di Panchina fino inprossimità della costa, fosse stato interessato dalla pre-senza di una vasta area cimiteriale 4.
Le nuove indagini dell’Università di Siena con il ri-lievo al dettaglio tridimensionale dei fronti di cava e
degli accessi alle tombe, lo scavo dei depositi, la catalo-gazione generale e il riesame completo delle evidenzerelative all’intera area 5, offrono ora un ulteriore apportoper la definizione delle strutture ipogee e nella com-prensione dei caratteri della necropoli (fig. 1).
In particolare, le verifiche effettuate nella zona inte-ressata dalla presenza delle tombe del fronte 8 e lo scavodel deposito posto in prossimità del dromos della tomba1 hanno chiarito come, in questo punto, la necropoliprese avvio una volta completate le attività di coltiva-zione della cava e la massiccia opera di scarico del ma-teriale di risulta; l’analisi del deposito prossimo allatomba 1 infatti risulta integralmente riconducibile al-l’attività di cava 6 e il dromos, che si apre direttamente inprossimità del deposito, venne scavato proprio all’in-terno di questo accumulo. Un ulteriore indizio in questosenso è offerto proprio dal rapporto tra l’andamento deldromos e la morfologia del piano di Panchina (oggi vi-sibile a lato) che si presenta inclinato in senso oppostoalla direzione della discesa nella camera ipogea (fig. 2);il piano roccioso poi, rispetto al probabile punto di par-tenza del dromos, emergeva ad una profondità tale danon consentire l’incisione della parte iniziale del corri-doio direttamente all’interno della calcarenite. Lo scavoper l’apprestamento della camera ipogea doveva dunqueessere iniziato partendo da un piano di calpestio similea quello attuale, procedendo con l’asportazione dei de-positi di scarico della cava all’interno del quale potevanoessere stati sagomati anche i gradini; con l’apertura deldromos veniva quindi raggiunto il piano risparmiato dicalcarenite, sepolto ma facilmente identificabile.
Da ciò che resta del dromos della tomba 3 (fig. 3) èpossibile acquisire un ulteriore dato sull’apprestamentodegli ipogei; qui infatti si conservano lungo le pareti duemuretti a secco costituiti da pietre di pezzatura mediache fungevano da spallette laterali, come contenimentodel materiale friabile scavato (fig. 4). Un indizio di unaprocedura analoga nell’apprestamento dei dromoi diret-
1 Per un quadro delle vicende e delle problematiche connessecon questa necropoli ipogea, si veda da ultimo Baratti 2007, 131-135, con bibliografia precedente.
2 Una più dettagliata disamina delle operazioni di rilievo e dellaproblematiche emerse dalla nuova lettura in Baratti 2006, 359-363, fig. 2; Baratti, Mordeglia 2005.
3 Chiaramonte Trerè 2004-2005, 000; Ead. 2006, 372-373.4 Baratti 2006, 366-367.5 Mascione, La cava e la necropoli di Buche delle Fate. Ri-
cerche svolte e metodologie applicate, in questo volume.6 Baratti, Coccoluto, in questo volume.
La necropolidi Giorgio Baratti
2
Giorgio Baratti
tamente nel suolo, può essere individuato nella tombaipogea identificata nei nuovi scavi dell’Università degliStudi di Milano in prossimità del mare (tomba 23), rin-venuta depredata e contenente solo scarsi frammenti dietà tardoellenistica: la camera ipogea (crollata) era stataaperta all’interno di un nucleo di Macigno e collegatacon l’esterno da un dromos a gradini sagomati diretta-mente nel suolo argilloso dell’orizzonte di base 7.
Lo schema operativo, cosìcome l’avvicendamento del-l’attività di coltivazione con ladestinazione sepolcrale, ri-chiama quanto emerso dallostudio del Fondo Scataglini aTarquinia. Qui è stato infattipossibile ricostruire, nell’am-bito dell’edizione dello scavo,come la necropoli ellenisticadovesse essere stata approntataquando i piani di vita si eranoormai rialzati e le profonde in-cisioni della cava colmate ingran parte con il materiale discarto 8. La stessa tomba mo-numentale della famiglia degliAnina che oggi, a seguito delleoperazioni di scavo archeolo-gico, si affaccia direttamentesu una sorta di piazzale rica-vato nella calcarenite, era inorigine accessibile dall’alto, at-traverso un lungo dromos in di-scesa, scavato nel materiale dicava 9; il piazzale (con relativastrada alla medesima quota)era stato in verità aperto du-rante le fasi di vita della cava equindi successivamente oblite-rato con materiale di scarto dalprocedere della coltivazione. Illungo corridoio scosceso eraqui completato da due muri la-terali di blocchi in calcarenitegiustapposti con analoga fun-zione dei più sommari murettidi Buche delle Fate 10.
Nel settore ipogeo di Buchedelle Fate, una volta raggiuntoil fronte di Panchina, la paretedoveva essere poi risistemataper adattarla alla nuova fun-zione sepolcrale; è probabile,sulla base degli elementi rile-vati sui fronti, che anche parti
delle pareti di Panchina venissero liberate dal materialedi scarto e in parte rilavorate, come indiziato dalla pre-
7 Baratti, Mordeglia 2008, 290-294, fig. 4.8 Linington, Serra Ridgway 1997, 121-129.9 Idem, 95.10 Idem, tavv. XXXVIII-XXXIX.
Fig. 1 - Planimetria dell’area di cava e necropoli di Buche delle Fate.
3
La necropoli
senza di probabili nicchie e altri intagli presenti attornoagli accessi delle tombe e difficilmente attribuibili, pertecnica e funzionalità, alle opere di cava (fig. 5). Che ap-parati anche monumentali sulle facciate e nei pressi delletombe fossero presenti nella necropoli di Buche delleFate è comunque attestato dal rinvenimento della testa inmarmo dagli strati di abbandono della necropoli 11 e da
un busto in riolite recuperato negli anni ’80 sempre dal-l’area di questa necropoli 12.
Come ben segnalato dall’analisi dei materiali raccoltidurante le indagini 13, il grande nucleo più meridionalesembrerebbe costituire un insieme unitario, predispostoquando in quella zona la coltivazione doveva essersiesaurita e il versante ridisegnato nel profilo dal grandeimpatto delle attività di scarico del materiale di scarto.
L’identificazione di tracce di muretti a secco in ma-cigno, per quanto gravemente compromessi nello statodi conservazione e attualmente difficilmente leggibili,nonché la disposizione topografica delle tombe, spessoaffiancate (fig. 1) lungo piani abbastanza lineari, po-trebbe essere verosimilmente riferita, oltre che al lascitodei precedenti fronti di coltivazione, alla presenza di ap-prestamenti finalizzati alla riqualificazione del versante;l’operazione dovette essersi resa necessaria in vista del-
11 Baratti, Coccoluto, Lo scavo, in questo volume; Mascione,Peresso, in questo volume.
12 Mascione, Peresso, in questo volume 00.13 Pagliantini, Salerno, in questo volume 00.
Fig. 2 - Area del fronte di taglio 8. In primo piano il dromos dellatomba 1 e sullo sfondo la tomba 3.
Fig. 3 - Il dromos della tomba 3 visto da est. Sopra l’ingresso sonovisibili i segni di cava lasciati dall’estrazione dei blocchi.
Fig. 4 - Dettaglio del muretto del dromos della tomba 3, sul pianodi cava per contenere i detriti (vista dall’ingresso della tomba).
Fig. 5 - Nicchia a lato del dromos della tomba 71, ricavata nelfronte di taglio 100.
4
l’approntamento del complesso cimiteriale dal momentoche l’area doveva apparire come una sorta di grande di-scarica caratterizzata da un instabile scosceso di mate-riale friabile.
Lo studio delle tipologie delle sepolture identificate,oggetto di approfondimento in una prossima pubblica-zione 14, offre un quadro abbastanza articolato dal qualeemerge in primo luogo l’esiguità in questa necropoli, adifferenza di quanto attestato alle Grotte 15, di tombe in-tegralmente scavate nella Panchina; più frequentementeuna volta raggiunto il filone residuo di calcarenite, la ca-mera ipogea veniva aperta all’interno delle stratificazionigeologiche sottostanti costituite essenzialmente da Ma-cigno alterato più friabile, mantenendo la Panchina comesoffitto. Nella tomba 1 è presente sul lato sinistro unabanchina ben sagomata, caso abbastanza isolato a Buchedelle Fate (fig. 6); tuttavia questa evidenza può esseremessa in relazione con la presenza in quest’area di unapiù profonda formazione calcarenitica compatta, sotto-stante il deposito più superficiale e sfruttato dalle atti-vità di cava (Pallecchi, in questo volume). Non si puòescludere che particolari apprestamenti fossero presentianche in altre camere, ma scavati in materiali più facil-mente soggetti all’usura del tempo e ai rimaneggiamentidegli scavatori clandestini. studio
Lungo i fronti sono presenti tombe con accessi conarchitrave piano o a volta; nel settore più settentrionaleè possibile apprezzare come a nord del fronte 203 (fig.1) i caratteri delle sepolture sembrino mutare, con unaparticolare predilezione per camere con accesso sensi-bilmente più basso e ingresso spesso marcatamente ar-rotondato (fig. 7). Particolarmente rilevante è il casodella tomba 72 (fig. 8), aperta proprio sul fronte 203 e ri-feribile a questa tipologia: il breve dromos con gradini
scavati nella Panchina intercetta, attraversandolo per-pendicolarmente e di fatto defunzionalizzandolo, quellodella tomba 35, caratterizzata da accesso più ampio e ar-chitrave piano. Qui la recenziorità dell’ipogeo, che se-gnala anche la ripresa di spazi precedenti con modalitàcostruttive mutate, facilmente identificabile dai segni la-sciati sulla calcarenite, è supportata dall’analisi dei fram-menti di anfore rinvenuti all’interno della tomba: lacronologia dei materiali risulta infatti genericamente col-locabile tra la metà e la fine del II secolo a.C., quindi po-steriore rispetto ai reperti raccolti nella tomba 35 che,parallelamente a quanto emerso per l’intero settore a suddi questa zona, riportano a una cronologia tra fine III emetà II a.C. 16.
Proprio l’analisi dei materiali ceramici raccolti in su-perficie segnala come, più o meno a partire da questifronti, il panorama verso nord sembri mutare con mor-fologie circoscrivibili tra metà e fine del II sec. a.C.; ildato dunque appare in linea con quanto già emerso dal-l’analisi delle strutture e permette di indiziare una pos-sibile ripresa, in un momento posteriore, dello sviluppodella necropoli che avrebbe così occupato, risalendo lependici del Poggio del Molino, verso nord, anche il set-tore immediatamente prossimo all’area residenziale el-lenistica identificata a monte dell’area di cava 17.
14 Uno studio più approfondita della necropoli di Buche delleFate è in preparazione da parte di chi scrive e sarà edita nella serieMateriali per Populonia.
15 Steingräber 2009, p. 25.16 Pagliantini, Salerno, in questo volume.17 Dallai 2002, 29-38; Bottarelli, Dallai 2003, 233-250, figg. 7-
8; Baratti 2007, p. 000.
Fig. 6 - Banchina all’interno della camera della tomba 1. Fig. 7 - Ingresso della tomba 57, ricavata in un piccolo fronte dicoltivazione (FR 207) nella zona settentrionale dell’affioramentodi Panchina.
Fig. 8 - I dromoi delle tombe 72 (di fronte) e 35 (sulla destra), ri-cavate nell’area di cava 203.
MATERIALI DA COSTRUZIONE E PRODUZIONE DEL FERRO. Studi sullʼeconomia populoniese - © 2009 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
123
Acconcia et alii, 2005 = V. Acconcia, M. Merlo, S. TenKortenaar, Nuove ricerche nella necropoli populoniesedi Piano e Poggio delle Granate, in Materiali 4, 165-174.
Acconcia et alii, 2006 = V. Acconcia, M. Milletti, C.C. Car-raro, F.R. De Castro, L. Gabbrielli, G. Galluzzi, C. Mot-tolese, F. Nomi, V. Palone, S. Picucci, V. Re, M. Taloni,Scavi sulla sommità del Poggio del Telegrafo: campa-gne 2003-2004, in Materiali 5, 13-78.
Acconcia et alii, 2007 = V. Acconcia, M. Milletti, F. Pitza-lis, Populonia, Poggio del Telegrafo: le ricerche nel-l’abitato degli anni 2003-2004, in Bartoloni 2007,57-87.
Alberti M., 2004, Ceramica da fuoco, in Romualdi 2002,143-177.
Andrén A., 1967, Marmora Etruriae, in Antike Plastik, 7,7-42.
Aoyagi M., Foschi E., 1997, I mosaici pavimentali dellavilla romana di Cazzanello (Tarquinia): problemi di da-tazione e di restauro conservativo, in AISCOM IV (Pa-lermo 1996), Ravenna, 815-828.
Aprosio M., 2004, Ceramiche dal saggio IV: elementi perla datazione, in Materiali 3, 107-125.
Aprosio M., Guideri S. (a cura di), 2008, Parco Archeolo-gico di Baratti e Populonia, Firenze.
Architettura funeraria = A. Zifferero (a cura di), L’archi-tettura funeraria a Populonia tra IX e VI secolo a.C.,Atti del Convegno (Populonia 1997), Firenze, 2000.
Arias C., Mello E., Oddone M., 1985, Studio sulla prove-nienza di alcuni manufatti archeologici in marmo me-diante analisi degli elementi in tracce, in Maggiani1985, 216-218.
Arias C., Mello E., Oddone M., 1991, Studio della prove-nienza di alcuni cippi etruschi in marmo bianco di Vol-terra e Pisa, ArchClass, XLIII, 818-827.
Baratti G., 2006, Indagine ricognitiva e rilievo preliminarenell’area di Buche delle Fate, in Materiali 5, 359-370.
Baratti G., 2007, Scavi e ricerche dell’Università degliStudi di Milano a Populonia, in G. Zanetto, S. Marti-nelli Tempesta, M. Ornaghi (a cura di), Vestigia Anti-quitatis, Quaderni di Acme, 89, Milano, 129-146.
Baratti G., Mordeglia L., 2005, Nuove indagini a Populonia,la necropoli di Buche delle Fate, in G. Bartoloni (a curadi), Populonia. Scavi e ricerche, Roma, 62-66.
Baratti G., Mordeglia L., 2008, Necropoli di Buca delleFate: il corredo di una ricca tomba del II secolo a.C.,in Materiali 7, 287-301.
Barbi L., Leggeri B., Nencioni S., Manganelli del Fa C.,
Pecchioni E., 1991, La Tomba dei Carri: indagini e pro-poste per la conservazione, Arkos Notizie, 15, 11-28.
Bartali L., 2005, Pittura di I stile a Populonia: repertoriodelle imitazioni marmoree, in Materiali 4, 135-142.
Bartali L., Ghizzani Marcìa F., Megale C., 2007, Il saggioXXI, in Materiali 6, 39-63.
Bartoloni G., 2000, La prima età del ferro a Populonia: lestrutture tombali, in Architettura funeraria, 19-36.
Bartoloni G., 2004, Populonia: l’insediamento della primaetà del ferro, in Materiali 3, 237-249.
Bartoloni G. (a cura di), 2007, Populonia. Scavi e ricerchedal 1998 al 2004, ScAnt, 12 (2004-2005), 11-227.
Benvenuti V., 2006, Le mura ‘ellenistiche’ di Populonia:alcuni appunti per la definizione cronologica, in Mate-riali 5, 429-435.
Bernabò Brea L., Cavalier M., 1985 (a cura di), Archeolo-gia subacquea nelle isole Eolie, ASubacq, 5, 11-127.
Bessac J.-Cl., 1986, La prospection archéologique des car-rières de pierre de taille: approche méthodologique,Aquitania, 4, 151-171.
Bessac J.-Cl., 1994, Stèles, piliers et bustes: description te-chnique, in M. Py, D. Lebeaupin, J.-Cl. Bessac, Strati-graphie du Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard), 6. Lesniveaux du Bronze final au milieu du Ve s. av. n. è. surle chantier central, DocAMerid, 17, 251-259.
Bessac J.-Cl., 1996, La pierre en Gaule Narbonnaise et lescarrières du Bois de Lens (Nîmes): histoire, archéolo-gie, ethnographie et techniques, JRA suppl, 16, AnnArbor, Michigan.
Bessac J.-Cl., 2002, Glossaire des termes techniques, inBessac, Sablayrolles 2002a, 189-194.
Bessac J.-Cl., 2004, L’archéologie de la pierre de taille, inLa construction. Les matériaux durs: pierre et terrecuite, Paris, 7-49.
Bessac J.-Cl., Sablayrolles R. (eds.), 2002a, Carrières an-tiques de la Gaule. Une recherches polymorphe, Gal-lia, 59, 1-204.
Bessac J.-Cl., Sablayrolles R., 2002b, Recherches récentssur les carrières antiques de Gaule. Bilan et perspecti-ves, in Bessac, Sablayrolles 2002a, 175-188.
Bigalli C., 2004, Un frammento di ceramica attica a figurenere: una proposta di lettura iconografica, in Materiali3, 133-136.
Bisi A.M., 1989, Associazioni di anfore puniche MañaC1=Uzita 3 e di «greco-italiche» in contesti punicidella Sicilia e del nordafrica, in Amphores romaines ethistoire èconomique: dix ans de recherche, Actes duColloque (Sienne 1986), Rome, 594-596.
Bibliografia
MATERIALI DA COSTRUZIONE E PRODUZIONE DEL FERRO. Studi sullʼeconomia populoniese - © 2009 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
124
Bibliografia
Blanco G., 1999, Dizionario dell’architettura di pietra. 1.I materiali, Roma.
Bonamici M., 1985, L’uso del marmo nell’Etruria setten-trionale, in Maggiani 1985, 123-137.
Bonamici M., 1989, Il marmo lunense in epoca preromana,in Dolci 1989, 84-97.
Bonamici M., 1991, Nuovi monumenti di marmo dal-l’Etruria settentrionale, ArchCl, XLIII, 795-817.
Bonamici M., 1996, Contributo Alle rotte arcaiche dell’altotirreno, StEtr, LXI, 16-43.
Bonamici M. (a cura di), 2003, Volterra. L’acropoli e il suosantuario. Scavi 1987-1995, Pisa.
Botarelli L., Dallai L., 2003, La ricognizione archeologicanel golfo di Baratti. Rapporto preliminare, in Materiali2, 233-250.
Bruni S., 1989, Attorno alla Tomba del bronzetto d’offe-rente di Populonia, RM, 96, 267-284.
Bruni S. (a cura di), 1993, Pisa. Piazza Dante: uno spac-cato della storia pisana. La campagna di scavo 1991,Pontedera.
Bruni S., 1996, Appunti su alcune sculture populoniesi dietà ellenistica, StEtr, LXII, 139-151.
Bruno M., Bianchi F., 2006, Lucus Feroniae: altri pavi-menti inediti, in AISCOM XI (Ancona 2005), Tivoli,213-222.
Bruschi G., Criscuolo A., Zanchetta G., 2004, Stratigrafiadelle discariche di detrito dei bacini marmiferi di Car-rara. I ravaneti antichi di Carbonera, Strinato, Gioia eScalocchiella, in A. Bartelletti, E. Paribeni (a cura di),Ante et post Lunam. Splendore e ricchezza dei marmiapuani, Lucca, 25-32.
Burkhard M., 1993, Calcite twins, their geometry, appea-rance and significance as stress-strain markers and in-dicators of tectonic regime: a review, Journal ofStructural Geology, 15 (3-5), 351-368.
Calloud I., Ghizzani Marcìa F., 2007, Terrecotte architet-toniche da Populonia, in Materiali 6, 237-272.
Camaiani S., 2005, Il saggio XXII, in Materiali 4, 41-47.Camilli A., 1999, Ampullae: balsamari ceramici di età el-
lenistica e romana, Roma, 1999.Camilli A., 2005, ... Ducit in arva sinum ... Breve nota sulla
definizione del sistema portuale populoniese, in Mate-riali 4, 203-217.
Camilli A. (a cura di), 2007, Piombino (LI). Populonia: in-dagini archeologiche 2006 nell’area urbana, nelle ne-cropoli e nel territorio, NotATos, 2/2006, 247-273.
Camilli A. (a cura di), 2008, Piombino (LI). Populonia: ag-giornamento sulle attività di ricerca (2007), NotATos,3/2007, 354-386.
Campolongo M., Miniere e metallurgia nell’Alta Maremma.Territorio e museo, Firenze, 1995.
Camporeale G. (a cura di), 1985, L’Etruria mineraria, Ca-talogo della Mostra (Massa Marittima, Piombino, Por-toferraio 1985), Milano.
Caramassi A., Saragosa C. (a cura di), 1990, Il bosco. Unaprima guida per conoscere e visitare il Parco di Mon-toni, Firenze.
Carmignani et alii, 2001 = L. Carmignani, F.A. Decandia,
L. Disperati, P.L. Fantozzi, R. Kligfield, A. Lazzarotto,D. Liotta, M. Meccheri, Inner Northern Appennines, inG.B. Vai, I.P. Martini (Eds.), Anatomy o fan Orogen:the Appennines and Adjacent Mediterranean Basins,Dordrecht, 197-214.
Carrazè F., 1975, L’epave Grand Ribaud A, CahASubaqu,4, 19-58.
Casini A. 1993, Archeologia di un territorio minerario: iMonti di Campiglia, in R. Mazzanti (a cura di), Lascienza della terra nell’area della Provincia di Livornoa sud del fiume Cecina, Quaderni del Museo di StoriaNaturale di Livorno, Suppl. n. 2, Livorno, 1993, 303-314.
Casini A., Zucconi M. (a cura di), 2003, Un’impresa persei parchi. Come gestire in modo imprenditoriale e in-novativo il patrimonio culturale e ambientale pubblico,Milano.
Cavagnaro Vanoni L., 1996, Tombe tarquiniesi di età elle-nistica. Catalogo di ventisei tombe a camera scopertedalla Fondazione Lerici in località Calvario, Roma.
Cavalieri Menasse G., 1977, La ceramica a vernice nera, inLUNI II, 78-113.
Cavari F., 2006, Un ambiente di I stile dall’acropoli di Po-pulonia (saggio III): i rinvenimenti della campagna2004, in Materiali 5, 207-233.
Cavari F., 2007, Sulla tecnica di esecuzione del pavimentocon emblema a cubi prospettici del saggio III, in Mate-riali 6, 127-133.
Cavari F., Bartali L., 2009, Manufatti marmorei dai saggiIII e IV, in Materiali 8, 25-38.
Cavari F., Coccoluto M., 2008, Tecniche edilizie in terracruda nel saggio IV, in Materiali 7, 145-168.
Cavari et alii, 2008 = F. Cavari, G. Cristoforetti, S. Legna-ioli, V. Palleschi, L. Spadolini, E. Rognoni, Decora-zione parietale di primo stile dall’acropoli:caratterizzazione dei pigmenti mediante spettroscopialaser LIBS, in Materiali 7, 185-196.
Cavari F., Donati F., 2002, Gli intonaci dipinti provenientidallo scavo dell’acropoli di Populonia (saggio III,2000), in Materiali 1, 167-182.
Cavari F., Donati F., 2004, Nuovi elementi della decora-zione parietale in I stile dall’acropoli, in Materiali 3,89-105.
Cavari F., Donati F., 2005, Pittura di I stile a Populonia:nuovi rinvenimenti dal saggio III (2003), in Materiali 4,119-134.
Cavari F., Droghini F., Giamello M., 2006, Un pavimentomusivo con emblema in opus sectile dall’acropoli diPopulonia: tecnica esecutiva e caratterizzazione deimateriali, in G. Biscontin, G. Druissi (a cura di), Pavi-mentazioni storiche. Uso e conservazione, Atti del Con-vegno di Studi (Bressanone 2006), Marghera-Venezia,675-684.
Chiaramonte Trerè C. (a cura di), 1999, Tarquinia. Scavisistematici nell’abitato, campagne 1982-1988. I Mate-riali 1, Roma.
Chiaramonte Trerè C., 2006, Scavi nella necropoli di Buchedelle Fate a Populonia, in Materiali 5, 371-388.
Chiaramonte Trerè C., 2007, Nuove ricerche nella necro-
MATERIALI DA COSTRUZIONE E PRODUZIONE DEL FERRO. Studi sullʼeconomia populoniese - © 2009 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
125
Bibliografia
poli populoniese di Buche delle Fate, in Bartoloni 2007,133-148.
Cibecchini F., 1999, La collezione Martelli, in Gambogi,Palladino 1999, 72-80.
Cibecchini F., 1999, Ritrovamenti di L. A. Milani, in Gam-bogi, Palladino 1999, 81-113.
Cipriani M., Lazzarini L., Cancelliere S., c.s., The whitemarbles of Roman Paestum, an archaeometric study, inIX ASMOSIA International Conference (Tarragona2009), in corso di stampa.
Coarelli F., 1987, I santuari del Lazio in età repubblicana,Roma.
Cocchiaro A., Masiello L., Giannotta M.T., Quarta G.,2004, Cocciopesti e tassellati pavimentali da Brundi-sium, in AISCOM IX, (Aosta 2003), Ravenna, 821-840.
Coccoluto M., 2006, Un gruppo di ghiande missili dal sag-gio III, in Materiali 5, 187-195.
Coccoluto M., Costantini A., Gasperi N., 2008, Il saggioIV, in Materiali 7, 63-82.
Coccoluto M., Gasperi N., 2007, Il saggio IV, in Materiali6, 79-104.
Coli M., Faggi D., Pallecchi P., Le Cave etrusche di Popu-lonia, http://aiqua.it/lapideiculturali/populonia_ini.htm.
Copedè E., 2004, Ceramica a vernice nera sovradipinta,in Materiali 3, 137-146.
Coralini A., Vecchietti E., 2007, L’archeologia attraversoun 3D virtual model, in A. Coralini, D. Scagliarini Cor-làita (a cura di), Ut natura ars. Virtual Reality e archeo-logia, Atti della Giornata di Studi (Bologna 2002),Imola, 17-40.
Cortemiglia G.C., Mazzanti R., Parea G.C., 1983, Geo-morfologia della baia di Baratti, Livorno-Toscana, edella sua spiaggia, Geografia Fisica e Dinamica Qua-ternaria, 6, 148-173.
Costantini A., Dadà M., 2009, Il saggio XX, in Materiali 8,13-24.
Costantini et alii, 1993 = A. Costantini, A. Lazzarotto, M.Maccantelli, R. Mazzanti, F. Sandrelli, E. Tavarnelli,Geologia della provincia di Livorno a Sud del FiumeCecina, Quaderni del Museo di Storia Naturale di Li-vorno, 13, suppl. n° 2, 1-164.
Cristofani M., Martelli M., 1972, Ceramica presigillata daVolterra, MEFRA, 84, n. 1, 499-514.
Cristofani Martelli M., 1978, Populonia, REE, XLVI, 325-329.
Cristofani Martelli M., 1979, Osservazioni sulle stele di Po-pulonia, in Scritti in onore di Enrico Fiumi, Pisa, 33-45.
Dallai L., 2002, Topografia archeologica nel territorio po-puloniese: alcuni dati preliminari, in Materiali 1, 29-38.
De Agostino A., 1963, Populonia. La zona archeologica eil museo, Roma.
De Grossi J., Mascione C., c.s., Populonia, acropoli: un de-posito rituale dalla cisterna pubblica, in I riti del co-struire nelle acque violate, Atti del Convegno (Roma2008), in corso di stampa.
De Tommaso G., Patera A., (a cura di), 2002, Il mare in una
stanza. Un pavimento musivo dall’acropoli di Populo-nia, Piombino.
De Tommaso G., Romualdi A., 2001, La ceramica corsadi Populonia, in A. Romualdi (a cura di), Le rotte nelMar Tirreno: Populonia e l’emporio di Aleria in Cor-sica, Piombino, 25-26.
Di Cola V., 2008, Materiali litici dall’acropoli, in Mate-riali 7, 83-114.
Dolci E., 1989, Il marmo nella civiltà romana: la produ-zione e il commercio, Carrara.
Dunham R.J., 1962, Classification of carbonate rocks ac-cording to depositional texture, in W.E. Ham (Ed.),Classification of carbonate rocks, A.A.P.G. Memoir, 1,108-121.
Dworakowska A., 1988, Wooden wedge in ancient quar-rying practice: critical examination of the state of re-search, Archeologia (Warszawa), 38, 25-35.
Faggi D., 2007, Uso storico delle risorse lapidee dell’areadi Populonia, Tesi di Laurea. Facoltà Scienze Matema-tiche Fisiche e Naturali, Corso di Laurea di ScienzeGeologiche (AA 2005-2006).
Fara A. (a cura di), 1999, Leonardo a Piombino e l’ideadella città moderna tra Quattro e Cinquecento, Città diCastello.
Fedeli F., 1983, Populonia. Storia e territorio, Firenze.Fedeli F., 1989, Tomba tardo ellenistica in località la Ster-
paia, RassAPiomb, 8, 201-223.Fedeli F., 2000, Le tombe a camera della necropoli villa-
noviana di Poggio del Molino o del Telegrafo, in Ar-chitettura funeraria, 37-46.
Fedeli et alii, 1993 = F. Fedeli, A. Galiberti, A. Romualdi,Populonia e il suo territorio. Profilo storico-archeolo-gico, Firenze.
Forti L., 1962, Gli unguentari del primo periodo ellenistico,RendNap, XXXVII, 143-157.
Fratini F., Pecchioni E., Pallecchi P., 2007, The decay of thecalcarenite utilised in the Etruscan tombs of S. Cerbonenecropolis (Populonia-Italy), Stone Newsletter on stonedecay, 2 (Aug 2007), 41-42.
Gambaro L., 1999, La Liguria costiera tra III e I secoloa.C.: una lettura archeologica della romanizzazione,Mantova.
Gambogi P., Palladino S., 1999 (a cura di), Castiglioncello:la necropoli ritrovata. Cento anni di scoperte e scavi(1986-1997), Catalogo della Mostra (Rosignano Marit-timo 1999), Rosignano Marittimo.
Gaye G., 1840, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV,XV, XVI, Firenze.
Ghizzani Marcìa F., 2006, Analisi dei materiali da costru-zione del Tempio B, in Materiali 5, 235-246.
Giambruni F., Goggioli S., Lodovici F., Roncaglia G., 2005,Rinvenimento di mosaici nella pieve di S. Giovanni Bat-tista di Ponte allo Spino, Sovicille (SI), in AISCOM X(Lecce 2004), Tivoli, 833-838.
Gilotta F., Romualdi A., 1985, Populonia, necropoli diPiano delle Granate. Tomba a cassone n. 3, in Campo-reale 1985, 258-261.
Giorgi E., 2004, Il saggio IX, in Materiali 3, 75-84.
MATERIALI DA COSTRUZIONE E PRODUZIONE DEL FERRO. Studi sullʼeconomia populoniese - © 2009 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
126
Bibliografia
Gnoli R., 1988, Marmora romana, Roma.Gottarelli A., 1995, La modellazione tridimensionale del
documento archeologico: livelli descrittivi e processa-mento digitale, Archeologia e calcolatori, 6, 75-103.
Grilli E., Russo N., 2002, Acropoli di Populonia: analisidelle tecniche costruttive delle mura di cinta, in Mate-riali 1, 51-63.
Gualandi M.L., 2002, Il mosaico dell’esedra con raffigu-razione di negri, in Materiali 1, 155-166.
Gualandi M.L., Bubba D., 2007, I pavimenti dell’edificioalla base delle Logge, in Materiali 6, 135-148.
Gualandi M.L., Manacorda D., Mascione C., 2007, Scavisull’acropoli di Populonia: l’area sacra della sella e ilcomplesso alla base delle Logge, in Camilli 2007, 248-253.
Gualandi M.L., Patera A., 2001, Un nuovo mosaico dal-l’acropoli di Populonia (Piombino-LI), in AISCOM VIII(Firenze 2001), Ravenna, 259-267.
Guasti C., 1857, La cupola di Santa Maria del Fiore illu-strata con i documenti dell’archivio dell’opera seco-lare, Firenze.
Guidobaldi F., 1985, Pavimenti in opus sectile di Roma edell’area romana: proposte per una classificazione ecriteri di datazione, in Marmi antichi. Problemi di im-piego, di restauro e di identificazione, Roma.
Guidobaldi F., 1989, L’intarsio marmoreo nella decora-zione parietale e pavimentale di età romana, in Dolci1989, 66-67.
Guidobaldi F., Olevano F., 1998, Sectilia pavimenta del-l’area vesuviana, in Marmi antichi II, 223-240.
Guidobaldi F., Vincenti V., 2005, Emblemata in sectileentro tappeti musivi come indizio di livello qualitativoed elemento di datazione, in AISCOM X (Lecce 2004),Tivoli, 445-466.
Gullini G., 1956, I mosaici di Palestrina, Roma. Gutiérrez Garcia-Moreno A., 2009, Roman quarries in the
Northeast of Hispania (modern Catalonia), Documenta10, Tarragona.
Guzzi O., Romualdi A., Settesoldi R., 2005, Populonia inetà ellenistica: nuovi dati dalla necropoli delle Grotte inMateriali 4, 175-202.
Guzzi O., Settesoldi R., 2009, I corredi, in Romualdi, Set-tesoldi 2009, 77-195.
Hesnard A., Lemoine C., Les amphores du Cecube et duFalerne. Prospections, typologie, analyses, MEFRA,93, n. 1, 243-295.
Jehasse J., Jehasse L., 1973, La nécropole préromained’Aléria, suppl. XXV a Gallia, Paris, 599-620.
Joncheray J., 1974, Quelques amphores en provenance duCap Roux, CahSubaqu, 3, 163-166.
Joncheray J., 1994, L’épave Dramont C, CahSubaqu, 12,5-51.
Joncheray J., Long L., 2002, L’epave profonde Heliopolis2-Nord Levant (Var,-80m). Une fouille d’epave à l’aidede plongeurs à saturation et d’un sous-marin d’obser-vation, CahSubaqu, 14, 131-159.
Lamboglia N., 1955, Sulla cronologia delle anfore romane
di età repubblicana (II-I secolo a.C.), RStLig, 21, 241-270.
Lancioni C., 2003, Materiali da un saggio stratigraficolungo le mura dell’acropoli di Populonia: ceramicaacroma e contenitori da trasporto, RassAPiomb, 20B,35-122.
Lazzarini L., 1998, Sulla provenienza senese della BrecciaDorata, Breccia Gialla e Breccia Gialla Fibrosa, inMarmi antichi II, 57-63.
Lazzarini L., 2007, Poikiloi lithoi, versiculores maculae: imarmi colorati della Grecia antica, Pisa-Roma.
Lazzarini L., Cancelliere S., 1999, Note sui marmi e le pie-tre di importazione e la loro lavorazione a Pompei, inA. Ciarallo, E. De Carolis (a cura di), Homo faber. Na-tura, scienza e tecnica nell’antica Pompei, Milano, 97-99.
Lazzarini L., Visona D., Giamello M., Villa L., c.s., Ar-chaeometric characterization of some calcareous ala-baster used in antiquity, in IX ASMOSIA InternationalConference (Tarragona 2009), in corso di stampa.
Lazzarotto A., 1993, Elementi di geologia, in F. Giusti (acura di), La storia naturale della Toscana Meridionale,Siena, 19-87.
Linington R.E., Serra Ridgway F.R., 1997, Lo scavo delFondo Scataglini a Tarquinia. Scavi della FondazioneIng. Carlo M. Lerici del Politecnico di Milano per laSoprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale,Milano.
Lugli G., 1957, La tecnica edilizia romana, Roma.LUNI II = A. Frova (a cura di), Scavi di Luni, II. Relazione
delle campagne di scavo 1972-1974, Roma, 1977.Macchiarola M., Fontanelli R., Nicolardi D., 2004, Studio
archeometrico di materiali musivi e interventi conser-vativi di pulitura, consolidamento e protezione per ilmosaico in situ, in AISCOM IX (Aosta 2003), Ravenna,685-692.
Maggiani A., 1981, Nuove evidenze archeologiche all’Isolad’Elba: i rinvenimenti di età classica ed ellenistica, inL’Etruria Mineraria, Atti del XII Convegno di StudiEtruschi ed Italici (Firenze, Populonia, Piombino 1979),Firenze, 173-192.
Maggiani A., 1982, Sant’Andrea - Relitto B, Archeologiasubacquea, suppl. al Bollettino d’Arte, 4, 72-79.
Maggiani A. (a cura di), 1985, Artigianato artistico: l’Etru-ria settentrionale interna in età ellenistica, Catalogodella Mostra (Volterra, Chiusi 1985), Milano.
Maggiani A., 1992, Le iscrizioni di età tardo classica edellenistica, in A. Romualdi, Populonia in età ellenistica.I materiali dalle necropoli, Atti del seminario (Firenze1986), Firenze.
Manacorda D., 2002, Populonia, Le Logge: i bolli laterizi,in Materiali 1, 125-143.
Manacorda D., 2003, Il mosaico delle Logge di Populoniae le immagini ambigue, in Materiali 2, 169-194.
Manacorda D., 2004, Populonia: una strada tra ricerca evalorizzazione, in M.S. Busana e F. Ghedini (a cura di),La via Annia e le sue infrastrutture, Atti delle Giornate
MATERIALI DA COSTRUZIONE E PRODUZIONE DEL FERRO. Studi sullʼeconomia populoniese - © 2009 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
127
Bibliografia
di Studio (Ca’ Tron di Roncade 2003), Cornuda (Tre-viso), 285-296.
Manacorda D., 2006, Dai Paapi agli Scauri?, in Materiali5, 305-321.
Mannoni T., 1985, Caratterizzazioni petrografiche di al-cune sculture etrusche in marmo bianco, in Maggiani 5,214-216.
Mannoni T., 1991, Analisi petrografiche e provenienze deimarmi di alcuni cippi funerari etruschi, ArchCl, XLIII,827-833.
Mannoni T., 1997, Il problema complesso delle muraturestoriche in pietra 1. Cultura materiale e cronotipolo-gia, AArchit, II, 15-24.
Mannoni T., Casini A., Parenti R., 1995, Il marmo Pariodell’Etruria, in G. Cavalieri Manasse, E. Roffia (a curadi), Splendida civitas nostra. Studi archeologici in onoredi Antonio Frova, Roma, 343-357.
Marabini Moevs M. T., 1973, The Roman Thin Walled Pot-tery from Cosa, MAAR, XXXII, Rome.
Marmi antichi II = P. Pensabene (a cura di), Marmi antichiII. Cave e tecnica di lavorazione, provenienze e distri-buzione, Studi Miscellanei, 31, Roma, 1998.
Marri F., 2005, I rivestimenti pavimentali degli edifici sul-l’acropoli di Populonia, in Materiali 4, 105-118.
Mascione C., 2002, L’edificio delle Logge, in Materiali 1,105-116.
Mascione C., 2004, Lo scavo dell’acropoli: i saggi del2002, in Materiali 3, 33-45.
Mascione C., 2007, Il tempio B: analisi e ricostruzione, inMateriali 6, 221-236.
Mascione C., 2008, Il tempio C e l’area sacra dell’ Acro-poli, in Materiali 7, 115-134.
Mastelloni M.A., 2001, Tusa (ME): pavimenti da uno scavodi A. Salinas (1912), in AISCOM VIII (Firenze 2001),Ravenna, 689-720.
Materiali 1 = F. Cambi, D. Manacorda (a cura di ), Mate-riali per Populonia, Firenze, 2002.
Materiali 2 = C. Mascione, A. Patera (a cura di), Materialiper Populonia 2, Firenze, 2003.
Materiali 3 = M. L. Gualandi, C. Mascione (a cura di), Ma-teriali per Populonia 3, Firenze, 2004.
Materiali 4 = A. Camilli, M.L. Gualandi (a cura di), Mate-riali per Populonia 4, Firenze, 2005.
Materiali 5 = M. Aprosio, C. Mascione (a cura di), Mate-riali per Populonia 5, Pisa, 2006.
Materiali 6 = L. Botarelli, M. Coccoluto, M.C. Mileti, Ma-teriali per Populonia 6, Pisa, 2007.
Materiali 7 = V. Acconcia, C. Rizzitelli (a cura di), Mate-riali per Populonia 7, Pisa, 2008.
Materiali 8 = F. Ghizzani Marcìa, C. Megale (a cura di),Materiali per Populonia 8, Pisa, 2009.
Mauz B., 1999, Late Pleistocene records of littoral proces-ses at the Tyrrhenian Coast (Central Italy): depositionalenvironments and luminescence chronology, QuaternaryScience Reviews, 18, Issues 10-11, 1173-1184.
Medri M., 2003, Manuale di rilievo archeologico, Roma.Minto A., 1934, Populonia, NotScavi, 351-428.
Morandi M., 2001, Populonia, REE, LXIV, 345-347.Monthel G., 2002, La carrière gallo-romaine de Saint-Boil
(Saône-et-Loire), in Bessac, Sablayrolles 2002a, 89-120.
Morel J., 1981, Céramique campanienne. I. Les formes,Roma.
Morel J., 1985, La ceramica campana A nell’economiadella Campania, in G. Macchiaroli (a cura di), NapoliAntica, Catalogo della Mostra (Napoli 1986), Napoli,372-378.
Moriello R., 2002, Ceramiche a vernice nera di produzioneetrusco-settentrionale, in Romualdi 2002, 65-77.
Morricone Matini M.L. (a cura di), 1967, Mosaici antichiin Italia. Roma: Reg. X Palatium, Roma.
Nielsen I., Poulsen B., 1992, The temple of Castor and Pol-lux, Roma.
Nizzo V., 2008, Poggio del Telegrafo. La cava dell’areasud-est, in Camilli 2008, 376-378.
Nolla J. M., Nieto F. J., La importación de anforas roma-nas en Cataluña durante el periodo tardo-republicano,in Amphores romaines et histoire èconomique: dix ansde recherche, Actes du Colloque (Sienne 1986), Rome,367-391.
Pais A., 2003, Edilizia monumentale a Populonia: il com-plesso delle Logge. Tecniche murarie, in Materiali 2,143-158.
Palermo L., 1994-1995, La ceramica campana A, RassA-Piomb, 12, 386-402.
Palermo L., 2003a, Ceramica a vernice nera, in Bonamici2003, 284-345.
Palermo L., 2003b, Ceramica a vernice rossa, in Bonamici2003, 346-358.
Palladino S., 1999, I materiali del 1997, in Gambogi, Pal-ladino 1999, 125-160.
Pallecchi P., Shepherd E.J., 2002, Materiale e tecniche diesecuzione, in De Tommaso, Patera 2002, 22-25.
Panella C., 1998, Anfore e archeologia subacquea, in G.Volpe (a cura di), Archeologia subacquea. Come operal’archeologo sott’acqua. Storie dalle acque, VIII Ciclodi lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Siena1996), Firenze, 531-559.
Paoletti O., 2000, I materiali lapidei, in Architettura fune-raria, 79-98.
Passchier C.W., Trouw R.A.J., 1996, Microtectonics, Ber-lin.
Pensabene P., 1998, Il fenomeno del marmo nella Romatardo-repubblicana e imperiale, in Marmi antichi II,333-348.
Pesando F., 1997, Domus: edilizia privata e società pom-peiana fra il II e il I secolo a.C., Roma.
Petrignani A., 1985, Tecnologie dell’Architettura, Roma.Pistolesi M., 2003, Anfore da trasporto, in Bonamici 2003,
454-459.Puma P. et alii, 2008, Per l’aggiornamento del Progetto Ne-
cropoli. Nuovi rilievi della necropoli etrusca di S. Cer-bone-Casone in Populonia, in Camilli 2008, 356-372.
Ramon Torres J., 1995, Las anforas fenicio-punicas delMediterraneo central y occidental, Barcelona.
MATERIALI DA COSTRUZIONE E PRODUZIONE DEL FERRO. Studi sullʼeconomia populoniese - © 2009 - Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
128
Bibliografia
Repetti E., 1833, Dizionario Geografico Fisico Storicodella Toscana, vol. I, Firenze.
Repetti E., 1846, Appendice al Dizionario geografico fi-sico storico della Toscana, Firenze.
Richter G. M. A., 1959, Calenian Pottery and ClassicalGreek Metalware, AJA, 63, n. 3, 241-249.
Rizzitelli C., 2006, Ceramica d’importazione sull’acropolidi Populonia, in Materiali 5, 143-168.
Rizzitelli et alii, 2003 = C. Rizzitelli, A. Costantini, F. Ghiz-zani Marcìa, C. Mileti, La ceramica dei saggi I-II e IX,in Materiali 2, 55-81.
Romualdi A., 1984-85 (1988), Populonia (Livorno). Loc.le Grotte. Relazione preliminare sulle campagne discavo 1965-67 e 1979 nella necropoli, NSc, XXXVIII-XXXIX, 5-68.
Romualdi A., 1985, Il popolamento in età ellenistica a Po-pulonia: le necropoli, in Camporeale 1985, 185-218.
Romualdi A., 1989, Il patrimonio disperso, Roma. Romualdi A., 1989a, Populonia. Località Poggio del Ca-
stello, StEtr, LV (1987-88), 505-506.Romualdi A., 1994-95, Il santuario e l’abitato sull’acro-
poli di Populonia (campagne di scavo 1980-82), Ras-sAPiomb, 12, 313-341.
Romualdi A., 1996, Populonia, in EAA, II Supplemento,vol. IV, 432-442.
Romualdi A., 2000, Le cave di pietra e la necropoli delleGrotte a Populonia, in F. Falchetti, A. Romualdi (a curadi), Etruschi. Le scoperte più recenti, Firenze, 183-202.
Romualdi A., 2002 (a cura di), Populonia. Ricerche sul-l’Acropoli, Pontedera.
Romualdi A., 2003, Considerazioni sulle tombe dipinte diPopulonia, in A. Minetti (a cura di), Pittura etrusca.Problemi e prospettive, Atti del Convegno (Sarteano,Chiusi 2001), 111-117.
Romualdi A., Settesoldi R., 2008, Le fortificazioni di Po-pulonia. Considerazioni per la cinta muraria della cittàbassa, in La città murata in Etruria, Atti del XXV Con-vegno di Studi Etruschi ed Italici (Chianciano Terme,Sarteano, Chiusi 2005), Pisa-Roma, 307-314.
Romualdi A., Settesoldi R. (a cura di), 2009, Populonia. Lanecropoli delle Grotte. Lo scavo nell’area della cava,Pisa.
Santoni S., Casola M., 2007, Il saggio II, in Materiali 6,105-126.
Santoni S., Vattimo E., 2005, Il saggio IX, in Materiali 4,63-72.
Sanzi Di Mino M., 1987, Pavimentazioni a Roma e nelLazio, in A.M. Reggiani (a cura di), Roma repubblicanadal 270 a.C. all’età augustea, Roma, 49-63.
Sartorio D., Venturini S., 1988, Southern Tethys biofacies,Atlante Agip, S. Donato Milanese, 1-235.
Sassatelli G., 1979, Ancora sui marmi in Etruria nel V se-colo. Confronti volterrani, StEtr, XLVII, 107-118.
Scotti C., 1999, Le anfore, in Chiaramonte Trerè 1999, 261-278.
Shepherd E.J., 1992, Ceramica acroma, verniciata e ar-gentata, in Romualdi A. (a cura di), Populonia in etàellenistica. I materiali dalle necropoli, Atti del Semi-nario (Firenze 1986), Firenze, 157-178.
Shepherd E.J., 1999, Populonia, un mosaico e l’iconogra-fia del naufragio, MEFRA, 111.1, 119-144.
Shepherd E.J., 2002, Mosaico con pesci e scena di naufra-gio da “Le Logge”: dati tecnici e identificazione dellaproveninza, in Materiali 1, 145-154.
Slavazzi F., 2001, Sostegni scanalati e modanati. A propo-sito degli arredi in marmo e pietra di età romana in Ci-salpina, in G. Sena Chiesa (a cura di), Il modelloromano in Cisalpina. Problemi di tecnologia, artigia-nato e arte, Firenze, 93-110.
Steingräber S., 2009, Populonia: necropoli delle Grotte.L’architettura funeraria, in Romualdi, Settesoldi 2009,Pisa, 21-34.
Ten Kortenaar S., Neri S., Nizzo V., 2006, La necropoli diPiano e Poggio delle Granate, in Materiali 5, 325-358.
Trevisan L., Giglia G., 1982, Introduzione alla geologia.Pisa.
Triolo E., 2006, Rilievo strutturale e analisi costruttiva delbasamento della Rocca di Populonia, in Materiali 5,247-262.
Vaggioli M.A., 1995, Lo scavo dell’area 4000 (SAS 4:settore meridionale), in AA.VV., Segesta. Parco ar-cheologico e relazioni preliminari delle campagne discavo 1990-1993, AnnPisa, Serie III, vol. XXV, 855-879.
Waelkens M. (ed.), 1990, Pierre éternelle du Nil au Rhin.Carrières et préfabrication, Catalogo della mostra(Bruxelles 1990), Bruxelles.
Waelkens M., De Paepe P., Moens L., 1990, The quarryingTechniques of the Greek World, in Marble. Art Histori-cal and Scientific Perspectives on Ancient Sculpture,Malibu, 47-72.
Zanini et alii, 2002 = E. Zanini, S. Camaiani, E. Giorgi, F.Minucci, C. Rizzitelli, Scavi sull’acropoli di Populo-nia: prima relazione preliminare sulle campagne 1998-2000, in Materiali 1, 73-104.
Zevi F., 1996, La Casa del Fauno, in M.R. Borriello, A.d’Ambrosio, S. De Caro, P.G. Guzzo (a cura di), Pom-pei. Abitare sotto il Vesuvio, Ferrara, 37-47.
Zifferero A., 2006, Confini e luoghi di culto nel suburbio enell’agro populoniese: un contributo alla ricerca, inMateriali 5, 391-427.
Zucconi M., 2007, Introduzione, in Materiali 6, 5-7.