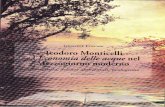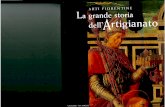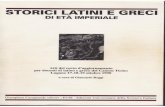Artigiani nella Salerno settecentesca, in «Annali Storici di Principato Citra», a. VIII n. 2,...
Transcript of Artigiani nella Salerno settecentesca, in «Annali Storici di Principato Citra», a. VIII n. 2,...
Annalí Storici: di Principatí Cítra VIII.2. 2010, pp. 97-117
Silvanu Sciarrottu
ARTIGIANI NELLA SALERNO SETTECENTESCA-
La piccola e media impresa continua ad essere uno dei settori piu vitali edinamici dell'economia italiana il suo successo o la sua tenuta nelle criii sono datida quel mix di sapiente organizzazione (sovente a carattere familiare con tanto dicosti contenuti o ridotti), dalla continua innovazione, dalla creatività, dallatecnologia, dal duro e metodico lavoro.
Anche la tradizione, il radicamento dei mestieri, il know-hou. che essarichiede, la propensione al lavoro associativo, che spesso hanno un'altrettantolunga storia alle spalle, influiscono beneficamente sui positivi risultati di questosegmento nodale.
L'afiigianato rappresenta uno dei fattori costitutivi della piccola-mediaimpresa, anzi, se si volge lo sguardo al passato, è proprio lì che essa è nata ed è suquel tereno che si sono sperimentati con buoni risultati i fattori che 1'hannoconsolidata e potenziata nel nostro "sistema paese".
Per queste ragioni, l'analisi del lavoro artigianalel in uno specifico contestocittadino, la Salerno del XVIII secolo, non è soltanto una mera rappresentazione diun segmento socioeconomico che ha ar,rrto un parlicolare rilievo nell'ambitolocale, ma anche, e soprattutto, I'idea di prestare attenzione ad un modello sociale,con le sue prassi organizzative, i suoi contenuti, le sue problematiche. leinnovazioni, le complicazioni determinate dalle esigenze della quotidianità, gliinevitabili difetti strutturali. Ed è anche un'occasione per svelare i punti nodali diun'identità e di un modo di essere, di comprenderne le strategie. di coglierepossibili compoftamenti organici e similari tra artigiani spesso in interazione traloro ma con storie, prospettive di lavoro e di emancipazione sociale alquantodifferenti.
Pur trattandosi di un mestiere per sua natura individualista, infatti, non eraprivo di mansioni e funzioni che dovevano necessariamente integrarsi. con équipe
* In questo saggio si presentano alcuni aspetti della tesi di doftorato Il lat'oro arfigianalea Salerno dal I 7 3 4 al I 7 64 di prossima pubblicazione.
I Per uno studio del mondo digli artigiani si vedano i classici P. MALANIM A. Economiapreindustriale. Mille anni: dal IX al Wil secolo, Milano, Mondadori. 1997, E. LUCIE-SMITH, storia dell'artigianaÍo, Roma-Bari, LaÍerza, 1994; Storia dell'artigianatoeuropeo, Milano, Etas, 1983; Storia dell'artigianaîo italiano, Milano, Etas, 1979; A.FANFANI, Storia del lavoro in Italia dallafne del secolo W agti inizi det XVIil, Milano,Giuffrè, 1959; L. DAL PANE, Storia del lavoro in lratia daglí inizi del secolo XVIII al1B1J, Milano, Giuffrè, 1958.
97
STvANA Sclq'nnorra
destinate a collaborare, come nel caso -deltr'industria :1:7:oui' oppure a
sperimentare forme oi-"ó.riorr" lavorativa, 1e società tra artigiani che praticavano
1o stesso mestiere, rese opportune dalle peculiarità del lavoro stesso'
Unmondodeisemplicichepresentacarufteristichepropriediunlavorometodico, lr,
"rri "ontuuuio le contào)-l'abilità e la destrezzamanuale congiunte
all,uso appropriato d;;ii ,tÀ*enti, un,attività che impegnava le braccia ma che
necessitava oi ing"gio, "Jl
pttOitposi,'ióne' di formaiione' di creatività' di
-*"J"tita e precisió"e' n' Oi rlttu disciplina' anche ferrea'
Si tratta di lavoratori ora compr.rri d;ii";;;ole delle corporazioni3, - sebbene
a Salerno labili e poco aggressive -' 9*;tù Juy2ci {i s.ottrarsi ai laccioli delle
organizzaziorri ai *"riúr;:;ih ricerca oi sóuri oiìiuerta.eo autonomia o, forse, più
sempiicemente, prorettati verso il ,uperu-Jnto aette rigidità sociali ed economiche,
nel segno del lento, *" it.t"t"tile, cambiamento dei témpi' Capaci di produrre per
sé, per i propri bi.";;i;;;di ; r1-illuti' ma anche con un occhio attento al
mercato; soventi rinJt iusi nella ristrett" ;;il del proprio. -old.9 p:"d"ntT^,:l
economico, *u un.t " ui"'tt t i""ttUili a leggere.i mutamenti sociali ed economrcr'
ad interpretur. r" n*uà.ìig.rrr. della^coriinità in cui operavano, ad adattarsi, a
modellare la propria esperienza p'of""iÀnute in ragióne delle esigenze che
provenivano dalla società'
L'economia artigtanaha alT rto come suo fulcro e luogo di espansion: 1T^":lt:trbantzzato a"ilu .lt?a, p.r àuerto motivo abbiamo rivolto la nostra attenztone a
tuno l,arligianato il;;í;^.-"perativo "rini.r* del capoluogo' Anche se nelle
campagne gli artigiani "on
erano certo assenti' - e nel caso di Salemo c'è tutto un
mondodiartigianilegatoaicasalidetlacitta,cheandrebbericostruitoeripoftatoalla luce -, ma è .opiu',*no ,rell'area.rruu*'.rr. essi appaiono consistenti4' qui' la
2 Per una comprensione deile diverse modalità di
veda P. MALAi{IMA, Economia preindustriale'orsanizzazione del lavoro arti gianale. si
Uirtu onni. dal IX at Wllt secolo' cit"
oB tlOf.not"o a tal proposito A. poLoNI, strutturazione der.mondo corporativo e
affermazione del popoto à Lrrro nel Duecento, in ,,et"rtiuio Storico Italiano))' III' 2001 '
pp. 449-486; Genua oiu'lo' pu'unin' Finanzl "o*mu"i e lusso a Genova tra WII e
,III secoro, Genova, San -Giorgio
Edrtrice," ióòi; p. - MASSA-A' MoroLr' Dalla
corporazione of .utuo'roìiorso. drganizzorioiu u tutela det lavoro tra WI e XX secolo'
Milano, Franco Ars"i;";óó[, É cuENii:P."Vrassa-4. MoIoLI (a cura di)',
Corporazioni " g'uppi"p'íini''i'onon 'nU'notio
moderna' Milano' F' Angeli' 1999; D'
7ARDIN, Corpi, ,1iat"eín|iii;:, mestieri nulto storio detla società europect' Roma, Bulzoni'
1998; L. MASCILLT rvtiCnOruX', Il sxim}-i,il" orti, Xapoii, Guida' 1992 C'
MOZZARE,LLI(acuradt),EconomiaeCorporazioni.Ilgoverno.degliinteressinellaStoria d,Italia dat U"aiiíro all'età ,ontuírrororeo, Miiano, Giuffrè' 1988; Arti e
corporazioní nelto stlrio d,Irolio, Spoleto, cir,r" Italiano di studi sull'Alto Medievo'
t1u3ì u.uu per un confronto F. soFIA, Economia e società a
-salerno nel settecento:
sînttture demografiche'-n-iiuttur" pro7rrrionoTi'l'ila metà del secolo' in <Bollettino Storico
98
5
Artigiani nella Sctlerno settecentesca
domanda dei beni pfodotti dall'artigiano poteva avere maggiori dimensioni e
permettere la prolifeiazione di .rrr'u-piu gamma di mestieri e di specializzazioni'
inoltre, era più agevole reperire le màteriè prime, in quanto il volume dei traffici
era largamente ..r"periote rispetto alla campagna e vi era una maggiore possibilità di
reclutare manodoPera.Salerrros, "À" uur"-o modo di rilevare, non ci appare una città isolata,
perché una buona parte delle funzioni degli artigiani era disponibile in loco, e
tuttavia, la comprensione del suo "fare artigianato" richiede la necessità di entrare
nel suo contesto urbano ma soprattutto di comprendere le interazioni che essa ha
avuto con altre vivacissime realtà poste a non proibitive distanze.
È questo che ci permette di parlare di una vitalità complessiva dell'arligianato
e, di cónse gtreîtza, ci prospetta segnali di trasformazione della struttura sociale
urbana e, soprattutto, dicogii"re le progressive afiicolazioni del sapere artigianale'
Così come .*.rgoio segnali -
distinguibili (ed inevitabili) di quella
funzionalità simbiotica tra arligiano e commerciante, o\ryero tra produttore e
distributore di beni e servizi, e tia queste due figure ed il consumatore' I1 tutto nel
contesto di una città che conosce una fase di espansione demografica, nel lasso di
tempo da noi considerato che va dal 1734 al 1164, doluta anche ad un costante
trasierimento a Salerno di lavoratori provenienti dalle vicine realtà urbane e rurali'
ed in cui si registra molta prudenzi ner compofiamenti dei suoi ceti benestanti,
aweduti ed aùorti ad evitare le più che abituali incertezze economiche ed a
tenerne sotto controllo 1e possibili incidenze.
per entrare nel vivo della realtà salemitana occoffe paftire, gioco forza, dal
dato numerico, che chiarisce l'entità del segmento economico di cui intendiamo
occuparci, che rappresentava il 30% della poiolazione attiva di Salernoo.
di Salerno e Principato Citru, a. VI, n. 1, i988't per uno studio del Capoluogo úel Principato Citeriore nel XVffi secolo si vedano G'
RESCIGNO, Salerno nei Settàcento. Economia e Società, Salemo, Plectica' 2005; A'
PLACANICA (a cura d1), Storia rii Salerno. Salerno in età moderna, Avellino' Seilino'
2001; A. MUS1, Salernoiodnrno, Cava de' Tirreni, Avagliano editore. 1999; A' M RAO'
Salerno nel Settecento; una città e lo stato, in <Rassegna Storica Salemitana>' a XlI' n' 2'l'
dicembre 1995, pp. 205-232;F. SOFIA (a cura d1), Saterno e il Principato Cin'a nell'età
moderna (secoli-wtxtxl, Napoli, ESI, 1987; A. MUSI, Ctthura e fttn:iotti tÍbane a
Salerno, in <Rassegna Siorica Salernitana>, a. III, n. 6, dicembre 1986. pp. 143-154;
IDEM, Il Principato Citrct dal 1266 at 1861, in Storia del trIe:;ogiorno, v. Napoli'
Edizioni del Sole, 1986, pp. 231-328. Per un'opportuna collocazione del Capoluogo nel
complesso delle vicendé à"t R"gno di Napoli ne1 periodo in considerazione si veda G'
GAiASSO, Storia del Regno à l,lapoti,1v, It M"rtogiorno borbonico e napoleonico
(1734-1815), Torino, UTET, 2007.' u C. nSSóÍ GNO, ialerno nel Settecento. Economia e Società, cit., pp. 225-226.
99
SweNe Scrennotra
SALERNO: NUMERO ARTIGIANI DIVISI PER SETTORI(r734-1764)
SETTORI TOT. o//o
t52 26.6T
^\/.IR ATORT DEI, SETTORE EDILIZIO
87 15.3I AVOR ATORI DELLA LANA E DEI TESSUTI
LAVORATORI DEL LEGNO
LAVORATORI DEI METALLI
r A\/OR ATORT D] PELLI E SCARPE
72 12.6
68 r 1.9
63 l1.l
T ^\/NR
ATORT ADDETTI AI SERVIZI 49 8.6
34 6LAVORATORI DEL SETTORE TRASPORTI
LAVORATORI VARi
TOTALI
45 7.9
570 t00
Fonte: ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (da questo- 1no-ry:tto tn
Protocollí Notarili, sur.*o, u[. 115l-5155; 5160; 5184; 5195-5199; 5216-5224;
5256-5216; 52.79_5285; lz'aÀ; szso s2s3; s296-5301; 5304-5314; 5317-5343:
5380-5381 ; 5387-5388, 5390-5393; 5400-5402; 5406; 5408; 5410 5429; 5434'
f 'EGENDA: r^*^-: r'r^cno*i in,orn '' scrittoriari' secatoriruno'*o.ia.llegno:chitarrari,falegnami,indoratori,intagliatori,organafl
di tavole' 1-L^-.: ^-^^-+:--: chiavettieri, ferrari,lavoratori dei metalli: ammolatori, argentieri, bommarart, campanafl'--
fontur',uti, forbiciari, orefici, ottonari, ramari'.tornieri'
lavoratori di pelli e scarpe: calzolai/solapianelli/ciavattini' pellari' -,.:
tavoratori adàetfi ai servizi: barbieri/perucchieri, panettieri/maccarronart.
lavoratori del settore .Oititio, caicarari, fabbricatori, marmorari, pipemieri' scalpellini'
stuccatori' d'oro e d'argento' arte della lana' cappellari'
lavoratori della lana e dei tessuti: arragamatorl
cardatori di lana, .on"iurorl di calzetie, fattori di coppole "di
luttu, sartori/cositori. tessitori,
tintori di cappelli, valcatori' . --:t^^*^-.lavoratori del settori irusporti: brigliari, capezzati, calestlca*ozzieri' guarnamentarl'
maniscalchi, mastari, sellari' . --^L
lavoratori vari: artificiari, ceraioli, faenzarì,orologiai, pittori' scultori' vetran'
Dai contratti rinvenuti nei protocolli notarili rogati nella città di Salerno
abbiamoricostruitoilnumerodiquegliarligiani-che,nell,arcoditempoconsiderato, esercitavano iìprop.io *.ttió a Salémo: 570 lavoratori in tutto' Essi
svolgevano 53 differlnii td..ti"ti che, per opportunità legate alla possibilità di
operare confronti e comparazioni, ma anche e soprattutto per :l]*1"^t::^::analoghe competenze, abbiamo preferito raggruppare in otto macro settorl' come sl
può evincere dalla tabella medesima'
100
poi ASSA),5229-5239;5355-53'72;
ì
I
Il!;-
Tenendo conto di questa varia articolazione e di questa vasta gamma diopportunità lavorative, possiamo dire che Salerno ,runturr. una sostanzialeautosufficienzanella produzione di beni di uso corrente e servizi, nel senso che ciòdi cui aveva bisogno la popol azione poteva essere reperito agevolmente in sedelocale. Questo aspetto, tuttavia, non baita a qualificare le carattàristiche del sistemaproduttivo artigianale della città, che appare, per altro verso, tutt,altro cheracchiuso nel perimetro urbano del
-óapolu-ogo di principato citeriore,
beneficiando, infatti, di una più vasta retè di relazioni sociò-lavorative, dispecialisti e di figure assenti in città ma, come dire, a portata di mano. Iniatti,l'impoftazione di addetti a specifiche mansioni, in particolàr modo in riferimento alsettore edilizio e ad ambiti di tipo aftistico, e ìa possibilità di fruire di altrecompetenze non locali, ma reperibili nelle aree poste nelle vicinanze e non cefiorestie a trasferirsi a Salerno (in via anche temporanea o quotidiana), arricchiva ilcomplesso delle competenze della città, ne imple^mentava la dinamicasocioeconomica, agevolava il superamento del tessuto protezionistico urbano, inlento ma progressivo dissolvimento. Inortre, creava le iondizioni per un vero eproprio "sistema" artigianale che intersecava i destini di Salemo con quelli der suoicasali, con San Severino, con cava, con la costiera amalfttana, con la Caprtale econ la piu depressa area posta a sud di Salemo.
Va da sé che, pur con tutte le sue debolezze economiche e criticità sociali,Salerno mantenesse un appeal ed un livello di gradimento fra i lavoraton dr altrecittà_vicine, ai quali certo non dispiacevan o la mltezza del clima e le non disager.olistrade di comunicazione. Trasferirsi dove c'era lavoro poteva essere una necessità,tuttavia, il costante implemento dei servizi e, di consegLtenza, degli arti_eiani. nonva disgiunto da condizioni materiali tutt'altro che siavorevoli ihe si-pote.''unoriscontrare nel tessuto urbano di Salerno.
Infatti, essa era una città media che presentava alcune specifìche funzioni chetendevano a contraddistinguerlaT. una di tipo economico, ln quanto iuogo diconcentrazione dei mercanti durante la fiera di settembre. Istituiia nella secondametà del XIII secolo, anche se appariva in declino nel corso del Settecento. restavapur sempre un momento di aggregazione sociale ed economica. Riconosciamo. poi,specifiche funzioni di govemo e di amministrazione, in quanto la città era la sededella Regia lJdienza, organo di controllo politico chè aveva anche caratteregiudiziario, della Percettoria provinciale, uflrcio finanziarto. e di do_eane: di tiporeligioso, per la presenza della Mensa arcivescovile e di nume.or" .hi.r., infine,era caratterizzata anche da una funzione di tipo culturale, in quanto erano operativila Scuola medica, di rilievo europeo fino alla fine de1 T....nto. e l,annesso
Artigíani nella Sqler no settecentesca
7 Per uno studio storiografico del ruolo e delle funzioni delle cinà medie nel Regno diNapoli si veda A. MUSI (a cura d1), Le citfa clel Mezzogionto in età ntodepra. Napoù, lSI,2000. Per un'analisi specifica sul ruolo di Salerno IDÈM, La citrà assenÍe; salerno nella"provincîalizzazione del Mezzogiorno spagnolo", in <Rassegna Storica salernitana>, a. v,n. 9, 1988, pp.63-82; IDEM, Cultura efunzioni urbane a Salerno, cit.
101
STvANA Scrannorre
co[egio, sorto nella metà del XV secolo. sebbene nel Settecento si ritrovassero in
una fase di stallod.Il prospetto sulla provenienza degli artigiani chiarisce in modo evidente la
capacità attrattiva del Capoluogo'
SALERNO: PROSPE.TTO GENERALE SULLA PROVENIENZA
DEGLI ARTIGTANL (r7 34-L7 64)
AREE GEOGRAFICHE
SALERNO
CAVA E CASALI
SAN SEVERINO E CASALI
AGRO-NOCERINO
COSTIE,RA AMALFITANA
ALTRE LOCALITA' DEL PRNCIPATO CITRA
NAPOLIr\Tn E pDTl\TaIPATO IILTRA
TOT. o//o
261 46.9
12',7 22.3
42 7.4
20 3.5
11 1.9
20 3.5
48 8.4
20 3.5
REGNO DI NAPOLI E STATO DELLA CHIE,SA
TOTALE
t5 2.6
5'10 100
F""t. ASSA. Ptotocolli Notarili, Salerno' ctt'
Entriamo nel dettaglio'Su un totale ai íi6 *tigiani presenti nel capoluogo del Principato c_itra, e da
noi censiti, 26J eranonativl "Oi
Salerno ed esercitàvano la propria attività alf interro
della città, costituendo 1147% della manodopera lavoratit'uìtt"ttu-ente locale' I1
restante 53oh, eq,rirrAip* J.fiu À"ta, era fonnato da specialisti provenienti da altri
luoghi' "imn dqtn crrl ortale I igiano su due non" In sostanza, il primo dato sul quale riflettere è che un art
fosse di Salerno.^""" È;;1";;
"h. q.,"rto aspetto avesse delle ricadute tutt'altro che secondarie sulla
città, non solo da "";;;; ài vista squisitamente lavorativo, ma anche sul piano
socioculturale e frnaict. O"ttu -"nàlità. Lo storico americano Biernacki ha
t A. M. RAO, salerno nel
EADEM, Il Settecento, ít Amoderna, cit.,P.62.
r02
Settecento:unacittàelostato,cit',pp'208-209'AncheinPLACANICA (a cura dr), Storia di Salerno' Salerno in età
Artígiani nellq Salerno settecente sca
sostenuto che esista una interdipendenza tra I'ordine economico o sociale, da unlato, e l'ordine curturale, dal|a1iro, ritenendo fondamentate ìl se"onoo rispetto arprimoe. Nel caso di Salemo |in"ialnru derla cultura sui processi di ravoroartigianale appare piuttosto. marginale 1" "omrnqu. d;'da dimostrare), maI'assenza di una vera e propria ,p"""ln"lta aftigianale locale e l,afflusso continuo divalenti artigiani da città vicìne creavano un ricorrente rimescoramento eriadattamento alle innovazioni negli stessi processi di ravoro. L,arligiano cheaccedeva nel capoluogo. d9l princif,ato poftava-con sé, in pratica, un bagagrio diesperienze e di abitrrdini che contribuivà a modificar.'qu"il. che sì erano andateconsolidando nella città. si pensi aile modalità di lavoio in Jqrip", ai tempi dircalizzazione di un'opera, al possibile abbattimento dei costi del lavoro per effettodella conco'renza che si "r"uìu,
ma anche al rapporto rru--*rtrunze ed afiigianilocali e.non,.con esperienze diverse ,n. "ntruuuno
inevitabilmente in contatto, conpossibili attriti, ma che finivano non di rado per contaminarsi.Il dato non resta isolato ed episodico, perché questo continuo travaso dioperatori da tenitori disparati delia provirr.iu " d"i R";;; rappresenrava irprosieguo di un processo iniziato.da tempo ed in_quarch" -ìo-oiia individuator0, inragione delf incremento urbanistico e demografico della città, e sarebbe stato untratto distintivo della sua crescita anche nei secoli successivi.
. Lo. screening degli aftigiani non nativi e/o non residenti a Sarerno. in unavalutazione che parra dar principato e a raggiera si ararghi "r
;r;;';;;;;r..'.,consegna questi dati: 1a vicina cava con i s-uoi casali .à rupp."sentata dal 22%degli arligiani;.a seguire troviamo San Severino con i ruoi "uràli,
con ii 79ó delrepresenze' Altri lavoratori, anche se in una percentuale rninore, pror-eni'anodall'Agro Nocerino, da cui arrivavano zo ,rtigr""i-iifiùr,'.enrre dalla 'icinaCostiera erano 11 gli addetti propensi a spostarsi, il2yo sultotale dei lar-oratori.completavano il,quadro ariri 20 artigiani oet erincifuto-ólr.u. pro'enienri dasvariate zone, Eboli, San cipriano, Montoio, Giffoni, corrispondenti ar 3o ir.Fuori
, dalla provincia, dobbiamo considerare il oàto significatir o de11acapitale, Napoli, con.l'8%o; mentre
_il 3o/o proveniva da Aveilino e dar principatoultra' Da altre località del Regno, cosenrà,.Rende, Strongoli. Aìtarnura. lratera,infine, pewenivano a Salerno uitri j: artigiani, e 2 dato Stato delra chiesa.
-n.*, BIERNACKI' The Fa.bricaÍion of Lobor. Gertttatt.t' ciltd Brirain. 1640-lgl4,Berkelel-Los Angeìes. Unirersiry of Calilornia pr.r., isn5." ''
^' sr vedano a tar proposito A. MUSI, sarerno mocrerto, cit.: D. DE\TE. Salerno tterSeicenro. Neil'inrerno d,. !n1 cirra. vor. tt pun'
^t. )rri,',' pì,'ì"i,"í,i ,',rir"r"'il,'ií rliii,Salerno,-Edisud, 1993; M. A. DEL GRosbo, sarerno nàr seicenro.,yerl,inrerno di unacitîà, vol. Il-parle il, Le attivita economi.che, Sarerno, Edisud. 1993' D. DENTE, sarernonel seicento. Nett'interno_di una citîà, vor. r,'rstitizi;;:i;,;i;,;:;t;,í;í;", Edisud, 1990; D.cosIMATo, salerno ner seicento. Econom'ia e società, Salerno, ruu.gtiu, toae.
103
SrvaNl Scrqnnorra
Ma chi erano questi lavoratori e quali le loro competenze?
Rispondere a questa domanda vuol dire acceftare la complessiva trama
dell'artigianato cittaaino, ma anche stabilire, entro cerli limiti, quali fossero le
esigenze- della domanda locale, di quali specifici servizi necessitasse la città, su
q,rà't Oi essi poteva contare in tempi piuttosto celeri, perché reperibili e disponibili
in sede locale, e di quali mestieri essa fosse quasi del tutto carente.
Sono aspetti di notevole rilievo che hanno reso necessaria un'attenta
ricostruzione del reticolo artigianale per specifici mestieri e per specifica
provenienza.possiamo confermare che a Salerno si trovassero piuttosto facilmente sarti e
calzolainativi della città, d'altronde erano gli unici mestieri riuniti in corporazioni'
i sarti nella confraternita del Santissimo s"alvatore di Drapperiall ed i calzolai in
quella di San Crispino e Crispinianot'.Vi erano anche barbieri, falegnami, orefici,
maniscalchi , cerresi, pittorí d'íncartate. Per il settore dei metalli notevole era
I'apporto dei lavoratori provenienti da San Severino, quello edilizio vantava ilprimato degli artigiani della vicina cava. Mentfe erano del tutto assenti nativi
salernitani óh. pruìi.u.sero le attività di indoratore, intagliatore, scultofe, vetraro'
faensaro, arragamatore di oro ecl argento. Per quanto riguarda tutta la filiera
laniera, occoffeva spostarsi nei vari caiali, come avveniva anche in altri centri, in
quanto la lavoraziòne completa di questa materia necessitava dell'opportuno
utilizzo di un corso d'acqua.
Ne deriva che la tipologia di artigianato che si era affermata e consolidafa a
Salerno fosse caratteriziatain modo prevalente da mestieri necessari e di supporto
alla vita quotidiana. Il rapporto con la città è una costante che aveva sempre
contrassegnato il mondo'àella produzione artigianale. I e attività manuali si
diversificavano e si perfezionuuuno in base alle richieste che provenivano
dall,ambito urbano. Poiché tutto doveva essere funzionale a questa esrgenza, c'era
poco spazio per l'arligianato artistico, se non in specifici e limitati campi di
intervento.
I1 successivo prospetto rende ragione della variegata trama degli arligiani sulla
base di una mobilità temporanea o definitiva:
tt ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (cia questo momento in poi ASSA),Intendenza'
Luoghi pií taici. Regole e statuti, b. 2017 , fasc. 30, copia dello Statuto recante la data del
13 g"iugno 1793;P .ÍROtt,q., Sîoria delle Confraîernite nella Diocesi di Salerno, Lancusi,
Gutenberg, 2002,P.13.-itîisÀ, Intenàenza, Luoghi pii laici. Regole e Statuti,b.20ll, fasc.4l, estratto dai
protocolli del Consiglio CoÀ.,ttute, adwanzi del 18 luglio 1890, la copia reca 1a data del'ZZ lugtio 1892; V. D'ARIENZO, L'arte tlei calzolai a Salerno in età moderna trct
assistínza e lo,voro, in E. DE, SIMONE-V. FERRANDINO (a cura d1), Assistenza,
previdenza e ntuîualità nel Mezzogiorno moderno, Milano, F. Angeli, 2006, vol. I, pp. 98-
1 10.
10-l
DDrl]
, r\v y lr\rQrrrr.tr r,l,wLl AKTTGIANI
ARTiGIANIDi SA_--ARTIGIANI ORIGINTRASFERITISI DEFINITIVAMENTE A SALERNOARTIGIANI DI ALTOCCASIONALMENTE
A SALERNO_--TOTALI--_ Foffi
TOT. o/
267 46.9
145 25.4
158 27.7
570 100
Artigiani nella Salerno settecentesco
ASSA,Protoco@
competenze, quasi come se fossero dei veri .- ;ì;ri',.;ì;;#'"..""il*l:ii:13 Le maestranze edili cavesi erano attive a Salemo anche nel Seicento. D. cosIMATo,Salerno nel Seicento- Econctmia e soci.eîìt, cii.,-p. 117.
Dalla tabella si evince che 303 artigiani provenivano da altre Iocalirà. di essi il250lo. si era rrasrerilo derìnitivame",.-, ii".r.";;,;;;;rJ: t';1.,n". Erano cororoche avevano bisogno di essere fiilil in maniera ;;il;;ra nerla boftega,
ffil'"1Xîi:runmestiere che necessit";;i un luogo fi.i;rd;; in un cui praticare
rl2\oh (corrispondente a 15g_ artigiani) aveva ravorato a Sarerno soro per unbreve periodo di tempo: si tratta ai .oÉ_-ro che erano deoiii -p"rr,rrno ar mesiiereedite. Di questi r5B artigiani ben eq ;;;;;r è;;;;;.;,;;, llii,, " re di \aporiQui conta molto la vicinanza o.rru
"iita d" h ò;;p"rl"i, ar vor_sere deila
fl;ff:XJtlorativa' sí poteva p"tt*."oì
'itornare u .uiu'ìn iì ,.rpo der tuno
Questa rete di artigiani, così come emerge dai dati sin qui esibiti. meritatuttavia un'ulteriore e più attenta riflessione.ci preme far rilevare come il oir"otro si presti anche ad un ra_eionamentomeno limitato e che osservi l'economia locale in un,ottica sisl-_i.u. pro'ando adindividuare le aree di speciariziizione^""h" nor, .;;-;"1;';eratir e a Saierno.tenendo conto di varis realtà viciniori e delle iì.o
"ìn.., iruuiri inrerazionieconomiche' Abbiamo già avuto .onr"Àu di un legame noio. *orto interessante,tra Salerno e caval3 per quanto riguarda i .uriri f;;;r;;;;;;;; I,a.t" a"i ceramisti(che, nello specifico, provenivanò dal casale costiero Oi Vio.if. emer_sono altricollegamenti. per esempio con sun i"*rino per ra rorte presenza di speciaristinella lavorazione dei -étulli, ancora cu,ra e i ,uoi .uruti f..'i ìu. orurori der iegno,Avellino ed il PrincipatolJltrap"tgri uaa"tti al settore dei trasporri. la capitale pertaluni specialisti d'ecceilenza" qíuli :, *ormorari. Forse si der e pensare ad
::ff"?':":.::^:liT: ed isolate, capacl di interagire proprio sLr,a base delle
10s
Sw.q.Na ScrARnorra
Terminologia moderna da ttrlizzare naturalmente con tutte le riserve del caso, ma
che sele solo a dare un'idea del reticolo organizzativo che si era andato
costruendo su base provinciale e ben oltre questa area territoriale.Infatti, come osservato, I'ottica sistemica legata alle specializzazioni riguarda
non solo alcuni casali di Salemo ma anche aree limitrofe alla città e la ricerca dilavoratori con parlicolari capacità ed attitudini provenienti dalla Capitale.
Si tratta di un circuito economico formato da mastri lavoratori che si
spostavano da una località ad un'altra per cercare opporlunità ed occasioni dilavorot4, ma anche e soprattutto la ricerca di una specifica manodopera qualificata
e riconosciuta come tale. E, evidente, poi, che ad alcune categorie, quali ad esempio
i marmorarl napoletani, si facessero richieste per affidare particolari opere diabbellimento o di parziale restauro delle chiese di Salerno. Tale committenzaproveniva dal mondo ecclesiastico, ma anche da alcuni nobili della città che negliedifici sacri si facevano costruire le cappelle di famiglia.
Quel che è importante considerare è che non si ftatlava di un sistema
codificato e strutturato, ma di una rete di servizi e di operatori in qualche modo
spontanea, che si costruiva con la prassi, con I'informazione e 1o scambio delle
conoscenze. Un sistema che si basava, ovviamente, sull'acceftamento diretto delle
qualità dell'artigiano, e dunque sulla sua esperienza, sulla sua pratica, ma anche, e
soprattutto, sulla sua affidabilità. Bisogna anche aggiungere che, in alcuni casi, la
richiesta della rnanodopera avveniva con il "metodo pubblicitario" del tempo,
owelo mediante l'afflssione dei bandi per appalti di grandi opere da realizzate,
quali le strade, che venivano posizionati lacldove si sapeva bene che ci fossero
specialisti particolarmente competenti''.Tutto cio awalora ancora di più la definizione che si potrebbe dare a Salerno
come una città non speciali.zzata, ma, nel contempo, come una città non certo
isolata.
Una digressione sulle commesse di lavoro e sulla natura de1le commitlenze
ne|l'arnbito del settore edilizio ci permette, per un verso, di analizzate i contratti
degli artigiani che, per I'appunto, provenivano da fuori città, per altro verso, ciconsente di allargare il ragionamento a quelle opporlunità che i privati e leistituzioni religiose riuscivano a garantire all'economia cittadina.
1a Claudia Petraccone studiando i mestieri presenti a Napoli nella metà del Seicento ha
rilevato che 1 1 tessitori presenti nella Capitale erano di Cava, il 40% det cositori proveniva
dai due Principati e dalla Tena di Lavoro, addirittura il 50% degli scarparl era di queste
località. Si trattava di artigiani che si erano spostati dal luogo natio per cercare lavoro' C.
PETRACCONE, Fonti e prime ricerche sui mestieri a Napoli alla vigilia della rivolta
antispagnola, in <Quaderni Storici>>, n. 26, maggio-agosto 1974,pp.501-522.tt ASSA, Protocolli l,{otorili,b.522l a. 1752, notaio F. Pecillo, Salerno, 26 aptile 1752,
cc.66v-6'7r.
106
Artigiani nella Salerno settecente sca
- In tal senso, appare evidente che la scelta dei mastri per eseguire determinatilavori dipendesse, per quel che abbiamo potuto comprendere, d-a due fattori: 1)dall'affidabilità dello specifico fabrica.tore, cerccraro, mormoraro o piperniere;2)dalle capacità che essi avevano di essere competitivi ofîendo prezziconvenienti.
r mastri fabricatori, ad esempio, provenivano, come detto, dalla vicina cava, eper i progetti di edifici di notevoli dimensioni avevano la tendenza ad associarsi inéquipe.
ci sembra opportuno citare come esempi, innanzitutto, ia costruzione dipalazzo Genovese, del barone Matteo, alla quale avevano collaborato i mastriLeone Jovene, Aniello catino, Matteo Landi, Mattia di Ruggiero (sostituito poi daAndrea Benincasa), Giuseppg Ferrara, tutti di cava. L'imporlo dell,opera era dipoco inferiore a 5000 ducatir6.
Possiamo fare anche riferimento alla cqsa palaziata di Ramrro de Ru_u_riero,patrizio salernitano del Seggio di Porta Rotese, per la cui realizzazione rtipjir-unoapposito contratto davanti al notaio Leone Jovene ed Aniello Catino. L'amnontaredei lavori all'edificio era di circa 3000 ducatil7. Ed infine la costmzrone di uncomprensorio di case per Giuseppe Barone da parte dei mastri Leone Jovene.Giuseppe Giordano, Domenico Antonio Serio e Antonio Giordano di car a eGirolamo di vita di Salerno. L'importo era di circa 1500 ducatilE. In questi casiesaminati, come in molti altri, non si trattava di vere e proprie società dr àiritto. madell'unione delle competenze di quegli artigiani òhe^ potevano così meelioassicurare il risultato finale sul piano tecnico ed unire le risorse tìna1zràrienecessarie per I'acquisto delle materie prime.
Tra gli arligiani più gettonati in città compare, in parlicolar modo. LeoneJovene, capo masfro fabricatore del casale di Alessia di Cava. già emerso nelleprecedenti commesse, il quale riuscì ad assicurarsi ben 12 contranr di iaroro.owero il 20% di tutti gli atti che abbiamo reperito tra r1 173-{ ed il 1?6-+.L'artigiano godeva, con molta probabilità di un cefio presti-eio ne1l'antbrto delsettore edilizio, ma riusciva anche ad offrire la propria .o*p.tèuru a prezzi molroconcotrenziali.
Tra i suoi interventi piu interessanti ricordiamo, oltre alla eià menzronataimportante tealizzazione dipalazzo Gerrovesere, la costruzione del iarnpanrle dellachiesa della Santissima Annunziata20, l'ampliamento del monastero di San
"'|vi,b.5311 a.7'744,nofaio S. A. de Fenza, Salemo.7 fèbbraro l--{".i.. cc. llr-16r.edatche lvi, Archiví Privati., Platea Genovese, n" 54, perizia del I7 agosto 1
-50. ft. 1r- 109r.t7 lvi, Protocolli Notarili,b.522A a. fi5ó,notaio F. Pecillo. Salerno. Li marzo 1750. cc7 7 r-8 8r.
't 1r,. b. 5391 a. 1758. notaio N. Salerno, Salerno, 7 aprile 17ig. cc. 6lr-63r.'-1vi. b. 5311 a. l744,notaio s. A. de Fenza, Salemo, T febbraio li44.cc.23r-26v-' Ivi,b. 5184 a. I 737, notaio S. Barone, Salerno, 20 agosto 1131, cc.g3v-g5v.
107
SweN.q Scmanorra
Giorgio2l e la costruzione di una taverna, con stalle e cantine per il barone
Geno=vese nel luogo detlo ít pagtiarone22.
Tenendo in considerazione, invece, i marmorarl, notiamo che ad ottenere le
maggiori commesse di lavoro (su 30 atti) era stato Nicola Vicinanzo, originario di
Napóti e residente a Salerno, con B incarichi. Occupandosi, per citarne alcuni, delle
riggiole colorate per la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Capriglia, casale di
Sàlèrnott, di diversi lavori in marmo per il Monte dei Mor1i, presente nella chiesa
di San Sebastiano2a, e della costruzione dell'altare maggiore nella chiesa di San
Pietro in Vingulis25. Seguiva Francesco Ragozzino, anch'egli napoletano, con 7opere in marrno negli edifici sacri della città. Quest'ultimo aveva realizzato, fra itanti, il pavimento per la chiesa della Santissima Annunziataz6 insieme a diversi
altri lavoìi di decorazione in marmo nel medesimo edificio2?.
Per quanto riguarda la natura delle committenze, abbiamo acceftato che ilvolume di quelle attivate per la manodopera dei mastri fabricatori denota una netta
incidenza dèlle domande dei privati, pari al 650À del totale dei contratti specifìci
per questa categoria. Se ci spostiamo invece nell'ambito dei marmorari, efano
soprattutto gli enti ecclesiastici a richiedere lavori aftistici, pertanto, le loro
commesse superavano ll 61% del totale relativo a tali artigiani. In quest'ultimo
ambito la committenzaprlata, come facilmente immaginabile, era esercitata solo
dalle famigl te patrizie.
Abbiamo provato a delineare taluni comportamenti degli artigiani in relazione
a tre questioni decisive sia sul piano "professionale" che dal punto di vista
strettamente personale e familiare: 1) rispetto all'acquisizione della sede logistica
del lavoro ed alla trasmissione de1 sapere; 2) al possesso dell'abitazione in cui
vivere; 3) alla logica matrimoniale. Bottega, casa e famiglia erano, d'altra parle, le
coordinate di riferimento della stessa identità di artigiano.
Pur riconoscendo che non è possibile fare generalizzazioni che non
renderebbero ragione delle diversifrcaztont inteme all'artigianato possiamo tuttavia
individuare dei òomportamenti abbastanza comuni ed alquanto omogenei.
Per definizione storiografica I'artigiano era colui che svolgeva una sola
occupazione, di consegltenza, raggiungeva una notevole abilità e l'affinava
concèntrando la sua ingegnosità sempre sullo stesso lavoro, acquisendo, così, una
tt |rí,b. 5266 a.1741, notaio G. de Fenza, Salerno, 6 agosto 1741, cc.339r-344v'
" Ivi,b. 5342 a. 1764,notaio G. Ricciardi, Salerno, 8 aprile 1764, cc.286t-294r'
'3 lvi,b.5l51 a. 1736, notaio A. de Notaris, Salerno, 3 matzo 1136, cc.62v-65v'2a \vi,b.5235 a. 174l ,notaío G. Sarlo, Salerno, 8 febbraio 1147, cc.35r-36r',, hi,b.5364 a. 1755, notaio c. Barone junior, Salemo, 8 dicembre 1755, cc. 8l9v-824r.26 lvi,b.5216 a.1735, notaio F. Pecillo, Salerno,2 giugno 1735, cc. 101v-107v't, Ivi,b. 5218 a.1741, notaio F. Pecillo, Salemo, 29 dicembre 1747, cc.295v-302v;b.
5219 a.1745, notaio F. Pecillo, Salerno, 2J marzo 1145, cc.88r-94v'
108
Artigiani nella Salerno settecentesca
specializzazione rilevante. Ogni articolo era prodotto grazie alle capacità fisiche edintellettive tramandate nel tempo ed ottenute con una lunga esperienza nello stessosettore.
In casi isolati egli praticava l'attività nella sua stessa casa, di frequente inveceaffÍtava (raramente acquistava) una bottega che diventava il suo abituale ambientedi lavoro. Ed era in questo luogo che costruiva un importante sistema di relazioni,perché doveva procurarsi le materie prime, vendere i prodotti finiti ed assumeremanodopera, avere quindi contatti con i venditori, con la clientela e con ilavoranti28.
Osserviamo, innanzitvtlo, che tali artigiani cosiddetti "semplici" praticavano illoro mestiere all'interno di una bottega, che, come chiarisce in modoinequivocabile la Baldassin Molli <è il luogo di lavoro che, nella sua genericità,spicca per la varietà dar,'vero amplissima di attività che può comprendere:I'artigiano produttore e venditore del suo prodotto a una clientela più o menoconosciuta, che a sua volta ordina specificamente la merce o acquista ciò che trovagià pronto, il rivendugliolo, l'orafo che inventa capolavori su esclusivacommittenza, il grande commerciante, chi vende generi alimentari, chi lena icavalli, chi lavora da solo o con apprendisti e lavoranti appartenenti o meno allacerchia familiare, l'artigiano indipendente o condizionato dalla grande manifattura,che concentra in un luogo un cerlo numero di lavoranti per lo svolgimento di unaparte del processo produttivo; nella città la bottega è insomma uno degli elementipiu caratterizzanti ed inconfondibili)2e. E evidente la concentrazione in un unicoluogo di una molteplicità di funzioni, dalla produzione alla vendital la presenza diuno o piu soggetti addetti alla realizzazione degli articoli e manufatti che sarebberostati poi destinati al commercio.
L'aftigiano, poi, poteva essere coadiuvato nelle sue mansioni dai figii o dainipoti, concentrando così I'attività nelle mani della propria famiglia. o anche daapprendisti che non avevano con lui alcun legame di sangue: in questo caso labottega, oltre ad essere luogo della produzione e della vendita, dir-entava anche unavera e propria palestra in cui imparare un mestiere. Gli artigiani. infafti,apprendevano l'attività manuale "andando a bottega"; in età moderna nonesistevano delle scuole propriamente dette che insegnassero i fondamenti delle arti;colui che voleva awiarsi ad un lavoro artigianale doveva aver svolto un periodo diapprendistato, utile per acquisire tutte le necessarie cognizioni-'0. Il giovane che
'* P. MALANIMA, Economia preindustriate. Mitte anni; dal IX al XI-U secolo. cit.. pp.
244-295.tn G. BALDASSIN MOLLI, I beni degli artigiani storici di Padot'a. in EADEM (a cura
di), Botteghe Artigiane dal Medioevo ctll'età moderna. Arti applicate e mestieri a Padova,Padova, I1 Prato, 2000,p. 17.
to Per uno studio dei contratti di apprendistato e delle modalità del suo svolgimento sivedano E. FRESCANI, L'arte di imparare. Note sull'apprendistato nella Valle dell'Irnonel WII secolo, in <Annali Storici di Principato Citru, a. VI, n. 2,2008, pp. 109-113; A.
109
SwaNe Scurinorra
voleva imparare un mestiere doveva "sottomettersi" ad ttn mastro ed osservare
attentamente le tecniche che quest'ultimo dlttlizzava. L'artigiano, colui che
lavorava stabilmente in bottega, aveva la capacità, la competenza e tutti gli alttezzi
per poter fungere da insegnante al tirocinante.
L'allievo che intendeva apprendere tutti i rudimenti del mestiere prima di
iniziare ad istruirsi lavorando ^dtrr.uu
stipulare un atto scritto davanti al notaio
(condizione vigente generalmente in tutti gli Stati regionali italiani sin dal
Medioevo, eccetto ch"e per i figli degli artigiani che intendevano continuare
l'attività paterna), nel quàle si pattuivano tutte le clausole attinenti l'attività che
avrebbe svolto all'intemo della bottega o anche nella casa dell'artigiano'
Abbiamo rinvenuto 51 contratti di apprendistato, nell'arco di tempo che va dal
1134 al I'164, relalivi a 18 mestieri. 11 maggior numero delle submissiones, 11 20%
circa, è a favore dei falegnami, seguono i calzolai con il l2oÀ citca degli
apprendisti.Considerando soltanto coloro che erano di Salemo, troviamo 13 ragazzi, di cui
uno del casale di coperchia. Differenti eralo i mestieri ,?i quali essi intendevano
dedicarsi: 4 sceglievano di fare il falegnamelr, 2 I'oreficet' ed altri 2 i calzolaf .3 , vi
era. ooi. oer le "..roUo"-i
ii frUll"t. di conciutore di peller5. di sartorb' di
fAb,rirorcìeI e di parrucchierei8. un unico tirocinante per ciascuna attività'
Lo scarso numero degli apprendisti locali in rapporto al totale degli arligiani ci
induce a pensare che il Lertiàt" continuasse ad essere trasmesso soprattutto in
VERONELLI, I maestri del saper fare. Le scuole dei mestieri d'arte a Milano, in P'
coLoMBO (u "rrru
di), Genii e materia. contributi per una Mnizione del mestiere
d'arte,Milano,Vitae'pensiero,2000,pp'82-83;M'P'ZANOBONI'Ilcontrattodiapprendistato di Giovaini Antonio Amaàeo, in IDEM, Artigiani, imprenditori, mercanti'
òigonirrorione tlel lavoro e conflÌtti socialÌ nella Milano sforzesca (1450-1476), Firenze,
La Nuova italia, 1996, pp. 114-i82;M. A. DEL GROSSO, ArtigianÌ e botteghe a Salerno
nella prima *"íì, dnl 'iò0, i"F. SOFiA (a cura di), Salerno e il P-rincipato Citra nell'età
mode)no $ecoli WI XHj, Napoli, ESI, 1987, pp' 567-584; M' NEGRI' La formazione
artigiana tra bottega e scuola, in Storía dell'Artigianato ilaliano, cit., pp. 208-212'- tiTsil, plrotoíoili Notctriii,b. 5231a. 1738, notaio G. Sarlo, Salerno, 9 ottobre 1738,
cc. 30lv-302 r; b. 5233 a. nú.,notaio G. Sarlo, Salerno, 29 luglio 1142, cc' 257r-258; b'
5311 a. 1749,notaio c. Sabatino, Salemo, 30 novembre 1749, cc.545r-545v;b.5334 a'
1756, notaio G. Ricciardi, Salerno, 15 novembre 1156, cc' 540v-543v',t ir;, i. si.zo a. li3l, notaio G. Sarlo, Salemo, 2 novembre 1137, cc. 342v-343v; b.
5312a.l740,notaioG.Vassallo,Salerno,8febbraioll40,cc'20t-2lv'-1,-tui, U. s:r 1 a. 1736, notaio C. Sabatino, Salerno, 24 gennalo 1736, cc. 16r-16v; a'
1 737, notaio C. Sabatino, Salerno, 4 agosto 1737 , cc' 58r-59r'' 'i íri, a. l7 42, notaio C. Sabatino, Salerno, 1 novembre 77 42, cc' 295r-295v '
" hi', a. 17 47 , totaio C. Sabatino, Salemo, 25 ottobre ll 4l , cc' 463r-464r '
.u hi', a.1736, notaio c. Sabatino, Salemo, 20 novembre 1736" cc. 35r-35v.t' hi', a.1739, notaio C. Sabatino' Salerno, 21 aprile 1739, cc' 130r-131r'tt;";, b. 5198'a. ll46,notaioF. A' Casale, Salemo, l2 agosto 1146'cc'2lk-212v'
110
Artigiani nella Salerno settecentescct,
ambito familiare, che, come abbiamo già riferito, non era soggetto a codificazionecontrattuale. Per coloro che preferivano continuare I'attivitJiatema il periodo diapprendistato si svolgeva nella bottega familiare e tale decisione forù non erasempre propriamente_una scelta, in quanto era necessario che almeno uno dei fijnmaschi proseguisse I'arte del padrè, per proseguire un'attività ben awiata osemplicemente perché era l'unica fonte di sosientamento della famiglia. cioavrebbe anche evitato l'onerosa assunzione di altri lavoranti o apprendisti.
Ritornando al discorso della funzionalità delle botteghe notiamo che gliartigiani salernitani tendevano a prenderle in locazion", "*u
non vi era unacontinuità nell'affitto (situazione présente nei secoli precedenti, tanto che le stradedella città solevano prendere il nome dai mestieri in Ésse pruti.itiilj, p;;;i;;;J;Pas.savano da un artigiano ad un altro anche non appartenènte al medèsimo ,"ìto.".E il caso del falegname Francesco Martorano che nel 1735 affiltava due locali dalConservatorio dell'Annunziatella, uno da adibire a bottega e I'altro a magazzinonel quale accumulare il legname, sino a quel momento íd,attati uno a ooit.gu oimLTrmoraro e I'altro di maslro d'ascia. Si trattava di due ambienti situati própriosotto il conselatorio. Martorano li prendeva in locazione per sei unni p"i t sducati annuiao. Ed ancora quello det càkolaio Andrea Incagliato (anche se questorappresenta uno dei pochi casi ritrovati di enfiteusi di botteghe), ii quale nel 1749stipulava il rogito per entrare l'anno successivo nel pieio lodimento di unabottega, sita di fronte all.apiazza di Sant'Agostino, la quale sino a quel momentoera stata adibita a merceriao'.
Questa mobilità logistica dipendeva dal fatto che gli artigiani subivano leinsidie delle condizioni economiche generali che non u."ri..rrurruno la necessariacopertura delle spese di affitto, ma poteva dipendeva dal fatto che ad essereconcesso in locazione fosse il nudo locale, irr quanto gli attrezzi del mestiereappartenevano agli artigiani, i quali dovevano acquistaili per poter aprire unabottega. coloro che non urr"vano il denaro per fario urr"uuno dìe opzioni: o simettevano in società con altri o restavano semplicemente dei lavorantr. Alcontrario, alcuni particolari ambienti, quari i giardiniper biancheggiare lu ..rao, eà
^3e I lavoratorj di pelle, ad esempio, avevano le botteghe in strade adiacenti. in Ruga deCoriariis, in Ruga de Calzolariis, itt Ruga de CoriÌserils. A. SNN o. Corttnercio e
indusÍrie nel Salernitano dal XIII ai primoldi del XIX secolo. vo1. Il. Salerno. Spadafora,1e54" p.76.toASSA, Protocolli l{orarili,b.5tg4 a. ll35,notaio S. Barone. Salerno. ri marzo 1735,
cc. l7v-19r.a^t,t\,i,A
52j,6 a. 1749,notaio G. Sarlo, Salerno,2 luglio I..49. cc. I22r_124v." [vi,b.5271 a.1745, noraio G. de Fenza, Salerno, 30 lugiio 1745, cc.510v-513v; b.5336 a.1758, notaio G. Ricciardi, Salerno,4 febbraio 175g,;. 35r-44v;b. 5314 a. 1i60,notaio N. de Berardinelli, Salerno, 22 gennaio 1760, cc. l2r_16v.
111
Swaua. Scrq'nnotta
una faenzieraa3 sita nel territorio cittadino, venivano dati in affitto con tutti gli
strumenti utili per esercitare il mestiere'
Spostandoci i,';Ài; più propriamente domestico, rileviamo come gli
artigiani salernitani t.rrààr..rà p"i to'più a vivere in dimore prese in enfiteusi,
owero, affittavano gii irn,,'oOiil ed avevano I'obbligo, derivante dalla tipologia
contrattuale, di apportarvi dei miglioramentiaa, arrivan-do, in alcuni casi' a costruire
anche altri varri uccanto u q,r"llipreesistenti. È il caso, ad esempio, di Giuseppe
Pagliuca, chitarraro,"h" inút'nt à1 f'uttllo Pasquale' Po-tl"-d:uu a titolo enfiteutico
una casa, con piu ,turrr" . munita di stal1a, di pràprieiÀ.del Monte dei Mor1i, a cui i
due uomini devolvevano ogni anno poco piri di 2O ducati,di affitto' L'artigiano
aveva fatto costruire ;;;"1; all'edifióio altie tre camere, delle quali adibirne una a
U"t.Àu; investendo 300 ducatia5'
Alcuni di essi, pol,;;;;a"tano in enfiteusi delle case' pur possedendo già una
struttura abitativa in.ui'rlri.aere;1'obiettivo era subaffifiàre aterzi' tendendo in
questo modo ad ln.r.-"ntu'e le pioprie entrate' magari per cedere ii Yi T:111t-:,1r....riuo il bene, insieme alle^migliorie che vi erano state appottate, al proprl
eredi, considerato che l' enfiteusi durava tre generazioniao'
Vi erano unrh.";"#il;;";-t, fia, nella generalità delle vicende, gli
addetti alle arti *un,uiit.rrdevano ad affittare rop'uttútto.le,botteghe' Ambienti di
lavoro che potevano essere anche compresi nellà casa di abitazione al suo piano
inferiore. A tal p;";"*;,-òosimato'ha. notato, in riferimento alla salerno
seicentesca, che le ,àrn pitoti"te del patriziato, ampie e spaziose, presentavano
alcune dipendenze, ó;t'ú;;hg, TTi' masazzini e stalle che venivano spesso
concesse in locazioné ai vari artigiani "h"
pop"olarrano la.cittàa8' Pochi erano coloro
che avevano delle abitazioni di p.oprietà ed alcuni arligiani riuscivano ad
o' Ivi,b. 5233 a. l'742, noraio G. Sarlo, Salerno' 27 luglio 11!2,' c1 249t-252r'b' 5326 a'
ti44,notaioC. ni.cJrd,,-Àuì.*o, tO iprtt:^tii+, "..1:6t-t3go; b.5329 a' 1751, notaio
G. Ricciardi, Salerno, 8 marzo l'751' cc' lSt-SZi;b' 5337 a' 1159' notaio G' Ricciardi'
Salerno,25 novembre l'759,cc' 597r-603v' -
oo lvi,b.52g1 a. rzii, ""i"i"'o. Mele, Salerno, 5 giugno1735' minuta, 1e carte non sono
numerate;b. 5253 a. ll36,notaio G' A" p*'u' SutJ-í' f S maruo 1136' cc'261r-266r;b'
5260 a. l73l,nofatoó. aà'r"n"u, Salerno, zl-*i"o 1737 ' cc.l40v-157v; b.5282 a' 1741,
notaio G. A. Barone, Salerno, 16 febbraio l]41,cC,.62t.66v;Salenro, T maggio |741 ,cc.
170v-185r; b. 5321 u."iiîl,i*uro G. Ricciaral, sut..no' 4 febbraio 1146, cc' 36v-40v;b'
5215 a.174g, notaio G. deFenza, Salerno,2i'dicembre l'748, cc.134r-',740r; b' 5308 a'
tisó, notuio ó' Suuutino, Salerno,6 grugno 1159'cc' 1131r-1132r'-.o' lvi,b.5318 a. Il4i,notaioS'-A' de Fenza' Salemo' 8 agosto 1148' cc' 68v-70r'
ou lvi,b.526'1 a. tll+i,notaioG' de Fenza' bale'no''zs Àaegio 1742' c' 552r;b' 5311 a'
1751, notaio C. Sabaiino, Salemo, S "9y9*Ut"
17i1' cc' Z-o:t-eO:u; b' 5392 a' 176l'
notalo X. Salerno, Salerno, 15 febbraio ll6l' cc' 25v-35v'o' hi,b. 5304 a.l734, notaio G' A' de Cotìtott' Sufemo' 28 febbraio l'734' cc' 4v-12r b'
5232 a.1740, notaio à"Sutto, Salerno' 10 marzo l'740'cc'75t-'76v't' D. COSIM 1itO, Sotnl,no nel Seicento' Economia e Società' cit'' p' 154'
112
acquistarle gîazie ai prestiti che contraevano con terze persone, perché magariavevano trovato un affare nel "mercato immobiliare"; altri le ricevevano in ereiitàdai propri cati. La ricchezza familiare accumulata nel tempo influenzava in modopositivo lavita futura degli artigiani.Essi, poi, avevano un forte legame con la propria casa, luogo di vita e spessoanche di-lavoro, quando_la bottàga si trovava al piano inferiore; preferivanoprendere f immobile in,enfiteusi, in questo modo garaniivano ài propri figli di poteravere una dimora o nella stessa casà o, una voltà ceduta l,enfiteusi, intascando ildenaro che in precedenza_era stato ,p.ro p., i lavori di ristrutfurazione. come nercaso del calzolaio Paolo Manganellà che nel 173i riceveva in dono dalla madreFelicia Antella i lavori di restauro eseguiti in una casa tenuta ìn enfrteusi. sita nelluogo detro San Leo, der varore di roo"ducati.r.;ir;fti;;-;;.;;;ìi#Hì;"i;
al.mastro calzolaio per costituire la dote deila_figlia. ggri inàtti, ro sresso giornodella donazione stipulava i capitoli matrimoniali íena l*;;;r,Appare, quindi,,palese in primo luogo I'attenrione che essi mostrar.ano per lacasa come principale. bene-rifugio, com" posto in cui vivere, ma anche comeoggetto di introito e, in qualche misura, di speculazion.. tnÀtti, questo int...rr"per le abitazioni da fittare in enfiteusi ci riciiama alla necessità di dispone delluogo fisico, appunto la casa, ma i vari documenti relativi al fitto a terzi ad unpÎezzo convenuto superiore a quello pattuito all'atto dell'enfiteusi ci drmostranouna sensibilità ed un'attenta pratica ìerso il patrimonio mobrliare anche comeattività speculativa che affiancava il mestiere prop.rà-.nr. esercitato.Naturalmente, si trattava del "massimo investimento finanziario,, possibile che essipotessero permettersi.
Jn secondo luogo, se il fatto che molti artigiani spendessero somme anchecosplcue per apportare miglioramenti alle abitazioni prèse in enfireusi aftesta laparticolare predisposizione che essi avevano verso questo bene. d.altra parte,appropriarsi di una :ru, anche pafticolarmente 'grande. risponder a arafondamentale esigenza di preservare liunità delra famiglia, che ci appare non unepisodico fatto ma una miiata strategia che rispond",ru'ud indubitabiii esisenze diaffetto,. ma che dipendeva ceftamùte dalropportLrnirà di ;;;;;;*.-.'i;"f"r;.
produttive della famiglia medesima.Il matrimonio diveltava una logica conseguenza di questa marcata identità; lafamiglia-era il luogo delle certezze, il punto nodale dell'esistenza. ma anche iiluogo della trasmissione del mestiere.Le eredità e le doti se.ivano per assicurare un futuro quanto meno dignitoso.Infatti' dall'analisi delle doti ricevúte dagli artigiani e da qr"tt. au essi donate alleproprie figlie notiamo una varietà nel loro contenuto, da quella costituita da solo
Artigiani nella Salerno settecentesco
on ASSA, Protocolli lr{otarili, b. 5195 a. rT3i,noraio F. A. casale. Sarerno, g maggio1731, cc. 156r-159r.to lvi, cc. l59v-162r.
113
SrvaNe Sclennotla
denaro a quella formata da beni, denaro ed anche Monti. La presenza dei Monti di
maritaggió era notevole; estratti a softe tra le fanciulle salernitane, contribuivano ad
urr*"niàr" l'entità monetaria della dote, ma molto spesso servivano a costituirla in
quanto si trattava di figlie di poveri artigiani o comunque provenienti da famiglie
non abbienti che non urr.uunb la possibilità di pror'vedere economicamente alle
Íagazze. Le doti ricevute dagli artigiani, nei capitoli matrimoniali da noi ritrovati,
oùilluuuno tra i 2l ed i 35b ducati; quelle donate alle loro fi'glie tra 10 e 400
ducati. Gli orefici costituivano un'eccezione: le loro mogli avevano portato doti
compfese in un range tra i 150 ed i 1500 ducati; le loro figlie ottenevano somme
un"oìu piu cospicué, dagli 80 ai 2000 ducati. La variabilità dotale riscontrata
corrisponde,ru àd una differenza di situazioni personali che difficilmente puo
permetterci di accertare la loro effettiva condizione nel contesto sociale della ciftà.
euello che appare evidente, al di 1à della concreta disponibilità di denaro, è
l'uso -parsimonioso
della dote che doveva selire per tamponare le esigenze
quotidiane e fornire al nuovo nucleo familiare quel supporlo necessario per awiare
là famiglia, ma che spesso diventava un vero e proprio investimento per I'attività
lavorativa. In sostanzà, non si registra un depauperamento dell'esiguo patrimonio
degli arligiani, come comprovato anche dal fatto che nelle doti compaiano somme
"rJditut. -clai
nonni, altro ìegnale di propensione al risparmio ed alf investimento
mirato e finanche Programmato.L'octlatezza, Lrnu gestione sobria, nessun cedimento al lusso, una
moderazione nei comportalenti e nello stile di vita: erano queste le regole auree di
quanti si affidavano esclusivamente al loro mestiere per contrastare le difficoltà del
quotidiano. E che ci fosse una penuria di disponibilità per molti di essi è
ampiamente dimostrato dal ricorso ài l'tonti che interyenivano per ampliare le doti
o, ao-a accadeva in varie occasioni, per SufTogare completamente il genitore
quando la poverlà e f indigenza la facevano da padrone. In ultima analisi.
liartigiano, ui.to itr un'accezi,one generale, era ben consapevole che il passo verso
b noZzepotesse rivelarsi utile per avere una spalla preziosaanche per il lavoro-.
t capitoti matrimoniali di un barbiere che aveva la sua bottega in città ci fanno
"o-pr.nà.re alcuni aspetti nodali dell'utilizzo della dote e della scelta della dimora
famiìiare. Nicola CimÀiniello, originario di Napoli, contraeva matrimonio la prima
volta nel 1748 con Angela delló Muto. La rugazza portava con sé una dote
sostanziosa, ben 350 ducàti, 200 in denaro le erano stati donati dalla donna presso
la quale aveva vissuto, Maria Siviglia, i restanti in beni, oggetti d'oro,. vestiti,
biancheria e mobili. Nicola, nel momento stesso della stipula dei capitoli, usava
150 ducati per acquistare da un altro perucchiero, Francesco Testa, tutta
l'attrezzaíra idonea a praticare il mestiere, subentrando anche nell'affitto della
stessa bottega che primagestiva Testasr. Notiamo come non sempre la dote venisse
utllizzatapér *"re problematiche familiari, ma spesso poteva trovare applicazione
t' Iri, b. 5357 a
numerate.
1'l.l
t
1748, notaio C. Barone j., Salerno, 6 settembre i748, carte non
Artigiani nella Salerno settecentesccr
anche per l'awio dell'attività lavorativa; il caso riscontrato dimostra per I'appunto
che la dote diventava determinante per aprire una bottega e comprare gli alftezzi
utili.Deceduta la prima moglie, lo stesso mastro Nicola sposava, due anni dopo,
Mariangela Riccio, ricamatrice, la quale aveva una dote di 130 ducati, 83 in Montie 47 in beni, oggetti d'oro e biancheria. I due coniugi avrebbero dovuto abitare in
casa della sposa per cinque anni, per fare in modo che Mariangela insegnasse alle
sorelle tutti i segreti del suo mestiere".In età moderna, i novelli coniugi delle famiglie artigiane solevano andare a
vivere per conto proprio oppure stabilivano la loro residenza presso la dimora dei
genitori dello sposo53. Situazioni differenti si verificavano sulla base di precise
motivazioni, come nell' esempio appena presentato.
Nella generalità dei casi, poi, ci troviamo in presenza di matrimoni
endogamici che awenivano, cioè, all'intemo dello stesso ceto sociale'. le nozze
erano pur sempre un affare di interesse economico.
Troviamo due conferme molto interessanti, che riporliamo come
esemplificative di quanto appena enunciato, due matrimoni che an'enivano
nell'ambito delle stesse famiglie, i cui capitoli matrimoniali venivano anche rogati
nel medesimo giorno.
I1 barbiere Francesco Testa, figlio del barbiere Giuseppe, doveva sposare Rosa
Feretti, figlia di un altro barbiere, Angelo Antonio. Quest'ultimo a\ie\:a costituito
per Rosa ina dote di 250 ducati, lO0 in denaro e 150 in oro e bìancheriesa. 11
fratello di Rosa, Bartolomeo Ferretti, anch'egli barbiere, doveva portare all'altare
Mariangela, sorella di Francesco Testa. Anche la dote di Mariangela era di 250
ducati, ZOO itt denaro e 50 in beni5s.
Da notare che la famiglia Ferretti non era formata tutta da barbien. in quanto
solo Bartolomeo aveva continuato il mestiere patemo, gli altri suoi tre fratelli,
Nicola, Pasquale e Domenico erano falegnami. E presumibile che i due
capifamiglia Angelo Antonio Ferretti e Giuseppe Testa si conoscessero molto bene
.d urr"..éto deciso di legare le loro famiglie con questo duplice matrimonio' Un
aspetto da tenere in coniiderazione, infatti, è la medesima entità monetana delle
due doti, in fondo, così, nessuno dei due artigiani avrebbe a\,-uto una dispersione di
denaro che invece si evitava grazie ad un'accorta strategia matrimoniale
In una prevalente forma di endogamia matrimoniale non poteva cefio mancare
chi ricercasse nozze vantaggiose per tentare la scalata sociale: fra tutti i capitoli
52 lvi,b.5328 a. 1750, notaio G. Ricciardi, Salerno, 8 marzo 1750. cc. 79r'-8-1r.tt R. SARTI, Vla di casa. Abitare, mangiarè, vestíre nell 'En'opa ntodenra. Roma-Bari,
Laterza,2006.to assA, Protocolli Notarili,b.5282 a. 1741 , notaio G. A. Barone, Salerno,6luglio
1741, cc.315v-320v.tt lri,
"".320v-325v.115
SwaNa Screanorte
matrimoniali studiati abbiamo ritrovato due casi. Quello di Giuseppe Sessa,
iut.gnu-., che nel 1735 contraeva matrimonio con Fortunata d'Auria, figlia
dell,orefice Pietro, *u, *-" possiamo leggere nel documento, <esso magnifico
pietro, che non ebbe mai p.nri"ro di dotaó defia sua figlia allorche contrasse il
matrimonio col detto mastrò Giuseppe, mentre se era in questo stato di poter dotare
detta sua figlia avrebbe stabilito collocarla con altra persona a se uguale)) In
"ff"tti, pietó d'Auria aveva ricevuto 400 ducati quando aveva. a sua volta contratto
matrimonio con la madre di Fortunata, una pafial'aveva impieg-ata nel negozio di
oreficeria, I'altral'aveva consumata per curarsi da un male che l'affliggeva e, non
avendo più denaro per costituire 1a dòte per la figlia per permetterle di sposare uno
Oi p"ii irado, lasciàva che la tagazza contraesse- matrimonio con un falegname, il
quale accettava di prenderla ii moglie senza che lei avesse una dotesT' Nella
iuttirp""i., che un falegname scegliJsse di sposare,-una fanciulla senza dote non
può che avere due ,fiJgurionl' ti Giuseppe era effettivamente innamorato della
ragazza; 2) rort.,rrJtu "pot"ua é"ttt. ia chiave di volta per un auspicato
-iglioru*.íto della cóndizione sociale. Da notare anche I'atteggiamento
dell,orefice che mal digeriva che la figlia "scendesse" la scala della società; occolre
considerare che gli oiefici fossero du,ru"ro un caso anomalo nel novero degli
"rttgi""i e che Jssi stessi (o almeno -una
parte di essi). avessero maturato la
convinzione che il loro status sociale méritasse maggiore considerazione e
riconoscimento.L'altro riguarda Graziadi vietri, figlia del panettiere Donato, la quale si unìv1
in matrimonio con il notaio Giuseppe Trrr"o, pòrtando una dote di 400 dtcati,240
in denaro, 100 in oro'" àólJiuoàteriett. Rilevante questo intreccio matrimoniale
tra ceti così diffèrenti che rappresenta una chiara eòcezione in un panorama di
standard che prevedeva per 1o più unioni tra pari grado'
Dall,esame A"i "upìtotl
matrimoniali emergà anche un ulteriore aspetto: su 68
artigiani, di cui abbiaÀo a disposizione gli atti che attestano la loro decisione di
convolare anozze,notiamo chè S & loro si sposavano pild:unavolta e 12 delle
loro consorti erano al secondo matrimonio; mentre su 42 figlie di artigiani che
prendevano marito, àruno 3 a sposarsi per la _seconda volta. Questi dati si
riferiscono alla sola valutazione dei capitàli, anche se.analizzando i documenti
nella loro complessità si scorge un numero maggiore di seconde nozze, segno di
un,ancora diffusa mortalità ,t""1 "orro
del Settecénto, ma soprattutto di un bisogno
a p;" degli artigiani (ma anche da parte delle donne) di avere una compagna con
cui condividere la pròti" vita, quàlcuno che accudisse la casa e' per alcuni
mestieri, anche di unà dònnu che potesse dare un'ulteriore mano nella bottega'
In ultima analisi possiamo sostenere che: 1) la variabilità della dote era
strettamente "onn"rru
alla variabilità delle situazioni personali e dei mestieri; 2)
tu 1vl, b. 5328 a.1749, notaio G. Ricciardi, Salerno, 22 gennaio 1749'c' 15v't' Ivi, cc. 14v-20r.t']";, U. 5t238 a.1754, notaio G. Sarlo, Salemo, 10 marzo 1754' cc' 56v-58v'
116
Artigiani nella Salerno settecentesca
non c'era un'attività manuale capace di dare più certezzerispetto ad un,altra, anchese non mancano arîigiani in grado di disporre di congrue doti o di dotareopporturamente le proprie figlie; 3) il matiimonio era in affare t a artig;lii,seguendo una costante endogamica che solo sporadicamente veniva infranta.Alla luce di tutte le consideiazioni sin qui fatte__l'artigiunÀ r.riu una volitiva figuranel panorama sociale, fortificato nell'animo dalla coriosc enza delmestiere che non1o avrebbe in alcun caso fatto diventare un.,marginale,,, costretto cioè ad andare adingrossare le {ila del disagio sociale, ed altresì u-ru p"r.oru "orrup"rrot.
dei proprilimiti economici ed attento a sfruttare le poche opportunità crre gri si potevanoprospettare.
l
tt7