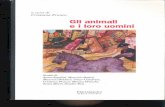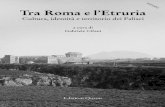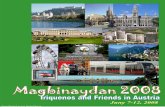2008. “Gli acroliti da Morgantina.”
Transcript of 2008. “Gli acroliti da Morgantina.”
I t
I
Rivisla di sloria dell'arte anlica e modema
Universila degli Studi di Siena Universita degli Studi di Napoli 'Federico II' Centro Di
Aprile·Luglio 2008
Prospettiva Rivista <Ii SlOria dell'artc antica c modcrna
Nn. 130-13 1, Aprilc- Luglio 2008
Univcrsitlt de.gli Studi di Siena Univcrsita degli Studi di Napoli 'Federico JI ' Cen tro Oi della Edifimi sri
Rivisla londata da Mauro Cristofulli c Giovanni PrcviUlli. RedaziOllc: Francesco Aceto, Benedetto Adcmbri, Giovanni Agosli, Alessandro Angelini, Alessandro Bagnali . Roberto Bartalini, Luciano Bdlosi, Evelina Dorea, Francesco Caglioti, Laura Cuvuzzini, Lucia Faeda, Aldo Galli, Carlo Gasparri, Adriano Maggiani, C lemente Marconi, Marina Martelli, Anna Maria Mum, Francesco Negri Arnoldi, Vinccnzo Saladino, Fiorella Sricchia Santoro, Fausto Zevi.
Direttore rcsponsabilc: Fiorella Sricchia Santoro Scgrctari di reduzionc: Benedetto Adembri, Alessandro Bagnoli.
Direzione e redazionc: Universit<i degli Studi di Siena. Dipartimento di archcologia e storia delle arti via Rom<'l 56, 53100 Siena, telcfono: 05 77 233636, e-mail: prospcuiva@uni si.it
Copyright: Centro Di , 1975-1982. Oal 1983, Centro Oi della Edifimi srI. Lungarno Serriiitori 35. 50125 Firenze. ISSN: 0394-0802 Chiuso in reda~ione: dicembre 2008 Stampa: Alpi Lito, Firenze.
rubblicazionc trimcSlralc. Un numero € 26 (ltalia c cstero). Anclrati € 29. Abbonamcnto annuo, 4 numeri € 100 (ltalia), € 140 (estero). C.c.p.53003067.
Distribuzione, abbonamcnt i: Centro Di della Edifimi sri via dc' Renai 20r, 50125 Fircnze, tclefono: 05 5 2342668, fax: 055 2342667, [email protected] www.ccntrodi.it
f\utori7.~ml.ione del Tribunalc di Firenl.e 11.2406 del 26.3.75. lscrizionc al RcgistrO Operntori ui Comunicaziollc u. 7257. IflVj\ Associa\o all'Ullionc Stampa ~ Pctiodica Italiilnil
Sommario
Clemente Marconi
Marco Ruffini
Francesco Caglioli
Gabriele Donati
Alessandro Campus
Simone Foresta
Flavia Coraggio
Silvia Colucci
Gabriel e Fallorilli
Lorenza Melli
Saggi:
Gli acroliti da Morgantina
Un'attribuzionc a Donalello de! 'Croeifisso' lignco dei Scrvi di Padova
J1 ;Crocifisso' ligneo di Donatello per i Servi di Padova
Un gio\'ane scultore fiorenlino e la congilltltura sanso\'inesca del pieno Rinascimento
Conlribuli:
RifleS$ioni sull'arte popolare puniea sarda
La coppa argentea di Mcrae. Spunti iconografiei per l 'inlcrprClaziorlc della seena di giudizio
Due rilratli in bronzo approdali nclle collczioni mcdicec. Una nota
Scultura gOlica senese: aggiuntc e prccisllzioni
Paolo di Gio\'anni Fei: una proposla per la pala Mannelli (con una nota sull 'iconografia di San Maurizio a Sicna)
La earezza di Gio\'annino: un IIUO\'O discgno di Raffacllo al LOllvre
22
50
107
135
147
154
161
168
183
Gli acroliti da Morgantina Clemente Marcon i
Gli acroliti da Morganlina costituiscono due opere di ri lieva de lla scultura greca arcaica, c due documenti di primo piano dcll 'ar\c in Sicilia nella seconda met,i del VI sceola a.e. I Gia appartencnti a una collczionc privata di New York, poi in prcsti to al Bayly Museum della Univcrsi-13 de ll a Vi rginia, Ie sculturc sono slate rcsliluitc all' ltalia e alia Sicilia da qualche Illesc. A breve, esse saranno csposte nel Musco di Aidone, dove si cooscrvano i materia li da Morganlina. In occasionc del rienlro delle scu lt urc in italia, des idcro prescnlaric in questa rivista, al fine di difTondernc In conosccnza nella comuni-1ft degli storiei dell'artc. I
In IOln lc, sono otto gli clementi pertinenti agl! acrol ili (fig. I): due teste, Ire mani e Ire piedi. Le due teste sono di dil1len~
sioni diverse, una leggermente piu grande de ll' altra. La stessa differenza c rile~ vabile nelle dimensioni di piedi e mani, chc sono in proporz ionc rispctto aile teste. Dato che anche il marmo appare essere 10 slesso, non puo esscrvi dubbio che gl i otto clementi appartengano aile stcsse statue, malgmdo I 'evidente d ifTe~ renza ne llo stato di conscrvazione - in particolare il grado di pul itura - delle teste rispetto aile mani e ai piedi. Piu prceisamenlc, ci troviamo in prcsenza di due statue acroli liche, ['u na (A) di dimensioni leggermente piu grandi dcll'a ltra (8). Dell 'Acrolito A si eonservano, oltre alia testa, entrambe Ie mani c i pied i. Dcll ' A~ erolito B si conservano invcce, ollre alia testa, solo la Olano sinistra e il piede destro. L'inserto eorrispondentc aHa testa dell' Aerolito A (figg. 2~4) si conscrva per i ntc~
ro e comprende il volta, dal punto di attaccatura de i capc ll i al centro dclla frontc fino alia basc del mento, e il co lla, fino alia base, corri spondenle aUe clavicalc. l La superficie e quasi complc ta~ mcnte inerostata in corrispondenza del
2 [Saggi]
colla c buona parte del volta, can I' eccezione del mento, della boeea, de l dorso dcl nasa, dei due occhi, de llo zigomo deslro e del margine destro della fronte. L' incrostazione in queste arce sembra cssere stata rim ossa in tempi recenti. La base del collo prescnla diverse seheggiature lungo il margine, de lle quali aleune recenti. II retro presenta d ivcrse scheggia~ lure su tutta In superfieie. La superficie dclla testa c segnata da numerosi gram, che risa lgono probabilmente al momenta dello scavo. Un grnfTio lungo e profondo alia zigomo, in partieolare, ha sfregiato la meta destra del volta, mentre altri graffi si osservano su lla frontc - sopra ]' arcala sopracciliare s inistra e, pili in alto, sopra I' arcata sopracciliare destra - , sui lalO sinistro del naso e pcr tutto illrallo che va dal la base del naso su quel lato fi no al labbro inreri orc, p<lssando per il labbro superiorc, nella meta sinistra del volta e in numerosi punli della superficic de l eollo. II limite superiore del1'i nscrlo, sui
1. [ due Acroliti (secunda meta del VJ scc. a.C.) all"Cl'OCa della [oro esposizione neg!; Stati Uniti .
davanti e in corrispondenza della fro nte, ha andamenlo ellitt ieo. II lim ite inferiore, corrispondente alia b<lse del collo, ha andamento semicireolare, ma alquanto sehiacc ialo. Un piano approssimalivamente vert ica le delimit·a I'inserto su I retro. Talc piano passa in corrispondenza della li nea delle oreeehie, che dovrebbero esscre incl use per ci rca Ire quarti, ma di cui manca pero ogn i indicazione. La testa s i dist inguc per i caralteri prollullciali dei tratti del volto. 11 naso e partieolarmente largo, s ia in corrispondenza del dorso che dell e narici . Le labbr<l carnose sono p ic~ gate in un sorriso accentuato, che deter~ mina agli angoli della bocca due profon~ de depressioni in corrispondenza della giuntura can Ic guance. Da tali depressio~
ni agl i angoli si dipartono due solehi che corrono I'uno sopra il labbro superiore e I'al lro, pill ma rcato, sotto il Inbbro infcriore, separando I'area della boeea dalla punta del menlo. Sono ind icate sia la picga Ira il labbro superiore e la base del
2-4. Aerolilo A, Testa. Aidone, Musco Areheologico.
naso, sin la picgn corrispondente al labbro inferiore. E bene precisare, pero, che a causa di un grafTio ehe attrnversa questa parte della testa, passando in corri spondenza delle due pieghe labial i, quella superiore in parlieolarc, lali pieghe appaiono ora assa i pilt marcate e profonde di quanto fossc ro all'originc. 11 mento, schiaccialo, c alquanto massicdo. Gli oeehi erano di riporto e non restano che g[i incavi corrispondenli. Entrambe [e pa[pebre sono incllrvatc - quc[la superiorc alquanto ncttamcnte a[ centro in corrispondenza del bul bo oeu[are - , e c'c una chiara difTcrcnziazionc Ira i due ango[i, can indieazionc della cnruncoln lacrima[e all'angolo interno. Le due palpebre sono indicate con leggero rili cvo, c ne c indicato il punto di unionc all'angolo eslerno. La palpebra supcriorc c in particolare ri salto ed c scpafala dall'arcata sopraeeiliarc da un solco abbastunza profo nda. 11 volta presenta palesi asim metrie: I'occhio sin istro e posizionalo pilt in alto del deslro, menl rc i1 mento e il nasa piegano entrambi verso la sini stra dcll'osservatore. Sui relro si distinguono numcrose Iracce dclla subbia, ul ilizzata pcr spianare e irruvidire la superficie. Tracee della subbia, len uta obliquamcnte rispelto al ia supcrficie , si distinguono anche su[ limite superiore. Su[ rctro, al centro, e all 'a ltczza del nasa, e un foro con relativo perno. II perno e modemo, come moderno scm bra cssere il relativo foro. Su i relro, dal margine superiore de[~ I' inscrto gi lt fi no al1'incirca all'a ltczza
del mento, la supcrfieic C stala legger· mente scavata can uno scalpello, cite Ita lascialo traccc evidenti. La depressione, che occupa 1a parte centrale della faecia posleriore dcll' inserlo, e antiea. Sulla superficie posteriore, nel quarto supcrio· re destro, 5i osservano una serie di Iracee di colore rosso. Tal i Iracce scmbrano sovrapporsi a un'i ncrostazione, C sono pertanto da eonsidcrarc moderne. 11 bor· do inferiore del colla presenta, in corri· spondenza dell a meta antcriore sco lpita , una banda liscia spessa circa un cent ime· tro, non perpendico[nre ma con una aceentuata inclinazione verso I'i nterno. Tale banda e ora visibilc solo in u[cuni punti, in parlicolare al li mite inferiore sinistro e destro, a causa delle numerose schcggiaturc di questa parte del coll a. L'inserto corrispondente alia mana destra (figg. 5·8) del1'Acrolito A comprende 1<1 mano, il polso e il principio dell 'avmnbraecio.· L.:indiee c seheggialo e la superfide presenta inerostazioni in corrispon. dcnza del dorso, del pa lmo e del cava d'inneslo. La mana si disl ingue per Ie dita alquallto lunghe c per Ie unghie alquanto sviluppale eben marcate. La struttura ossea del polso c accenuata, rna non e partieolarmcnte mareala. La mana c doJcemente Sirelta al pugno. Ai [ati, nc llo spazio Ira [e dita, lasciato pieno, si disti nguono un foro clal lato del poll icc (diametro em 1,41) e due fo ri dallato dcl mi gnol o (diamctro cm 1,15 c em 0,92 ). Qucsti due u[timi fori sono alquanlo diversi. II foro maggiore c rotondo e poco profondo. II foro minore ha fo rma nllungala cd e alquanto profondo. Non si
osservano {raeee di metallo e ossidazione in eorrispondenza di quesli fori. L'incasso dal lato del polso per I'i nnesto dcl riporto (profondita cm 3,5; larghezza em 2, I) ha sezione rettangolare. L'inserto eorrispondente alla mana sin i· Slra dell' Aerolito A (figg. 9- 10) comprende la mana e il polsa. J Sono scheggiate Ie eSlremita del pollice e de ll 'i ndice, e seheggiature sana present i anche sui retro e sui 1ato dcslro dell' inserlo. La superfieie c incrostata , partico larmcnte in corrispondenza del dorso. Inerostazio· IIi SOIlO presenti anehe nel cavo d' innesto . La mana si distingue per Ie dila alquanto lunghe e pCI' [e unghie svi luppate eben marcate. La strutlura ossen del polso non c marca!'n, almena dal lata sinistro, con~ scrvato. La mallo e dolcemente Slretla al pugno. Ai lati, nella spazio tra Ie dita , lascialo pieno, si disti nguono un foro dal lata del pollice (diametro cm 1,2) e due fori, simili , dallato del mignolo (diame· Iro per entrambi cm 0,96). L'incasso dal 1ato del po1so per I'innesto del ri porlo eben conservato (profondita em 3,7; larghezza em 3,7) ed ha sczione approssimalivamente rettangolare. AI polso, dal lato del palmo, c un forellino (diamctro em 0,6) che raggiunge I' incasso per I'innesto. Nell'i nserto corri spondente a[ piedc deslro dell 'Aerolito A (fig. II) e resa la sola partc anteriorc del piede, fino a poco prima [a linea dei malleoli, che 50110
csclusi. & II quarto dito e fratturato e privo della prima falange, mentre la punta del
[Saggi} 3
5-8. AcrolilO A, Mano dCslr;l. Aidonc, Musco Archcologico.
terzo dito c schcggiata. La supcrficie del piede c in gran parte inerostata, eon l'eccezione del dorso delle dita . L:inserto e delimitato posteriormente da un piano leggermente obliquo, che inclina verso la fronte. Al limite posteriorc, suI dorso, e una banda ribassata larga em 3,5, clal profilo anteriore ad arco di cerchio. II piedc si distingue per Ie dita alquanto allungatc e squadrate. II secondo e il terzo dito sono leggermente piu lunghi rispello all'alluec. L:indieazione delle unghie c molto marcata, mentre per nessun dito sembra esserc indieata la picga prima
9, 10. Acrolilo A, Mano sinislra. Aidonc, Musco Archcologico. 11. Acrolilo fI, Picdc dcslro. Aidonc, Musco Archcologico.
12. Acrolilo A, Picdc siniSlro. Aidonc, Musco Archcologico.
dcll'unghia. II piede aderisce eompletamente al suolo con la pianta. Si distinguono traccc di colore rosso nci punti in cui sono state rimosse Ie incrostazioni: tali tracce sono particolarmente abbondanti presso I 'atlaeeo delle dila, Ira allucc e secondo dito. Nell'inscrto corrispondente al piede sinislro dell ' Acrolito A (fig. 12) e resa la sola parte anteriore del piede, fino a poco prima la linea dei malleoli, ehe sonG esclusi. 1 L'alluce c scheggiato e sono anche parzialmente scheggiale Ie punte del secondo e terzo dito. Le inerostazioni sono state largamenlc rimossc da tulia la superficie, tranne ehe in corrispondenza della pianta e dell' area Ira l'alluce e il secondo dilo. Si osservano diversi graffi e scheggiature recenti su tulia la superficie, che prescnta un certo livello di corrosione . L'inserto e delim italo posteriormente da un piano vcrticale. Al limite
posleriore, sui dorso, e una banda ribassala larga cm 4, dal profilo anteriore ad areo di eerchio. II picde si distingue per Ie dila alquanto allungatc e squadrate. II secondo dito e leggermentc pill lungo rispetto all'alluce. Malgrado la corrosione della superfieie, I'indieazione delle unghie appare marcata. Pcr nessu n dito, invccc, sembra possibile rilevare I'indicazione di una piega prima dCll'unghia, con I'eecezione, forse, del secondo dito, dove pero Sl potrebbe csscre in prcscnza di un graffio. II piede aderisee completamente al suolo con la piaota. Si distinguono aneora traeee di colore rosso su parte del dorsa: gran parte di questo colore scmbra esserc stato cancellato in oeeasione della rimozione delle incrostazIOn!. L:inserto corrispondente alia testa dell' Acrolito B (figg. 13-15) si conserva per intero e comprclldc il volto, dalla sommi-
13-1 S. Acrol ito a, Testa. Aidone. Museo Archoologico. a destra:
16,17. Acrolito a , Mano sinistra. Aidone, Musco Archeologico. 18. Acrolito a , Piedc destro. Aidone, Musco Archcologico.
la dclla fronlc al menlO, c il caito, fino alia basc, corri spondenlc aile clavieole. I La superficie e quasi com plelamenlc incroslata in corrispondenza del colla e buona parte dcl volto, con ]'cccezione de ll'area degl i occhi e degli zigomi. L'inerostazione in quesle aree sembra esscre stata rimossa sistcmaticamcnte in tempi reeenli. E prescnte una schcggiatura al lata sini stro della base del colla. AI collo e ai lati del volto si dist inguono una serie di graffiature recenti eomparabili a quelIe che si osscrvano sulla superficic dell,l testa dell ' Aerolito A. II limite superiorc de ll 'i nserto, alia fronte, picga, g rosso modo, ad ango lo ottuso. II limite inferiore, corrispondente alia base del collo, ha un chi aro andamento semici rcolarc. Un piano approssimativamente vert icalc
delimita I' inserto sui retro: in alto la superficie appare pero reccdcre Icggermente verso la fronte. Talc piano passa in corrispondenza dclla linea delle orccchic, di cui Ire quarti circa dovrebbero csscre eomprcsi nell'i nserto, ma di cui manca pen> ogni indicazione. I tratti del volto sono meno pronuneiat i ehe nella testa dell' Aerolito A. II naso C pero sempre di dimensioni considerevoli. Le labbra sono spesse, rna leggermcnte meno earnose, e piegale in un sorriso meno pronuncialo. Conseguentemente. Ie depressioni agli angol i della boeea sono meno pronuneiate, comc meno pronullciati sono i solchi sopra il labbro superiorc e sotto illabbro infcriore. Lc duc leggere pieghe al labbro superiore c al labbro inferiore sono mcglio conservnte che nclla testa dell' A-
crolito A. II mento c sempre sch iaceiato e massiccio, anehe se leggermcntc menD promi nenle. Gl i occhi, di ri porto, maneano. L'incurvatura delle paJpebre e la stessa della testa dell 'Aerolito A. [n particolare, la palpebra superiore si ineurva netlamente in corrispondenza del globo ocularc. Si riscontra inollre la stessa di ffe renziazione dcgl i angol i esterni ed interni, come l'i ndicazione della caruncola lacrimale all'angolo interno. E da notare che In resa dell'angolo intcrno dei due oeehi c leggermente diversa rispetto alia testa dell'Acrolito A. Come nella testa dell'Acrol ito A, entrambe Ie palpebre sono indicate a rilievo, compreso I'a naeco all ' angolo esterno. La palpebra supe-
[Saggi] 5
riore e in particolare risalto ed e separata dall'arca ta sopracciliare da un solco abbastanza profondo. Anche questo volta presenta chiare asimmetric: I'occhio sinistro e posizionato pill alto del deslro, mentre il mento e il naso piegano verso la si nistra dell'osservatore . Sui relro, al centro, all'allezza del naso, c un foro con pel'l1o. Ll foro, quadrato (Iarghezza cm 2) appare moderno, come il relativo perno. Antiea, inveee, e la depressione sui retro, alJ'altezza del naso, comparabile alia dcprcssione riJcvata sulla testa dell ' Aerolito A, ma di dimensioni minori . Sui retro, in particola re ne lla meta superiore, si distinguono numerose traeee della subbia, tenuta perpendicolarmcnte rispetto alIa superficie. Tracee della subbia, tcnuta obliquamentc rispetto alia supcrficic, si distinguono anche suI limite superiore. 11 bordo inferiore del colla presenta, in corrispondenza della meta anteriore scolpita, una banda [iscia dello spcssore di meno di em I. Talc banda appare ora leggermente convessa, a causa della corrosione. Tale banda c visibile solo in corrispondenza dell,l porzione destra dell 'inserto. Lungo il lato destro del colio, a conlatto con il limite posteriore dell'inserto, la supcrficie appare tagliata verti cal mente e liseia, formando una banda di circa em I di larghczza. L'insel'to corrispondente alia mano sinistra de ll 'Acrolito B (figg. 16-17) comprcndcva la mano e i1 pol so, ora mancante. 9 La mano c Fratlurata all'atlacco col polso, mentre I' indice e schcggiato in corrispondenza della seconda e terza falange. Resta qualche incrostazione in corrispondenza del dorso e di parte del pa l mo. AI palmo la superficic c stata in gran parte ripulita, men Ire la superficic del] 'incasso dal lato del polso e incrostatao La mana si distingue per Ie dita alquanto [unghe e per Ie unghie ben marcate. E da notare pef() che Ic unghie sono mcno sviluppate in lunghezza che neiI' Aerolito A. La mana c dolcemente SIrena al pugno. La pressione del polliee contra I'indiee c leggermente pill accentuata che in entrambe [c mani dell'Aeralito A. Ai lati, nello spazio tra Ie dita, lasciato pieno, si distinguono £lei fori , uno dal lata del pollice (diametro em 1,24) e due, sostanzialmente simi li , dal lato del mignolo (diametri em 0,88 e 0,68). Si eonscrva purte dcll'incasso dal lato del polso pel' I'innesto del riporto (profondita em 2,5; larghezza cm 2,5), di seziol1c- all'origine approssimativamente rettangolare. Sulla sua superfic ie si distingue un foro di sondaggio moderno.
6 (Saggi]
Nell'inserto cor rispondenle al piede destro dell'Aerolito B (fig. 18) e resa la sola parte anteriore de l piede, fino a poco prima la linea dei malleo li , che sono esclusi. 10 L'alluce e considcrevolmente sehegg iato e sono ancora presenti divcrse incrostazion i. L'inserto c de[imitato posteriormente da un piano verticale che obJiqua solo leggermente verso I'avanti . Allimi lc posteriore, sui dorso, e una banda ribassata larga em 1,5, dal profilo anteriore so lo approssimativamenle ad area di cerehio. II piede si distingue per Ie d ita alquanto allungate e squadrate. II secondo e ter.w dito sono pill [unghi dell'aHuce. L'indicazionc delle unghie c molto mareata. A differenza dell' Acrolito A, I'auaeco de[]'unghia ha un andamento meno squadrato e pill tondeggiante. InolIre, a difTerenza dei piedi de[I' Aerolito A, per ogni dito e ind icata una piega prima dell ' unghia. II piede aderisce al suolo con la pianta: la pianta stessa e pero coneava e risulta scavata a colpi di subbia. Muovendo dalla descrizione agJi aspelti tecnici e al problema della ricostruzione delle due seu1ture analizzero in successione gli inserti corrispondenti aile leste, ai piedi e aJlc mani. La prima carallcristica delle teste dei nostri acroliti che merita discutcre c la lavorazione della sola parte anteriore di testa e collo, con un lag lio pressoche vertica le che limita gJi inserti posteriormente. Nelle teste aerolitiehe di eta arcaica e elussica a noi note sia Ja testa che i[ eo110 sono generalmente resi per I'intera profond ita, pur con tulte Ie variazioni del caso nella resa della ealotta cranica, talvolta olllessa 0 lasciata liscia: basti citare, per questa resa di testa c collo per ['intera profondita, l'Apollo di Ci ro (figg. 24-25). 11 Non mancano pero casi in cui risulta scolpita [a sola porzionc antcriore di testa e co110, con I'inserto delimitato posteriormenle secondo un piano verti caIe, come si riscontra nei nostri aeroliti . Si tratla della testa di Cirene 14.413 (rigg. 26_28),12 del1a testa di Taranto 3885 (figg. 29-30), I) e, infine, di una testa da Larisa. 10
Se acrolitiche, due teste in marmo da Paesturn (fig. 31) II offrirebbero un ulteriore confronto, mentre tra Ie sculture cosiddette pseudo-acrolitiehe - prodolte eioc
19. Tesla della Kore 671 dal1'Aeropoli (530-10 a.C.). Alene, Musco dcll'Acropoli (da 1-1. l'aynca.M. Young, Archaic Marble Sculplllrejrom the Acropolis', London 1950).
20. Testa della Kore 682 dal1'Aeropoli (530-20 a.C.). Alene, Musco dc!l'Acropoti (da H. Paynea.M. Young, Archaic Mal'ble Sculpllll'cjrom the Acropolis', London 1950).
21. Testa della Nike da Del0 (me'~! del VI sec. a.C.). Alene, Musco Nazionale inv. 21 (da C. Rolley, La sClllp/lirc grccqllC, Paris \994-(999).
combinando il marmo con una pictra pill tenera, come il ea leare 0 I'arcnaria - un eonfronto e o fTerto dalle teste femmi nili appartenenti aile metope ovest dcl l'He· raion (tcmpio E) di Selinunte: particolar· mentc istruttivo, al riguardo, e il confran· to con la testa di Palermo 3884. I ~
La seeonda earatterist ica de ll e nOSlre teste che merita altell zione C la preSen7.l'1 di una depress ione al centro del retro, pi ll accenluata nel caso dell' Acro lito A. QllC~ sta dcpressione richiama alia mente la resa del retro delle testc ora citate da Taranto e Larisa, che risu ltano cntmmbe scavale, al doppio scopo di ri durnc il peso, limilando cosl il rischio d i una cadula in avanti, e di conlribuirc all'llsscm blaggio con I' impa lcat ura lignea . Questo uso di scavare il retro delle teste d i statue llcrolitiche (0 marmorcc, ma escguite in parti separate) e par!icolarmente di tTuso in eta ellenistica. 17 Al con~ fronlo con gli esemplari citali, la deprcssione nel retro delle nostre teste C perc> minima. Essa risulta comunquc evidente e disl ingue i nostri aerol iti daUe cilatc teste da Paestum e da Selinunle, e sopnH ~
tu tto dalla citata testa di Cirene, iI cu i retro sembra rcgo lare, con I 'cccezione di una leggera deprcssione al centro della spigo lo formato dalla facc ia superiore e posteriorc dell' inser!o, dovuta pera fo rse a frauu ra 0 corrosione. Un'ultima considerazione ri guarda la resa del limite inferiore dell 'inserto, che come si e visto c caratteri u..ala in entrambe Ie teste da una banda li scia spessa cir~ ea un centimetro. Si {raUa del tenone, destinato all ' inserimento in una depres~ stone corrispondente nel corpo delhI statua, e ehe ncl caso dei n051ri acroliti r isul ~ 1a ridotto .11 mini mo. come del resto nelle citllte teste da PacstUnl e da Selinuntc. II rieorso a un lenone di dimensiolli mini me e slalo messo in rclazionc da Am<lllda Claridgc, per il I secolo a.C. c il I secolo d.C., con la scarsa disponibilila di mar~ mo, e la conseguente necessitil di risparmiare su questo materialc, una possibi lita che non PllO esscre esc\usa nel noslro caso. II La lavorazione degli in serti delle teste otrre indicazioni circa I'originaria conri ~ gurazione degli aerol it i. Nella testa dell' Acrolito A, I'andamenlo ellittico del lim ite supcriore dell'i nscrto sopra la fronte indica che i capelli, presu~ mibilmente in stucco, erano spartiti al centro. Di qui essi dovcvano essere riporlati verso il relro, descrivendo Icggcri arch i ai lali della fronte e coprendo b uo~ nl! parte dell e tempie, fin quasi a toccare I'angolo eS1erno dell'arcata sopracciliare. Nella serle delle kora i. il migliore con~
22. Testa de lla Carintide e;.: ·enidia (terzo quarto del VI sec. a.c.). Dclfi, Museo inv. 1203 (da C. Rolk)', La sClilp/l/J"C grcclfue. Paris 1 994~ \999).
23. Testa delta Carinlide del Tesoro dei Sifni (530-525 a.C.). Delfi, Musco (da C. Rolley, La sCIII,1IIIre grcCqllc, I'uris 1994-1999).
fronlO C offerto dall a kore 67 1 I' del Musco dcll'Acropol i (fig. 19), rna si pos~ sono menzionare <lnche numerose altre teste femrnin ili, tra i qua li la testa dell a cariatide ex~cnid i a 19 a Delft ( fi g. 22) 0 In kore 68 2 1 1 del Musco dell 'Acro po li (figg. 20, 37-38). La spartizione dei capelli al centro della fronte e infatt i frc~ quente nelle teste femllli nili della secon~ da meta del VI seeolo, anche sc non mancano esempi ne lle leste masch il i, a eominciare dal kou ros di Anavyssos. U II ratto che nell a nostm testa i capell i copriv vano buona pllrte delle tcmpi e, fin quasi a tocca re I':lrcata soprnec iliare, parla perc> nctlamcnte a t~1vore de ll ' identificll ~
zione dcll a nosl ra testa can una testa fem~ min i Ie. Tale idcntiricazione c anche sug~
gcrita dall a struttura pa rtieolarmente massicc ia del mento. L:andamento a mez· 7..a luna del limi te inferiore dell'inserlo, corrispondente alia base del eollo , c da porre in relazione con la prescnza di un abi to con il bordo semicircolare in eorri ~
spondenza del collo, come un chitone. Un !malogo andarnento a mezza luna del lim ite in fe riore dcll'in serto si rilrova in una delle teste da Paestum g ia citale (Paeslum, inv. 133150). Nella testa de ll 'Aerolito B, I' andamento del limite supcriore dell'inserto ha una forma leggermentc diversa rispetto all ' A~ crolilO A. Sopra la fronte, esso forma infatti un angolo 01lU50, mentre sopra Ie temp ie, tale limite, che IHl un andamcllto so lo Icggermentc di agona le, corre piutto· slo tn alto, mantenendosi a una certa distanza dalle arcalc sopraccili ari . E da cOlleludere che i capell i, nell' Acro lito B, anch 'essi presumibi lmenle in stucco, erano riportat i ai lati in malliera sim rnelrica rispeUo al cenlro dclla fron te, Illa questa volta con una netta scriminalura nel mez· zoo Se poi ai lati il limite sUllCriore de l ~ I'inserto andasse preSQ alia leuera, si dovrebbc coneludere che i ca pcll i copriva llo una porzione solo limilat a delle tempie, e sccndcvano solo leggcrrnentc verso il relro, passando sopra Ie orccchie. Pcr questa d isposizione, i migliori con~ fronti , nella statuaria della seconda meta del VI seco10, si rilrovano nOll nelle lestc femmin ili, ma neUe teste maschili. 1) Cic> non scmbra abbastanza per6 per dubilare dell ' identita della nostra Icsta, che appare fcmminile, anche se dai trall i pili g io~ van i dell' Aerolito A. L:andamento a mcz~
zaluna del limite inferiore dell ' inscrto dell a tcsta dell ' Acro lito B, andrebbc posto in rclaz ione, come nel caso dell ' A~ crolito A, con la presenz<1 di un ch itonc. L:assenza di ogni aecenno aile orecehie in entramb i gli acrolit i, indica chiaramenIe che la parle posteriore degli inserli non doveva cssere visibi le. La si im maginera coperta da Ull velo, presu lllibi lmente di sioffa. L' uso di vcstirc statue acrolitichc con abi ti di sto ffa e infalli ben documen~
lato. I '
Dail e dimcnsioni dell e teste, bisogna dedurre che l'Acrolito A era nettamente supcriore al naturale (sta nte, la figura sarebbe stata alta allorno a em 207), mentre I'AcroliiO B 10 era solo di poco (stan~ Ie, la figura sarebbe slata alta aHomo a cm 180). Dci picdi delle nostre statue c lavorata la so la porz ione anteriore, fino a poco prima In linea del malleoli. che sono esclu~
si. AI limite posteriore si osscrva un a
{Saggi] 7
banda ribassata, ricavata nella superficie superiore dcgli inserti e con II profilo anterlore ad arco dl cerehio. Tale profilo corrisponde senza dubbio al bordo inferiore dcll'abito della statua, che copriva la parte posteriore dei piedi. I piedi erano inseriti ncl corpo dclla statua, dietro I'abito, per tulia la profondit;\ della banda, elte misura cm 3,5-4 nei piedi dell' Acrolito A e cm 1,5 ncll'unico piede conservalo dcll'Acrolito B. In pianta, la superficie dei piedi dell' Acrolito A e liscia, mentre appare Icggermente concava al
8 [Saggi]
centro, seavata con l'uso sistematico delIa subbia, nel piedc dell' Aero lito B. L'assenza di ineassi nel retro si spicga con il fatto , osservato piu di rcccnte da Giorgos Despinis, ehe i pied i delle statue aerolitiehe non avevano bisogno di csscre aneorati all'impalcatura lignea, poggiando semplicemente sui plinto. 15
La nostra conoscenza dei piedi di sculture aerolitiehe di eta arcaica e classica c parziale . Per limitarci ai casi piu significalivi, il paio di piedi da Thori kos, riferito da Dcspinis a una figura seduta, c diserctamentc ben eonservalo: lavorali per intero, fino al calcagno, entrambi i piedi
24, 25. Testa della statua acrolitiea di Apollo da Ciro (470-60 a.c.). Reggio Calabria, Musco Archcologico Naziollalc inv. 6499 (da S. ScttisM,C. Parra cds., Magna Grrecia: arche%gia di u/! sape,.e, Milano-Catanzaro 2005),
26-28. Testa acrolitica ill marmo da Cirene, EI BogaTa (460 a.C.). CiTenc, Musco in\!. 14.413. (da E. Paribcni, CII/a/ogo delle seu/ture di Ch·ene. Statue e ri/ievi di carollere religioso, Rorna 1959).
prcsentano nella parte posteriore un cospicuo incasso rettangolare funzionalc all 'asscmblaggio con il corpo ligneo, che aUraversa tutto l'inserto. Davanti a questo incasso, in corrispondenza della suola, e un piccolo foro di perno circolare funzionale all 'aggancio eon il plinto. 16
Ben conservati sono entrambi i piedi, cavigJia c limitc inferiore della gamba compresi, dell'Apollo di Ciro. Tali piedi presentano fori di perno rettango lari di dimcnsioni considerevoli, sia al limite superiore dcgli inserti, sopra Ie eav iglie, che alla pianta dcl piedc sini stro. 21 La replica di Vienna dell' Alena Medici eon-
serva entrambi i piedi , eli cui appare resa in marmo la sola porzione anteriore, pill hmga in corrispondcnza del piede deslro che nel piede sini slro. l. In enlrambi i piedi, illimile posteriore dell ' inserto e eostituilo da un piano obliquo. Quanto alia seultura eosiddetm pseudo-acrolilica, SI conserva il piede deslro della dea del Getty Museum c qualchc frammenlo del piedc sin iSlro. 1'1 Oi entrambi questi piedi era rcsa nel marmo solo la porLione anteriore, attacca!a al corro in calcarc: la parte posteriore, sia di qucll o destro, adercnIe al suolo, sia di quell o sini slro, scartato lateral mente, era nascosta dal bordo inferiore del ehitonc vcstito dalla den. Per rcstare aile sculture cosiddettc pseudoacrolitiche, vanno menzionati i piedi in marmo dell e figure femminil i de ll e metope dell ' Hernion (tempio E) di Selinunte, esegu iti pit'! 0 meno completamenIe in marmo a seconda del tipo di abilo indossato dal la figura corri spondente. Particolarmentc significativo at riguardo il confronto Ira i piedi di Era - quello sinist ro avanzato e reso per intero, menlre di quello destro c resa la sola pon ione anteriore, essendo iI retro copen o dal bordo in fe riore del chitonc - , e i piedi di Artemide - enlrambi resi per inlero, dato che I'abito veslilo dalla dca, il peplo, scende solo fino all'altez7..a dei malleoli -. Per Peta ellenistica, si eonservano il piede sinistro e parte del piede destro dell'A tena aerolil'iCli di Priene, restituita slante sulla gamba destra , eon la gamba sini stra e il piede corri spondente scartati leggermente di lato. JO Oi entrambi i piedi e resa la sola eslremit;\ anteriore, essendo il retro coperto dal bordo inferiore del pep lo vestito da Atena . In particolare, il retro e delimitato di netto, secondo un taglio quasi vertica le. II falto che i piedi dell' Aerolito A siano della Slessa lunghezza e fosse ro originariamenlc coperli nel retro dallimite inferiore dell 'abito suggerisce la loro attribuzione a una s!alUa seduta . Nellc statue sedute della seeonda metil del V I secolo i piedi sono infatli general mente - rna non sempre, c bene precisare - all ineal i e paralleli, con il retro occultato dal bordo inferiore dell'abilo. 8asli citare la statua di Aiakes l' a Sarno, datata al 540 a.c. ca., o la statua fcmminile sedula del Musco dell ' Acropoli , 61 8 (fig. 32), )) datata al 520 a.C. ca. E bene pera aggiungere che, per quanto a partire da poco prima delhi melll del VI sec. Ie korai presentino di norma il pi ede sini slro pi ll avan zato rispeUo al destro, nOll Illancano eccezioni : basti citare il easo dellu kore da Myrrhinous, lJ per III qua Ie Ie datazioni oseillano general mente tra il 550 e il 530
29,30. Testa aerolitiea da Taranto (inizi del tV sec. a.C.). Tarolllto, Museo Arel1cologieo Nazionalc in .... 3885 (ua N. Giustoz7.i, "Gii ll.H «0 pezzi~: I'Hercules n:oAv~1..to~e lalecli /ca ocrolirica IIel II secolQ II.C.". in ' tlo l1ett ino della COlllmissione Arehcologiea Comunale' 102. 2001. pp. 7-82).
a.c. (Ni kolaos Kaltsas data ora la statua al 550-540), con Ie gambe allineale e i piedi ehe cmergono con uguale profondita dal bordo inferiore dell 'abito. Si tralta, come gift soltolineato, di eecezion i. Resla da aggiungere che Ie abbondant i Iracce di colore rosso su i dorso di entrambi i pied i dcll'Aerolito A vanno con ogni probabilita rifcriti all'indicazione delle einghie dei ca lzari , rese con colore piuttosto ehe con riporti metallici (utilizzati ncl caso dei piedi della statua di Thorikos e dell ' Apollo di Ciro). Tracee signi ficative sl osservano sui picde destro nell 'area anteriore del metatarso, nello spazio tra allucc e secondo dito, in una posizione occupata di solilo cia due einghie, una nonnale e I'a ltra parallcla alia fronte del piede (si confrontino ad esempio i calzari della kore da Myrrhinous, appcna cilata). Tracce ana loghe si riscontrano anche suI piede sini stro, sui quale si osservano anche due linee rosse che corrono oblique verso il retro. Le mani dei due acrol it i erano separate dal corpo, come indica la loro lavorazione a tullo tondo. Nel caso dell ' Aerolito A, si conserva in entrmnbi i riporti I' incasso funziona le all'inncSlo con il eorpo in legno, dal lato del polsa: talc incasso ha forma rettangolare ed e ubbastllllza profondo. Credo sia da e8cl udere un giunto con tenone inverso, ovvcro dalla parte del eorpo, alloggiato nell ' inca8so praticalo ncll'inserto. Ii da ipoti zzare, piUllosto, il fissaggio del riporto tramite un grosso perno (piu probabilmcnle in
legno chc in metallo) a sezione rcttangolare, che nel caso della mano sinistra era fi ssato a sua volta tramite un perno Irasversale a sez ione circolare. Entrambi i sistemi di fissaggio SOIlO documentali ne lla scultura arcaiea, in parlieolare nella serie de lle korai dall ' Acropoli. :I-' Quanto alia lavorazione dei riporli e Ie indieazioni ehe essa offre circa la eonfigurazione originaria degl i acroliti , merila qui saltol ineare tre earatteriSliche. La prima c ehe gli inserti non vanno ollre
31. Testa aerolitica da Pacstum (500 a.C. ea.). Paestum, Museo Archcologico Naziorla le in .... 133150 (da E Larlglotz. TlreAI'/ ofMllKl!(1 Graccia. Greek An ill SourlICf/1 l ral), (/Ild Sici(l'. New York 1965).
LSaggiJ 9
I'area tra il polso e I' in izio dell 'avambraccio . Cic. vale per entrambe Ie mani dell'Acrolilo A. Oal lalo del polso la mano sini slra dell'Acrolito B e fratturata c non c poss ibi lc detcrminare la lunghczza originaria dcll' inserto. Almeno nel easo dell' Aerolito A, eomunque, buona parte degli avambracci era originariamente coperla, circostanza che parla a favorc sia del fatto chc la fi gura corrispondentc vcstiva un lungo mantello sopra Ie spalJ e - reso presumibilmente in stoffa - , che scendeva a coprire parte deg li avambracci, sia del fatto che ambeduc Ic braccia non erano di stcsc in avanti , ma picgatc al gomito. Oivcrsamcnte, in assenza di un mantcllo a ncl caso di braccia distese in avanti, ci si sarcbbe aspcttati che buona parte dell'avambraccia fosse lasciato scoperto - come si osserva costantemcnlc nella serie delle korai - , e fosse eonseguenlcmente reso in manna nei nostri inscrti. Mancano confronti nella staluaria di VI seeo lo pcr una simi le posa e non resta che ricorrcre al rilievo 0 alla corop lastiea. Pcr il rilicvo cito la piccola metopa can Ie tre dec da Selinunte, )$ c per la corop laslica una delle statuette raffi guranti una dc.a in trona dal Santuario della Malophoros, scmpre a Sclinunte (fig. 33). ;>G In entrambi i eas i, il lungo mantello gettalo sulle spalJ e copre
--, ..... '
32. Slalua femminile seduta in manno dall'Aeropoli (520 a.C.). Alene, Musco dell'Acropoli inv. 618.
10 [SaggiJ
buona parte degl i avambracc i. La seconda caratteristica dcgli insert i cite mette canto sottolineare e il falto che la posizione di tulte e tre Ie mani conserV(lIe e identica, strelta in pugno, e che sono identici i fori per gli inserti di meta llo praticati ai lati , nello spaz io tra Ie dila: un largo foro dal lata dcl pollice e due fori minori dal lato del mignolo. Si tratta in tutti eI re i casi di fori non passanti. t..: A~ crolito A sembra dunque impugnasse gJi stessi attributi in ambo Ie mani, e un attributo ana!ogo era stretto in una mano dall'Aerolito B. Della natura di questo attributo danno indicazione da un lato il fatto che il pugno c al quanto serrato, e dall 'altro il fatto che i fori per I'i nserto di metallo non sono passanti. Una lancia, uno seet· tro, 0 una lorcia andrebbero esclusi, dalO che essi richiedcrebbero un 'apertura maggiore del pugno dclla mana e, al tempo stesso, fori passanti, e di maggior diametro. E da pensare, piuttosto, a un attributo relativamente sottile e, a giudicare dalla presenza di un foro da un lata, e di due fori dall'altro, costituito da piu elementi. Non saprci immaginare un candidato migliore, per tale attributo, di un fascio di spighe di grano . Talvolta Ie spighe sono ten ute delieatamente in punta di dita, come ne[ caso di Persefone nei pinakes loercsi; 17 ma nella maggior parte dei casi il fascio di spighc e tenuto nel pugno della mana, come mostrano i numerosi vasi che rappresentano [a partenza di Trittolemo, come il craterc a c(lmpana da Agrigento, a Palermo, attribuito al Pittorc di Orizia (470 a.e. ca.) (fig. 34). lS Al riguardo, il eonfronto migliore e offerto dall'anfora del PiHore dell'Alta lena a Gottingen (ca. 530 a.C.) (fig. 35), con la figura di Trittolemo ehc licne nc[ pugno si nistro un fasc io eli spighe. J9
11 riconoscimenlo di spighe di grano come attributi tcmlli in entrambc Ie mani da lle due dee contribui sce in man iera determinante a identifieare ['Acrolito A con Oemetra e I'Acrolilo B con Kore : un'identifieazione su lla quale concordano quanti si sono gill pronunciati sulle scuhure. Piu precisamente, ci trovcrcmmo dinanzi a un gruppo statuario di dimensioni monumentali, ehe si restituirebbe piu plausibilmente con Ie due dee scdute e appaiate, secondo un'ieonogra· fia ben documenta la netl'a rte greea arcaica e classica . 01(1 NOll mancherebbcro poi confronti per la diffcrenziazione di madre e figlia tramite [e dimensioni. Sarebbc soprattutto questa il easo, se I'idcntifi cazione eOIl Ie nostre dee cogliessc net segno, di aleuni gruppi fittili beoti ei da 10m be, uno £lei quali, data bile aJ VII
sec., c al Musco Nazionalc di Atene. 41 In quest i gruppi madre e figlia sono differenziate, oltre che negli ab iti ehe indossa-110 e nel1e aeeoneiature, anehe nelle dimensioni, can la figlia leggennente piu piccola della madre. In un altro gruppo fitti le da Milo, al British Museum (fig. 36), datato al 450 a.C. ca., la figlia, che licnc la lira nella mana sinist ra, c illveee neltamente pi" piccola della madre: qui l'identificazione can Oemelra e Kore c suggerila dal fatto ehe Ie figure sicdono su eiste . · l Oi questa ieonografia della eoppia Demetra-Kore sedute e appaiatc i nostri acmHti rapprese nterebbero oggi , se la ricoslruzione e I' identifieazione proposta coglie nel segno, il documenlo pill significativo e al tempo stesso piu spettaeoJare a noi nolO. Nelle poche mcnzioni dei noslri acrolili in letteratura sono avanzate due datazioni diverse: una datazione alta, alia media-
33. StalUCtl:1 di dea ill trollo in terracotta, dal SalllUario della Mnlophoros a Selinullte (fille del VI sec. a.C.). Palermo, Musco Archeologico Rcgionale in\'. 2124 (da E Langlolz, TIle Art of Alagna Gmecia. Greek An ill Southern 1/IIIy mul Sicily . New York 1965).
tmda cli. arca ica, c unn d<llazionc bassa, al 490.·) Talc divergcnza sollccita un esame sistematico del problema. Ai fin i della dawzione dei nostri aeroliti gli unici elementi signirieativi nella resa dell'anatomia sono costitui ti da lla bocca e dalle di la dei pied!. Degli altri lraui del "olto. il naso, largo e prominen le, non consente eonfronti sistemat ici con la slatuaria del VI seeolo, dato ehe talc elemento C Iroppo spcsso dannegg;ato negl; csemplari rimasti pcr pOlcrnc lJaeciare un'cvoluzionc. Dcgl i ocehi relati vamcntc streni e srinati, inveee, originariamente di riporto, troppo poco puo ancora osscrvarsi: il di segno generale comprende la difTercnziazione dell'angolo interno da que llo cstcrno; la palpebra sllperiore si incurva in corrispondellza del bu lbo oculare; una larga c profond:t dcprcssione marca 10 spazio tra 1,1 palpebra supcriore e I'arcata sopracciliare, e si continua fino all'angolo interne dcll'oceh io. Nulla puo dirsi, per6, circa la eonfo rmazionc originaria del bulbo ocu larc, e cio rellde alquanto ditric ilc ogoi confronto con sculture della seconda meta del VI seco-10. Pcr questo, come ho anticipato, solo la bocea, dei tralti del volto, forn isee elementi signifieativi ai f ini della datazione della testa. La boeea dell' Acrol ito A e ben eonservula . Le labbra sonG incurvate verso I'a llo, e la transizione dalla bocea aile guanee C segnata da una dcpressione agli angoli dc ll e labbra, che si prolunga con un solco poco accentuato ehe pa sSa sopra il labbro supcriore c sotto il labbro infcriore. Le due Inbbra sono nettamentc difTerenz iate: hanno pcr6 ugualc spcssorc c il labbro supcriore sporge solo leggenncllte rispcI-10 al labbro infcriore. La bocca dcll'Aerolito B c leggermcllte eorrosa, con il risu ltato ehe una valutazione dei dettagli non c poss ibile. La bocca appare leggermente piu Slretta rispctto all ' Aero lito A e Ie labbra sono meno incllrvate verso I' alto. Tuttav ia, la struttu ra eomplessiva c paragonabi lc a quclla dell' Acrol ito A. L'uniea discuss ionc sistematica del l'evoluzione nella resa della bocea nella scultura della seeonda meta del VI secolo resla quella ofTerta da Gi sela M.A. Richter mezzo seeolo flL '" II sistcma di datazionc della scultura ar(.:aica proposto dalla Richter - basato sui principio di una evoluzione costanle , progress iva, e uniforme della scultura greca areaiea da forme convenzionali verso forme pill realistiche nella resa dcll'analomia - , c stato oggetto, negli anni , di ripetll tc critic he: in parte a causa dclla sua matricc posi tivista, e in parte a causa del SllO sostanziale di sconoscimento della poss ibilita di dif-
34. Cralcrc a campana anieo a fi gure rosse, auribuilo al piltore di Orizia. I'arlenza di Tritto1emo (470 a.C.). Palerlllo, Musco Areheologieo Regionale inY. 2124 (da M. Bennet! - AJ. Paul, cd., Magna GllIeciu. Greek Arlfiv m Solllh /IU/)' und S;cily . eatalogo dcl b mostrn (Clcyeland, The Cleyeland Museum of Art). Cleyeland 20(2).
ferenziazioni rcgiona li e di iniziative individual i. Resta pero il falto ehe a tale sistema di datazionc non si c rnai oppOSIO un modello alternativo valido. Con il ri sultato ehe, come osscrvato di reeente da Claude Ro lley, il sistema elaborato dalJa Riehler costitui see ancora I' unico serio fondamento per stabilire la dataz io~ nc relativa delle opere del la seultura greca arcaica. Cia non sorprende, sc si considera ehc parte del princip io alia base di quel sistema puo considerarsi ancora valido: ovvero, I'esistenza di un'evoluzionc ncl trallamento dell ' :l11:lIomia nell a scu ltura g rcea areaiea, che consiste in una serie di trasformazioni deltate dalj'intenzione di inglobarc un numero sem~
pre maggiore di detlagli presi in preslito dalla natura. 'l Secondo la Richter. questa generale evoluzione verso forme piu natura Ii che caratterizza la scultura di VI sccolo Irova riflesso, nella resa della bocca, in una tcndcnza a rcnderc progress ivamente pi li gradua le la transizionc tra gli angoli e Ie guanee, riduccndo la profondita della depressione agl i angoli delle labbra e del solco eorri spondente sopra il labbro superiorc e inferiore. Tale tcndcnza si rileva al meglio, secondo la Ri chter, nel confronlo tra ulla serie di sculture stilistieamente aITini , tradizionalmentc associatc alia scuola di scu ltori da Chio (una seuola a noi nota, purtroppo, pill in base aile fonti letterarie cd cpigrafiche dIe a rinvcni mcnti di scultura nell ' iso la). J~ La prima scultura della seric , datala gcncral-
35. Anfora a eollo distinto attica a figure nere, al1 ribuito al Pillore dcll'Allalcll:l . Parte llza di Triuolemo (530 a.C. ca.). Gi:iuillgell, GeorgAugust-Universitiil iny. 1. 14 (Da K. Sehefold. GO/ler- I1l1d f/c/dcI1Mlgell del' Griechen in del' spi;uwchllischcl1 KUIISI, Miinchcn 1978).
mente tra il 560 e il 550, C la Nike da De lo"' al Musco Nazionale di Atene (fig. 21), una statua generalmente attribuita ad Arehcrmos di Chio in base all ' assoc iazione con un 'iscrizionc dedieatoria la cui Iclt ura e la cui perti nenza sono state oggetto di ampia eontroversia. Segue la testa dell a cariatidc ex-cnidia Ia a Delfi (fig. 22), per la qua Ie Ie datazioni oseill ano Int il 550-535 e il 530. Conclude la serie, sempre a Delri, la testa de-li a carialide del Tesoro dei Sifni '" (fig. 23), I 'uni~ ca scullura databile can sicurczza in base all ' assoeiazione con I' edificio, la cui costTuzione c da porsi tra il 530 c il 525. In qucste ope re In Ri chter ha osservato la lenden za a ridurrc gradualmenle la pro-
[Saggij II
fondit"l della depressione agl i angoli delle labbra e il solco corrispondellte sopra il labbro superiore e satta it labbro infcriore. In questa sequenza, la resa della bocca de i nostri acro li ti si colloca chiaramente Ira In testa della cariatide ex-cnidia e la testa della cariatide del Tesoro dei Sifni. Ci6 si traduce, in anni, al 530 ca. Tale datazione c conferrnata dal confronto con duc korai dell'Acropoli riferibili allo stesso torno di tempo e vicine ai nostri acroliti nelle forme generali del viso. La prima e la kore 682 XI (figg. 20, 37-38), datata generalmente al 530-520 a.C. in questa stiltua, la bocca appare pill stretta che nelle nostre teste, ma la configurazione del ntpporto tra Ie due labbra e molto simile. La seconda stallm e la kore 671 51 (fig. 19), per la quale Ie datazioni osc illano Ira il530 c il 510 a.e. In qucsta statua la forma della bocca appare pill avanzata, specie per cio che riguarda la difTerenziazione delle labbra e la resa de l labbro inferiore. II secondo clemento significat ivo ai fini della datazione dei noslri acroliti e Ja resa dei piedi. Preliminarmcnte si deve osservare che tale resa si distingue per la forma squadrata delle dita e per I'assenza di riferiment i alia struthlra ossea. M,lIlcn, in parlicoiare, I' indicazione delle ossa del metatarso. Mcntrc Ie teste, come qualit:l eli esecuzione, reggono bene il confronto con la statuaria eontemporanca, la qua liu\ dei piedi non sembra all'altezza. Si confronti , ad esempio, la resa dei nostri piedi con quclla del piede destro, ben conservato, della gia menzionata kore 682 (figg. 37-38): In qualita della resa delle dita dci piedi £Ii questa slatua, come di altre statue dell ' Acropoli di eHi tardoarcaica, appare neltamente superiore , se solo si considcrano Ie dita affusolate, accuratamente l110dellate e I' indieazione aitenta dell'impalcatura ossea. Annloghe considerazioni possono fursi confrontando i piedi dei nostri aeroliti con quelli di una scultura leggermenlc pill antiea, la kore opera di Phaidimos al Musco Nazionale di Atcne (fig. 39), di cui resta la sola base, inelusi i piedi. j2 Questa scultura c importante in quanto offre il migl iore confronlo pCI' la forma squadrata delle unghie dei piedi dei nostri acroliti. Le pieghe alia prima falange di qucst'ultimi , invcec, rcstano senza confronto. A fini cronologici, I'elcmento significativo dei piedi dei nostri acroliti e il fatto ehc il secondo dito appare leggermente piu lungo rispelto al1'al1uee. Come osservato a suo tempo dalla Richter, nella stahmria arcaiea, siu nella serie dei komoi che delle
12 [Saggi]
kOrai, si distinguono due fasi: a una prima fuse nella quale l'alluce e pill lungo delle rimanenti dila, con il I'isultato chc la parte anteriore del pied!! dis!!gna una curvu continua, segue una fase in cui il secondo dito risuha piu lungo dell'all uce . Sl Tale fase e associata dalla Richter al gruppo V nella serie dei kouroi (Anavyssos-Ptooll 12, dalato 540-520 a.e.) e al gruppo IV nella serie delle korai (korc di Lione-Etcso, datato 555-535 a.C.). Cio non fa che confermare una datazione posteriorc al 540 a.C. per Ie nostre scu lture. In concJusione, i nostri acroliti dovrebbero essere datati , in base all'anatomia,
36. Dl!mClJ'a e Kore. Gruppo finite da Milo (450 a.C. ca.). Londra, I3ri!ish Mllscum itIY. TB 760 (da Lexico/l /cOIwgraphicllm My llw/og lae Clnssicac, 10, Ziirich J 981-1999).
attorno al 530 a.C. Talc datazione, naturalmente, esprime pill una coll ocazione relativa degli aeroliti all'interno dell ' evoluzione della scultura greea areaica, cite una coJlocazione nel tempo in termini assoluti. Quest ' ultima, infaHi, potrebbe scendere benissimo di un decennio. Questa datazione dei nostri acroliti al 530-520 a.C. , ben prima dunque della fine del VI secolo, costitui sce il primo dato significativo da rimarcare in sede di com men to generale. Lc nostre statue mppresentano oggi la testimonianza monumentale pill antica per I'uso della seultura acrolitica. Infatli , messi da parte i !loslri acroliti , Ie due scultul'e pill antiche a noi note can possibil e dest inazione acrolitiea non datano
prima del 500 a.C . ca. La prima e un volto femminile in marmo bianco a grana fine da Cirene, che non si sa bene, PCI'(), se pcrlinente a una scultura aerolitiea 0 pseudo-acrolitiea. }I La seeonda c il braccio destro in marinO da Egina, sollevato e con la mana che impugnavu una lancia, attribuito da Dieter Ohly e pili di rceente da Despini s a una statua aerolitiea , ma riferi to da Eli sabeth Hager-Weigel a una statua in marmo. 51 A queste due scu lture, generalmente datate al 500 a.e. ca. , seguono due statue la cui identificazione come acroliti pare indiseutibile. Della prima statua, da Thorikos, rimangono oggi i due piedi, in marmo pario, datati da Despinis al primo 0 secondo decennio del V secolo a.C. li La seconda statua, da Tera, e identificata dallo stesso studioso con I'immagine di cu lto di Apo llo Karncios: ne resta parte della testa, in marmo pario, datab ile al 490 a.C. j7 A questi esel1lplari in marmo dalla Grecia segue una testa da Taranto, pertinente a una statua acrolitica di dimensioni superiori al vero. 51 Eseguita in pietra arenarla locale, la testa, seppure in canivo stato di conservazione, puo essere datata ai primi decenni del V secolo, in base all'aceonciatura, che punta alla transizione dalla finc dell 'ctil areaica all'in izio dell 'eta severa. Dopo la testa di Taranto, gli origina li di scu lture acrolitiche ai noi note datano giu alia piena et,i severa: la testa di Cirene gift menzionata (470-460) (figg. 26-28), alia quale si puo aggiungere un secondo esemplare S
? ora al Briti sh Museum, generalmentc datato agli stcssi anni , j frammenti di statue da Chios (oO) (470-460 a.C.), I'acro lito Ludovisi 61 (460 a.C.), la testa VogUc r.l da Egina (460-450 a.e.), la testa femminile dei Musei Vat ieani oj (450 a.e.), e, infine, la testa femminile del J. Paul Getty Museum ~ (450 a.e.). In eta severa Ie sculture acrolitiehe sembrano avere goduto di partieolare favore, e non a easo a questo stesso periodo viene dala~
to l'originale dell'Atena Medici 61 (460 a.e.). I nostl'i acroliti, I'uttavia, dimostrano ehe I'uso di scullure acrolitiehe risale ad un periodo ben pili antico, prima della fine del VI secolo. Cio si accorda bene call la menzione, nell a CI'OIlGC(I di Lindo (XXVI II, 29-35), di una Gorgone real izzata in legno di eiprcsso e COil il volto di pietra dedicata ad Alena Lindia da Deinomenes, padre di Gclonc, krone, Trasibulo c Pol izelo . "" La Cronaca aggiunge I' informazione errata secondo la quale Deinomenes avrcbbe colonizzato Gela assieme ad Antiphlllnos. Tale aggiunta e scnza dubbio un'interpolazione e la dedi-
ca va datata al 525 a.C. ci rca. La Gorgone puo considerarsi una statlla acrolilica nonoslante I'uso della pictra (Ia cui nalura non c megl io precisata) fosse limitalo al volto, " e ben a ragione Despinis I' ha considerata, pio di recente, il documento pill anlieo pcr la scultura acrolitica . .. A questo documcnto, pe ro, possiamo affhmcare oggi Ie nost re scu ltltTc, databiIi agli slessi anni. Veri c propri acrolit i, con non solo iI volto, ma anchc Ie mani e piedi in manno bianco, Ie sculture d i Morgantina indicano comc la pmtica dclla scultura acrolitica con corpo in Icgno ed cstrernita in
37. Korc 682 dall' Acropo!j (530-20 a.C.). Alcne, Musco dell' Aeropoli (da K. Karakasi, Archaic KOr{l i, Los Angeles 2003).
marmo bianco dati a solo pochi deeenni dopo I' introduzione, nella Grecia Continentale, della scultllra crisclefantina di proporzioni monumenta li. II riferimento va, natural mente, alia serie di seulture d 'oro e avorio frammcntarie 69 ri nvenute dagli areheologi franeesi nel 1939 nelle favissae de ll ' area dcll'Halos a Delfi. A qllt:sla seric appartengono i resti di aleune statue di dimensioni pressoehc <II naturale di cui sono meglio noti i tre volti in avodo, tradi zionalmente identifieati con Apol lo (fig. 40), Artemide (fig. 4 1) e Latona. 1" Si tratl'a di pezz i la cui ident ificazione e controversa, tanto quanta I'attribuzione a un ambito geografieo preeiso, ma ehe vcngono comunque generalmente datati alia meta ( 'A pollo') e alia meta-terzo quarto ('Artcm ide' e ' Lato~
na') del VI seco lo. 71 La vieina nza cronologiea Ira i nostri acroliti e Ie sClilture criselefanti ne di Delfi rafforza I'idea, che trova un sostenitore piu recente in Kenneth Lapati n, che la seultura acrolitica sia nata dall'intenz ione di repl icare, in materiali meno costosi, la struUura e la forma esteriore delle sculture eriselefantine. '2
Si Iratta di una idea alia qua Ie Sl e opposta, pill di reeente, Hiiger-Weigel, la quaIe ha sostenuto la natura lUtI 'altro ehe povera delle statue acro litiche, postu lando un uso consistcnte di metallo 0 altro materiale prezioso nella loro fini tura: mctallo e materiale prezioso che sarebbe stalO uli lizzato per indicare particolari anatom iei, come gli occh i, 0 clementi dell'ornamento personale, come orecchi ni e diadem i. 1) E bene pera precisare che al momenta non esistc aleun riseonlro materiale per ta lc uti lizzo di metall o 0
altro materia Ie prezioso pCI' arricchire Ie seulrure aerol itiehc. Una eircostanza che include Ie noslre statue, per Ie qua Ii I'evemuale presen:.t.a di inserti in metallo prezioso c solo indi cata dalla trad izione orale rclativa alia scoperta, che parla del ri nvenimento di oro assicme aile seulture. Con gli acrohti da Morgantina ei troviamo, dunque, di fronle a una eommissiolle ambiziosa, in tesa a em ulare in un materiale me no eostoso, rna pur sempre importalo, Ie dediche prest igiose in oro e avorio nei grandi santuari internazionali di eta arcaica. Dediche ehc potrebbero includere, per questo pc riodo, Ie cilia sieeliote, se la statua erisoelefantina di Dioniso menzionata da Pausani a (6.19.16) nel tesoro dei Sel inuntini a Olimpia data agli stessi anni della costrllziolle di questo edifieio, ovvero l'ult imo quarto del VI secolo a.C. J' Cia ci porta a discutere del cOllteslo di provenienza dei 1l0Stri aeroliti , rinve nu ti notte lempo, come stabilito da una inehiesta giudizia-
ria del Tribunale di Enna e del Comando Tutela Patrimon io Artistico de i Carabi~ nieri, nell' estate del 1979 in Contrada San Francesco Biseonti (fig. 42)." Contrada San Francesco Bisconti e stata oggello di scavi ad opera de lla Soprintendenza cli Agrigento nel 1979, e pill cli recente ad opera della Soprintendenza di Enna. 76 L'area , prossima n una delle necropoli (V I) e per questa oggelto di saccheggio ad opera de i clandestini , 5i e rivclata sede di un santuario cxtramurano di Demetra e Kore: un imponente eomplesso Olomnncnta le distribuito su terrazze, COil una serie di edific i d isposti a sehiera. I material i pili antichi datano alta seconda meta del VI secolo a.c., e la frequentazione del si lO C ancora ben doeumentata per il V seco lo. Utilizzato lUleo v
I'll durante il IV e III seco lo, il santllario venne di strutto attorno alia fille del III seco lo a. C. Uno de i dati pill intercssanti relativi a questo santuario e la presenza di ecl ifi ci a schiera, desti nati non solo a COIl
tenere offerte votive e ad ospi tare sacri fici , ma anche ad altoggiare statue di
38. I'nrlieol arc della figura 37. 39. I' iedi c fra11lmCniO di plinlo della Korc di Phaidi11los, da Vourv3 (550.40 a.C.). Atene, Musco Naziona1c inv. 81 (dn K. Knrakasi, Archllic Komi, Los Angeles 2003).
[Saggi] 13
40. Testa crisclcfall tina (Apollo) dall 'area dell' Halos a Delfi (,"eta del VI sec. a.C.). OeUl, Musco inv. 104 13.
di mensioni monumentali. Negli senvi della Soprin lcndellza di Agrigento fUl"ono rinvenut i, Ira !'a llro, fTammenti £I i statue femmini!i in lenaeolla di grande modulo, dalabili al Veal IV seeolo a.C., ora in mostra <II Museo di Aidone. Quesli fram· menti non possono considerarsi perl inen· Ii ai !lOSlri acrolili, per molivi sia cronologici che teenici, ma sono importanti in quanto confe rmano ehe nel Santuario di San Francesco Biseonti erano esposte statue el i grande modu lo. Pitl precisamellte, i nosl1"i acroliti potrebbcro essere ri ferili al momento della fondnzione del santuario, una dedica appropriala per quel lo che appare oggi, in base all'ev idenza archeologiea, uno dei princi pali luoghi di cullo di Demetra c Kore in Sicilia. La ded ica aHorno al 530-520 a.C., in un santuario demelriaco d i Morganlina, di slatue monumentali di forme greche non slupisce, eonsiderato che in quesli ann i il processo di ricezione di modell i cul turali greei cia parte dell a popolazione indigena
14 (Saggi]
era in una fase gi,l pi uttosto avanzata. 11
Oi tale aceulturazione danno la testimonianza migliore Ie necropoli, che documentano, Ira il tardo VI seeo[o e I' in izio del V seeo[o a.c. , I'es istenza d i un ' elite 10e,lle sensibi le a prati ehe soeia li di ti po greco, a eominciare clal simposio. Esemp[are al riguardo [a tomba a camera 4, con cinque sepolture, tulte inumazion i, databili tra la meu\ de l VI e il 475 a.C. in base al materiale ccramico d' importazione, gran parte de l qua Ie funziona le alia eonsumazione del vino e al simposio. Tra queste sepolture spiceano Ie numero 4 e 5: [a pri ma (525 a.c. ca.), in una fossa, pertinente, in base nll 'analisi dei resti della sche[etro, a una don na di 35-40 anni di eta; la seconda (550 a.C. ca.), in un sa reo fago scavato nella roccia, anch'essa riferibile a una donna, rna solo in base al corredo. Si Imlla delle sepoltu+ re piu rieche di etil arca ica a Morganli na, earatlerizzale dalla presenza di numerosi oggetti di metallo, Ira i quali d iversi fe rmatrecce, anelli e fibule in argento. Si tmlla di oggelli preziosi ehe ribadiseono Ie possibi li ta eeollomichc e ['alto stailis soeiale delle de funIc: due donne indigene, a giudiearc dagli oggelli di metallo di
41. Testa crisclcfantina (Arlcmide) dall'arca dell"Halos a Dclfi (terto quarto del VI sec. a.c.). Oelfi, Musco inv. 10414.
tipo tradizionale che ne accompagnavano i resti. 7I Nei membri di qucst' lUite locale pot remmo identificarc la commi llenza dei nostri aeroliti. Onl punto di vista stilistieo Ie noslre sell [lure costi luiseono un gruppo omogeneo. A parte Ie dimens ioni, e malgrado differellze minori , ravvisabil i nella resa degli angoli interni degl i ocehi e de lle labbra , gli inserti corrispondenti alia testa e al colla sono infatti molto simili. I due pezzi sono att ribuibili a uno stesso seultorc. Quanto aile due mani de ll 'AcrolilO A, Ie proportion i genera[ i e la resa delle dila e delle unghic sono soslanzia lmentc identiehe e gi uslificano I'allribuzione all 'autore delle teste. Leggermcnte diversa, inveCC, C la resa della mana sinistm dell'A · erolito B: la forma e Ie dimensioni delle unghie differiseono da quella delle mani del l' Aerolito A. Malgrado Ie inerostazioni, Ie schcggiature, C la corrosione delle supcrfici, i due piedi dell' Aerolito A presenhtno Ie stesse proporzioni generali e la stessa resa delle di ta e de lle unghie. Oi nu~vo pero, la resa del piede sinislro del['Acro lito B e Icggennente divcrsa: Ie proporzioni generali de[ piede e de lle dita sono Ie slesse, ma nel piede in csame In resa del le pieghe prima dell'unghia c doeumen tala per tulte Ie dita e appnre decisnmentc pili mareata. Analogamenle, la resa dell'ungh ia dell'alluce c leggermente divcrsa, deserivendo una curva alia base divcrsa dalla forma ad angolo retlo documentala ehiaramente nel piedc si nistro dell' Aerolito A. E difTie ile stabi~ lire se ta li [eggere d ifferenze nell a resa di mani e piedi siano da riferire all 'inter-
I ve nto di due di st inti seultori. Esse, eom unquc, mcrilano di esscrc 110131e. Resta comunque il fatto che, come detto al principio. Ie nostre scullurc coslitui~ scono, dal punlo di vista dello sti le, un gruppo omogenco: si lrutta ccrtatl1enlc di opere prodo\le nella slessa bO\lega. III prepamzione per it Simposio sugli 11el'olili lenutosi all ' Univcrsilil della Vir~ gin ia ne l Fcbbraio del 2008, John Herr~ mann Ita condOllo un ' analis i su un ca m· pi onc di marmo prclevato dalla test:l de l ~ l'Acro lito A. Qucst ' anali si ha confe rma-10 I'i dentifieazione de lla pielra can mar· 1U0 di Taso avanzala qualche anna prilllll dallo stesso studioso in base a un csamc autopti co delle scu lturc. "lt Tale identifica~ zionc dovrcbbe essere estcsa al reslo degli inserti , ehc appaiono esserc dell o slesso materia Ie. L' illlportazione del marmo di Taso in [Ia· lia e un fenomeno be n docWllentato archeologicamente per I'eta romana. ~ Per il periodo greco, c in particolare per l'cla arca ica e classica, la documentazione c assai pi u modesta. Tutlo s i riduee, sostan zi almentc, al Trono Ludovisi e al Trono di Boston - Ia cui provenienza dalI' !tal ia Meridionale 0 eventual mente dal · la Sicilia pLIO dilTie ilmcnlc cssere messa in di sclissionc -, eseguiti ne l manno dolomitico a gross i eristalli , prcsllmi bilm!;!nle dalla reg ionc di Saliari. I' L:identificazione con marmo di Taso del maleri a· Ie per 1<1 Slat Uli di Mozia '" e stala infatli confUlata dai risultali delle anal is i di Rosa rio Ala imo e Marcello Carapezza. IJ
La testa di Stil e Severo a C leveland ehe Ie nnali si hanno pravalo essere nel mar· mo dolomiti co a grossi cristnlli cia Taso, non prcscnta inveee ana log ic tali con I'efebo in bronzo da Sel inuntc 0 J'cfcbo in marrno da Agrigellto da rendere s icura una sua provenienz.'l dalla Sicilia 0 dall ' [· talia Meridionale . ... I nostri ae ro lili sarebbcro dunqlle il pri A
rno csempio noto di importaz.ione di mar~ rno lasio in hali a durante i1 periotlo areuico. Tutto cio, natural mente, ha va lore molto relm ivo, se si consitlera che s iamo aneora lontani da una campionatu ru com~ pleta dei manni bianchi di el~\ grcea dalla Sici lia. '" L'originc tasia del marmo utilizzato per i nostri aero lili invita a eereare eonfronti can la scultura arcaica di quest' isola. " Della seultura arcaica di Taso conoscia· mo un buon numero di slatue e ri liev i, eonservatisi purtroppo nella gran parte dei eas i alquanto mala mente. La produ~ zionc di scultUnl C documentaHl [oealmente fin dalterzo quarto del VII seeo lo (rilievi dall' area del san luario di Apollo Pi zio, ogg i al Louvre), e prosegue florida
fino al 463 <I.e .. an no in cui Taso passa SOItO il controllo di Atene. Pcr tullo questo periodo, In sCllltura £I i Taso present.! legami s igni fien livi con Paro, una circaSI:1I1za chc non sorprende, duto ehe in eta areai ea I'apoikia munlennc rapporti molto strelti con la melropoli. E merilo di Ernsl Langlotz avcre per primo ev iden~
zialo questo strello Icgamc Ira la scultura arcaica di Taso e Paro, a fronle della scct· ticismo manifeslato al riguardo da[l a l e t ~
tc ratura coeva. 1I In particolarc, Langlolz aHribuiva 10 111 COllrl ali a serie di Para la eosiddetta testa Wix c i komai tin Taso :'Illom noli. La testa Wix c risultata poi.
42. Morgmllina. PinOla del Sa!llll"rin ill coolrada Sllll Francesco !lisconli (dll V. !-linz, Dt'I" KIlIr I'OII Dcmcter lilld KVrc wySiziliell IIlId ill del" MagliO Gmec/a, Wicsbadcn 1998).
grazie a una bri llante ricongiunzione tl i Ilernard Hohzmann, perlinente a una Minge, piutiosto che a un kouros, ma resla il fatto ehe il legume Ira la seultura di Taso e quel1n di Paro emerge piil chiamlllenle nella serie dei kouroi in manna. Di questi si eonsc rvano oggi , a parte il colossa[e eriororo non finito del princi· pio del VI seco lo. cinque torsi e duc teste. Dei torsi , il meglio eonservato, quell o a Istanbu l, provcniente da Ali ki '5 e databiIe alia mela del VI secolo, oITre il confronlo pill s ignifiealivo con la scultura eoeva di Paro, in particolare con il komos dall'Asklepicion , ora al Louvre. " Le pro~ porzioni del torso delle due smtue sono Ie stesse, come il discgno di singole parti anatomi che, quaJi la linea inguinale, la cresta iliaca, e l' arcata epigastriea. La scuitura in marmo di Taso di cia arcai · ea non sembra potersi riassllmere, pera, esciusivamenle in un confronto con la scuhura di Paro. Cio eben dil11ostrato da due teste di komi tli atla qua lila , perti· !lenti a dediehe vOli ve comparabili a que lie dell'Aeropoli di Alene. La prima testa (fig. 43), scoperla !le i pOi'· tieD nord~ovest dell ' agora nel 1948, C sta~ ta oggetto di un ' anali ~ i sistemati ca da parle di Holtzman n in UllO studio pubbli cuto nel 1977. lID Holtzmann eonfronta In testa di Taso con quella della eariatide del
tesaro dei Sifn i a Delfi (fig. 23), un riferimenlo pill che pertinenle, dalo chc la st rullura della tcsla e i tralti del volto appa iono molto sim ili, come pure il rendimcn to dei cape lli , in particolare Ie ciocche sOllili e Ie ondulazioni sull a fronIe. Piullosto c ite allribuire Ie due scu lture alia stess:! mana, Hohzmann ipotizza una matricc C0111une, attribucndo la testa di Taso a uno seu1tore locale che lavorava a[l" manicra pari a, c la eariatidc delteso~ ro dei Sifni a uno scu ltore di Para, respol1sabi lc anehe dei fregi Est e Nord dello stesso edific io. " Hohz mann data conseguentemelll"c la testa da Taso ad
anni posteriori rispel\o "Ila eariatide del Tesoro dci Sifni , ma non di molto , data la qual ita nOlcvo le: dunque, a[ quinqttenni o 5 [5·5 10 a. C. Pur eseguita nell,l maniera paria, la testa del Musco di Taso presenta dei virtuosismi nella lavorazione del marmO, dalln rcsa sof isticata dcll'accolle iaturll a ll 'indicaziol1c in marlllO di elemcnIi dell 'ornamento, che non s i riscontrano nella testa della eari atide del tcsora dei Sifni. Questi virluosisrni SOllO consideraIi dn Holt zmann la spia dcll 'i nnuenza di un secondo centro, da lui" idcntiricalo con Chio. Analogo ragionamcnto vale per la sccon~ da tcsta di kore da Taso (figg. 44~4 S), ehe prcsenta un tipo tli virtllos ismo dive rso, che si csprime nel cospicuo ricorso a ele· menti di riporto. Si tmlta della lestn gia apparlenenle alia cOllezione del Vicccon~ sole Francese r. Voulgnridi s a KavalJa , e dal 1976 all ' Antikenmuseum di Bas ile,,- ~1
Discussa in letleratura fin dal 19 13, la testa C slain oggelto di una nuova ana li si da parte di Dietrich Boschung, in uno sludio pubblicmo nel 1985. Lc prineipali earatterisliehe d i quesla testa sana Ie dimensioni leggcr mcn te superio ri al naturale, la f ineua nella resa dei capelli , dei quali sono definite con minllzia Ie s ingo lc eiocchc. e l ' i1mpi o 1"ieorso a clementi di ripor1 0. Questi clcmen ti . ass ie~ me a[la poliero111ia de lla stahla, devono averc contribuito nOll poco ad aumenli1r~
[Saggil 15
ne l'e fTctto. A parte elementi in marmo per la resa dell'aeconeiatura sopra Ie orecehie e per gli orecch ini, meUe eonto soprallullo menzionare i riport i in malcriale diverso dal marmo: gli occhi , alloggiati in profondi incavi, per j qua li Boschung ipotizza il ricorso al vclro 0
cristallo di rocca per iI bu lbo oculare, una pictra colorata per I' iride, e, forse , lamina di bronzo per Ie pa lpcbre; quindi elementi dell 'ornamcnlO personale, indiziati da una serie di fori di trapano: nove fori sopra la fronle , in corri spondenza della parte terminale dei capell i, e quattro fori in corrispondenza de lla step/wile. I fori
43. Tcsta di kore daU'area dcU ' ;lgora di Taso (515-510 H.C.). ' l~'so , Musco in .... 618 (dll K. Karak:lsi. Archaic Knmi. Los Angelcs 2003).
sopra 1a ft'onte , secondo 13ose hun g, sarebbero stati destinati all 'allacco di decorazioni in mctallo, probabihncnte rosette in bronzo 0 metallo prezioso, menlre gli altri sarebbero stati dcstinati ad alloggia re decorazioni sussidiarie delIa sfepha/lc, in fo rma di boceioli. Boschung confronta la testa Vou lgaridis can quella della cariatide ex-en idia a DeIfi (fig. 22), eertamenle il miglior para lle-10 data I'analoga struttura del vo lto, 10 stesso uso degli occhi inseri ti e la somiglianza dcil' acconeiatura . Sull a base di questo confronto, Bosehllng data la testa Voulgaridis a pochi anni dopo la testa della carialide cx·cnidia, attomo al 530-520 a. e. Nel suo studio della tcsta Voulgaridis, Boschung, raccogliendo sistemalicamcnIe In docllmclltazione relaliva al matcriale scultoreo di cta arcai ca cia T<lso, si c spin-
16 rSaggi]
to a proporre I'esistenza nell ' isola, a pnrtire dalla meta del VI seco lo, di una scuo· la di scultori can una sua precisa ri siono· mia e molto omogenea dOl i punto di vista slilislico. Si tratta di utHl proposta che non ha avulo molta fori una, e ha inconIralO anche qualehe crit ica esplicila . 91
]]
problema e che, come ev idenzinto dn Holtzmann e Rolley, la scultura di Taso di eta arcaica non 5i presenta troppo omogcnea a livello stilistico, rivclando piultosto una diversificazione di soluzioni forma l 1 e di ispirazioni che gli stud iosi rrancesi spiegano con 1'0rigi ne coloniale della c ilta c ia sua posizione mnrginale nell 'Egeo. Per usare Ie parole di Holtzmann, la seu llura di Taso sarebbe una sinlesi sempre instabile Ira il fondo cielad ico dei coloni venuti da Paro e gli apporti success ivi di centri con i qual i Taso e entrata in rapporto a seguito di legami politic! e commcrciali . Ncl corso del VI seeolo, in par· licolare, il rondo pario si verrebbe a meseolare can gli apporti di Chio e delle cilia greche della costa nord-ovest delI'Asia Minore. Per ragioni cronologiehe, il term inc di eonfronto obbligato per i nostri aeroliti e la testa Voulgaridis (figg. 44-45), riferibiIe al medesimo decennio. Purtroppo, la frattura della testa di Basilea in corrispondenza del nasa ci priva di un termi ne di riferimemo importante per confrontare I' impalcatura dei tratti del vo lta. Da quanto resta appare peri> evidente che il naso dei nostri acroliti era decisamente piu largo. Si tratta della prima indicazione della generale tendenza dell 'autore de lle nostre scu lture a dare maggiore enfasi ai tratti distintivi del valla. Cia c confermato da un conFronto sistemllti co Ira Ie teste dei nostri acroliti e la testa di 13asilea , che lase ia emergere ana logie e difTerenze alquanto significative. Le diffe rcnze riguardano anzitutto la rcsa della fronte , ehe nei nostri acrolit i c neltmncnte piu sviluppata verso I'a lto e pili sfug· gente. La seconda difTerenza riguarda Ie arcate sopracei liari, chc nei nostri acroliti sono nettamente piu alte e profondc che nella testa di Basilea. Cio si accompagna a una maggiore prominenza degli occhi, pill alt i e sopranutto piu larghi. Le stesse osservazioni relat ive al nasa e agli occhi valgono per la bocca, chc appa re di nuo· vo piu larga e pronuncillta nelle !lostre teste, specic in quell a dell' Acrolito A, e per il memo, che nei nostri acroliti, specie quello A, apparc pill massiccio. II confronto dell 'area infcriore del vo lto c pera complicato dalla presenza di duc scheggiature nella parte corrispondcntc della testa Vou lgaridis, alIa meta destra della bocca, e alia punta del mento. A
fianco di queste diffcrenze, e bene pe~6 sottolineare la presenza di un 'anal ogta molto importante tra Ie tre teste. Si tratta dclla resa molto acccntuata del sorriso, che curva la bocca e so lleva gl i zigomi, di modo cite Ie labbra descrivono un areo iscritto in una depressione i cui limiti estremi sono costituiti dagli zigomi e dal mento, entrambi abbastanza prominenti. Come evide nzialo in particola re da Holtzmann, quest'articolazione del l'area della bocca - che si mallifesta pcr la pri. ma volta attorno agli anni 570-560 a.e. nella lesta dell a sfinge Wix - e caratteri stica di una serie di opere da Paro, Delo,
44 .45. Tcsla di kore da Taso, c.d. Testa Vou lgaridi s (530-20 (I.e.). Basile,]. Anl ikcns(lnlm lung in .... I3S 245 (da K. Karakasi , A,y:llflic Komi . Los Angeles 2003).
I Taso e Delfi databili ai decenni aHomo alIa meta del VI scco lo a.c., cd apparc costituirc un tratto di stile distintivo di quel la corrente pario-chiala nella qualc 5i inscrisce la scultura lasia del VI sceol0 a.C. ~ La presenza di questa tralt'o nelle noslre teste mi scmbra sufJicicntc per avanzarc l':tttribuzione dei nostri acroliti a un' officina t<lsia del VI sceol0 a.c., plenamente inscrita nella corrente pario-chiata, can Ie cui opere sanD del reslo possibili i migliori termini di confronto. Basti pcnsare in particolarc alia testa della cariatidc cx-cnidia (fig. 22) dove il confronlo 5i estende all ' usa di ocehi inseriti. 93
Rivolgendosi ad nitre aree geograriche della Grecia arcaica, gJi uniei confronti di un cerlo significato sono con Ie korai dell'Acropoli 682 (figg. 20, 37-38) 06 e 671 (fig. 19), 91 duc opere tra loro molto vicine, che ho gin avuto modo di mcnzionareo J1 confronto con la korc 682 e piu nclI' uso degli occhi inseriti che nella configurazione complessiva del volio: basti considerare 1<1 boccn relntivnmente stretla e il mento appuntito. II eonfronlo con la korc 671 riguurda, invece , elcmenti importanti dell'anatomia, qua Ie la forma obl unga del volto, I'enfasi sulle arcatc sopraceiliari, In bocea larga, e il men to massiecio. Si trutta di un eonfronto significativo, ma che non puo dirottare I' attribuzione dei 110stri acroliti da un'ofTicina lasia n un'officina <I\tica . Cio per In ragione che la kore 671 , malgrado sia quas i certamente da attribuirsi a uno scuitore attico, deve mol to, proprio nelle forme del volta, alia scultura insulare, come gia rilevato da Langlotz. '18 Si tratta di un'influenza ehe anchl' i sostenitori piu recenti di una origine attica dell 'autore della korc 671, come ad escmpio Francis Cro issant, 99 sono costretti a concedere. Per questo ritengo che il confronto con la korl' 671 non sia sufTic ienle per attribuirc i nostri acro liti a uno seultore att ieo. E difficile immaginarc, nc! caso di statue ncrol itiehe, a una spcdizionc dcgli inserti di marmo gii'l rifin iti al luogo di destinazione, e ad un loro succcssivo assemblaggio con il corpo di legno ad opera di un gruppo diverso di eseeutori. Cio gia solo per la necessita di raccordare Ie parti in marmo con Ie parti in lcgno, che comportava la rcalizzazione di incassi nelte prime, e per la nccessita di interven ire sugli inserti di manna per l'app licazionc degli elementi di riporto, in mcfallo 0 in pietra preziosa. Per questo, 10 scenario pill plausibile e quello che vede gli aulori dei nost !"i inserti giungcre in Sicil ia con il marmo, cd cseguire gl i aerol iti ncl luogo di destinazione. Se questa ricostruzione
eogli c neJ segno, I' importanza degli acroliti di Morgantina risicde aHara anche nel fatto di documcntare !'attivila nel1' isola di scultori provenienti dal1'Egeo al1a lransizionc dalla media alia tarda eta arcaica. La letteratura degli ultim i deeenni su lla scu ltura de\l'[lalia Meridionale e della Sicilia e stata dominala da una generale tendenza a riattribuire a ofTicine loculi i pezzi pill significat ivi della statuaria in manno di etil arcaica provenienti dallc coloni c greche e dai centri indigeni. lOll
Cio in opposizione alIa tcndenza della letteralu ra precedeme Csu tutti merit a
46. PrOlomc fcmminilc in t~rracoUa dal Thcsmophorion di tlitalcmi a Gela, apparlencntc al "Macander Polos Type" (530-10 a.C.). Sinlcusa, Musco Areheologico Regionalc "Paolo Or~i" inv. 21301 (da J.I'. Uhlcnbrock, Til e Tl'.rmCOI/(1 Prolonwi/rom Gela: (I di.w:u.\·$ioll /I/local SIY!C ill Arc/mic Sicily, Roma 1988).
eilare il nomc di Langlotz) ad idenl ificare come importazione 0 prodotto di scultori provenienli dall 'esterno ogni opera in manno di una qualche qual ita, in nome del ricorso in quest' area geog rufiea a marmo bianco dal l'area egea, e della presunla, concorrcnte inabilita a lavorare questo rnateriale da partc del1e officine loeali, abiluate a Invorarc il piu tcnero calcare. Se quest' ulti mo modello interpretativo e privo di fondamento - esso sembra infatti ignorarc I'estrema dllttilita a livello teenico degli scultori arcaici , spec ie per cio ehe riguarda it materialc da lavorare - , devo pure osservare che molte delle riattribuzioni recenti a officine loeali , italiote e sieeliote, non appaiollo scmpre cogenti , basate come sono su cri-
teri di raggruppnmcnto stilistico alquanlo labili. NOll C questa illuogo per disclltere, pill in generale, del problema della connoissellrship della seultura green arcaica e elass ica. Vonei pillttosto porta~ re l'attellzione sui fatlo ehe questa generale tcndenza alia riatlribuziotlc ad o ffi cine locali riscllia £Ii farci pcrdere di vista un dato strutturale fomlamenlale della scultura greeil di eta arcaica: ovvero la continua mobilit:i degli scultari. Al fenomeno della mobilita dcgli seultori e delle loro botteghe in eta areaica si e fatto spcsso riferimento in letteratuTa, specie anglosassone, ma csso non e stato ancora
oggetlo di un 'analisi sistematica . I~I Un ricsame sistematico e di prima mano della doeumcntazione letteraria ed epigrafica relativa agli sellilori di eta arcaica produce pero al riguardo risultati signifieativi. 101
La storia per originali e senza 110mi della scultura arcaica portala avanti net '900, in opposizione alIa storia per copie e per nomi della scu ltura elassiea pOl·tata avanti nell'800, ci ha abitual i a pcnsarc che conosciamo molto poco circa la biografia <legli scultori del periodo arcaieo e delle loro boueghe. In rea Ita, da fonti letterarie cd epigrariche conosciamo i nOllli di almcno I ° I scultori sparsi per tutlo il MediteHaneo. La documcntazione c incoerente e parziale, 111a certa sufficiente per osservare, Ira I ' altro, come la mobililft fosse una cOl1lponcnte essenziaIe della profcssione dcllo scultore (per 20 scultori sono documentate opere loc<llizzalc!provcnienti da pill luoghi ; per altri
[Saggi] 17
32 SCliltori sono documen talc opere in un iuogo di st into ri spetto a quello di provenienza). Che si tralti eli SCliltori operanti alia transizione gall'cta orientalizzante all'eta arcaica, qual i Dipoinos c Skyll is, ache si traUi di figure operanti alia meta del sccola , quali Archerrnos e Theodoros, ache si tratti , infine, degli arlefie i della transizione alia prima eta severa come Kanachos, gJi scultori dimostrano una eostame propens ione a muoversi sulle diverse sponde del Mediterraneo. II caso pill cst remo e forse quello el i Telephanes di Focea (0, in aiternativa, Foeide) di clii gli autori antichi conoscevano opere tanto in Tessaglia che in Persia. 'OJ
II riflcsso di questa mobilita emerge chiaramente in quei contcsti chc ci riconsegnano, grazie a circostanze cccezional i, una porzione soddi sfacente della produzione originari a, come Itei casu dcll 'Acropoli £Ii Alcne. Qui, la mobilita degl i scultori e la eonseguentc in lersezione di sli li Irovano conferma nella eostante diff ieoh il. della criti ca a distinguere ITa Ie korai tardoareaic he cia ehe c atti co. cia che t: cicladico, e cia che c della Grecia dell' Est. E proprio in questa quadro di 11l0bilitll ehe crcdo si debbano colloearc gli aerolili da Morgant ina, opera eli un'ofTicina tasia recatasi in Sicilia per cscguirc questa, c evc ntuaJmClltc altre prestigiose commissioni , se e Iceito pcnsare che- la dedi ca di due stahle acrolit iche in un silo dcll 'interno come Morgantina emulassc fenomell i 31laloghi ne ll e co lonic della cosla (si e g ia mcnzianata [a dedica di Dcinomenes di Gela ad Atena Lind ia a Rodi). Questa auivita di scultori dall' arca grecoorientalc a Morganlina, intorno al 530-520 a.C., non dovrebbe sorprclldcrc. Sono stati nolati da tempo, infntti, i paralk:li tra la cu ltura matcriale £Ii eta ,lrcaica di Morgantillu e il monelo greco-orientale, chc hanno portato a postu larc non solo rapport i mediati dalle co lon ic greeile delIa cosla orientale c meridionale della Sici lia. ma anche rapporti diretli, consistenti nell' arrivo di coloni , mereanii e art igiani. ,1).4 Si tfaUa dei parallcli nelle forme di decorazione tra Iii eeramica locale e la eeramica di produzione eieladiea e ionica; dcllo stile di chi ara isp iraz ione greco-orientale dell e terreeotte arch itettoniehe figurate che dccoravano gli edi fi ci della Ci tladclla, quali Ie <lntefisse a teste femminili del "Four Room Building," la cui prima fase e datata da John Kenfie ld al 550-540 a.C.; e, in fine, dei rrammenti in pietra da una strultura non meglio identifieata della f ine del VI
IS [Saggij
secolo, tra i quali spi eea una corn icc con dceorazione ad aSlragaio e a logli c di chi ara ispirazionc cieladica c ioniea. riu in genera Ie, questa prescnza di seultori di provcniellza egea in Sicilia dcve avere gioeato un ruolo significalivo ncl le dinamiehc arti stiehe dell ' iso la, eonlribuendo in maniera significativa alia diffusionc della manicra ion ica e ispirando la pratiea artigiaoale corrente: I~l si pensi ad esempio alia produzione di protomi femminili in Icrracotta. Confronti inleressanti con i nostri aerolil i si ril evano nellc protomi £Ii Naxos di pili chiara dipenden za da modelli greco-orientali, come I'esemplare di fabbrica locale Naxos 615. lOG Soprattutto, melle eonto cilare qui Ie protomi di Gcla, in particolarc il secondo tipo (fig. 46) dclla classifieazione di Jai mee UhlelJbroek, il "Maeandel' Polos Type," per la cui ereazionc Ie datazioni osciJlano Ira il 530-520 (Piero Orlandini) c il 510 (Uhlenbroek). '07 Si tratta di un tipo di prolome che nella resa £lei tratti faeeiali prescllta analogic significa tive con Ie sc ulture eli maniera patiachiota aIl e quali si e gia aecennato, specie per il modo £Ii ueccn tuare il sorriso tramite Ie labbra carnose, gli zigomi prominenti e il mento arrotondato. ,~ Non a easo, la Uhl cnbroek identifiea come COI1-
fronto pri vi legiata per Ie protomi di questo lipo proprio la lesta della eariatide excnidia a Delfi (fig. 22). A questo confronlo possiamo oggi aggiungere i noslri aerol iti, ehe con altre opere consimili della scultura monumcl1lale non possono non averc eserei tato una lora influenza sulla produzione eoroplastica iso lana, almeno tanto quanto I'importazione direita di terrecotte dall 'Egeo e dall 'Asia Minore. Ovvero: g li aero1i li eli Morgantiml non sono solo due operc £Ii rilievo della scultum greca arcaica, ma anehe due doeumenti di primo piano dell 'urte in Sici lia nell a seconda meta del VI a.e. Essi ei restit uiseono infatti un'idea delle spell acolari potenzialita delle e01l1m ittcnzc delI'cpoea. indusa la capaeita di aUrarre artefici dall ' arca egca pcrinearichi prestigiosi, in un periodo pcraltro assai propizio per sim ili spostamenti. Un motivo in pil) per rnllcgrarsi del ritorno dei due aeroliti in ltuli a e in Sici lia, e della loro prossima esposizione al Musco eli Aidonc.
1) I! mio primo esamc dcgli aerolil! da Morganlina risale al MarLO 2002, quando fui inear icato tlal Minisicro dei l3enl Culturali e Ambicnlali tli valularne l 'aUlcllticih\. Lc selllture appartenCvallo allora a una col1e1.iol1e privata di New York e il miD C$<\mc si svotse lIet eaveau di una Banca ddla Fiflh Avenue. in eomlizioni mnbicnlali non idea Ii. I risultati di qucll'e~mne sonG in porte cont1uiti in un~ nola apparsa nel 2005 (C. Marconi. Gli IIcrolili di lI1org(llllilla , in Ul'bllllis{iclI e IIrcllitelllll'(1 lieU" Sicilia Grect!, a eura di P. Min~ , Regione Siciliaml. Palermo 2005, p. 81).112 febbraio 2008 ,o;i c lenulo, pl'esso l'UniversilA della Virginia, un Simposio sugli aeroliti (The Goddesses Rcrum. A Symposilll/1 Celebrating tbe Repwrilllioll to IllIly of l/emlithie Scu/plllre.f flvl/1 Morglllllillll) organiuato do Muleolm Bell, che ringrazio dcll'invi-10. Ohrc a Molcollll Bell (provenienz3 degli HCfOlitL rieo~truziollc, c signifieato storieO-i1 rti~lieo) e allo serivente (ricoslruzionc e $igniricoto siorieoartistico), SOllO inlefVclluti ~u ll c scuiture John J. I·krrllll\nn (~na li si dd marl1lo) c Carla MaThl AntOllllccio (santuari areaici di MOTgantina) . In oce,\sione del Simposio, ho al'uto l'opporlnnilJ di riesaminarc Ie $euituTe in condizioni di luee migliori, sia pure dietro una teell di velro. La re lazionc pcr quel Simposio form " il nuc1co della presenlC nota.
2) Dill:! la loro 3ppartenen1.a [ler divers! al1l1i <\ una eolle1.iol1e privata, la lctlcl'(\\urn sui nostri acrol iti i: lllqual1lo ridotla: cfr. i brevi riferimenti in J. Pol lin! , Acmfililic 0 1' Pseudo-ncl'f//ithic Sculplrlre of (he Malure Cla ... yical Grcek PCI'iod ill IlleArchal.'ologicill MUSCUIII of tM JOhll.T Hopia"I.v Uniw:rsit)', in Clllssical Marble: Geocfrcmi$lry. 7ccimQlog),. 7i'0(/e, a ellra di N. Hc • .l c M. Waelkens, Dordrcehl e Boston 1988, pp. 207-216, ill pari. pp. 208·209; J.J. Herrmann, nit/50S (lI1d the AIlCiell1 !dllrble 7i"fldc: Evidence flvlII Amel'iclllI Museums, in Mllrble. Art Hisloric(11 (!lui SCielllific Pcrspectil'es 011 Auciell! ""'II/plUfe, a cura di M. Trlle e J. I'odany, Malibu 1990, pp. 73-1 00, in part. p. 79 (qui 5i eila, alJa nota 33, lin nmlloseritto inedito di C.C. Vermeule datalo al 1984 - Cow{ogue of (I ColleCfioll of Greek. ElfIlSC(1II (lnd Rom(1II Al1ti~ ({!lities - in cui gli aerolili sono disclL~si aile pp. 13-\4, n. 6); C. Rolley, LII SCII/{!IUrf' greCf/lle, P;lris 1994-1999, I, p. 77; E. Hilger-Weigel, CriechischeAkrolitfl-SlillUCII des 5. lind 4. Jlls. 1'. Chi:, Berlin 1997, p. 20, note 42 e 44: N. GiuSlozzi. Gli diN (/(1 pe:zill: I'Hercllicl>' ll'oA'UKto~ e III tC~'niCIl aero/ilico lIeI II Sl'c% a.e . in '13ollcuino dci Musci Comunali di Roma ' 102. 2001, pp. 7-82, in part. p. 62 . nOla 233; G.!. Dcspinis, 1.11 Akrolilh · stlliliell griechlsc!w,. IIIlIl romisc/l!1r Zeit, in 'Nach· richten der Ak:\dcmic der Wisscnschafien 1. ll GOItingcn' 8, 2004, pp. 245-301 . in parI. pp. 247, nOla 7,e251,1\01333.
3) Dimensioni in em: ahen.a 33.5; Ilirghezza 20; spessore 18. Distanza £lalla punta del Illento alia sOfllmit a della fronte 23 ; distan1.a dalla punta de l mento alia base dclnaso 7.5; dislanza £lalla base del naso all'a rcala sopl'acciliare 7; Inrghezza di entrambi gJi ocehi 5.
4) Dimensioni in em: ]ullghczza 19; larghczza 9.5; 1I11ezza 8. 5) Dimensioni in em: lunghezza 19; larghez1.a 10.5; ahezz~ 8.5.
6) Dimensioni in em: lunghezza J9.2; larghez1.a 11.8: nltczzlI 7.7.
7) Dimensioni in em: lunghczza 20.5; larghezza 11.8: ahez1.a 7.7.
8) Dil1Jen~i()ni: aile1.z;! 30; larghczzn 18; spessorc 1 S. Distan1.~ £lalla punla del menlQ ~lIa $ol11111il;\ della froille 20. Distanza dalla punta del menlo alJa base del naso 7; distan1.a da lla base dc1naso all'a~(lla sopJ'oleciliare 7. Larghezzu ocehio sinistro 5; larghez1.a occhio 1Iesl ro 4 .7.
9) DimensiOlli in em: lunghezza 12; larghezza 9; ahezza 7.
I
10) l)Llncnsioni in cm: lunghc1.Zl1 16; larghczza 10; nltczza 6.5. II) Reggio Calabria, Musco Nnzionat.: dc ll ~l Magn;l Grecia, inv. 6499: M. Merlens-Horn. Rest; IIi tluc gmlllli statIle di Apol/o ritll}1"Mlllel S(IIIIIIar/o tli lillOI/O A/eo (Ii Giro, in Silllwari deffu Moglia Gn'cia itl Culabr/(I, a cura di E. Lallanzi. Napoli 1996. pp. 261-265; lIilger-Weigel, Grie('MscileAkro/ilh-SllItllf/l (eiL a nola 2), pp. 12-17, 46-48 74-7S, 99-114. C:II. n. 1. pp. 259-260, tavv. 1.1-3.'1, 7.2, 25.1·25.2, 28.2-30.2 eon bib!.; Dcspinis, 211 Akrolilh.tlllllwtl (cil. a nOla 2), n. I, pp. 274-276. figg. 10-14; N. GiUSlozzi, Acrvli/fl eli Apol/o, in "'-It/gila GIT/feia: IIrchealogia IIi UII j upero, a cura di S. SCllis c C. I'arm, Milano 2005, pp.259-262.
12) Cirene, Mu~eo, inv. 14.413: lIager-Weigel, GI·ii'('hi.~che Ak'"(llilh-SIMIUtl! (cit. a nOla 2). pp. 21-22,96-98, C111. n. 10. pp. 260-267. I"I'V. 6.1-7: I con bib!.; L. Beschi , Vlllli C aero/ili ri,..:nllici, 1Il S/IU/i di areheolQgitJ in a/wIT! tli GU.tllll'O Tna'!',.stlri, a cum di M. Fano Sanli, Rluna 2004, pp. HI-91, in parI. p. 82.
13) Taranto, Musco Nazionnle Arehcologico, inv. 3885: R. Belli Pasqua, Catalogo del Mllseo NlIziolillie Arc1le%gic(J tlf 1ilnml(J. IV, I. 1immlo. itl S(,llltlirt/ ill murmo fI In pielfa, T~rJnIO 1995. I'p. 5.'1 -5 7j Wiger-Wcigel. GrieclJische Akl'QIi!lI~Sfcl' /IIeli (cil. It nota 2), pp. 33-3R, 78-82, cat. n. 7, p. 265, [;IVV. 18.1-19.2 nlll bibL Giusto?zi, Gli tla "0 JH'zzi)J (ci l. a nOla 2), p. 24 e rigg. 23-24.
14) Larisa, collezione E. Kar.mlanolis: HilgerWeigel, Oriechische , lkrolllh-S/lI/IICII (ci t. a nota 2). PI). 29-45, 91-96, 244-252, cal. n. 14, p. 270, I~VV. 16.1-17.2 con bib!.: Giustoz.d, Gli did /((1
pi'~i' (cit. (I not3 2). 1m. 44-47, rigg. 73-76; 13 dn lazionc delta leSla alia prima mcla del IV scco· 10 suggerila da Hilger-Weigel c mcssa in discussione da Des])inis, 211 ""mlilllstalm!/l (cit. a /lota 2), p. 272, ehe prcferisce una dal3zione al II seeo·
'0. 15) Paeslum, MuSt'o Archeologico Nazionale: C, Rolley, 7etes tie murb/"€ (Ie Pael/lli11, in Lo Slife severo in Orceia e III Ocddf'llltl, a cum di N. Bonaeasa. Roma 1995, pp. 107-113, nil. I (inv. 133 J 50: pp. 107-108. lavv. XX II. I-4 ; XXV.I ) e 3 (p. 108, lav. XXI Y. 1·4). La leSla n. 2 (inl'. 133151: p. IOH, lavv. XXIII.3-6) andrebhe esclusa. d:no I:he I'andamelllo del rClro non {: rigorosamcnle verlic~ le. Sullc leste crr. ancilc Giusloni, Gli dCi 1((1 I}(!zzi>l (cit. ~ n01l1 2), p, 62, nota 232.
16) Palermo, Musco Areheologieo Rcgionale, inv. 3884; C. Marconi, Se.limmlc. Le me/(l}Jl' dcll"lIcmiol1, Modena 1994. pp. 159- 161, figg. a pp. 94-95. 17) Talc .~ul uzione Iccnica C diseussa pill di reeell· Ie sia da GiUSlozzi, Gli dei «a IN!zti>> (cit. a nol,l 2), pp. 24-35, 49. che d3 Despinis, ZII Akrolilhslulue/l (c it. a nota 2), pp. 265-266.
18) A. Claridge, Allcie/ll Teciuriqm:.I· of Milking Joins in Marble SlatlUIIY. in MorbiI' . .Atl Hiswr/cal oml Sclenlific PuI1lIHcli.,es on Alldenl SculpIW'f!, a cura di M. True c J. Podany, Malibu 1990, 135-162, in part pp. 143·144.
19) Alene, l\1usco dcll'AcrOI)()l\, inll. 671: H. Payne c G.M. Yuung, Archaic M(lrblt· ScUlpIHl"C/rOIll IheAcl'Opolis, London 1936, lavv. 42.2-3, 43 .1; E. Langlolz, Oil! Koren, in Die urchtJischen Mflrmorbi/dwerlie dcr Akrwwl/s, a curo di 11 . Schroder. Fronkfun am Main 1939. pp. 1-184, in part. pp. 56·57 n. 14. lavv. 25·26 (520 a.C.); G.M.A. Richler, KOI"(,I, London 1968, pp. 70-71 u. III, rigg. 34 1-344 (530-525 a.C.): J. Boardman, Gred Sclllplllre. Tile Archaic Period, london 1978, fig. 11 1 (530 a.C,); J. Floren. Die griccllische PI(lsfik, I. Die gtwmclrische 111111 (IIr.haische PlaSlik, Munchell 1987, p. 273, nota 52 (520-510 a.C.), (;i)n bib!.; V. Brinkmal1l1, Die POlrc/II'Qmlc tIC/" orelwi. fc/um II/ul filihk/(/,vsischell Sk,.lplllr, Miinehcn 2003, n. 92: K. Karakasi, ArehtJi(' KartJi, Los
Angele~ 2003, laV\!. 159- 161 (520 a.C.).
20) Ddri, Musco: G.M.A. Richter. 1.11 tlMr de la I{!le eX-f;lIi(/irllllc de Drlpill's, in 'Bullelin de Corrtspondnncc Hclleniquc' 82, 1958, I'P. 92-108; Richter. Konli (cit. a nola 19). p. 55 (550-535 a.C.); Bo;mllllan, Grr-i'k SClllpl/lft' (cil. a nOla 19), rig. 209 (530 a.C.); Floren, Dill grieciJi.1che I'las/i/!' (cil. a 11(1319), p. 338, nOla 35 (550-535 o.C.), con bib!.; Rolley, La st'lIlpl/l~ grecqlle «(it. a nola 2), I. pp. 223, 269 e IIg. 276 (530 a.C.).
21) Alene, Mu~o dell'Acropoli, inv. 682: Payne Young, Alrlmit' Marble SclllplIIJT! (cil. a nOla 19), pp. 27-2H, Iftvv. 40-41, 42.1, 411; L~ngl()lz, Die KOIY'11 (cit. a nOla 19), pp. 86-90, n. 41 , I;WI'. 53-56 (525 a.C.); Ric.hlcr, Komi (cil. a nota 19), pp. 71-75. n. 116, figg. 362-367 (525 a.C.); Boardman, Gn:ck SClliJ'llwe (cit. a nota 19), fig. 15 1 (530-520 a.C.); Floren, Die griecltische Plt/slik (Cit. n nOla 19). p. 331\. notH 40, lilV. 29,5 (500 a.C.), con bib!.; Brinkmann, Die Polycill"Vlllie (c it 01 nola 19), n. 103; Karakasi, Arclwic KOI"i (cit. 8 noln 19), taw. 146-147, 252-253 (525 a.C.).
22) Alene, Musco Nazionale, inl'. 3851: (i.M.A. Richler. KOllroi ' j London 1970, pp. 11 8-\19, n. 136, rigg. 395-398, 400-40 I: Floren. Die gl'ieeh!· schl! I'luslik (ci l. a nota 19), p. 255, nola 21, con bib!.
23) Cfr. nd es. due kOllroi dall0 Ploon, uno al Musco di Tebc (inv. 3: Rielncr, KlIllI'Ql (cit, a nOla 22), pp. 99-100, n. 94, figg. 302-305; Floren, Dic gricchisdll' I'lus/ik (cit. a nol8 19). p. 315, nota 33. con bib!.) c I'allto 01 Museo Nazionale di Ale· I\e (inv. 10: Richl~'r, KO/lmi(ci t. a nota 22). p. 100. 11. 95, figg. 306·311; Floren, Die gl"/(Icl!isc/te Pia.flik (cit. a nOI~ 19), p. 315, nola 31, Clln bibl.).
24) Crr. GiUSIOZl'.i, Gli 'lei /f{l pez.i» (cil . a nOla 2), p.59.
25) Despinis, lu AkrolillululIlCII (ci t. a nOla 2), pp. 262-263.
26) Cfr. III//"{/, nOla 57.
27) Crr . . wpm, 1I0la II.
2S) Crr. iI/1m, nota 66.
29) Malibu. The John Paul Gelty Museum. inv. 88.AA.76: A. Giuliano, SigillI/II Cell:l"i.f, in ' Rcn· dieonti dell'Accademia Naziona1c dei Lincei' 4. 1993, pp. 49·65; Rolley, fA sClilpture g,.n:q./e (cil. a nOl3 2), II , pp. 193-194, figg. 183· 1K4; IlagerWeigel. Griechisdte Akrf)IIIIr·S/(l/1/e1l (cil . :I nOla 2), p. 47, lav. 11.2; Dcspinis, ZII Akmlilhslatllcn (cil. a nota 2), p. 250; E.C. Porlalc, L(I s/atuo di Morgamitro. in UrmllliJlicll t> archilellun, (cit. a nota 1). pp. 91·92. 214-2 15; C. Mnreoui, Una rica da MOI'g(/f!lbla II Malibu, in 'Kalos' 19.2, 2007, pp.4-9. 30) Lonura, Urilish Muscum. in\'. 1150. 1-2; J.C. Caner, Tire SeIIIJlwrt! of Ihe Sancllwry of Alhellu Polius /1/ Pdf!IIC, London 1983. pp. 242-245 nn. 7H-79. la". XXX IV. 31) Sal11o, Musco di l'ythagorc i()I1 .Tigani , inv. 285: Boardman, Grcek SClllpllire (cit. a nol:l 19), rig. 96; Floren, Die gttechiJche Pl(J!;lik (cil. a nola 19), p. 355. nOla 50, UIV. 30.4, con bib!.
32) Alene, Musco dcll 'Acropoli , in\". 6 18: Floren, Die Wiechisch(! Plosli/; (cil. a nOla 19), p. 275. n. 68, con bibl.; U!iukll1i1nn, Die I'olych/Y)/!/i(' (cit. a nota 19), n. 61 . 33) Alene, MuS<!O Naziollale. inv. 4RR9: Floren. Die grie('hisciu' PI/wik (cit. a not:t 19), p. 164, nola 37, lav. 10.4, con bibl.: Rolley, til .1·("u/p/III"e grecqllc (ei l. a nOla 2), I, I'p. 282-283, rig. 287; N. KallS~ls , Sculplure ill Ihe Na/iollol Archueoll«icol Mllsfillm. Alhells: Culliloglle, J. I'au! GeHy Museum. Lo~ Angeles 2002. p. 48, n. 45; Idem, f)ie Kurt. II/Ill elcr Klllvs (illS Myrrllillolls. in 'Anlikc Plaslik' 28. 2002, pp. 7-40, in part. ,Pp. 7-26. lav". 1-1 2: Karakasi , AI-choic Komi (C it . a nola 19), law. 114- 115 ,235-237 .
34) Claridge, Anciel// 7edmiqllcs (cit. a nOI:t 18),
pp. 137-142.
35) Palermo, Musco Arehcologico Regioll~le , inv. 39 13: C. Marconi, Temple Dec()mliOIl/llltl Cu/lU. ml It/cmily ill lite Arclwic Greek IVorld: The Me/oIlCSoj&IiIlIfS, New York 2007, pp. 96-99, 226·227 n. 5M3, fig. 42.
36) Palermo. fo" luseo Archeologieo Regiollltle , inv. 2124: E. Langlotz, L'u!"tc del/o MlIglI(( Orecia, Roma 1968, p. 269. tav. 34.
37) I'inakes di Locri: crr. ad es. LanglOI1 ... L'arlc dell" MagI'" G!"I?cia (cil. alia nol~ 36), tavv. 72-73. 3R) Palermo. Museo Archcologico RcgiollHle. inv. V779: J.D. l3eazley, Allie Rcd-Flgurc Vuse-Paill ' lerr, OXrord 1963. p. 496, 11. 5; T. I" . Carpenler (3 CUrB di), Bctl:ley AcldC/If/(I', Oxrord - New York 1989, p. 250; CarJ1I1S I~StJrtlm AllliqllQI"1II11 Palermo I ( !tali~ 14), tilVI'. 35.37 ; L.l3eschi, s.v. Dcmerer, in Lexicoll Ico/l ographit"ulII. M)'lil%gille CI(j,~siclle, IV (1988), pp. 844-892, III parI. p. 873, 11. 346. lal'. 586; O. 5dIW;lrz, s.v. Triplolemos. in LlMC(cit.).V1I! (1997), pp. 56-68, in part. p. 63. 11. l OR; A. Merra, ill M. Bennetl - A.J. Paul (II cum di). Moglia Gm"cill. G,"C!:/( An fivm Sill/lit Italy alltl Sicily , Clelleland 2002, llP. 302-303.
39) GUlIingen, Georg Augusl Unil'ers itiil, inv. J.14 : J.D. Beazley, Allie Black· Figure Vase-Parlller.f. Oxford 1956, p. 309, 11. 83; 8etJtlc),A(/(lelllla' (cit. a nota 39), p, 83; K. Schcfold, Gijlle!'" II1IIf
IIdtie/!.mge/! ,fer OriechcII ill dcr spiillll'c/w/schen K UI1!I/. Miinchen 1978, pp. 33 ·34 , rig. 28; E. Bohr. Der Schlw",·I/I/lIler, Mainz 1982 (Ketnl!leus 4), P]l. 94-95. n. 103, laVl'. 104-105; Schwar..:, s.v. n'iplolelllos (cit. a nOla 38). p. 60, n. 54, lav. 33.
40) SII questa iconogr ... fi;1 cfr. in generale T. HadziSleliou-Price. DOl/ble mul Mlliliple Represeilltltlolls {II Greck Art amI Religious Thoughl, in . Journal or l lellen;c Studies' 91, 1971, pp. 48·69: Beschi , s.v. Demelel" (eil. a nOla 38), pp. 866-867, nn.2.'12-260. 4 1) Alene, Mu~eo Nazioualc, inl'. 4011 : IIndziste!iou-Price. Double 01111 Muilillie Repre!JclIIl/lioll.f (ci l. a n011l 40), p. 60, lav. VI. 16; Bcschi. s.v. Deme/cr (eil. a nOI~ 3S), p. 866, 11. 252.
42) Londr~ . Urilish Museum, inv. TB 760 : R.A. l'liggins, Ca/{/l(Jgne 0/ Ihe 7'e1·/y/CIlIfIl.5 iu l ire De/lUrlmcnl ofGreck mltl ROil/OIl Anri'lI.lJles. BriIish Museum, Tnlslel!S of Ihe Uril ish Museum, London 1954·2001 , I, pp. 165-166, n. 61 0, lav; 79; Il adl.iSleliou- I'riee. Double IIIIlI Mltllipll' R('prl!.I·CI/ ltllions (ci l. a nula 40). ]Jr. 52. 56, la v. 11.3: llcschi, 5.V. /)eli/eM,. (cit. a nola 38), p]l. 866. 867, n. 259. lav. 578. 43) Dal~zione alia media-\3rdn cia arcaica: Poll ini, Acmlithic or Pseuc/o-IIcm/l/hic SClllplll!'e (cil. n nOla 2), p. 208: efr. anellC l'lerrmann , Tlw.l·lIS WIt!
the Ancien( Marble Trade (cit. a noU! 2), p. 79 (seeonda mel;'! del VI seeolo). DalaZlunc al 490 a.C.: Vcrmeule, Catologue of II ColleClioll (ci l. a nota 2), pp. 13 · 14; I lager-Weigel, Grie"hische Akmii/It-Slllllle/l (cit. a nola 2). p. 20; Despinis, Zu AkmlUl/slalllell lcit. a noUl 2), pp. 247, no ta 7, 251,nola33. 44) Riehler, J..u ,laic (eil. a nOla 20). p. 96; Richter, Komi (c it. ~ 1)0la 19), p. l it: Richler. KOllrOi (cil. a nOla 22), ]1 . 22; Eadcm, The SelllpllI/'l! allll Sclilp/o,.~, IIf lire Greeks '. Ncw 1·laven I: LondOIJ 1970, p. 46. Due escmpi di eritiche assai perl inenIi sono ofTerli da P. de La Costc-Messclii:rc. Les Cores groc'll/c.I", in ' Journl11 de Savants' 1970, pp. 129-1 50, in part. 132- 135 e S. Se\lis, 511 1111 kOlll'lls do Mt:dl!l(l , in . Archcologil\ C1assica' 23, 197 1, pp. 52-76, in purt. pp. 75-76. Pcr un rieSllnl';! tri lico del sislema elaboralo d~lla Richler clr. Rolley. Lo S'-lIlplUTT! grecquc (eil . a nOla 2), I, PII. 160-161.
45) Cfr. ill gCl1eralc Rulley, Ltl SCll lplll/"t! grt:cq lle (cil. a nola 2), I, pp. 160-Hi4.
46) Sull3 sellola di Chio crr. pilt di recente F.
[Saggi] 19
Croi~sant , Les plvlomes j cn!infncs IIrchoi'ques. Paris [984 (BibliOlheqlle ties Eco/e Imn~(/ise II 'Aliu'mel> el tie Hume 250). pp. 69-93: B,S. Ridgway, 77ul 'Nike of Ardlenllos' (lilt! Her Attire, in 1. 13oardm:m - C.E. VaphojJou[ou-Richardson (a cura di), Chios, Oxford 1986. pp. 259-274: F[oren, Die griechische PllIslik (cit. a nOla [9), pp. 335-340, can bibl.; Rolley, LII J'C/IIPIIII~' grect/lle (cit . a nOla 2), I, pp. 257-259.
47) Floren, Die. gried,ische Pil/slik (cit. 3 nOla 19), p. 336. nota 2S (560 a,C.), con bibl.: Boardman, Greek SCldplllre (cit. a notu 19), fig. 103 (550 a.e.); Rolley, L(I sculplW'e grecqllc (cit, a notu 2), I , p. 258, fig . 259 (550 a.C.).
48) Cfr. SIlIJITI nOla 12.
49) Riehler. Komi (cit. :1 nOll! 19), pp. 66-67, n, 104, figg. 317-320; Boardman, Greek SL'lIlplU/'C (c it. a nota 19), fig. 210; Floren, Die griechi,\'che P/nslik (c it. a 110ta 19), p. 173, nota 9, can bib[.; Rolley, La SCtilpllll-e grccqlle (cit. a nolu 2), [, pp. 224,269, fig, 277; suI Tesoro dei Sifni rinvio a C. Marconi, Milo e m/loltlpp.-e.wlllaziOlle lIellll decoruzione figurat(1 dei tiresal/roi tli eI(; IIrcaictI, in Slmnieri c non cillm/ini nei Sall/llOri gred, a cum di A. Nasa, Fircnzc 2006, pp. [58-186.
50) err. srlpm nota 13.
51) Cfr . .l'llpm n0111 11.
52) Atcnc, Musco Nazionale, inv. 8[ : Richter, Komi (cit. a nota 19), pp. Sti-59, n. 91. figg. 284-285 (S40 a.C.); Floren, Die griechi.l'che Plastik (cit. a nota 19), p. 299, not:1 2 (ca. 550 a.C.), can bib!.; Karakasi. Arc/wfc Komf (dt. a nOla 19). tav. 116.
53) Richter, Komi (cil. a nota 19), p. 20; Richter, K(>l/l'Oi (ci t. a nota 22). pp. 20-21, 25.
54) Cirene, Musco, inl'. 14.412: E. raribcni , Ca/(Ilogo delle SClllwrc di Cirenc. Roma 1959, p. 22, n, 25, lavv. 32 e 34; Floren, Die griechische PltlSlik (cit. a nota 19). p. 184, nota 9, con bib!. ; Beschi, Ivltf (cit. a nola 12), pp. 82,83 ; Despinis, Zu Akl'l!lilhswlllen (cit. a nota 2), p. 251.
55) Alene, Musco Na7.iollah:, inv. 4506: floren, Die griecMsche PhMlik (cit , a nola (9), p. 3 10. nota 17, con bib!" E. Waher-Karydi, Die. agil/etische Bildlwllel'schlrie, Maim: am Rhein 1987, Pl'. 71, n. 25, 76, tavv, 21-22; Hiiger- Weigel , Gricchisehe Akrolilh·S((Itrwn (eiL a nota 2), pp. 51-53 , lavv. 21.1-2, 28.1; Despinis, Zu Akro/ilh.!tailicil (cil. a nota 2), p. 295, n. 7.
56) Alene, Musco Nazionale, inv, 3444: Floren, Die griecMsc!re P/aslik (cit. a nCllll 19), p. 275. nota 70; DcspiniS, Zrl Akrolithstaluen (eil. a nota 2), pp. 276·281 , n. 2, figg. 22-29.
57) Tera, Musco, inv, 28 : Despinis, ZuAkrolitlls/(/lrIen (CiL a nota 2), pp. 281-284, n. 3, figg. 30-33. Resta un'ipolesi ['idcntificazione con una sla!U<l aerolitiea propostn da Dcspinis per it frammenlo di avambraeeio in marmo pario dar Santuario di Alenn ad A[ipheira, datalo al principia del V seco-10: F[oren, Die griechisL'iw P/I/slik (cil. ~ nola 19). p. 229, nota 9; Despillis, ZI/ AklYJ/ith.I'ltI flren (c it. a nota 2), p, 296, n. 8, figg. 46-47 .
58) Taranto, Musco Na7.iona1c Archeologico, inv, 3881: Hiigcr- Weigel. Griechische AklVlil/r·SJalul!n (cit. n nolll 2), pp. 18-2Q, 57, nola 7, cat. n. 5. pp. 263-264, lavv. 4.1-5.2, con bib!.; Belli Pasqua, Catalogo lcil. a nota 13). pp. 23 -26.
59) Londra, British Museum, inv. 6[ 11-2789: Hilger-Weige[, GriechischeAklvlilh-S/muen (cit. n nota 2), pp. 21-23 , 96-98, cat. n. II pp. 267-268, laVII. 9.1-1 L I, con bib!.
60) Despinis, Z/I Akrolitl1$lIlIUI! II (cit. a nota 2), pp. 286-294, n. 5 figg. 34-45,
6 1) Roma, Musco Na~ionale Romano (Palazzo Altemps), inv, 8598: Hager-Weigel. Griechische AklVlilh-SUrluel1 (cit. a IIQln 2), pp. 18, 64-68,
20 [Saggi]
115-146, cnt. n. "2, pr. 260·261. tavy. 32.1-34.2 COIl bib!.
62) Parigi , Musec du Louvre, inv. A 3109: HiigerWeigel, G/'i('clIi~'c/te Ilkm/il/r-Slatuen (ci t.. a nota 2), pp. 23-24, 82·86,183-199, cat. n. 12, pp. 268-269, tavv. 40. 1-42 .1, 43.1 con bib!.; Despinis, ZII AkrofitlWatrlel1 (cil. a notn 2), p. 294 , n, 6.
63) ROllla, Musei Valieani , illV, 905: Hiiger-Wcigel , Griecllisfiw IlkroliTIr-Staluen (ei\. a nola 2), pp. 18,68-74, 147-[65,262, cat. n. 3, tavv. 35.1-36.2 con bib!.
64) Malibu, The John Paul Getly Museum, inv. 74 AA 33: Hilger-Weigel, Gl'feclli~'clle Akrolith-StaIrum (ci t. a nota 2), IIp. 18, 70-74, 166·182, 262· 263, cal. n. 4, tavv. 37.1-38 .2 con bibl; Despinis, ZII A/i.I'()/ilhstalllen (c it. a nota 2), pp. 284-286, n. 4. rigg. 3-5.
65) Hager-Weigel, Griechisc fte AI..1'olilh-Slatuel1 (cil. a nol~ 2), pp, 24-27, 86-90, 200-241, 269-270, cat. n. 13, tavv. [2. [-15.2,43.2·47.2 eOll bibJ.
66) Ch. l3[inkcnbcrg, Die limlische Te/llpclchmnik. BOl1n 1915, Jlp. 22-23; eh. l3[inkcnix:rg - K.F. Kinch, UIU/OS: lorril/£'~ £'1 l-eci1£'l'ci1£'s. 1902-1914, Berlin 1931-1960, II, pp. [71-172; J. Shaya, The Greek r.'mple I1S MlIse,lIlI: Tire Case of Ihe Legendmy 7i'<"l/srl/'{! 01 Athena /rom Lilfdo~', in 'Amcrican JOIlTilal of Archaeology' 109. 2005. pp. 423-442, in part. p. 439.
67) Co~i, tfll gli altri , B. Pace, Arle I.' dllillti del/II Sicilill Antica, Mi[lIl1o-Roma-Napo[i-Cittii di Castello 1935-1949, H, p. 6[ c nota 2, Ill. p. 73[; G. Lippo[(~ Die Gn·edrf.w:he l'ltlslik, MUnchen 1950, 1', 15, 1101(1 1,
68) Dcspinis, ZII Akrolilhsttllrlen (cil. a noto 2), p. 251.
69) Cfr. in gcner~le Floren, Di(1 gricr.:hische PI(ISIlk (cil. a nol:l 19), p. 394, nota 27-28, tlW. 34.5-6, can bib!.: P. Amandry in Grride de De/pile .... Le Mrw}e, a cura di O. Picard, Athcncs 1991, pp. 191-226; Rolley, LII sClilplIlI'egl'ccqlle (eil. a nota 2), I, p. 76, figg. 5, 275; K.D,S. Lapatin, C:lII}'se/ephanline SWlmll), ill the Am.klfl MediTermnean Wrw/d. Oxford-New York 200[, pp. 57-60.
70) De[fi, Museo, inv. 10413, 10414, 10415: Lapalin, CllI'yse!eplwnlillC Stammy (cit. a IlOla 67), Pl'. 57-60,147-148, nn. 31.1-3, tav. VI, figg . 114-125, con bib[.
71) Lapa!in. CIII),seleplwlllille SIIIIIIIJI:l' (cit. a nOla 67), PP, 57-60.
72) L lpatin, ChlJ'w/ep/wlftine StaIUIJI)' (ci t. ~ nota 67), p. 61 ; cfr. anchc Besehi. Volti (ci t. a not~ 12), p. 81.
7]) Hager-Weigel, Gricchische Ak/v /iI/,-Swlllell (cit. a nota 2), pp. 10-13.
14) SuI tesoro dei Selinunlini a Olimpia cfr. A. Mallwilz, Olympi(J 11111/ J'dlle IJaulell, Milnehcn 1972, pp. [73-174; M. Rups, T/ws(lw'O$. A Sllrdy of Ih e 7iWISl/ry Building as Found in Greek Sanc-1U0rie~" rh.D. diss. Johns Hopkins Univcni lY 19!:i6, pp. 40-42; M. Mertens-Horn - L. Viola, Al'clwi.~che 1imdiicher 1I 'C,\' lgriet:hisc/tu Typulogic in Delphi Ulltl Olympia , in ' Hespel'ia' 59, 1990, pp. 235-250, in par\. p. 240,
75) S. RaITiolla, C 'era /lila 1'011(1 Morgmlfina. Enna 1996, pp. 110-1 12; C. Greco, 7i'llffico til repel'li (lfche%gici e ini;:ialil'C p CI' i/ reClIJ!elV dd beni: il C(lSQ di Elllw. in Un !!cc% di lIIagntwime virtrl. I Cambini(/ri ,wi dOCrl/lu:nti degli archivi s fdlioni, Palermo 2002, pp. [81-[ 86. Sui rJnveni· menlO delle sculturc si c conecnt ratn iiI rel:lziollC di Ma[colm Bell a[ Simposio tcnulosi all'UniversitiL della Virginiu nel Fcbbraio 2008.
76) E. Dc Miro - G. Fiorentini, Calliviti!. del/a Soprin!lmde"ul Arche%gicll cii Agl'igenlo dill 1916 til 1980. in ' DCA Siciliu' 1.1-4, 19&0, pp. 113-137, in part. pp. 134-131, figs. 28-29; G. Fiorcmini, Riccl'ch(' m'c!rc(liogielre nella Sicilia cellIro-lIIl'ridiQIlOlc, in 'Kokalos ' 26-27, 1980-19!:i 1.
pp. 581·600, in part. pp. 593-598, tavv. 81 -85; V. Hinz, Del' KIIII von Demeter rllul Korl! I.lIIlSizilien ulld in del' Magno Graecia, Wiesbmlen 1998, pp. 124-127; S. R<lffioll<l, 1'errecollefigllrate 11(// san· IIm";o iIi S'III I'hlll c(>~'eo Bisconti a Morgmllintr , Assoro 2007. Le riecrchc pill recenti della Soprintendcnza di Ellna diTellc da Caterina Greco sono in corso di pubblieazione.
77) E. SjOqviSl, Sicily (lmlthe G,-eeks, Ann Arbor 1973, pp. 28-35; C.L. Lyons, Modalita iii (/ccullUrazilIHe (/ MOl'gtll1lin<l, in ' Bol1ellino di Arcbeologia' 11-12, 199 [, pp. 1-! 0; R.M. Albancse ProeelIi, SiClllli, Siculi. f/imi, Mi[ano 2003, pa.\·sim.
78) Lyons, Mudalitu (eil. a nOla 75), pr, 5-6; Eadem, Morganlill(/ Swdies. 5. Tire Archaic Cemelel'i('s. Princelon 19Y6. IlP, 138-152 e passim; A[bancse; Procelli , Sicolfi (cit. a nota 75), p. 236.
79) Herrmann, T/W$OS (cit. a nota 2), p. 79.
80) Sulle clive di tl1armo a Taso e, in gcnerale, suI marlllO tllsio cfr. J.P. Sod ini - A. Lambraki - T. Kozelj, in A/iki, I , a cur3 di J. Serv~is CI aI., Paris 1980 (Eco'" /lvnfaise d'Athenes t:wde5' Ihusien.,es IX), pp. 5-63 ; M.C. Marchei, in Mormf alllichi, a eura di O. Borghini , ROllla 2001 , p. 253, n. 100. con bib!.: M. Bruno - L. Conti - L. Lazzarini - r. l'tnsabene - 8. Turi, The Marble Qrwrrif!5' 4 Tlwsos: All Arc/laeollll!lric Swdy, in Imen/{sr.ipliIW ry SlUdh:w on Ancielll Slone, a eura di L. La7.zarini, Padova 2002 (ASMOSIA VI), pp, 157-162. Sull'uso del marlllo tasio in scnltura e sulla sua csportazione in eta greca e romana efr. Herrmann, T/UIJ'OS (cit. a nola 2); U. Herrmann, J::.rport(lfion o/OQlomilic Marble/rom T/wsos, in Allciellt StolIeo5 , a cura di M , WaclkcllS - N. HerJ: - L. Mocns, Leuven 1992 (AS/II/OSIA II), pp. 93-104; J.J. Herrmann - V. Barbin, The Expatiation of MMbie /lVI/I the Aliki Qllal'l'i('s on T/w.~oo5. in 'American Journal of Al'ehlleology ' 97, 1993 , pp. 91-103; J.J . Ilernnann - R. Newman, 11re Explomlion 0/ Dolomilie SCu/lltural Marble/rom !lWSO!!, in The Study of MMb/e lind Other Stones Use(/In Antiquity, a eura oJi Y. Mmliatis - N. Herl: - y, l3asiakos, London 1995 (ASMO$IA 1IJ), pp, 73-86; J.J. Herrmann - R. Ncwman, D%milic Marble from TII(/sos Ncar ,IIId Far. in Archcomllteri(lIIx, a cura di M. Sclwocrcr, Bordeaux-Ta[cnce !999 (ASMOSIA IV), pp. 293-304; 1.1. Herrmann - R. Newman, Ncw SCI/lplures in Th(/sian Dolomite, in Imerdi~'cipIiIfIllY SllIdi('s Oil Ancicnt Slone (cit.) pp. 215-224; J.J. Herrmann - A. Van den Hock - R. Newman, N,'IV Sculptures il/ Thilsian Dolomite, in jnlel'diJ'ciplilwry Studies 011 Allcieni SlOne (cil.), pp. 357-362; R.H . Tykol, 1.1. Herrmann, N.J. van del' Mcrwe, R. Newman, e K.O. Allegreuo, Tlra.l'illll Marble Sculplm-es in Ewvpca/l (llId Americlfn Colleciions, in Inlel'disciplillfl/Y Slrldies 011 Ancielfl Siol/c (ei!.), pp. 188-195 .
81) Herrmann, 7'11(/.1'05 (ei l. a nota 2), pp. 79-80, con bib!.
82) Cfr. Herrmann, 7'ha,~()s (eil. u nOla 2). p. 80 e nola 40.
83) R. A[aimo - M. Carapena, II marlllo del/a XIi/Iua di Muzia : c(l/'(/lIel'i geocllimici fj pos.,·ibili al'l~e tli provenfellz(I, in La S/(lIl/a lIIal'l/Iorea di MOzjtl e 1(1 sCII/tum di Slile s<>~'el'o ill Sicili(l , a cum di N_ l30nacasa - A. l3ullitla, Rom~ 1988, pp. 29-37 . I[ marmo - 10 sIesS(} utilizzalo per gli inserti dclle metopc dell'HeraiOll (Iempio E) di Selinunte non provienc dal1'Asi;l Minore, eomc SOSlenuto dai due autori sulla base delle conosccnze dcl1 ' cpoca, m~ da Pam: efr. Marconi, Sdimrnle (ci t. a nota 16), p, 191.
84) C[e"cla!l(~ The Cleveland Museum of Art, J.H , Wade Fuud, inv. 28.195: O.S. Ridgwny, Th,' Sel'/'re Slyfe ill Greek Seu lpture, Princelon ! 970, pp, 59-60, figg. 88·9} (qui it suggerimento di una provcnicnza dalla Sicilia 0 dall'Hnlia Meridionale); IIcrTmann, Thas(}s (c it. a nota 2). p. 80, figg , Sa-b.
85) La pTOvenienza dci manni bianehi per!a seu[-
lura di CUI greta dall ' ltulin Meridionale c stala oggcUo di analisi, ul limam ... ntc, da p:Ir1C di Lorenzo Lazzarini, ehe hn idcntific,Ltll un quasi monopolio del marmo purio in CIa arcaiea c SC\'cra, St:gu ilo d~ IIna prcvatcllzll de l marmo pcntcl ico c da una prcSCnz.1 spurodica del nl;lrlllO uassio in e ta class icn cd cllclJisljca: cfr. L. Lazzllrini, Iml(tgill; (IrCheomelrkhc :;ui nI'".,1I1 biuneA; dell" s/(lIImri(1
e flrrhilcltllrll della M(lgJlfI Gree/" , in 'Marmora ' ),2007, pp. 2 1·52.
86) Lc mis liori discussiolll della sculhml II Tasu in cia ar<:uica SOno rappresentnlc dn B. HoI17.mann, Sip/mas. Tlwsos - PII/'O$, in £/II(les tlelplliqrtes, ' l3ulletin de CorresJXmdancc I-Iclh.:niquc', Suppl. 4, 1971, pp. 295·304 (Taso, MusCQ in\'. 678); D. l3oschung. t',." Ilwsisc1rer KorellllOp!;'1 Basel, in Anl ikc Kunst' 28, 1985. pp. 146·156 (tesla Voul· garidis); 13. Iloi tzmaun, DC/I,{ I'l:lief~ orierl/a/i· l·(IIlt.t de Thasol' , in A,.c/Illisene wltl klassisene gril!cn;sche !JIaslik, a eum di II. KyrieJeis, "" Iainz 1986. I. pp. 73·77 (ri lieYi orienlalizzanli ill Lou· yre); Idem, Une .~/}MlIge (l,.('lwrqlle d Thu$liS, in 'Bullelin de Corrcspondan~e 1I 1!lJ~niqu c' 115, 199 1. pp. 125·165 (sfingc Will ). Cfr. allehc Ie sin· lesi di Floren, Die gl'ieclrist'he P!a.l'llk (cit. a nOlu 19), pp. 323·325, eOll bib!.; Rolley, La sClilplure gl"t!ciflle (cit. a nota 2). I. pp. 295·296; 11 l'lohzn'lanll in Gurde de Thosos 1, a cum di Y. Grondjcan _ I'. Sal yiat, Alhens 2000, pp. 237-241.
87) ~ . LanglOlz, Frrihs;I"i,'chr"sche Bildhartl'l"Sclrrtlell, NiLrnbcrg 1927, pp, 132-136. Rapporli della scuttum tasia con I'aro emno encrgieamente esclusi, ad esclllpio, da Picard: cfr. Ch. Picard. Bas· relie/ iQlliell arcllilj'qlle de Th(rso:r, in 'MonumenlS Piot' 20, 1913, pp. 39-69, 10 part. pp. 66-69.
88) Istanbul. Musco Archeolugico, inv. 374. da Aliki. 550 B.C. ca.: Richter. Kouroi (cit. a notll 22), p. 104, n. 108, figg. 336·33R; J.G. I'edley, Greek SClilplure of tilt Archaif' Peri()(/. The Islmld " orbhops, Mainz 1916, p. 4 1, n. 27; 130schung, Ein thasisclrer Korenkolif(eil. ,L 1I0la 84), p. 154, II.
10; Floren, Die griechiscf,e Plastik (eil . a nOla 19), p. 324, nota 5, cun bib!.; lIoltzmann in Gilide de TlwsQS (eil. II nota 84). p. 239, fi g. 164 .
89) I'n rigi, Musee du Louvre., inv. MA 3 !OJ : Richter, Karl/vi (ci t. a nut~ 22), p. 107, n. 116, figg. 356·358; I'edley, G,-cck SCldpttll"e (cit , It Mtl' 86), p. 39, n. 24, IllVV. 16- 17; Floren, Die gricchische plaslik (cit. a nOla 19), p. 161. nota 9, con bib!.; M. I-Iamiau)(, /I1l1sb: "U LOllVl"(!. Deptlrlemelll riG IlIIliquil(;S gr(>cqll e~·. CIl"lrs'tUI'S 1'1 romailw.I'. Les .fClllpllll""S gI1!cque,~, I . Des oris;incs (i lajin drr /Ve !fiee/c avOM J .• c., Paris 1992, pp. 80-81, n. 73; Ph.N . ZaphiropoulolL. P(r,.ische Sklllplll,.en, in Alrlike PlaSlik 2.7, 2000, pp. 7.35, in part. p. 14, figg. 11-12, 19·20.
90) 'Iaso, Mu$Co, lnv. 678: I-Ioltzmann, Siphl1f1s (ci t. a nola 84), pp. 295·304; Bosehung, £ill Ilmsi,fcher KOrlmkop/(eit. a nOla 84), p. 152, p . 15J , n. 2, lav. 37.1-3; Florcn. Die g,.iechi.vche plaSlii (c it . a nOla 19), p. 324, nOla 8, con bib!.; Holtzmann in Gllide de Tlrosos (cit . a nota 84). p. 239, pp. 247-248. n. 4, fig . '74; Karakas i, ArcllUlc Komi (cit. II nOla 19), p. 98, la\'. 9Oa-e.
91) Floren (ci l. a nOla 88), (: llndato phi in Iii nel eonfronto, fi nendo con J'lIuribuire la tcSla di Taso, /0111 corin. allo SICSSO InaeSlro pario :lUIOn.: della caria lide del Tesoro dei Si fni : si IrJlla di un ':,uribuzione che non ~ suppurllli ll dLi un confronto del discgno degJi oechi , che prescllla dHfcrenze leg. gere, 1»:1 signif'ieati\'c, specie per qUllnlO rigwlf(la l'andamcrtto dC'lla palebra Infe.riore.
92) Ilasilea. Antikens(UllnlJuug, inv, I3S 245: 1l0S\:hung, Ein Ih(uisener Korento!,j (ciL a nOla 114), taw. 33-3S; Floren. Dic s;rlec!Jische Pli/stik (cil. II nOla 19), p. 324, uOla 9. con bibJ.; Hohz· mann, in Gllitle dc 71Jaso.~ (cil. n nota 84), pp. 247-248; Karakasi, AIY: lraic Korai (c it. a nota 19), PI'. 96·98. laY. 86.
93) efr. Karakasi, AI"f.:lwk Komi (ci l. a nola 19).
pp.96-98.
94) Holtzmann, U,le ~7)hi'IS;f' (Cil , :L nOla 84), pp. 146-147; efr. anche Croissant, Les pmlOmeX (cil . a nOla 46), pp. 71 -78.
9S) Per quesl' uso cfr. anehe il \'0110 fcmmillilc in marmo bianco d! Cirenc (ci tato a no!!t 55). nLvvi· einabile slilislicamC'ntc II seuhure neSiOlichc. in particulare la lest:t Voulgaridis.
96) crr. $llpm nol~ 42.
97) efr. srtpm nOln 43.
98) Lllnglotz, Die Kore'l (cit. II nOla 19), p. 57,
99) Croissant, I.es profQrJl('S (ci t. a nota 46), pp. 258-26\.
1(0) Cfr. ad es. Ie sintesL rceenli di Rolley, UI sCUIPIUfC grecque (cit. II nola 2), I, pp. 299·30 I ; R. Uelli Pasqua, LII seulWr(r ill nwmlll. in Al'le e Arli· gialm/o i lr /lfllglll! Gl'eeill . II eura eli E. Lippolis, Napoli 1996, pp. 485.491 ; Eadem, /I marlllO tli Paros neirlwlia meritlimwle, in !'al'ia l.ilJr(J.~, II eura di D.D. Schilardi - D. Katsonopoulou, Atene 2000, pp. 519-526; IJ. Barletta, Ardlilic (III/I ela.I'· ~·Ic(ll Mag/III Graccifl , in Greek Sculpw"r., :L CLII'3 di O. Palagia, New York 2006, PI). 77·118. in parI . pp.94-100.
101) Cfr. soprattutto, per I'e ta arcaica. Richter. Komi (eil. a nota 19). pp. 1·3 e B.S. Ridgway, nle Are/It/Ie Slyle itl Gl"et-k SClilplllI~ I, ChicllgO 199J, pp. 419-444. efr. anehc A. S tewart , Greek Srulplure, New lIavcn 1990, p. 33 e passim c piu di recentc M.e. Sturgeon, Archaic Alhells and the Cycl(ldes, in Greek SeuJplul'C lei l. a nOla 85), pp. 32-76, p. 50.
102) Rinyio pcr il momcnlu a C. M3fconi, Arlc e insu!arlla. II cllsa delle IJIClopt' del lelJlpia F ,1/ Selillllllle, in Alii (Ielff.' selle giol'lrare intemu:iQ· nali di stlldi slIll'(l/'ea elima e 10 Sicilia OCciilenll/· Ie nel COII/CSIO mCc/ilernlllCO. Ericr.. 11-/j ollobl'e 2006, PiSa c.d.s.
103) Crr. Floren, Die griechi~'che Plus/ii (cit. :I
nota (9), p. 41 5, nOla I: R. Vtl l1 kommcr, s.v. TIde· phum:.f (II), in Kiin.l·tle/, U:xicQlI tier Antike, p. 874.
1(4) In gcneralc efr. O. Barletta, I (lnic Illf/ucllce in Archaic Sicil),. tnc M OlIIlI/wlI/a/ An. Gothenburg 1983, pp. 49-67. Cenuniea : Lyons, AlOllal/lil (cil. a nota 75), p. 8; Eadcm, MOl'gunfilla Studi,~s (cit. a nota 76), pp. 73-91, Tcrracottc 3rehitcuoniehe: J.F. Kenfield, A I) East G,.eek Mas/cr CO/vplllsi (II Lale Arc!Jaie Mal"gm)liIUi , in ' Hesperia' 59, 1990, pp.265-274; Idem, Tire Casefo/' a Phoka /fllI Pre· Sl!"n('c at MOl'g(llllin(1 (IS Elliticlleetl by Ih c Si lt!:f Archaic Archi/l!clI/lVl TermcolMs, in Ln gl1lmls aleliers d 'aIThilccture dilllS !e monde egecil till Vi c shkle all. J.-G. , a cum di 1. des Courlil5 e l·C. Morelli , Istllrlbul 1993, pp. 26 1-69; Mem , If M()(lelled Terrocolla Frieze /ivm Arch(rie AlOJ"8(u1-till(l, in Deliciae Fi('liles, a eura di E. RySledt - C. Wik:lnder - O. Wikander, Stockholm 1993, pp. 2 1-28. Cornice in pictro: Barlella, Ionic Inf/uence (Cil.), pp. 59-62; Eadem, !onic Inj1l1ellce iii Westenl G,Y?ek Architeclllre, in Die> Agiiis /,Iml das IVestliche Millelmee,., a eura dl F. Krinzi nger. Wien 2000, pp. 203·2 16. in part. pp. 201·208.
105) SulilL dilTusione della m:lI1icm ionita in Oceidente cfr. piil di rcce1l1e C. Rolley,l.a scul,Jl/ire, in Magnll Grecia e O,./ente Meditermlleo prim(l del· I 'Na ellellisliclI, Ali i dcl Trell1anovesimo Convegno di Studi sullo Magna Greeia (Tarun1o 1999), Taralllo 2000. pp. 41 7-426 e E Croissant, La di[fllSione de! modelli s/ilisliei gre/'"IJ-(},.ierrlali nella CQITJpla~'/ic(/ III'Cll i CII della Gn!citr d'Oech/ell/l.'. ihidem, pp. 427-455.
106) J.P. Uhlenbrock, ConcernilJg Sal/J(' Al'chaic Termcol/tl PrO/Ol/wi fivm N(uos, in 'Xenia ' 18, 1989, pp. 9-26. in part. pp. 16-17. figg. 1 I a·b; U, Spigo, Pel' 1111 c:onlriblilO al/o sllIilfo dellir com· plastieu tlretlletl di N(IXOS, in UII 'a l"rl/a 1m lIeit/dberg e NIIXOS, a cur'! di M,e. Lentini, Palermo 1993, pp. 47-52, in pari. fi g, 3; Croissant , Lil IIi[-
jusioll l! (ciL n notn 103), I). 440, 1:\\1. XX.2·3,
107) P. Orlandini, GellI. L'i slipe ,'o/i .·,{/ iII'coica del pl'l:riio Solil, in 'Monumenti Antichi dei Lincei ' 46, 1963 , ce. J·78, in part. c. 18; 1.1'. UMen· brock, The Termeol/a Pmlol/wi from Gela , Rom~L 1988. pp. 4-445; D-Qissanl, 1.(1 diffll$!olle (cit. II nota 103), pp. 447-448. Uno dcgli csemplari meglio eonscrvat i di questa lipu, qui illustralo, e quc llo dnl Thcsmophorion di l3ilal l'mi cOnSCrvillo 21 Musco Archcologico Rcgionale " Paolo On i" tli Sif"Jc.usa (inv. 21301 : Uhlenbrock. Tile Termcolf,' P"f>lQmal (ci t.), pp. 68-69 ca1. n. 19, lav. 2; E.C. l'orl:llc Ln I Gree; ill Uccidente, a cum tli G. " uglieSt: CarmleJli , Milnno 1996, p. 680, n. 92 I; A.M. Vanenli in Sicilia. A,.te e Ar"Cheolugill dillla p,.ciJ/arill OIl'Ullilll d'/liIlia, Cinisello Balsnmo 2008, p. 241 n. 37).
108) Uhlenbrock, The Tel"lY/colla Pm/QII/ai (e il . tI 1l0t~l 105), in particolare PI'. -44-015,
(Saggi] 21