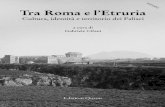Lévi-Strauss e gli studi andini
Transcript of Lévi-Strauss e gli studi andini
329
Lévi-Strauss e la storiaUn dibattito a cura di Silvia Salvatici, con interventi di Francesco Remotti, Gérard Delille, Peter Burke, Marco Curatola-Petrocchi, Daniel A. Segal
Come si trattano gli antenati? Ma, prima
ancora, che ne è dei morti? Non tutti i morti
diventano degli antenati: molti di loro sono
infatti destinati a scomparire nell’oblio.
Claude Lévi-Strauss ha tutte le caratteri-
stiche per divenire un antenato, un autore
cioè che continua a essere ricordato, a es-
sere in qualche modo presente tra «noi», i
momentaneamente sopravvissuti. Ma ci
sono antenati e antenati: autori cioè che per
un verso vengono imbalsamati nel ricordo,
ricordati e però non utilizzati, e autori in-
vece che per l’altro verso continuano a es-
sere discussi, che per la forza del loro pen-
siero non cessano di fare riflettere e in certi
casi persino tormentare i loro successori
(come, per esempio, accade in molti culti
di possessione africani). Può anche succe-
dere che gli antenati vengano smembrati,
ovvero che i sopravvissuti non si limitino
affatto a subirne il fascino, ma praticando
un esercizio critico sul loro pensiero lo fac-
ciano in qualche modo «a pezzi», così da
prelevarne le parti ritenute più preziose e
significative, contestandone e rifiutandone
altre. Nelle isole Trobriand della Melanesia,
quelle studiate da Bronislaw Malinowski
durante gli anni della Prima guerra mon-
diale, era proprio così che si trattavano i
morti: dopo una prima inumazione, veni-
vano riesumati e i loro cadaveri spezzati in
modo da ricavarne oggetti utilizzabili nella
vita quotidiana o monili da indossare sul
proprio corpo1. Come si sa, in diverse al-
tre parti del mondo (per esempio, in molte
società dell’Amazzonia), il corpo bruciato e
incenerito era mescolato a cibi, così da es-
sere ingoiato e assimilato dai propri discen-
denti. Da antropologo, avvezzo a prendere
in considerazione il significato profondo di
questi modi di trattare gli antenati, è pro-
babile che Lévi-Strauss avrebbe apprezzato
un simile trattamento del suo pensiero: a
pensarci bene, è la soluzione migliore (e
B E R S A G L I O
Francesco Remotti
La difficile eredità di Lévi-Strauss
1 B. Malinowski, La vita sessuale dei selvaggi nella Melanesia nord-occidentale, Milano, Cortina, 2005 [New York, 1929].
Contemporanea / a. XIV, n. 2, aprile 2011
330
forse l’unica) per continuare a tenerlo in
vita, tra noi o in noi.
Beninteso, sono i «noi» (i sopravvissuti) che
decidono sugli antenati: se tenerli in vita e
in quale modo utilizzarli. Sono i «noi» che
selezionano, che decidono quali parti ab-
bandonare, quali utilizzare, quali trasfor-
mare: sono i noi che, in primo luogo, sta-
biliscono se valga la pena compiere queste
operazioni in tutti i sensi impegnative. Nel
caso di Lévi-Strauss, ne vale senza dubbio
la pena. Per quali motivi? In questo breve
scritto, ci concentreremo su due livelli: uno
relativo ai contenuti o temi di antropologia
e l’altro relativo ai modi di intendere la ri-
cerca antropologica.
I contenuti di antropologiaNell’antropologia del Novecento Lévi-
Strauss è stato uno degli autori che mag-
giormente hanno dato importanza allo
studio delle idee e del pensiero delle «altre»
società, quelle società che di solito gli an-
tropologi si recano a studiare in luoghi più
o meno lontani ed esotici. Nel libro La Pen-
sée sauvage del 1962 Lévi-Strauss sottolinea
con grande convinzione la «brama di co-
noscenza oggettiva» che è reperibile un po’
in tutte le società, un desiderio del sapere
per il sapere, che invece di perdersi nelle
nebbie della mentalità mistica (alla Lévy-
Bruhl) dà luogo a un vero e proprio sapere
scientifico, a ciò che egli chiama «la scienza
del concreto», un sapere che si rivolge agli
aspetti percepibili della natura, un sapere
botanico, zoologico, astronomico e così
via2. Va ricordato che negli stessi anni l’an-
tropologia americana aveva prodotto un
importante filone di indagine, quello che va
sotto il nome di «etnoscienza», fondato sullo
stesso presupposto di Lévi-Strauss, secondo
cui nelle diverse culture vi sono nuclei di
scientificità, che gli antropologi farebbero
bene ad analizzare per porne in luce prin-
cipi, prospettive, categorie, implicazioni.
Ciò che tuttavia colpisce nell’opera di Lévi-
Strauss (oltre che nell’etnoscienza) è il
netto privilegiamento per un sapere scienti-
fico rivolto alla natura, come se le società di
cui si indaga il sapere scientifico fossero più
interessate alla natura, intesa come realtà
o ambiente esterno, nei suoi diversi aspetti
e ambiti, che non alla società umana e alla
stessa realtà umana. Accanto a saperi bota-
nici e zoologici (per limitarci a questi) non
vi è nell’opera di Lévi-Strauss uno studio
dei saperi rivolti all’essere umano: accanto
alla botanica, alla zoologia (o alla mineralo-
gia ecc.) non vi è un’antropologia indigena.
La questione che subito si pone è allora la
seguente: sono queste società a non avere
sviluppato un interesse scientifico per l’es-
sere umano (la condizione umana) oppure
è Lévi-Strauss refrattario a questo tipo di
interesse, riluttante a indagare le antro-
pologie sviluppate nelle diverse società?
Siamo propensi a ritenere che sia valida la
seconda alternativa. Perché mai?
La risposta che riteniamo più appropriata è
la seguente: Lévi-Strauss non è interessato
allo studio delle antropologie altrui, per-
ché – come egli stesso dichiara – è convinto
della indiscutibilità della natura umana.
Molti antropologi culturali hanno preso
le distanze da questo concetto, soprattutto
nella misura in cui hanno voluto porre in
2 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1965 [Paris, 1962], pp. 14-15.
331
evidenza il peso della cultura nell’organiz-
zazione sociale, e persino biologica, degli
esseri umani. Al contrario, nonostante tutte
le critiche a cui è stata sottoposta – sostiene
Lévi-Strauss3 – «noi persistiamo nell’usare»
questa nozione. Beninteso, la natura umana
a cui Lévi-Strauss si riferisce non va intesa
come un nucleo sostanziale compatto ed
omogeneo, bensì come un insieme di «ma-
trici da cui si generano certe strutture». E
tuttavia, a fronte di questa realtà di ordine
bio-psicologico – che nella concezione di
Lévi-Strauss viene a coincidere con ciò
che egli chiama da un capo all’altro della
sua opera «spirito umano», ovvero «un
pensiero oggettivo» il quale funziona «in
maniera autonoma e razionale», «un pen-
siero anonimo» che opera nei più diversi
contesti4 –, le idee, le credenze o i miti che
le società sviluppano in relazione alla con-
dizione umana assumono inevitabilmente
un aspetto di «narrazioni assurde»5. I con-
tenuti di questi discorsi antropologici sono
di per sé assai poco credibili: significativo,
e degno di essere indagato, non è per Lévi-
Strauss ciò che questi discorsi dicono; im-
portante e meritevole di essere indagata è
invece la «logica segreta» che «regola i rap-
porti tra tutte queste assurdità»6, una logica
che evidentemente agisce all’insaputa dei
soggetti. In conclusione, per Lévi-Strauss
l’antropologia non rientra di per sé negli
interessi scientifici delle società indagate
dagli antropologi; e quando tali società di-
scorrono sugli esseri umani enunciano
tutto sommato delle assurdità. Tra una
scienza prevalentemente naturalistica (la
scienza del concreto) da un lato e le assur-
dità mitologiche dall’altro sembra non es-
servi spazio, nell’opera di Lévi-Strauss, per
un’etno-antropologia, ossia per uno studio
antropologico delle antropologie degli altri.
E questa è una grave lacuna dell’antropo-
logia di Lévi-Strauss, anche se nella sua
opera non mancano spunti che potrebbero
essere sfruttati in questa prospettiva.
La ricerca antropologicaTra gli spunti «etno-antropologici» reperi-
bili nell’opera di Lévi-Strauss ne scegliamo
tre. Il primo riguarda l’interpretazione che
Lévi-Strauss fornisce del totemismo, ov-
vero di società suddivise in gruppi collegati
a specie animali o vegetali e che trovano in
società vicine o lontane altri gruppi colle-
gati alle stesse specie (il clan dell’orso della
società X troverà, per esempio, il proprio
corrispettivo nella società Y). L’interpreta-
zione di Lévi-Strauss è tutta giocata sulla
nozione di umanità, un’umanità i cui con-
fini vengono di solito fatti coincidere con
i «limiti del proprio gruppo tribale»7 e che
tuttavia il totemismo dilata sia verso altre
società, sia verso altre specie naturali. Il
secondo spunto è rintracciabile in Tristes
Tropiques, là dove Lévi-Strauss pone a
confronto due diverse indagini antropo-
logiche: quella dei colonizzatori spagnoli
che nel XVI secolo, di fronte agli abitanti di
Hispaniola (l’attuale Haiti e San Domingo),
3 Id., L’uomo nudo, Milano, Il Saggiatore, 1974 [Paris, 1971].4 Ivi, pp. 648 e 589.5 Ivi, p. 648.6 Ibidem.7 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, cit., pp. 184-185.
332
si chiedevano se davvero «fossero uomini,
o non piuttosto creature diaboliche o ani-
mali», e quella degli indigeni di Porto Rico
che, dopo avere catturato i bianchi e averli
affogati, «per settimane facevano la guardia
ai cadaveri per vedere se erano soggetti o
no alla putrefazione»8. Il terzo spunto è con-
tenuto nell’analisi di insiemi mitologici del
Nord America, interpretati da Lévi-Strauss
come concezioni in cui è programmatica-
mente prevista la possibilità dell’altro, ov-
vero come sistemi che non semplicemente
rappresentano la propria umanità, ma pre-
vedono la possibilità che esistano forme di
umanità ulteriori e alternative9.
Che cosa si può trarre da questi spunti? In
tutti e tre i casi si intravedono all’opera con-
cezioni dell’uomo, vere e proprie antropolo-
gie, in altri termini un pensiero che si pone
domande del tipo: che cos’è l’uomo, ma an-
che quali sono i confini dell’umanità? Il tema
dei confini dell’umanità è intrinseco a ogni
forma di antropologia, e nei tre casi citati
vediamo come il pensiero antropologico si
concentri sull’alterità. Come i confini, l’alte-
rità costituisce sempre un problema per ogni
definizione di umanità e forse possiamo dire
che ogni antropologia (indigena e non) sorge
esattamente da questo tipo di problema. Gli
spunti tratti da Lévi-Strauss fanno intrave-
dere tuttavia un’ulteriore problematica: non
soltanto i confini dell’umanità nelle antro-
pologie indigene, ma anche il modo in cui
queste ultime possono essere indagate.
Con il tramonto dello strutturalismo l’an-
tropologia si è convinta che la sua missione
consista soprattutto in uno scavo etnogra-
fico10. Per quanto riguarda le antropologie
indigene, si tratterebbe di ricercarne moti-
vazioni e presupposti negli specifici contesti
culturali, considerati come fattori di senso
(un esempio per tutti: il combattimento dei
galli a Bali nell’interpretazione di Clifford
Geertz). Ma l’antropologia è solo etnografia,
come sosteneva Geertz, oppure antropolo-
gia ed etnografia sono due diverse imprese,
per quanto connesse tra loro11?
I tre spunti a cui sopra abbiamo accen-
nato fanno capire che le antropologie non
sono mai soltanto uno sguardo rivolto a
se stessi: i confini sono importanti, perché
importanti sono anche le concezioni altrui,
altri modi di concepire e praticare il senso
dell’umanità. Se questo vale per le antro-
pologie indigene, ancor più deve valere
per l’antropologia che vuole essere scien-
tifica: anch’essa è una sorta di antropologia
indigena, ma un’antropologia che esalta e
professionalizza il senso delle possibilità.
È vero: da tempo lo strutturalismo di Lévi-
Strauss non appare più scientificamente
proponibile. Ma vi sono due dimensioni
dello strutturalismo che vanno tenute di-
stinte e alla fine separate. La prima è l’idea
secondo cui la struttura non coincide mai
con un sistema, bensì con le modalità di
transizione da un sistema all’altro (ciò che
Lévi-Strauss chiamava «gruppo di trasfor-
8 Id., Tristi Tropici, Milano, Il Saggiatore, 1960 [Paris, 1955] pp. 71-72.9 Id., Storia di Lince: il mito dei gemelli e le radici etiche del dualismo amerindiano, Torino, Einaudi, 1993 [Paris, 1991].10 C. Geertz, Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 1987 [New York, 1973].11 T. Ingold, Anthropology is not Ethnography, Radcliffe-Brown Lecture in Social Anthropology, Proceed-ings of the British Academy, vol. 154, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 69-92.
333
mazioni»): un sistema non può mai essere spiegato da solo; per essere compreso, un sistema deve essere posto in connessione con sistemi differenti. La seconda è che questa esplorazione trasversale finisce col determinare un numero finito di possibilità: la completezza era in effetti l’ambizione ori-ginaria dello strutturalismo di Lévi-Strauss. È questa ambizione (con le implicazioni che comportava, quali un’astrazione spinta all’estremo) che ha indotto gli antropologi a prendere le distanze da Lévi-Strauss e dalla sua antropologia strutturale.Trattare Lévi-Strauss come un antenato dovrebbe davvero comportare – come face-vano i trobriandesi con i loro morti – uno smembramento: non già buttare via tutto, ma distinguere e selezionare. Se giusta-mente si rifiuta la pretesa della completezza, ciò che rimane è invece la prima dimen-sione, che potremmo chiamare la trasver-salità12. L’antropologia si configura quindi come un sapere trasversale, che attraversa e connette culture, società, contesti – tra cui le antropologie indigene (qualunque forma esse assumano) –, e tuttavia come un sapere che si considera incompleto, persino infinito (nel senso negativo di mai concluso, mai perfetto), sempre provvisorio. Il suo obiet-tivo è senza dubbio la generalizzazione, ma una generalizzazione orizzontale, piuttosto che verticale, capace di costruire una rete di connessioni, il cui tessuto tiene fin che tiene, che spesso richiede di essere riparato e sottoposto a incessanti verifiche. Non si tratta di negare l’etnografia. Al contrario, essa viene esaltata ed acquista un senso più
pregnante, allorché viene immessa nella rete delle connessioni antropologiche.In fondo, Lévi-Strauss si è impegnato in un grandioso tentativo su cui si è ancora oggi costretti a riflettere: può l’antropologia con-siderarsi un sapere distinto dalla storia? Lévi-Strauss ha risposto di sì. Il modo con cui ha risposto – lo strutturalismo come giro completo, come delineazione di un quadro completo e finito di possibilità – è ciò che l’antropologia ha lasciato cadere. Ma la rivendicazione di connettere casi diversi, ovvero di praticare una trasversalità tra i casi, a prescindere dai loro legami storici, è probabilmente l’unico fattore che consente di sottrarsi alla secca e mortificante alter-nativa enunciata da Frederick W. Maitland nel 1899: «ben presto l’antropologia dovrà scegliere tra essere storia o essere niente»13. Non si tratta affatto di negare la storia o di diminuirne la portata; si tratta però per l’antropologia di decidere se confluire nella storia o riflettere, ancora una volta, sulla possibilità di rivendicare una propria auto-nomia di indagine. Lévi-Strauss è un ante-nato che ha avuto il coraggio di rifiutare a viso aperto il dilemma di Maitland: proprio per questo può continuare a parlarci e a farci discutere. Del resto, un’antropologia capace di rivendicare una propria autono-mia epistemologica non costituisce forse un prezioso arricchimento del quadro delle scienze umane e delle scienze sociali? E questo quadro non risulterebbe forse impo-verito, se l’antropologia finisse per scompa-rire nella storia da un lato o nella sociologia
dall’altro?
12 F. Remotti, Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia, Torino, Bollati Boringhieri, 20092.13 F.W. Maitland, The Body Politic, in The Collected Papers of Frederic William Maitland, Cambridge, Cam-bridge University Press, 1991, vol. III, p. 295.
334
Come per ogni antropologo abituato a
lavorare «sul terreno», attraverso un dia-
logo immediato con i suoi interlocutori,
e a costruire interpretazioni del sociale o
del culturale con dati tratti dalla sincronia,
senza un passato e un futuro, il rapporto di
Lévi-Strauss con il tempo e la storia è stato
complesso e difficile. Non soltanto perché
è radicata nella cultura occidentale l’idea
che nessuna società può fare astrazione
della sua storia in qualunque modo – miti,
racconti orali, monumenti, documenti
scritti – essa sia tramandata lungo le ge-
nerazioni (Lévi-Strauss distinguerà le
società «fredde», senza scrittura ma non
certo senza storia, da quelle «calde», con la
scrittura) ma anche perché l’antropologia
culturale nutre l’ambizione di imposses-
sarsi della storia e di spiegarla con altri
concetti e altri strumenti: non più raccon-
tando avvenimenti lungo un asse cronolo-
gico pre-definito ma cercando di capire le
regole fondamentali, le «strutture» su cui
si costruiscono le società e le interazioni
tra le strutture stesse. Su queste questioni
essenziali, il pensiero di Lévi-Strauss non
è stato definito una volta per tutte da Le
strutture elementari della parentela1 o da
Antropologia strutturale2, fino all’articolo
del 1983 Histoire et ethnologie3, si scorgono
continuità ma forse anche cambiamenti di
punti di vista. Per capire la o le posizioni
di Lévi-Strauss credo però che non sia suf-
ficiente limitarsi ad una esegesi – già più
volte ampiamente e spesso brillantemente
eseguita4 – del suo pensiero; è invece ne-
cessario ricollocarlo nel contesto dei dibat-
titi scientifico-culturali del tempo per ca-
pirne tutte le ragioni condivise, le sfuma-
ture, le prese di distanza o le motivazioni
polemiche.
Murdock e le strutture socialiNello stesso anno in cui Lévi-Strauss pub-
blica la sua prima opera fondamentale, Le
strutture elementari della parentela, il 1949,
esce negli Stati Uniti quello che rimarrà un
altro monumento dell’antropologia cultu-
rale, Social Structure di George Peter Mur-
dock. Partendo dall’analisi comparata di
150 società ripartite in tutto il mondo, Mur-
dock individua i criteri fondamentali che
presiedono ad ogni organizzazione sociale.
Egli stabilisce una classificazione (orga-
nizzazione sociale di tipo eskimo, di cui fa
parte la nostra società europea occidentale,
di tipo hawaiano, di tipo sudanese, di tipo
omaha e così via, ognuna è definita da un
incrocio specifico di caratteri) che ritiene
esaustiva per tutte le società del mondo. Ma
Gérard Delille
Lévi-Strauss, il tempo e la storia
1 C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli, 1969 [Paris, 1947].2 Id., Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 1966 [Paris, 1958].3 Id., Histoire et ethnologie, «Annales. Esc», 1983, 6, pp. 1217-1231.4 Tra molti titoli mi limito a citare la biografia di M. Hénaff, Claude Lévi-Strauss, Paris, Belfond, 1991, e lo studio di L. Scubla, Lire Lévi-Strauss, Paris, Odile Jacob, 1998.
335
l’ambizione di Murdock va ben al di là di
questa classificazione di per sé fondamen-
tale, perché il libro sulle «strutture» vuole
anche essere, come suggeriscono i titoli del
capitolo VIII (L’evoluzione dell’organizza-
zione sociale) e dell’appendice (Una tecnica
di ricostruzione storica), un libro di «sto-
ria». Egli vuole indicare attraverso quali
modifiche si passa da un tipo strutturale
ad un altro. Ma in nessun momento Mur-
dock si richiama a ricerche di storici tradi-
zionali. Le ignora, ignora la cronologia e
la «storia» nel senso in cui le intendiamo.
Tutt’al più troviamo indicazioni molto ge-
nerali del tipo «i Curdi sono chiaramente
derivati dal tipo sudanese normale, dopo
avere perso la esogamia sib di un tempo in
conseguenza della conversione all’Islam
e dell’adozione della preferenza maomet-
tana per il matrimonio con una PaFrFf [fi-
glia del fratello del padre]»5. La modifica di
un elemento fondamentale quale l’esoga-
mia dei sib (gruppo di parentela consan-
guinea discendente, in linea maschile o
in linea femminile da un originario ceppo
comune) ha fatto così passare i curdi dal
tipo sudanese al tipo fox. Non si tratta qui
di un mero gioco classificatorio: ogni tipo
risponde a caratteristiche molto precise e
l’intento è di capire quale conseguenze il
cambiamento di una di esse provoca sulle
altre, quale evoluzione, anche «storica»,
mette in moto. Una società appartenente a
un dato tipo potrà evolversi verso alcuni
tipi ma non altri. Attraverso le interazioni
di strutture, l’obiettivo è dunque di stabi-
lire le leggi «scientifiche» dell’evoluzione
sociale. Alcune affermazioni di Murdock
sono, a questo proposito, molto chiare:
lungi dal «riflett[ere] un “accidente sto-
rico”» o dal costituire «un sistema chiuso
all’interno delle culture umane», i modi
di comportamento sessuali (l’incesto e le
regole di scambi matrimoniali) sono così
dipendenti dalle forme dominanti dell’or-
ganizzazione sociale «che possono essere
previsti in misura notevole se le forme
strutturali [dell’organizzazione sociale]
sono note», «può essere perfino possibile
organizzare principi dominanti in leggi
scientifiche di notevole complessità»6.
Siamo lontano dalle tesi evoluzioniste di
alcuni dei padri fondatori dell’antropologia
che vedevano nelle diverse organizzazioni
sociali gli stadi successivi di un processo di
«civilizzazione», di una marcia verso forme
sempre più perfette (quella occidentale es-
sendo, ovviamente, la più perfetta di tutte).
Con la struttura invece il tempo non conta
più e la nostra società si trova apparentata
con altre tra le più «arretrate» del pianeta.
Si può vedere in questa mise hors du temps
dei fatti sociali e culturali un semplice
tentativo di giustificazione di un approc-
cio e di un metodo antropologico che, a
causa del materiale umano di cui tratta, è
incapace di considerare e analizzare fatti
storici concreti. Lévi-Strauss non elude il
problema e lo risolve, come abbiamo visto,
in modo un po’ sbrigativo e non del tutto
convincente con la distinzione tra società
fredde e calde. Ma fermarci a questo sa-
rebbe avvalorare un’interpretazione molto
riduttiva; vi è, credo, più profondamente,
5 G.P. Murdock, Struttura sociale, Milano, Etas Kompass, 1971 [New York, 1949], p. 199.6 Ivi, p. 261.
336
una volontà precisa di escludere il tempo
e la storia-cronologia, basata sulla convin-
zione che la descrizione delle interazioni
tra strutture non abbia bisogno di un rife-
rimento temporale. Una convinzione che
ha accompagnato le scienze «dure» nei
loro sviluppi – paradossalmente fondati
sulla possibilità di misurare nel tempo i
fenomeni fisici – e che, dopo Einstein che
ha fatto del tempo un valore non più as-
soluto, viene riproposta di nuovo oggi con
forza da alcuni fisici come Carlo Rovelli
nel tentativo di unificare la teoria della
relatività con quella quantistica7. Quando
descriviamo per esempio un fenomeno
fisico, mettiamo in relazione un inizio (la
mela lasciata cadde) e una fine (la mela
tocca terra) misurando il tempo impie-
gato. Ma il tempo, in realtà, ci serve solo
a nascondere e inglobare l’azione di altre
variabili fisiche di cui non abbiamo –o non
avevamo – conoscenza né sappiamo come
agiscono, e che in questo modo possiamo
mettere temporaneamente da parte. Se,
per ipotesi, conoscessimo tutte queste va-
riabili, potremmo descrivere il nostro fe-
nomeno fisico con un’equazione che non
includerebbe il tempo. Il tempo è dunque
una misura che ci serve a confrontare due
o più variabili e a capire la relazione che
intrattengono, e nello stesso tempo è una
misura della nostra ignoranza. «Com-
prendere» vorrebbe dire allora utilizzare
il tempo per meglio, in seguito, eliminarlo
progressivamente. Come diceva Paul La-
combe all’inizio del Novecento, «il tempo
in sé non è niente, obiettivamente è sol-
tanto un’idea nostra»8.
Le «qualità senza tempo»Ci possiamo chiedere tuttavia se un tale
concetto di tempo dedotto dall’esperienza
scientifica sia direttamente e interamente
trasferibile, come fa Murdock, alle scienze
umane. Che vi sia un’interazione di strut-
ture e che questa determini l’evoluzione
delle società, lo possiamo ammettere. Ma
cosa fa interagire le strutture o più sempli-
cemente provoca il cambiamento di uno dei
loro caratteri fondamentali? I curdi si sono
«piegati» – perché, supponiamo, sottomessi
militarmente dagli arabi – al costume mao-
mettano del matrimonio con la cugina pa-
rallela patri laterale, ma avrebbero potuto
anche non farlo e conservare la loro eso-
gamia di sib. Molti ebrei e cristiani hanno
rifiutato di convertirsi all’islam. Si può
eludere il problema della scelta? Ammet-
tiamo che si possa; ma cosa significa allora,
socialmente, comprendere un fenomeno,
cosa significa «l’intelligenza»? È soltanto
una variabile in più nel gioco dell’intera-
zione delle strutture? O è lo strumento con
il quale gli uomini creano altre strutture,
creano altro tempo, al di fuori delle leggi
della fisica?
A questo punto, possiamo tornare a Lévi-
Strauss. Profondo conoscitore dell’an-
tropologia americana, con la quale ha
completato, durante la Seconda guerra
7 C. Rovelli, Che cos’è il tempo? Che cos’è lo spazio, Roma, Di Renzo, 2004, e Id., Forget time, in The nature of Time. Essay Contest, Foxi Forum, agosto 2008, www.fqxi.org/community/forum/category/10.8 La science de l’histoire d’après M. Xenopol, «Revue de Synthèse Historique», 1900, 1, p. 32. Il passo è ri-cordato da Feranand Braudel nell’articolo Storia e scienze sociali. La «lunga durata» (1958), in F. Braudel, Scritti sulla storia, Milano, Mondadori, 1973 [Paris, 1969].
337
mondiale, la sua formazione scientifica,
egli condivide senza dubbio, con Mur-
dock, l’idea essenziale che la spiegazione
dei fenomeni sociali e culturali non abbia
bisogno del tempo e della storia. Quello
che conta sono le qualità delle diverse va-
riabili e le loro relazioni. Nelle Strutture
elementari della parentela, Lévi-Strauss
mostra come la proibizione dell’incesto,
passaggio dalla natura alla cultura, sia la
condizione obbligata di ogni costruzione
sociale e come nelle società che prescri-
vono determinate regole di scambio matri-
moniale queste generino una circolazione
delle donne – e parallelamente anche dei
beni – molto diversi a secondo dei pas-
saggi previsti: se la regola è di sposare la
cugina incrociata matrilaterale, il circuito
si allarga, attraverso le donne, verso altre
famiglie, mentre se la regola è di sposare la
cugina incrociata patrilaterale, si chiuderà
subito su se stesso. Lévi-Strauss dimostra
che queste qualità sono inerenti alla strut-
tura e determinano sistemi sociali molto
diversi, sono qualità «senza tempo». Nelle
Mythologiques9, il tempo e la storia non
sono necessariamente assenti poiché una
prima fase della ricerca consiste nel colla-
zionare le diverse versioni, anche storiche,
di uno stesso mito per cercare di capire i
meccanismi concettuali – «universali» e
fuori dal tempo – che presiedono alla loro
costruzione. Come lo stesso Lévi-Strauss
ha sinteticamente sottolineato nel breve
articolo Le temps du mythe10, ogni mito
si costruisce intorno alla costatazione di
un’asimmetria fondamentale (il cielo e
la terra, il vicino e il lontano, il maschio
e la femmina...) che mette in moto un’ap-
parecchiatura concettuale fatta di regole
d’opposizione sistematiche «preesistenti
in anticipo nell’intento», apparecchiatura
che si nutre di situazioni concrete a cui
dà senso, «è con l’applicazione sistematica
delle regole di opposizione che i miti na-
scono, irrompono, si trasformano in altri
miti che si trasformano a loro volta». Così,
«i miti si parlano e si rispondono» e se tale
dialogo come qualunque altro necessita di
tempo, quest’ultimo non ne è la condizione
e non rappresenta neanche una variabile
interessante. Lo stesso potrà dirsi delle
maschere: quelle di una data tribù si spie-
gano guardando i loro contrari, cioè quelle
delle tribù vicine. L’uno è nero con delle
piume perché l’altro è bianco con della
pelliccia11.
La «lunga durata»Non ci sembra necessario insistere: se i
temi abbordati da Lévi-Strauss e la sua
esposizione dei risultati, come la sua scrit-
tura, sono molto lontani da quelli di Mur-
dock, le problematiche fondamentali e i
concetti adoperati sono, invece, molto vi-
cini. I «nemici» per tutti e due sono rappre-
sentanti da quelle correnti di pensiero che
vedono nelle costruzioni sociali «un “guaz-
zabuglio”, una cosa fatta di “brandelli e
pezze”» senza rendersi conto che le forme
di organizzazione di tutte le società, anche
la nostra, «manifestano le stesse regolarità e
9 Mitologica, Milano, Il Saggiatore, 1966-1974 [Paris, 1964-1971]. L’opera, in quattro volumi, comprende: Il crudo e il cotto, Dal miele alle ceneri, Le origini delle buone maniere a tavola, L’uomo nudo.10 «Annales. Économies Sociétés, Civilisations», 1971, 3-4, pp. 533-540; la citazione è a p. 534.11 La via delle maschere, Torino, Einaudi, 1985 [Genève, 1975].
338
seguono gli stessi principi»12 o che iniettano massicciamente il tempo a tutti i livelli, ri-portando ogni spiegazione ai contesti e alle scelte degli attori. È contro l’autore della Critique de la raison dialectique, contro Sar-tre che definisce l’uomo con la dialettica e la dialettica con la storia, cioè con delle scelte fatte nel tempo, con la storia che sola dà senso agli atti umani, che il «primo» Lévi-Strauss dirige le sue frecce nel Pensée sauvage13. La storia come la concepisce Sartre è un culto della storia, la conoscenza costruita di un passato collettivo per criti-care e orientare la società presente; è un mito, peggio una mistificazione che dispone in modo arbitrario gli avvenimenti lungo un senso lineare, la cronologia, che gli serve da codice. «La storia è un insieme disconti-nuo formato da zone di storia, ciascuna delle quali è definita da una frequenza pro-pria, e da una codificazione differenziale del prima e del poi»; «nella misura in cui la storia aspira al significato, si autocondanna a scegliere regioni, epoche, gruppi di uo-mini e individui in questi gruppi, e a met-terli in risalto, come figure discontinue, su un continuo buono appena a servire di tela di sfondo»14. Un giudizio severo e apparen-temente senza appello, ma che risente del contesto polemico in cui viene espresso. Sul fondo Lévi-Strauss è più duttile e lascia spazi aperti, rifiuta un certo modo di fare storia ma non ignora la storia né la rigetta. Non condivide l’atteggiamento di un Mali-
nowski e di molti altri antropologi per cui la conoscenza del passato di una società non è necessaria alla sua comprensione. Storia e etnologia hanno uno stesso scopo: capire la vita sociale. Nelle società fredde, la storia è pura, iscritta nella natura: gli alberi, le fonti e così via sono collegati ad un antenato e alla sua storia. Soprattutto, sin dal 1952, in Race et histoire, Lévi-Strauss aveva avan-zato una distinzione più complessa, quella tra storia stazionaria e storia cumulativa15. Quest’ultima si afferma quando, nello stesso tempo, una serie di elementi favorevoli si combinano per creare le condizioni di un balzo in avanti. Si potrebbe dissertare all’in-finito sulle nozioni di «elementi favorevoli», di «combinazione» e di «balzo in avanti»; importa di più la presa in considerazione, contrariamente a quanto avviene con Mur-dock, della presenza della storia. L’am-biente parigino in cui Lévi-Strauss opera è, molto più di quello americano, permeato dalla ricerca storica e dai suoi problemi. È il periodo in cui le «Annales», sulla scia delle precedenti critiche alla storia évene-mentielle, elaborano nuovi metodi d’inda-gine, messi alla prova in studi di tipo socio-economico su determinate regioni (per esempio il Beauvaisis di P. Goubert)16, ed esaltano l’interdisciplinarità (il metodo della ricostituzione delle famiglie in demo-grafia storica). È il periodo dominato dalla
grande tesi di Fernand Braudel su La Médi-
terranée et le monde méditerranéen17, tutta
12 G.P. Murdock, Struttura sociale, cit., p. 309.13 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1964 [Paris, 1962].14 Storia e dialettica, ivi, p. 281 e 279.15 C. Lévi-Strauss, Razza e storia e altri studi di antropologia, Torino, Einaudi, 1967 [Paris, 1952].16 P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 a 1730. Contribution a l’histoire sociale de la France du 17eme siécle, Sl, Sevpen, 1960.17 F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, Einaudi, 1953 [Paris, 1949].
339
costruita sulla distinzione dei tempi della
storia. Ora, l’irruzione dello «strutturali-
smo» sulla scena scientifica spinge Braudel
ad intervenire con il famoso articolo – il cui
interlocutore privilegiato è Lévi-Strauss –
sulla lunga durata, del 195818. Nel dibattito
tra le scienze sociali, di fronte a un’antropo-
logia dinamica e conquistatrice, Fernand
Braudel vuole prima di tutto, come già in
passato aveva fatto Lucien Febvre nei con-
fronti della scuola durkheimiana, sottoline-
are «l’importanza, l’utilità della storia, o
piuttosto della dialettica della durata»19.
Un’espressione, quest’ultima, forse non
molto gradita a Lévi-Strauss. Al di là delle
precauzioni del linguaggio, Braudel marca
la sua distanza non solo da quegli etnografi
ed etnologi che come Malinowski hanno
sottolineato «l’impossibilità (ma ogni intel-
lettuale è tenuto ad affrontare l’impossibile)
e l’inutilità della storia all’interno del loro
mestiere» ma anche rispetto a un Lévi-
Strauss che condivide con gli storici la
«stessa avventura dello spirito» e di cui tesse
grandi lodi. Lévi-Strauss, seguendo la
strada aperta dalla linguistica («come la sto-
ria presa nella trappola dell’avvenimento,
così la linguistica, presa nella trappola delle
parole [...] se n’è liberata grazie alla rivolu-
zione fonologica»), ha saputo estendere il
senso del linguaggio alle strutture elemen-
tari della parentela e «tradurre in termini
matematici il frutto dell’osservazione
dell’antropologo»; è riuscito a superare la
superficie per raggiungere quella zona pro-
fonda, spesso inconscia, in cui si possono
intravedere «le leggi di struttura più gene-
rali»20. Egli procede nello stesso modo con i
miti che riduce «ad una serie di cellule ele-
mentari», «Ogni volta egli è alla ricerca di
livelli profondi, subconsci»21. Come Lévi-
Strauss, Braudel se la prende con Sartre,
colpevole, attraverso un gioco condotto con
grande intelligenza ma pericoloso, di accol-
lare a dei frammenti di storia tempi supe-
riori alla loro durata e sensi che non conte-
nevano, colpevole di voler rinnovare le vi-
sioni troppo semplici e troppo pesanti del
marxismo «in nome [...] della realtà troppo
ricca dell’événementiel»22, delle scelte degli
attori e delle biografie, mentre questo rin-
novamento andava fatto con la compren-
sione delle realtà di lunga durata. Il «dis-
senso» con Lévi-Strauss è espresso attra-
verso un problema tecnico, apparentemente
secondario: le matematiche sociali qualita-
tive a cui egli si richiama e che gli permet-
tono di tradurre in formule «scientifiche» le
relazioni sociali da lui osservate non appa-
iono ancora adatte a tradurre l’estrema
complessità delle società moderne. «Le ma-
tematiche sociali qualitative saranno perà
messe alla prova solo quando avranno af-
frontato gli intricati problemi e le diverse
velocità della vita propri d’una società mo-
derna»; quello che propone Lévi-Strauss,
per ora, funziona solo per gruppi umani ri-
dotti, in cui «una vita sociale molto omoge-
nea permette di definire a colpo sicuro le
relazioni umane semplici e concrete, poco
18 Id., Storia e scienze sociali, cit.19 Ivi, p. 726.20 Ivi, pp. 736, 744 e 745.21 Ivi, p. 745.22 Ivi, p. 751.
340
variabili» da lui studiate, per porre problemi
e formulare osservazioni con un procedi-
mento che «non si colloca solo a livello mi-
crosociologico, ma al punto d’incontro tra
l’infinitamente piccolo e la lunghissima du-
rata»23. È forse sottointeso: se quelle società
avessero una storia e la loro vita sociale
fosse vista nel tempo, le loro relazioni appa-
rirebbero molto più variabili e più difficil-
mente riducibili a un linguaggio matema-
tico? Solo i modelli statistici ci permettono
di affrontare e capire le società larghe e
complesse. La statistica che propone Brau-
del è quella che quantifica le realtà sociali o
economiche (le nascite, i rendimenti agri-
coli ...) e tende a fondere insieme le diverse
relazioni sociali che hanno dato origine a
questi fenomeni. Il senso sta nella quantifi-
cazione e delimitazione di masse e ordini di
grandezze più che nella «qualità» delle rela-
zioni e nei meccanismi a loro inerenti. È la
statistica che ci permette di distinguere le
invarianti di una società dai fenomeni con-
giunturali, la lunga durata dai tempi brevi.
Contrariamente a quanto avviene con le in-
terpretazioni semplificatrici della lunga du-
rata, Braudel non butta alle ortiche gli avve-
nimenti e la breve durata, le rotture, «le in-
temperie della storia», i cambiamenti che
investono la struttura stessa. Non rinuncia
alla diversità dei tempi della storia, vuole
solo distinguerli per meglio capire. Siamo
dunque su problematiche e metodologie
ben diverse. La lunga durata non è la strut-
tura di Lévi-Strauss; è quello che, per ra-
gioni diverse, spesso esterne (in particolare
la geografia), dura a lungo e in questo sol-
tanto si avvicina alla struttura che invece
attiene alla cultura, alle regole del dono e
alle sue qualità inerenti, ai dispositivi di op-
posizioni, cioè a meccanismi concettuali
condivisi da tutti gli uomini. Vi è, nella po-
sizione di Braudel verso lo strutturalismo di
Lévi-Strauss e verso la sua concezione del
tempo, una sorta di sfida: le problematiche
e i metodi che sono stati applicati in modo
così efficace e con risultati così convincenti
per le società «primitive» non sono trasferi-
bili allo studio delle società moderne, delle
società complesse. Braudel rimanda a Lévi-
Strauss la sua distinzione tra società fredde
e società calde: ciò che vale per le prime,
fuori dal tempo, senza una storia decifra-
bile, non vale per le seconde immerse nel
tempo.
Lévi-Strauss non risponderà a questa sfida
o piuttosto risponderà molto più tardi, nel
1983 con l’articolo Histoire et etnologie pub-
blicato nelle stesse «Annales Esc». Torne-
remo su questo testo. Negli anni Cinquanta
e Sessanta, Lévi-Strauss non sembra, in
realtà, in profondo disaccordo con Braudel:
le società come quella europea occidentale
del periodo medievale e moderno gli ap-
paiono mosse da relazioni estremamente
complesse e variabili, «un turbine conti-
nuo» irriducibile a leggi di scambio precise
e a formule matematiche semplici. Queste
società «complesse» (Braudel parlava di
società «larghe e complesse») sono carat-
terizzate in particolare, per l’antropologo,
da divieti matrimoniali (e non più da pre-
scrizioni come nel caso delle società ele-
mentari) molto ampi (fino alla quarta ge-
nerazione nella cristianità occidentale), per
cui l’esistenza di eventuali cicli controllati
23 Ivi, p. 748, 747.
341
e meccanismi di reciprocità nel dare e ri-
cevere le donne appaiono improbabili. Un
ciclo completo dovrebbe chiudersi al di là
della consanguineità proibita, cioè cinque
o sei generazioni dopo un matrimonio ini-
ziale, cioè ancora circa un secolo dopo. In
queste società, le nozioni di scambio delle
donne, di reciprocità, di definizione dei ci-
cli di scambio non esistono più, si passa ad
altre definizioni del dono e dello scambio,
ad altri sistemi di relazioni, ad altri rap-
porti col tempo e con la storia. I «giochi»
dunque sembrano fatti, il dibattito chiuso:
agli antropologi le società «primitive» e le
strutture, agli storici le società complesse e
il tempo.
In realtà, Lévi-Strauss non si ferma a questo
primo approccio apparentemente logico ma
troppo semplice; il problema delle società
complesse e della loro interpretazione, che
si era già posto nel 1949, in prosecuzione al
libro sulle Strutture elementari («la mia idea
era di scrivere un secondo volume [...] Le
strutture di parentela complesse [...] Mi ac-
corsi ben presto che quei sistemi complessi
non potevano essere trattati con metodi
artigianali: bisognava ricorrere all’infor-
matica. Io non ne avevo i mezzi pratici né
soprattutto quelli intellettuali»)24, gli appare
sempre più fondamentale, poiché rap-
presenta una chiave per la comprensione
unitaria delle società umane, per superare
la dicotomia società calde/fredde, con la
storia/senza storia. Dietro o al di là del tur-
bine continuo vi sono principi ordinatori e
regolarità; dietro l’apparente disordine e la
fluidità, nel tempo, dei rapporti sociali, lo
scambio delle donne e la reciprocità con-
tinuano, insieme al tabù dell’incesto, ad es-
sere al cuore delle relazioni sociali. Questo,
come era per Murdock, non implica che
vi sia un legame diretto e necessario tra
struttura sociale e sviluppo economico e
culturale: una società complessa non è ne-
cessariamente, come la nostra, una società
tecnologicamente avanzata. Lévi-Strauss
segue e guida questa ricerca difficile ma
la affida soprattutto ad alcuni suoi allievi,
in particolare Françoise Héritier che inizia
una ricerca sui samo dell’Alta Volta (Bur-
kina Faso), una popolazione che presenta
divieti matrimoniali abbastanza simili ai
nostri (non entro qui nei dettagli di queste
regole); un lavoro impegnativo che neces-
sita della raccolta di una quantità impo-
nente di dati di natura genealogica e il loro
trattamento informatico allo scopo di deter-
minare eventuali replicazioni di alleanze e
chiusure di circuiti matrimoniali.
Nel frattempo, Lévi-Strauss precisa alcune
sue posizioni e «apre» alla storia. L’attività
inconscia dello spirito che impone forme
a un contenuto, non implica una visione
anti-storica dei fenomeni sociali. I problemi
che deve affrontare lo spirito sono posti in
modo diverso dalla geografia, dal clima,
dallo stato della civiltà a un dato momento
mentre ogni individuo ha un suo carattere,
una sua storia personale, una sua posizione
nel gruppo. Insomma, «il meccanismo dun-
que è sempre lo stesso, cambia quello che
si mette dentro»25. Il nostro sguardo sul
24 C. Lévi-Strauss, D. Éribon, Da vicino e da lontano. Discutendo con Claude Lévi-Strauss, Milano, Rizzoli, 1988 [Paris, 1988], p. 83.25 Ivi, p. 175.
342
passato deve integrare tutti gli aspetti della
temporalità e le diverse rappresentazione
del tempo: miti, memoria orale, storia; il
passato, però, può essere studiato e capito
soltanto perché gli uomini pensano fonda-
mentalmente sempre nello stesso modo.
Nel 1975 dichiara «bisogna arrendersi alla
contingenza irriducibile della storia»26.
L’avvenimento è un dato imprevedibile
ma una volta successo si può cercare di ca-
pirlo, di collegarlo ad altri avvenimenti, di
posizionarlo nel quadro più generale delle
strutture. Il problema, tuttavia, rimane
sempre, come per Braudel, quello dell’ar-
ticolazione dei diversi livelli o istanze di
tempo, un problema che Lévi-Strauss non
affronta; non chiarirà mai precisamente la
sua concezione delle relazioni che le società
intrattengono con il tempo. Vi è nel suo
rapporto con la storia e con il tempo una
sorta di andirivieni continuo tra la strut-
tura e l’avvenimento, tra il «quasi fuori del
tempo» e il tempo sempre presente, tra lo
spiegabile e l’inspiegabile. Altri come Pierre
Bourdieu o Marshall Sahlins cercano, in
quello stesso periodo, di reintrodurre una
tematica dell’azione e di capire la relazione
tra sistemi e pratica27. Altre correnti come
il postmodernismo o il decostruzionismo
avanzeranno poi critiche ben più radi-
cali, accusando l’osservatore antropologo,
nella sua inchiesta sul terreno, di fermare
l’azione per potere costruire una visione
atemporale delle società. Una critica rivolta
anche, nel campo storico, contro la lunga
durata di Braudel e all’approccio statistico
dei fenomeni sociali.
Intanto la ricerca di Françoise Héritier
giunge a termine. Il libro L’exercice de la
parenté, esce nel 1981 e allarga i risultati
tratti dal caso dei samo al problema gene-
rale delle società semi-complesse e com-
plesse28. È una svolta. L’autrice mostra
come, in queste società caratterizzate da
divieti matrimoniali ampi, ciò che non può
essere replicato nella filiazione diretta può
esserlo nelle linee collaterali (per esempio
un matrimonio può essere replicato, alla
generazione seguente, attraverso quello dei
loro rispettivi nipoti ex-frate o soror; è il co-
sidetto «scambio tra linee alterne») e come
le regole d’esogamia abbiano per fine non
tanto la dispersione delle alleanze quanto le
fusioni a venire nel gruppo di origine (con
chiusure matrimoniali una volta superati
i limiti posti dai divieti). Vi sono dunque,
dietro l’apparente turbine delle relazioni
sociali, dei principi e dei meccanismi ordi-
natori e classificatori che «orientano» i ma-
trimoni e i circuiti dello scambio.
Struttura e storiaNel 1983, Lévi-Strauss può finalmente «ri-
spondere» a Braudel che avrà appena il
tempo di leggere il suo saggio (muore nel
1985). L’impostazione del problema è chiara:
«la storia e l’etnologia si distinguevano in
due modi. L’una considera il suo campo
d’azione le società [...] complesse o evolute,
il cui passato è attestato dagli archivi; l’altra
26 Anthropologie, histoire, idéologie, «L’Homme», luglio-dicembre 1975, pp. 177-188.27 P. Bourdieu, Per una teoria della pratica, con tre studi di etnologia cabila, Milano, Cortina, 2003 [Genève, 1972]; M. Sahlins, Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in the Early History of the Sand-wich Islands Kingdom, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1981.28 F. Heritier, L’ esercizio della parentela, Roma-Bari, Laterza, 1984 [Paris, 1981].
343
le società impropriamente dette primitive
o arcaiche, in ogni caso senza scrittura [...]
ciò che incita a restringere il loro studio al
tempo presente»29. Lévi-Strauss tesse le lodi
della nuova antropologia storica di grande
aiuto per gli etnologi, ci trasporta nel Giap-
pone medievale o – attraverso le Memorie
di Saint Simon – alla corte di Luigi XIV, per
mostrarci come il passaggio da una forma a
un’altra di sistema matrimoniale «è spesso
poco percettibile, rilevabile solo attraverso
una lieve flessione delle regole e dei com-
portamenti», come la dialettica tra nom de
race e nom de terre30 comune a molte società
in transizione verso un sistema «complesso»
(i gruppi di discendenza risultano allora
«tanto dell’alleanza quanto della filiazione,
i quali diventano sostituibili l’un l’altro»)31.
Risultato: «tra le società dette “complesse” o
“sviluppate” e quelle chiamate a torto “pri-
mitive” o “arcaiche”, la distanza è meno
grande di quella che potevamo credere»32.
Lévi-Strauss si affretta a precisare ciò che
intende per «complesse» e «sviluppate». La
distinzione tra società elementari e società
complesse «rileva una classificazione dei
sistemi secondo la loro forma [...]. La rela-
zione tra forma semplice e forma complessa
pone un problema di ordine logico che non
implica necessariamente quello, storico, del
passaggio da una forma antica ad una più
recente»33. Donde la domanda: «ordinando
logicamente delle strutture, si rinunzia a
conoscere la loro evoluzione nel tempo?»34.
Non si rinunzia, ma bisogna per questo tro-
vare ed elaborare, come ha fatto la cladistica
(scienza della classificazione delle specie)
nelle scienze naturali, una metodologia che
ci permetta di passare alternativamente
dalla determinazione di un ordine di succes-
sione nel tempo ad una tipologia elaborata a
partire delle caratteristiche dei gruppi, indi-
pendentemente dalla loro origine, dalla loro
storia; «una via mediana tra l’ordine della
struttura e quello del avvenimento». «Lungi
dal rigettare la storia, l’analisi strutturale gli
propone una lista di cammini possibili tra i
quali la storia potrà sola determinare quello
o quelli effettivamente seguiti»35. Tuttavia,
la distanza con Braudel è ribadita in modo
pacato ma chiaro: «quello che consideriamo
una struttura sociale [...] non si riduce forse
ad una media statistica di scelte fatte in tutta
libertà [...]? [...] è poco plausibile che le so-
cietà umane si ripartiscono in due gruppi
irriducibili, alcune rilevante dalla struttura,
altre del avvenimento»36. Pur riconoscendo
il ruolo dell’avvenimento, Lévi-Strauss si
rifiuta di farne l’asse portante di ogni co-
struzione sociale e critica aspramente le
nuove correnti di pensiero che partono
dall’individuo-attore: «Dovremo dunque ri-
nunciare a scoprire nella vita delle società
umane qualche principio organizzatore, ve-
29 C. Lévi-Strauss, Histoire et ethnologie, cit., p. 1217.30 Il primo è il cognome del gruppo di parentela biologica o legale, il secondo quello che deriva dal pos-sesso di una proprietà o dalla residenza.31 C. Lévi-Strauss, Histoire et ethnologie, cit., pp. 1220 e 1224.32 Ivi, p. 1226.33 Ibidem34 Ibidem.35 Ivi, p. 1229.36 Ibidem.
344
dervi soltanto un immenso caos di atti cre-
atori provenienti tutti da scala individuale
e assicurando la fecondità di un disordine
permanente?»37. L’etnologia deve, come ha
fatto Françoise Héritier, affrontare i turbini
per capire i livelli di ordini che nascondono;
lo deve fare con gli storici, spogliando le
Memorie di Saint Simon, le raccolte genea-
logiche del Padre Anselme, di Imhof, di Ho-
zier, privilegiando non la storia immobile
ma quella quotidiana, che dietro il pullulare
degli aneddoti e delle date ci rivela dei prin-
cipi organizzatori. La storia per ritrovare le
strutture.
Bisogna riconoscere a Lévi-Strauss il merito
di non avere, come ha fatto invece Murdock,
scelto la soluzione «facile» e radicale di elu-
dere il problema del tempo e della storia. Al
di là dell’interazione delle variabili struttu-
rali lascia spazio e ruolo per la storia e per
gli attori, attori che tuttavia rispettano alcune
regole esplicite o implicite definendo così
una «curvatura del campo». Le sue rifles-
sioni rimangono stimolanti e «aprono uno
spazio di riflessione sui modi di considera-
zione del tempo che modellano la vita po-
litica e sociale». Ha sottolineato con forza i
limiti dell’obiettività storica e incitato ad una
visione più larga integrando tutti gli aspetti
della «temporalità», incluso il modo con cui
la percezione del tempo struttura il nostro
presente e le nostre relazioni al passato38.
Anche se nell’articolo del 1983 Lévi-Strauss
si augurava di vedere superato «il dualismo
della struttura e dell’avvenimento», non c’è
dubbio che nel suo approccio, come spesso
anche in quello dei suoi contraddittori, strut-
tura e storia sono due cose «diverse» che
però interferiscono tra di loro con modalità
e intensità difficili da definire e capire. Il pro-
blema, forse, è che quell’assioma di base è
falso; se gli attori si riferiscono a delle regole
dettate dalla struttura e «curvano il campo»
è anche vero che ogni struttura, anche
quelle apparentemente più costringenti, la-
sciano – «coscientemente» o no – ampi spazi
di «libertà» a questi stessi attori. Nelle strut-
ture complesse, le replicazioni o le chiusure
matrimoniali avvengono sulla base di scelte
iniziali «libere». Lo storico o l’antropologo
non hanno, credo, da scegliere tra struttura
o pratica, né devono isolare l’una dall’al-
tra. Devono definirle e capire come inte-
ragiscono e se, e in quali condizioni, l’una
può cambiare l’altra. La tesi dell’individuo
attore che ragiona e agisce in funzione del
contesto immediato in cui si trova, non fa
altro che reintrodurre il tempo breve a tutti
i livelli e pone in principio la soluzione dei
problemi; sono un’interpretazione e un me-
todo non scientifici. Il tempo ci è necessario
per capire le interrazioni sociali ma anche,
non dimentichiamolo, per «nascondere» ciò
che non capiamo.
37 Ivi, p. 1230.38 M. Abélès, Avec le temps, «Critique», numero speciale su Claude Lévi-Strauss, gennaio-febbraio 1999, pp. 42-60, in particolare p. 60.
345
Gli storici in generale e quelli britannici in
particolare sono propensi a respingere l’at-
tinenza di Claude Lévi-Strauss con la loro
disciplina in quanto il suo lavoro «è splen-
dido, ma non è storia». Per loro l’opera di
Lévi-Strauss è a-storica o antistorica, e
bisogna ammettere che alcune sue idee si
prestano a questa interpretazione. Come
ciò che ha chiamato «il pensiero selvaggio»
e definito intemporelle, il pensiero etnolo-
gico di Lévi-Strauss si è incentrato sulle in-
variants, su «la struttura inconscia, soggia-
cente ad ogni istituzione o ad ogni usanza»1.
Anche analizzando le società del passato
come le corti giapponesi del periodo Heian
o la Francia di Luigi XIV, egli non ha stu-
diato il cambiamento nell’arco del tempo.
Da ciò derivano la definizione della sua
pratica come «antropologia strutturale» e
la sua reputazione come uno dei fondatori
dello «strutturalismo»2.
La distinzione successiva tra le società
«calde», soggette ai cambiamenti, e quelle
relativamente «fredde», su cui preferiva
concentrare la sua ricerca, consolidò l’im-
pressione che Lévi-Strauss respingesse
la storia3. Altrettanto fece la sua critica di
Sartre in Il pensiero selvaggio, del 1962,
talvolta letta come critica degli storici in
generale4.
Lévi-Strauss e il passatoNonostante questo, Lévi-Strauss era ben
lontano dal respingere il passato. Come i
linguisti, di cui considerò il lavoro come
modello del proprio, almeno per certi aspetti
importanti, apprezzava l’analisi diacronica
come quella sincronica, pur sottolineando
che anche l’analisi sincronica comportava
«un ricorso costante alla storia», in quanto
una struttura si rivelava attraverso lo stu-
dio delle sue trasformazioni5. Nella sua le-
zione inaugurale al Collège de France, egli
probabilmente sorprese alcuni ascoltatori
con quello che definì una «professione di
fede storica», dichiarando che «non la pra-
tichiamo, ma ci teniamo a riservarle i suoi
diritti»6. Nello stesso periodo, nel 1961,
egli studiò il problema della discontinui tà
culturale, osservando gli effetti dell’in-
Peter Burke
Gli usi di Lévi-Strauss
1 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, Milano, Il Saggiatore, 1964 [Paris, 1962], p. 284; Id., Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 1966 [Paris, 1958], p. 33.2 M. Lane (ed.), Structuralism: a reader, London, Cape, 1970; D. Robey (ed.) Structuralism: an introduction, Oxford, Clarendon Press, 1973; T. Hawkes, Structuralism and Semiotics, London, Methuen & C., 1977.3 G. Charbonnier, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss, Paris, Plon-Juillard, 1961. Cfr. C. Lévi-Strauss, D. Éribon, Da vicino e da lontano. Discutendo con Claude Lévi-Strauss, Milano, Rizzoli, 1988 [Paris, 1988], pp. 76-77.4 C. Lévi-Strauss, Il pensiero selvaggio, cit., pp. 267-277. Cfr. M.E. Harkin, Lévi-Strauss and History, in B. Wiseman (ed.), The Cambridge Companion to Lévi-Strauss, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, pp. 39-58.5 C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, cit., p. 34.6 Id., Le champ de l’anthropologie lezione inaugurale pronunciata al Collège de France il 5 gennaio 1960, ristampata in Id., Antropologa strutturale due, Milano, Il Saggiatore, 1978 [Paris, 1973], p. 49.
346
troduzione del cavallo in Nordamerica e
dell’ascia di metallo in Australia, elementi
che riscaldarono le culture prima fredde
degli abitanti indigeni7. Più di due decenni
dopo, nel 1983, Lévi-Strauss ritornò alla
relazione tra storia ed etnologia in un arti-
colo della famosa rivista storica «Annales»,
osservando che la frontiera tra le due disci-
pline si era spostata da quando aveva ini-
ziato a scrivere sull’argomento, e gli storici
diventavano più consapevoli della società
e della cultura8.
Soprattutto in Tristi tropici, del 1955, spesso
si può cogliere Lévi-Strauss nell’atto di pen-
sare come uno storico, per esempio quando
paragona le proprie osservazioni del Cadu-
veo con quelle dell’esploratore Guido Bog-
giani quarant’anni prima; quando osserva
come sia la disposizione dei villaggi bororo
sia le loro terrecotte cambiassero nel corso
del tempo; quando studia la data dell’arrivo
umano nel Nuovo Mondo; e quando de-
scrive l’ascesa della cultura neolitica come
«un importante evento nella vita dell’uma-
nità»9.
E poi Lévi-Strauss non respinse il lavoro
degli storici. Fece riferimento a Henri Hau-
ser, per esempio, a Lucien Febvre (si diede
un gran daffare per elogiare il suo libro su
Rabelais), a Fernand Braudel (che conobbe
alla fine degli anni Trenta quando entrambi
insegnavano all’Università di São Paulo),
al classicista Jean-Pierre Vernant, al quale
dichiarò di sentirsi vicino, e allo storico
dell’arte Erwin Panofsky, che definì «un
grande strutturalista»10.
Lévi-Strauss tra gli storici francesiA loro volta alcuni storici, prevalentemente
francesi e legati alla rivista «Annales», non
si sono limitati a fare omaggio alle conqui-
ste di Lévi-Strauss, ma hanno fatto un uso
costruttivo di alcune sue idee nelle loro
opere. Negli anni Cinquanta Braudel esa-
minò alcune di queste idee nel suo famoso
articolo su la longue durée come lingua co-
mune delle scienze sociali11. L’articolo di
Braudel è stato interpretato come critica a
Lévi-Strauss, o addirittura come difesa del
territorio dello storico contro un’invasione:
«per lui si trattava di preservare i diritti
della storia dall’avanzata della marea dello
strutturalismo di Lévi-Strauss»12. Nell’ar-
ticolo, tuttavia, Braudel cita Lévi-Strauss
come alleato, ne elogia il lavoro e fa uso di
alcune delle sue idee, pur cercando di sosti-
tuire il principio delle strutture immutabili
con quello di strutture che cambiano con
molta lentezza13.
Un nucleo di quattro studiosi di storia
dell’antica Grecia, che si conoscono bene tra
7 Id., Le problème des discontinuités culturelles, testo di una comunicazione alla Table ronde sur le premisses sociales de l’industrialisation del 1961; ristampato in Antropologia strutturale due, cit.8 Id., Histoire et ethnologie, «Annales: economies, sociétés, civilisations», 1983, 38, pp. 217-231.9 Id., Tristi tropici, Milano, Il Saggiatore, 1960 [Paris, 1955], pp. 170-171, 207, 212 e 69-77.10 C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, cit., pp. 13, 28-29, 36; C. Lévi-Strauss, D. Éribon, Da vicino e da lontano, cit. pp. 83, 109, 170-171, 174-175; C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale due, cit., p. 316.11 F. Braudel, Storia e scienze sociali. La «lunga durata» (1958), in F. Braudel, Scritti sulla storia, Milano, Mondadori, 1973 [Paris, 1969], pp. 150, 161 e 169-173; cfr. Id., Histoire et sociologie, in G. Gurvitch (sous la direction de), Traité de sociologie, Paris, Puf, 1958, pp. 184-185, 189 e 191. 12 A. Burguière, L’École des Annales: une histoire intellectuelle, Paris, Odile Jacob, 2006, p. 228.13 F. Braudel, Storia e scienze sociali, cit., pp. 150, 161, 165, 169-73, 184, 189 e 191.
347
di loro e talvolta collaborano, ha utilizzato
Lévi-Strauss in maniera particolarmente
sistematica, in particolare il suo lavoro sul
mito, evidenziando le opposizioni e le in-
versioni binarie. Lo stesso Lévi-Strauss si
era avvicinato all’antica Grecia con un in-
teressante studio breve della leggenda di
Edipo14.
Il capo del gruppo era Jean-Pierre Vernant,
ex allievo del classicista Louis Gernet (la
cui antropologia storica dell’antica Grecia
si ispirava a sua volta all’opera di Emile
Durkheim). Già nel 1960 aveva pubblicato
un’«analisi strutturale» del mito delle Quat-
tro razze del poeta Esiodo, un saggio che
non cita Lévi-Strauss ma è in debito con il
suo «studio strutturale del mito» pubblicato
cinque anni prima, per l’accento che pone
su quelli che Vernant definì i «due aspetti
opposti e complementari» del mito15. Molti
anni dopo, in un’intervista, Vernant si de-
finì uno strutturalista, ma aggiunse «il mio
è uno strutturalismo storico»16.
Anche Marcel Detienne, un collega più
giovane con cui Vernant talvolta colla-
borò, trovò l’idea del «gioco di un numero
contenuto di opposizioni» illuminante per
i suoi studi del mito dei giardini di Adone.
Lo studio successivo del mito di Dioniso da
parte di Detienne incluse una severa critica
dell’analisi di Lévi-Strauss sulla leggenda
di Edipo, in quanto ignorava la specificità
dei greci, lo stesso «contesto etnografico»
che l’antropologo aveva sottolineato nella
sua interpretazione della storia di Asdiwal
degli indiani tsimshian, utilizzando quindi
Lévi-Strauss contro se stesso17.
Gli altri due membri del gruppo non lavo-
rarono direttamente sul mito, ma trovarono
comunque utile l’enfasi di Lévi-Strauss
sulle opposizioni e le inversioni. Pierre
Vidal-Naquet si occupò dell’efebo greco, il
maschio adolescente, e della sua rappre-
sentazione come cacciatore nero, rispetto
all’oplita, il soldato adulto18. E ancora, il
saggio di François Hartog sullo storico Ero-
doto si imperniava sulla sua rappresenta-
zione dell’«altro», specialmente gli sciti, gli
egizi e i persiani, come rovescio dei greci.
Hartog osservò inoltre, in una formula par-
ticolarmente lévi-straussiana, che «rispetto
ai Persiani, gli Sciti sono come erano stati
gli Ateniesi rispetto agli stessi Persiani»19.
Gli storici francesi dei periodi successivi
hanno utilizzato Lévi-Strauss in misura
molto minore. Nel 1971, tuttavia, la rivista
«Annales» pubblicò un numero speciale su
Histoire et structure, che includeva un arti-
colo dello stesso Lévi-Strauss e un’introdu-
zione dello studioso di demografia storica
André Burguière, il quale evidenziava la
convergenza tra antropologia e storia. Jac-
14 C. Lévi-Strauss, The Structural Study of Myth, «Journal of American Folklore», 1955, 78, pp. 428-444.15 J.-P. Vernant, Le mythe hésiodique des races: essai d’analyse structurale, «Revue de l’Histoire des Re-ligions», 1960, ristampato in Id., Mito e pensiero presso i Greci. Torino, Einaudi, 1970 [Paris, 1965], pp. 15-90.16 J.-P. Vernant, La volonté de comprendre, La Tour-D’Aigues, Éd. de l’Aube, 1999, p. 56.17 M. Detienne, I giardini di Adone. I miti della seduzione erotica, Torino, Einaudi, 1975 [Paris, 1972], p. 17; Id., Dioniso e la pantera profumata, Roma-Bari, Laterza, 1981 [Paris, 1977], pp. 22-23. Cfr. J.-P. Vernant, P. Vidal-Naquet, Oedipe et ses mythes, Bruxelles, Complexe, 1988.18 P. Vidal-Naquet, Le chasseur noir et l’origine de l’éphébie athénienne, «Annales», 1968, 23, pp. 947-964.19 F. Hartog, Lo specchio di Erodoto, Milano, Il Saggiatore, 1992 [Paris, 1980], p. 63.
348
ques Le Goff ed Emmanuel Le Roy Ladurie,
che avrebbero presto interpretato entrambi
un ruolo di primo piano nell’ascesa di quella
che definirono «antropologia storica», pro-
posero analisi complementari della storia
popolare della Melusina. Le Goff accettò le
analisi di Lévi-Strauss sulla trasformazione
dei miti, ma obiettò che non si trattava del
«semplice svolgimento di un meccanismo
interno». Al contrario, «sono le risposte del
racconto alle sollecitazioni della storia»20.
Le Goff ritornò all’analisi strutturale della
narrativa in un saggio scritto con Vidal-Na-
quet in omaggio a Lévi-Strauss, imperniato
su un’immaginaria foresta medievale, Bro-
céliande, come simbolo della natura con-
trapposta alla cultura21.
Anche due membri del circolo di Le Goff,
i medievalisti Jean-Claude Schmitt e Alain
Boureau, hanno fatto uso di Lévi-Strauss di
tanto in tanto: Boureau, uno dei più audaci
storici francesi sperimentalisti, ha dedicato
un libro al «sistema narrativo» della Le-
genda Aurea – la raccolta di vite dei santi
scritta da Jacopo da Varazze nel XIII se-
colo –, trattando le leggende dei santi come
Lévi-Strauss aveva trattato la mitologia
degli indiani d’America, ovvero come una
serie di trasformazioni22.
Contrariamente a Le Goff, Le Roy Ladurie si
mantenne a distanza e, per esempio nel suo
studio della struttura di base di un racconto
popolare francese, fece più uso dell’esperto
finlandese di storie popolari Anti Aarne e
dello strutturalista russo Vladimir Propp
che di Lévi-Strauss23. In lavori successivi
come Montaillou e Le carnaval de Romans24
Le Roy Ladurie fece riferimenti occasionali
a Lévi-Strauss, ma utilizzò molto di più altri
antropologi.
Accanto allo studio dei miti e dei racconti
popolari, l’ambito degli studi storici su
cui le idee di Lévi-Strauss hanno avuto
maggior impatto è la storia della famiglia.
Come abbiamo visto, fu lo storico demo-
grafico Burguière a organizzare il numero
speciale delle «Annales», Histoire et struc-
ture. Burguière fu anche uno dei curatori
di una storia collettiva della famiglia, a
cui Lévi-Strauss contribuì con un’introdu-
zione25.
Oltre la FranciaGli storici al di fuori della Francia hanno
manifestato un interesse più contenuto per
Lévi-Strauss e per lo strutturalismo più
in generale, lasciando quest’approccio ai
professionisti di altre discipline, dall’an-
20 J. Le Goff, Mélusine au Moyen Age, «Annales Esc», 1971, 26, pp. 587-603, citazioni a p. 598.21 J. Le Goff, P. Vidal-Naquet, Lévi-Strauss en Brocéliande. Esquisse pour une analyse d’un roman courtois (Yvain de Chrétien de Troyes), «Critique», 1974, 325, numero speciale, Hommage à Lévi-Strauss, pp. 541-571.22 J.C. Schmitt, Le corps, les rites, les rêves, le temps, Paris, Gallimard, 2001, p. 69; A. Boureau, La lé gende doré e: le systè me narratif de Jacques de Voragine, Paris, Cerf, 1984.23 E. Le Roy Ladurie, Mélusine ruralisée, «Annales Esc», 26, 1971, pp. 604-616; Id., Il denaro, l’amore, la morte in Occitania, Milano, Rizzoli, 1983 [Paris, 1980].24 Id., Storia di un paese: Montaillou, Milano, Rizzoli, 1977 [Paris, 1975], e Il carnevale di Romans, Milano, Rizzoli, 1981 [Paris, 1979].25 A. Burguière (diretto da), Storia universale della famiglia, Milano, Rizzoli, 2 voll., 1987-1988 [Paris, 1986].
349
tropologia alla letteratura. La principale
eccezione a questa regola sicuramente è
rappresentata dall’erudito Carlo Ginzburg,
specialmente, ma non esclusivamente,
nella Storia notturna (1989), che attinge
all’analisi del mito di Vernant e Detienne,
ma offre anche quello che è, per quanto mi
è dato di sapere, il più serio esame critico e
utilizzo di Lévi-Strauss mai offerto da uno
storico26.
In Gran Bretagna, come ho già detto, si è
assistito a un generale rifiuto a confrontarsi
con le idee di Lévi-Strauss, fatta eccezione
per qualche raro classicista (più vicino alla
letteratura che alla storia), come Geoffrey
Kirk, il cui studio comparativo Myth (1970)
fu aspramente criticato dallo storico lette-
rario Brian Vickers27. Come altra eccezione
alla regola sono costretto a citare me stesso,
ma questa scelta mi offre almeno il vantag-
gio di poter spiegare quello che mi ha at-
tratto e come ho utilizzato ciò che ho preso
in prestito.
Nel mio Cultura popolare nell’Europa mo-
derna28, per esempio, ho preso a prestito
l’idea del bricolage da Il pensiero selvaggio,
sostenendo che è particolarmente appro-
priato per l’analisi della cultura popolare in
generale e in particolare per il genere della
parodia del Pater Noster e per altri testi cri-
stiani. Anche in questo caso ho suggerito –
senza mettere in pratica il suggerimento –
che un corpus di tradizionali ballate euro-
pee come le cosiddette Child Ballads (che
prendono il nome dal loro curatore ameri-
cano) in Gran Bretagna potrebbero essere
studiate come trasformazioni reciproche
per analogia con le trasformazioni dei miti
degli indiani d’America studiati in Mytho-
logiques. La mia analisi del carnevale e dei
riti carnevaleschi di inversione deve molto
anche allo studio di Lévi-Strauss sui sistemi
degli opposti29.
In Scene di vita quotidiana nell’Italia mo-
derna30, ho coniato il termine «cerimonieri»,
sull’analogia dei «mitemi» di Lévi-Strauss
per descrivere elementi di cerimoniale che
ricorrono in diverse combinazioni, mentre
un esame dei rituali di guarigione attinge
al suo famoso saggio sulla «efficacia simbo-
lica». Il rompicapo che cercavo di risolvere
era l’invocazione regolare a Santa Marghe-
rita nell’Italia moderna nei casi di parto
difficile. Perché scegliere proprio questa
santa? La leggenda di Santa Margherita,
diffusa nel XVI secolo, era che fosse stata di-
vorata da un drago ma fosse uscita indenne
dal suo ventre, come dovrebbe accadere al
neonato. Quello che aggiunse Lévi-Strauss
in un esame del parto tra i cuna di Panama,
era l’idea che l’espressione verbale «pro-
voca l’avvio del processo fisiologico». «Se
una leggenda di discesa agli inferi funziona
come talking cure le indiane di Cuna, perché
26 C. Ginzburg, Storia notturna, Torino, Einaudi, 1989, pp. XXXI, XXXIII-XXXVII, XLIII-XLIV, 126, 178, 181, 183, 205, 251-2, 259-61, 264, 266, 270-2, 275, 291, 294.27 G.S. Kirk, Il mito: significato e funzioni nella cultura antica e nelle culture alter, Napoli, Liguori, 1980 [Cambridge, 1970]; B. Vickers, Towards Greek Tragedy, London, Longman, 1973, pp. 173-177 e 196-199.28 Milano, Mondadori, 1980 [London, 1978].29 Ivi, pp. 174-193.30 Roma-Bari, Laterza, 1998 [Cambridge, 1987].
350
non avrebbe dovuto avere altrettanta effica-
cia per l’Italia del sedicesimo secolo?»31.
A mio avviso «Lévi-Strauss resta ancora
buono da pensarci insieme». A differenza
di Max Weber, Norbert Elias e Michel
Foucault egli si è concentrato sulle «inva-
rianti» o costanti piuttosto che invadere il
territorio degli storici. Ha fatto resistenza
a una sorta di storia, come le società da
lui studiate avevano fatto resistenza a una
sorta di cambiamento, rapido ed esogeno.
Il suo più grande valore per noi risiede
nella sfida a cui rispose Braudel (tradu-
cendo le costanti in cambiamento molto
lento) e nella sensibilizzazione degli sto-
rici a quello che Vernant ha definito «op-
posizioni, contraddizioni all’interno di un
sistema»32.
Marco Curatola-Petrocchi
Lévi-Strauss e gli studi andini
31 C. Lévi-Strauss, L’efficacité symbolique, «Revue de l’Histoire des Religions», 1949, 1, pp. 5-27; ristampato in Id. Antropologia strutturale, cit., pp. 210-230; P. Burke, Scene di vita quotidiana nell’Italia moderna, cit., p. 265.32 J.-P. Vernant, La volonté, cit., p. 57.
1 P. Wilken, Claude Lévi-Strauss. The Poet in the Laboratory, New York, The Penguin Press, 2010, pp. 139-140.
In nessuna delle sue ricerche e dei suoi
scritti Claude Lévi-Strauss si occupò speci-
ficamente del mondo andino. Eppure l’in-
flusso del suo pensiero e del suo struttura-
lismo antropologico è stato estremamente
importante e fecondo nello sviluppo degli
studi andini, soprattutto dalla metà degli
anni Sessanta alla metà degli anni Ottanta
del secolo scorso.
Nell’opera di Lévi-Strauss i riferimenti agli
incas, e più in generale alle culture andine,
sono quanto mai sporadici e concisi, ancor-
ché tutt’altro che estemporanei. Di fatto, lo
studioso dovette acquisire una certa fami-
liarità con la letteratura relativa alla storia
e alla cultura dei popoli andini durante
l’esilio negli Stati Uniti, dove si rifugiò nel
1941, per sfuggire alla persecuzione nazi-
sta degli ebrei, avviata tanto nella Francia
occupata dalla Wehrmacht come in quella
del governo collaborazionista filo-tedesco
di Vichy. Alla New School of Social Rese-
arch di New York, dove venne chiamato
a insegnare grazie alla segnalazione di
due eminenti americanisti come Robert
H. Lowie ed Alfred Métraux, Lévi-Strauss
tenne lezioni di sociologia contemporanea
del Sud America, analizzando la realtà di
paesi come il Perù e la Bolivia. E più tardi,
all’École Libre des Hautes Etudes, fondata
nel 1942 a New York sotto gli auspici del
governo della France libre del generale De
Gaulle e del governo belga in esilio, tenne,
tra gli altri, un corso dal titolo Il primo stato
totalitario: gli incas1. In quegli stessi anni
strinse una fraterna amicizia con Métraux
(1902-1963), etnologo di origine svizzera
che aveva condotto importanti ricerche
351
sull’altopiano boliviano e che qualche
anno più tardi avrebbe pubblicato un pre-
gevole libro di divulgazione sugli incas.
All’epoca, quest’ultimo lavorava al Bureau
of American Ethnology della Smithsonian
Institution di Washington, impegnato nella
preparazione dell’Handbook of South Ame-
rican Indians, monumentale opera in vari
volumi alla quale ben presto chiamò a
collaborare lo stesso Léví-Strauss con una
serie di articoli sulle culture indigene del
Brasile2. Il sodalizio tra i due studiosi fu
tale che Métraux, quando si recava a New
York, era solito farsi ospitare nel piccolo
appartamento dell’amico al Greenwich Vil-
lage. Così non è difficile immaginare che
Métraux abbia potuto rappresentare per
Lévi-Strauss, nella preparazione delle sue
lezioni, una preziosa fonte di informazioni
ed indicazioni bibliografiche sulle antiche
culture e i moderni popoli delle Ande.
La proibizione dell’incestoNe Les structures élementaires de la parenté3,
il libro che Lévi-Strauss scrisse durante gli
anni negli Stati Uniti e presentò al suo ri-
torno in Francia come tesi di dottorato alla
Sorbona (1948), i riferimenti all’antico Perù
sono scarsi, ma quanto mai puntuali. La
prima menzione la si incontra nelle pagine
in cui l’autore presenta la sua famosa teo-
ria, per lo più accettata senza obiezioni di
fondo, relativa alla proibizione dell’incesto.
Secondo Lévi-Strauss, questa rappresen-
terebbe l’unica norma sociale di carattere
realmente universale, ossia comune a tutte
le culture di tutti i tempi. Nel rendere obbli-
gatoria la ricerca di partner matrimoniali
al di fuori della ristretta cerchia familiare,
essa avrebbe infatti creato la necessità per
l’intercambio, la comunicazione e la reci-
procità fra i diversi gruppi, dando origine
alla formazione della vita sociale ed assicu-
rando le condizioni minime ed essenziali
per il suo sviluppo. In definitiva, sarebbe
stato il «tabù» dell’incesto a segnare il pas-
saggio dell’umanità dallo stato di natura
a quello di cultura, e sarebbe sempre tale
proibizione a garantire e rinnovare costan-
temente i fondamenti della dinamica so-
ciale. Quanto alle apparenti eccezioni alla
universalità della norma, come quelle rap-
presentate dai casi delle antiche monarchie
del Perù, dell’Egitto e delle Hawaii, il cui so-
vrano poteva, o meglio doveva prendere in
sposa una sorella, Lévi-Strauss tenta di spie-
garle, e in qualche modo invalidarle, addu-
cendo la grande variabilità da una cultura
all’altra delle categorie di parenti con cui
può essere proibito il matrimonio. «Il pro-
blema non è dunque di sapere – scrive – se
esistono gruppi che permettano matrimoni
che sono invece esclusi da altri gruppi, ma
invece è di sapere se ci sono dei gruppi
presso i quali nessun tipo di matrimonio sia
proibito. La risposta deve essere allora as-
solutamente negativa, e a doppio titolo: in-
nanzitutto, perché il matrimonio non è mai
autorizzato tra tutti i parenti prossimi, ma
soltanto all’interno di certe categorie (sorel-
2 Lévi-Strauss contribuì al terzo volume: The Tropical Forest Tribes (Washington, Smithsonian Institution, 1948) dell’Hsai, con gli articoli The Tupí-Cawahíb, Tribes of Upper Xingú River, The Nambicuara e Tribes of the Right Bank of the Guaporé River, e al quinto volume: Physical Anthropology, Linguistics and Cultural Geography of South American Indians (1950) con The Use of Wild Plants in Tropical South America.3 C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli, 1969 [Paris, 1947].
352
lastra a esclusione della sorella, sorella ad
esclusione della madre, ecc.); inoltre per-
ché queste unioni consanguinee hanno o
un carattere temporaneo e rituale, o invece
un carattere ufficiale e permanente, ma in
quest’ultimo caso restano privilegio di una
categoria sociale molto ristretta»4. Sebbene
logica, e in ultima istanza fondamental-
mente corretta, l’argomentazione di Lévi-
Strauss, per lo meno nella forma in cui è
espressa, appare invero stiracchiata e poco
convincente, soprattutto perché non arriva
a fornire una spiegazione chiara e coerente
del perché in alcune società si sia arrivato
a concedere a determinati individui, ancor-
ché appartenenti a una cerchia assoluta-
mente ristretta, quello che per tutti gli altri
membri della medesima società è conside-
rato come qualcosa di abominevole, immo-
rale, pregiudizievole per l’ordine collettivo
e passibile delle pene più severe. Nondi-
meno, la pratica di contrarre matrimonio
con una consanguinea di primo grado ri-
sulta pienamente intellegibile, per lo meno
nel caso del sovrano degli incas, proprio
assumendo come valida e, in un certo qual
modo, «veridica» la spiegazione antropolo-
gica della proibizione dell’incesto avanzata
da Lévi-Strauss.
Gli incas furono un gruppo etnico di circa
quarantamila individui, stanziato nella
valle del Cuzco, che tra il XV secolo e gli
inizi del XVI, arrivò a esercitare la propria
egemonia sugli oltre dieci milioni di indi-
vidui, divisi in decine e decine di differenti
gruppi etnici, che popolavano le Ande
dall’Ecuador settentrionale al Cile cen-
trale. Al vertice di tale vasto impero stava
il re degli incas, il Sapa Inca [l’Unico Inca],
chiamato anche Intip Churin [Figlio del
Sole]. Secondo le tradizioni inca, sarebbe
stato Pachacuti, il fondatore dell’impero,
a istituire la pratica del matrimonio del
sovrano con una sorella, dando in sposa
una delle sue figlie a suo figlio Tupa Yu-
panqui, nella cerimonia in cui lo nominò
suo successore5. Da allora in poi, la moglie
principale del Sapa Inca, la Coya [Regina],
venne invariabilmente scelta tra una delle
sue sorelle, vale a dire nell’ambito di quello
che Tom Zuidema, nella sua ricostruzione
del sistema di parentela inca, segnala come
il «grado zero»6. E la pratica venne mante-
nuta persino dopo la caduta dell’impero,
tra gli incas che si rifugiarono nella imper-
via regione di Vilcabamba, a nord-est del
Cuzco, dove per vari decenni, fino al 1572,
opposero un’ostinata resistenza alla domi-
nazione spagnola. Sayri Tupa, pronipote
di Tupa Yupanqui e secondo sovrano del
piccolo stato neo-inca di Vilcabamba, non
solo seguì l’antica usanza imperiale inca di
prendere in moglie a sua sorella Cusi Huar-
cay, ma addirittura ottenne, tra i numerosi
benefici e privilegi ottenuti in cambio della
personale sottomissione alle autorità colo-
niali, che la sua unione fosse riconosciuta
e convalidata dalla stessa chiesa cattolica.
Su richiesta del viceré del Perù e del re di
Spagna gli venne infatti elargita dal papa
4 C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 47-48.5 J. de Betanzos, Suma y narración de los Incas (1551), Madrid, Polifemo, 2004, pp. 165-166 (parte I, cap. XXVI).6 R.T. Zuidema, El sistema de parentesco incaico: una nueva visión teórica, in E. Mayer, R. Bolton (editores), Parentesco y matrimonio en los Andes, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1980, pp. 57-113.
353
Giulio III una speciale dispensa per poter
contrarre matrimonio cristiano con la so-
rella. La cerimonia nuziale fu celebrata,
nel 1558, dal vescovo del Cuzco Juan de
Solano, e venne immortalata dal cronista
andino Felipe Guaman Poma de Ayala, in
una illustrazione della sua Nueva corónica
y buen gobierno (1615)7. Nella medesima
opera, si narra come la prima – mitica –
coppia fondatrice del Cuzco e della dinastia
reale inca fosse costituita da una donna do-
tata di grandi poteri magici, di nome Mama
Huaco, figlia del Sole e della Luna, e dal di
lei figlio, Manco Capac8. Un connubio, que-
sto, se è possibile ancor più incestuoso di
quello descritto nel mito di fondazione inca
riportato dalla maggior parte degli altri
cronisti, secondo cui Manco Capac e Mama
Huaco (o Mama Ocllo) sarebbero stati fra-
tello e sorella9.
Per lo meno in apparenza, il matrimonio
fra fratelli (così come la originaria unione
mitica madre-figlio) degli imperatori inca
contrasta grandemente con la morale an-
dina tradizionale che condanna le relazioni
incestuose, soprattutto quelle fra consangui-
nei di primo grado, come il peccato nefando
per eccellenza. Di fatto, tra le popolazioni
di lingua quechua della sierra peruviana è
tuttora molto diffusa la credenza che esse
attraggano le più gravi calamità all’intera
comunità e che gli incestuosi siano desti-
nati a trasformarsi in qarqachas, termine
col quale si indicano malefici lama e altre
immaginarie bestie «demoniache» che va-
gano nella notte emettendo terrificanti urli
e attaccando chiunque passi loro vicino10.
In definitiva, nel sistema di credenze e rap-
presentazioni collettive andine, la persona
che non rispetta la proibizione dell’incesto
perde la condizione stessa di essere umano,
per divenire un animale, un mostro, una
bestia pericolosa per l’intera collettività.
Ma, questa concezione andina (e presunta
universale) dell’incesto, come si concilia
culturalmente e storicamente con la pratica
del matrimonio dell’imperatore inca con
una delle sue sorelle? Quale può mai essere
il denominatore comune fra l’immonda fi-
gura della qarqacha e il sublime, augusto ed
idillico connubio fra il Sapa Inca e la Coya,
qual è in modo esemplare rappresentato in
una splendida tavola a colori, della mano
di Guaman Poma, che illustra la cronaca di
fra’ Martín de Murúa (1590)?11 Semplice-
mente, che tanto l’una come l’altro evocano
esseri che si collocano al di fuori della so-
cietà degli uomini: nel caso della qarqacha,
al di sotto di essa, nel sub-umano; nel caso
dei sovrani inca, al di sopra, nell’empireo,
vicino al padre Sole. Col loro matrimonio
incestuoso, che va scientemente oltre ogni
7 J. Hemming, La fine degli Incas, Milano, Rizzoli, 1975 [London, 1970], p. 285; F. Guaman Poma de Ayala, El primer nueva corónica y buen gobierno (1615), México, D.F., 1980, vol. II, p. 411 (f. 444).8 F. Guaman Poma de Ayala, El primer nueva corónica, cit., 1980, Vol. I., p. 99 (f. 120).9 Vedasi, ad esempio, P. Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas (1572), Madrid, Miraguano/Polifemo, 2001, p. 51-61 (capp. XI-XIII), e Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas (1609), Lima, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 47-48 (Lib. I, cap. XVIII).10 R. Cavero Carrasco, Incesto en los Andes. Las «llamas demoníacas» como castigo sobrenatural, Ayacucho, Wari, 1990.11 M. de Murúa, Historia del origen, y genealogía real de los Reyes ingas del Piru (1590), Códice Galvin, Madrid, Testimonio, 2004 (edizione facsimilare), tra i fogli 81 e 82.
354
limite morale e sociale ammissibile per i
mortali, i Figli del dio Sole non fanno che
riaffermare in modo categorico di fronte al
mondo la loro natura completamente di-
versa, extra e sovra-umana, divina. E, nel
contempo, così facendo, rendono palese
la concezione andina (e universale) che
considera l’osservanza della proibizione
dell’incesto come la condizione che san-
cisce e definisce l’appartenenza al genere
umano. Il caso dell’unione fratello-sorella
degli imperatori inca – così come, probabil-
mente, quelli dei sovrani dell’antico Egitto,
delle Hawaii e di altre monarchie divine di
società antiche e di culture tradizionali –
rappresenta dunque a tutti gli effetti l’ecce-
zione che conferma la regola: non solo non
invalida la teoria di Lévi-Strauss relativa
all’importanza primordiale e all’univer-
salità della proibizione dell’incesto, ma la
comprova appieno.
Organizzazioni dualistiche e vita socialeUna seconda menzione delle culture an-
dine ne Les structures élementaires de la
parenté la si incontra nel capitolo sesto, de-
dicato alle organizzazioni dualistiche, cioè
alle formazioni sociali che si presentano
divise in forma molto netta in due parti, o
metà, opposte e complementari, in quanto
le loro relazioni sono improntate tanto alla
rivalità che alla cooperazione. Per Lévi-
Strauss questi sistemi non sarebbero altro
che l’espressione più schietta, la codifica-
zione più diretta di un universale principio
di reciprocità, alla base di ogni forma di vita
sociale. Tale principio, originariamente at-
tivato proprio dalla proibizione dell’ince-
sto, presuppone e impone infatti l’esistenza
di almeno due gruppi sociali separati, ma
al tempo stesso in continua comunicazione
fra loro per gli scambi matrimoniali e per
una serie di altre prestazioni e contro-pre-
stazioni di ordine economico e cerimoniale.
Inoltre, Lévi-Strauss osserva come sovente
la dualità non si limiti alla sola sfera sociale,
ma «si prolunghi» in una organizzazione
e classificazione binaria di tutti gli esseri
e le cose dell’universo. E, nell’elencare le
diverse società storiche e tradizionali pa-
lesemente strutturate in forma dualistica,
ricorda di sfuggita come nelle cronache del
XVI secolo si incontrino allusioni a questo
tipo di organizzazione in seno alle alte cul-
ture americane, comprese quelle andine.
Per poi riprendere il discorso più avanti,
nel capitolo ventesimo, in cui analizza l’an-
tico sistema cinese di parentela e la parti-
colare disposizione (ordine tchao mou)
delle tavolette che rappresentavano gli an-
tenati all’interno dei templi gentilizi della
Cina feudale. Nelle considerazioni finali di
detto capitolo, Lévi-Strauss prospetta l’esi-
stenza di una forte analogia strutturale tra
gli elaborati rituali funebri degli imperatori
cinesi e il culto dei corpi mummificati dei
sovrani inca. Al riguardo, citando il cro-
nista Inca Garcilaso de la Vega12, ricorda
come questi ultimi all’interno del grande
tempio del Sole del Cuzco stavano dispo-
sti in rigoroso ordine dinastico ai due lati
dell’immagine del dio. E, quindi, riporta
testualmente due passi-chiave de la Rela-
12 I. Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas (1609), Lima, Fondo de Cultura Económica, 1991, t. I, p. 190 (Lib. III, cap. XX).
355
ción (1575) de Cristóbal de Molina, da cui
si evince con chiarezza la netta divisione
sociale e cerimoniale vigente tra i lignaggi
di Hanan [Alto] e Urin [Basso] Cuzco13. Ma
Lévi-Strauss non si limita semplicemente
a sottolineare che gli Inca dovettero posse-
dere una organizzazione dualistica. Osser-
vando che un segmento del Capac-Ñan, la
grande strada imperiale inca, tagliava per-
pendicolarmente l’asse divisorio fra la metá
Hanan e quella Urin della città, giunge alla
conclusione che l’organizzazione sociale e
politica del Cuzco dovette caratterizzarsi
per «una duplice dicotomia», con tutta la
maggiore complessità di interazioni socio-
politiche che una struttura quadripartita di
questo tipo comporta.
Successivamente, Lévi-Strauss pubblicava
tre importanti articoli (poi raccolti in An-
thropologie structurale)14 volti ad appro-
fondire lo studio della società dualiste. In
La notion de arcaïsme en ethnologie (1952)
riproponeva l’analogia fra rituali funebri
inca e quelli dell’antica Cina, ma soprat-
tutto si preoccupava di porre in evidenza
l’esistenza in Sudamerica di una vasta
area – non necessariamente continua –
con organizzazioni dualistiche, che andava
dagli altipiani andini alle savane e foreste
tropicali, accomunando i più differenti tipi
di società, da quelle apparentemente più
semplici di cacciatori-raccoglitori, come i
piccoli gruppi bororo del Mato Grosso, nel
Brasile orientale, alle grandi civiltà preco-
lombiane del Perù e della Bolivia, come la
Inca e la Tiahuanaco. E proprio l’analisi
del dualismo dei bororo – da Lévi-Strauss
studiati sul terreno verso la metà degli anni
Trenta – con i loro villaggi divisi in due metà
esogamiche, ciascuna delle quali composta
di quattro clan matrilineari, a loro volta
divisi in tre sezioni (una «superiore», una
media e una «inferiore»), costituì il fulcro, il
leitmotiv degli altri due articoli: Les structu-
res sociales dans le Brésil centarl et oriental,
del 1952, nel quale si mostra come il dua-
lismo e la simmetria apparentemente per-
fetti di queste popolazioni in qualche modo
celassero e interagissero con un livello
più profondo di organizzazione tripartita e
asimmetrica, e il celeberrimo Les organisa-
tions dualists existent-elles?, del 1956, in cui
l’autore perviene alla conclusione che la
struttura binaria doveva servire fondamen-
talmente a definire i gruppi, mentre quella
ternaria avrebbe avuto la funzione di rego-
lare le relazioni fra loro.
Nonostante in questi ultimi due lavori non
si faccia la minima allusione alle società
della cordigliera, di fatto essi ebbero un pro-
fondo impatto nel campo degli studi andini,
per l’influenza diretta che esercitarono sulle
ricerche di Reiner Tom Zuidema, un bril-
lante antropologo olandese della cosiddetta
scuola strutturalista di Leiden15. Nel 1964
Zuidema pubblicò The Cheque System of
Cuzco, la sua tesi di dottorato nella quale,
rifacendosi esplicitamente all’analisi levi-
13 C. de Molina, Relaciòn de las fábulas y ritos de los Incas (1575), Lima, Universidad de San Martín de Porres, 2008, pp. 51-52, 105. 14 Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 1966 [Paris, 1958].15 Cfr. G. Urton, R.T. Zuidema, Dutch Structuralism, and the Application of the «Leiden Orientation», in Structure, Knowledge and Representation in the Andes: Studies Presented to Reiner Tom Zuidema on the Occasion of His 70th Birthday, «Journal of the Steward Anthropological Society», 1996, 1-2.
356
straussiana dei villaggi bororo16, prendeva
in esame il sistema inca di linee immagi-
narie (chiamate ceques), che dipartivano a
raggiera dal centro della capitale imperiale
e lungo le quali di trovavano innumerevoli
santuari (huacas). In tale studio, attraverso
la disamina dei più vari dati offerti dalle
cronache e altre fonti del XVI e XVII sec.,
l’autore arrivò a mostrare come la strut-
tura socio-politica-territoriale degli abitanti
del Cuzco fosse fondata su una sofisticata
articolazione di tre principi organizzativi,
o «rappresentazioni»: dualismo-quadri-
partizione, tripartizione, e ripartizione per
cinque e per dieci. Il libro non solo fu la
prima monografia in cui il metodo struttu-
rale venne applicato in forma sistematica e
onnicomprensiva allo studio di una società
altamente complessa, e per di più del pas-
sato (quindi fondamentalmente sulla base
di documentazione storica piuttosto che
etnografica)17, ma per l’originalità dell’im-
postazione e per le nuove prospettive che
aprì nello specifico campo di ricerca, rap-
presentò una vera e propria pietra miliare
nello sviluppo dell’etnostoria e l’antropo-
logia andina. Successivamente, attraverso
una serie di approfondimenti, variazioni e
sviluppi delle tematiche e i problemi solle-
vati nella sua tesi18, Zuidema è pervenuto a
dimostrare come il sistema incaico dei ce-
ques, con la sua complessa combinazione di
differenti principi organizzativi, costituisse
in ultima istanza un sofisticato sistema ope-
razionale polivalente di rappresentazioni,
in grado di far coincidere i differenti piani
dell’esperienza e della realtà, dall’organiz-
zazione socio-politica a quella dello spazio,
dall’astronomia e il calendario al ciclo delle
attività economiche e cerimoniali, dalla
cosmologia alle manifestazioni artistiche,
in una grandiosa operazione di raziona-
lizzazione ed organizzazione dell’universo
culturale e naturale che per dimensioni e
complessità probabilmente non ha uguali
in nessun’altra civiltà antica della storia.
Anche se il fulcro degli interessi di Zuidema
è stato in ogni momento l’impero inca e le
sue indagini hanno avuto un carattere emi-
nentemente (etno)storico, consistendo per
lo più in una lettura antropologica di do-
cumenti coloniali, nondimeno questo stu-
dioso – nell’Università di Huamanga (Aya-
cucho), dove insegnò intorno alla metà degli
anni Sessanta, e quindi in quella di Illinois
(Urbana) – promosse tra i suoi alunni ricer-
16 Nella prefazione del libro, P.E. de Josselin de Jong, direttore della tesi, osservava: «Apparirá chiaramente come l’uso fatto da Zuidema del sistema dei ceque e dei testi mitici pseudostorici, come di guide alla com-prensione dei concetti inca, delle «rappresentazioni» inca della loro struttura sociale, sia debitore verso l’articolo di Lévi-Strauss Les organisations dualistes existent-elles? (1956) e verso Anthropologie structurale (1958)» (in R.T. Zuidema, Etnología e storia, Cuzco e le strutture dell’Impero Inca, Torino, Einaudi, 1971, p. XXX). E lo stesso Zuidema, molti anni dopo, nell’Ensayo preliminar scritto per l’edizione in lingua spa-gnola dell’opera, riconosceva senza mezzi termini: «Trovai le mie fonti di ispirazione nelle culture Ge del Brasile, negli articoli che poi Lévi-Strauss (1958) aveva dedicato a quelle culture » (R.T Zuidema, El sistema de ceques del Cuzco, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995, p. 25).17 N. Wachtel, Sociedad e ideología. Ensayos de historia y antropología andinas, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1973, p. 24.18 Vedasi in particolare La civilisation inca au Cuzco, Paris, Presses Universitaires de France, 1986; Reyes y guerreros. Ensayos de cultura andina, Lima, Fomciencias, 1989, e El calendario inca, Lima, Congreso de la República del Perù/Pontificia Universidad Católica del Perú, in corso di stampa.
357
che sul terreno che portarono al riscontro
della piena vigenza di principi dualistici a
tutti i livelli dell’organizzazione sociale e
rituale di molte comunità andine della se-
conda metà del XX secolo, e alla pubblica-
zione di una serie di importanti monografie
etnografiche19.
Lo strutturalismo e gli studi andiniMa l’approccio strutturalista, con la sua en-
fasi sugli aspetti più profondi, stabili e du-
raturi della vita socio-culturale, non poteva
non risultare particolarmente attraente per
un folto gruppo di intellettuali peruviani for-
matisi sotto l’influenza della corrente indi-
genista, il cui più eminente rappresentante,
Luis E. Valcárcel (1891-1987), propugnava
con forza l’idea che gli andini, nonostante
secoli di colonialismo e di oppressione,
erano riusciti a conservare praticamente
intatti i fondamenti della cultura dei loro
avi incas. E lo stesso dicasi per vari etnologi
europei, ad un tempo à la page (strutturali-
sta) e alla romantica ricerca dei «caratteri
originali» della cultura andina, in un’epoca
in cui i processi di modernizzazione e di
incipiente globalizzazione stavano trasfor-
mando radicalmente il loro tradizionale
oggetto di studio, come peraltro ben colto
dallo stesso Lévi-Strauss, con riferimento
alle culture indigene del Brasile, in alcune
delle più struggenti pagine di Tristes Tro-
piques20. Lo strutturalismo, anche se talora
compreso in modo superficiale ed appli-
cato in forma meccanica e riduttiva, offrì
agli uni e agli altri un orizzonte cognitivo
e un indirizzo metodologico pienamente
rispondenti alle loro esigenze e alle loro
rispettive ideologie, dando luogo sovente a
risultati di notevole valore euristico. Fra gli
antropologi peruviani, possiamo ricordare
Juan Ossio, che condusse un pionieristico
e illuminante studio sulle categorie andine
relative al tempo e allo spazio (dualismo,
quadripartizione, ripartizione per cinque)
plasmate nella menzionata cronaca illu-
strata (1615) di Guaman Poma21, e che
nella sua tesi di dottorato sulla parentela
nella comunità di Andamarca (Ayacu-
cho)22 prospettò in forma convincente la
coesistenza nei rituali della festa dell’acqua
dei due tipi di dualismo, il diametrale e il
concentrico, evidenziati da Lévi-Strauss in
Les organisations dualists existent-elles?23.
Vanno inoltre menzionati Alejando Ortiz
19 Si vedano, per esempio, U. Quispe M, La herranza en Choque Huarcaya y Hancasancos, Ayacucho, Lima, Ministerio de Trabajo, 1969; S Palomino Flores, La dualidad en la organización socio-cultural de algunos pueblos del área andina, «Revista del Museo Nacional», XXVII, 1971, pp. 232-260; El sistema de oposiciones en la comunidad de Sarhua, Ayacucho, Pueblo Indio, 1984; B.J. Isbell, To Defend Ourselves, Ecology and Ritual in An Andean Village, Austin, The University of Texas at Austin, 1978; G. Urton, At the Crossroads of the Earth and the Sky. An Andean Cosmology, Austin, University of Texas Press, 1981. Tutte pubblicazioni, queste, derivate da tesi dirette da R.T. Zuidema.20 C. Lévi-Strauss, Tristi tropici, Milano, Il Saggiatore, 1960 [Paris, 1955].21 J.M. Ossio A, The Idea of History in Felipe Guaman Poma de Ayala, tesi di Bachelor Litterae, University of Oxford, 1970, e En busca del orden perdido. La idea de la Historia en Felipe Guaman Poma de Ayala, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008.22 J.M. Ossio Acuña, Parentesco, reciprocidad y jerarquía en los Andes. Una aproximación a la organización social de la comunidad de Andamarca, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1992.23 C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, Milano, Il Saggiatore, 1971, pp. 172-173.
358
Rescaniere, che, analizzando il sistema di
opposizioni complementari presente nei
miti i antichi e moderni della sierra pe-
ruviana, mostrò – come ebbe a scrivere
Pierre Duviols nell’introduzione al suo
De Adaneva a Inkarrí – «la profonda unità
storica e spaziale della cultura andina»24, e
Raúl León Caparó, le cui ricerche in una
comunità vicino a Paucartambo (Cuzco)
agli inizi degli anni Settanta del secolo
scorso misero in luce l’esistenza in loco di
un’organizzazione spaziale, connessa a ad
uno sfruttamento ottimale delle differenti
risorse agricole offerte dal territorio, con
molti punti in comune con il sistema dei
ceques del Cuzco25. E fra i vari andinisti
europei che produssero significativi studi
di orientamento strutturalista spiccano i
nomi di Nathan Wachtel e Tristan Platt.
Wachtel, in due articoli palesemente ispi-
rati sin dal titolo ai lavori di Lévi-Strauss26
e in seguito rifusi in quella specie di grande
compendio e manifesto dell’etnostoria an-
dina che rappresentò il suo La vision des
vaincus (1971), si propose, da un lato, di
chiarire la complessa ricostruzione di
Zuidema dell’organizzazione del Cuzco –
suggerendo, fra l’altro, che tra gli incas la
dualità e la tripartizione dovettero servire
a regolare soprattutto le relazioni di paren-
tela, improntate alla reciprocità, mentre la
divisione decimale dovette fornire la gri-
glia di riferimento dell’amministrazione
statale, che operava secondo il principio
della redistribuzione27 – e, dall’altro, di
precisare, riprendendo l’analisi di Ossio
delle categorie del tempo e dello spazio
espresse dalla Nueva Corónica, i principi
classificatori e la logica stessa del pensiero
«selvaggio» (andino). Quanto a Platt, le sue
ricerche sull’universo rituale e simbolico
dei Macha della Bolivia lo portarono all’in-
dividuazione della nozione di yanantin, un
termine dotato di una certa ambiguità, con
il quale gli Aymara esprimono il concetto
di una coppia ideale di elementi (uomini,
animali o cose) al tempo stesso opposti,
simmetrici, speculari e complementari,
associandolo con rappresentazioni di ca-
rattere geometrico-ortogonale, secondo
quella che Lévi-Strauss in Du miel aux cen-
dres (1966) chiamò con molta giustezza la
«logica delle forme», distinta dalla «logica
delle qualità»28. Dentro di questa logica
delle forme, Platt mostra come il yanantin
con il suo geometrismo ortogonale dina-
mico debba essere considerato la rappre-
sentazione primordiale, la matrice stessa
della dualità e delle altre ripartizioni (o
rappresentazioni) impiegate in forma si-
stematica dagli andini per organizzare co-
gnitivamente e concretamente ogni aspetto
24 A. Ortiz Rescaniere, De Adaneva a Inkarrí. Una visión indígena del Perú, Lima, Retablo de Papel, 1973, p. XII. Dello stesso autore si veda anche Huarochiri, 400 años después, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1980.25 R. León Caparó, Racionalidad andina en el uso del espacio, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú-Banco Central de Reserva del Perú, 1994.26 N. Wachtel, Structuralisme et histoire: à propos de l’organisation sociale de Cuzco, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 1966, 1, pp. 71-94, e Pensée sauvage at acculturation: l’espace e le temps chez Felipe Guaman Poma de Ayala et l’Inca Garcilaso de la Vega, ivi, 1971, 3-4, pp. 793-840.27 N. Wachtel, La vision des vaincus. Les Indiens du Pérou devant la Conquête españole, Paris, Gallimard, 1971, p. 122.28 C. Lévi-Strauss, Dal miele alle ceneri, Milano, Il Saggiatore, 1970, pp. 315-317.
359
del loro mondo naturale e del loro universo
sociale29.
Quelli che ho appena menzionato sono
solo alcuni dei molti ed importanti studi
storici ed etnografici relativi alle società
andine del passato e del presente realizzati
sulla base dei paradigmi proposti da Lévi-
Strauss. L’elenco certamente potrebbe (e
dovrebbe) essere molto più lungo. Ma,
in tutti i modi, credo che essi siano suffi-
cienti per dare un’idea dell’apporto che
lo strutturalismo antropologico ha dato
alla conoscenza del mondo andino an-
tico e tradizionale. Anche se, nel campo
dell’antropologia andina, le suggestioni
levistraussiane si sono andate negli ultimi
due decenni decisamente affievolendo, per
cedere il passo – come peraltro era logico
che fosse – a nuovi approcci e prospettive
teorico-metodologiche, e i lavori etnostorici
si sono fatti sempre più storici e meno an-
tropologici, privilegiando la discontinuità,
l’événementiel e la ricostruzione delle mille
caleidoscopiche sfumature della realtà,
nondimeno le conoscenze sulla «cultura
andina» e i suoi caratteri originali acquisite
attraverso le ricerche impostate secondo
criteri strutturali permangono come un so-
lido patrimonio tanto del sapere antropolo-
gico che dell’identità locale, regionale e na-
zionale degli abitanti dei vari paesi andini.
Ma non solo. Silenziosamente, in anni re-
centi, l’analisi strutturale è rifiorita in uno
specifico campo disciplinare degli studi
andini, che in precedenza l’aveva semi-
ignorata: quello dell’archeologia, e in par-
ticolare l’archeologia inca. Concetti come
dualità, quadripartizione, ripartizione per
cinque e per dieci hanno vissuto un vero
e proprio revival, essendo stati ripresi in-
tegralmente da molti archeologi per inter-
pretare siti e monumenti inca, le relazioni
tra gli edifici, il loro orientamento spaziale
ed astronomico, i processi e le modalità di
costruzione, la forma delle strutture archi-
tettoniche, la loro decorazione, e la fun-
zione sociale e cerimoniale degli spazi.
In uno scritto apparso nel 1976 su
«L’Homme» (rivista fondata dallo stesso
Lévi-Strauss) in risposta alle aspre criti-
che mosse all’analisi strutturale (dei miti)
da Marvin Harris in un articolo pubblicato
nello stesso numero della rivista, Lévi-
Strauss dopo aver ribattuto una dopo l’altra
le argomentazioni del collega americano,
concludeva, precisando con certa mode-
stia, ma anche con grande consapevo-
lezza: «L’analisi strutturale non pretende
di rispondere a tutte le domande. Le sue
ambizioni restano discrete: individuare e
circoscrivere i problemi, disporli in ordine
metodico, risolverne forse alcuni, ma so-
prattutto suggerire ai ricercatori la via che
potranno utilmente seguire se intendono
cimentarsi con la gran massa di quelli che
sono in sospeso e che tali rimarranno senza
dubbio a lungo»30. Alla luce di quanto sono
venuto esponendo fin qui, la posizione di
Lévi-Strauss mi sembra ampiamente giu-
stificata.
29 T. Platt, Espejos y maís, Temas de la estructura simbólica andina, La Paz, Centro de Investigación y Pro-moción del Campesinado, 1976. Si veda anche Symétries en miroir. Le concept de yanantin chez les Macha de Bolivie, «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», 1978, 5-6, pp. 1081-1105.30 C. Lévi-Strauss, Structuralisme et empirisme, «L’Homme», 1976, 2-3, p. 37; Lo sguardo da lontano. Antro-pologia, cultura, scienza raffronto,Torino, Einaudi, 1984, p. 165.
360
Forse più di ogni altro nostro pensatore
Claude Lévi-Strauss ha svolto un’intensa
indagine sulle capacità e sulle tendenze
originali degli esseri umani, in base al prin-
cipio antropologico che tutti i casi dell’uma-
nità contano, indipendentemente da quanto
possano essere o apparire «altri». Nella sua
opera, Lévi-Strauss respinse ripetutamente
l’esclusione della differenza dall’umanità e
la sua scomposizione (equivalente a que-
sta esclusione) in popolazioni alle quali
è stato concesso uno stato universale e in
altre ridotte allo stato di fenomeno da ba-
raccone ed etichettate come «esotiche», «ar-
caiche» o «devianti». Questa scomposizione
dell’umanità, ci ha insegnato Lévi-Strauss,
normalizza il pensiero e le abitudini dei
privilegiati («il normale adulto bianco») e,
allo stesso tempo, depaupera la nostra com-
prensione di «umanità»1.
Ma che cosa ha appreso Lévi-Strauss dalla
sua intensa indagine sul genere umano,
svolta su questa base solidamente antropo-
logica? Innanzitutto questo: gli esseri umani
non lasciano mai perdere. Gli uomini, in al-
tre parole, prendono quello che accade per
caso o per necessità (le due manifestazioni
della natura) e poi sostituiscono al primo e
aggiungono alla seconda qualche schema
oppure un ordine, sempre in base a una re-
gola creata o inventata. Queste regole sono,
fin da subito, notevolmente più deboli delle
leggi della natura, in quanto prive di potere
di determinazione, e anche notevolmente
più ricche in quanto creano significati. Da ciò
deriva il fatto che, come esseri umani, noi vi-
viamo – per prendere a prestito l’espressione
di Clifford Geertz – «in reti di senso» create
da noi2. Attingendo a Lévi-Strauss, possiamo
aggiungere che un altro aspetto o manifesta-
zione dell’universale propensione umana a
«non lasciar perdere mai» è che gli uomini
non si accontentano di lasciarsi in pace l’uno
con l’altro; al contrario, si spingono insisten-
temente a vicenda nella vita sociale, non
come mezzo per raggiungere un fine pratico,
ma per la società stessa, anche se la trovano
a tratti nociva»3. In altri termini, insieme con
Daniel A. Segal
Sempre fedele al genere umano
1 La citazione tra parentesi è tratta dalle pagine d’inizio di Le totémisme aujourd’hui. Lévi-Strauss scrive: «Per mantenere nella loro integrità e fondare allo stesso tempo le modalità di pensiero dell’uomo nor-male, bianco e adulto, niente sarebbe stato quindi più comodo della raccolta esterna dei costumi e delle credenze.. intorno ai quali si sarebbero cristallizzate, in una massa inerte, delle idee che sarebbero state meno inoffensive se fosse stato necessario riconoscerne la presenza e l’attività in tutte le civiltà, compresa la nostra», cfr. Lévi-Strauss, Il totemismo oggi, Milano, Feltrinelli, 1964 [Paris, 1962], pp. 7-8. Analizzando l’orientalismo piuttosto che il totemismo, Edward Said riecheggia questo brano, più o meno consapevol-mente, quando scrive: «Si può dividere la realtà umana [... ] in culture, storie, tradizioni, società, persino razze chiaramente diverse e sopravvivere umanamente alle conseguenze?», «Orientalism», 1978, 45. 2 Qui Geertz sta parlando dell’altro maestro, Max Weber; la fonte è Verso una teoria interpretativa della cultura, in C. Geerz, Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 1987 [New York, 1973], p. 41. 3 A proposito dell’ambivalenza di Lévi-Strauss sulla vita sociale e la sua convinzione che quest’ambiva-lenza sia diffusa tra gli esseri umani, vedere l’ultimo capitolo, l’ultimo paragrafo e soprattutto l’ultima frase di Le strutture elementari della parentela: «In entrambe le estremità della terra e in entrambi gli estremi
361
la creazione dei significati o come loro com-
ponenti, gli uomini diventano esseri sociali
grazie a regole inventate.
Il cotto e il crudoMangiare è, naturalmente, un importante
esempio di questi punti per Lévi-Strauss.
Osserviamo, per cominciare, che ciò che
l’uomo non fa è prendere le sostanze nu-
trienti semplicemente come vengono of-
ferte dalla natura. Per l’uomo in ogni con-
testo, nel tempo e nello spazio, l’alimento
viene sempre alterato in qualche modo o
«cotto», per utilizzare il secondo termine nel
suo senso più generale. La «cottura» può es-
sere arrostitura, bollitura, fermentazione,
conservazione, salamoia, o anche solo «di-
sposizione sul piatto» (per utilizzare un ter-
mine oggi di moda nel campo dell’arte cu-
linaria) ma, indipendentemente da questa
varietà, comporta sempre un’alterazione
di quanto viene diversamente fornito o tro-
vato – e l’alterazione è sempre organizzata
con una regola o delle regole inventate.
Come ci ha insegnato Lévi-Strauss, questa
particolare combinazione di universalità
e varietà è analoga esattamente alla situa-
zione della lingua: le lingue umane variano
notevolmente, ma la lingua in sé è un ele-
mento universale nell’esistenza umana. La
cottura e la lingua sono, per Lévi-Strauss,
due convenzioni ordinate che gli uomini
aggiungono al mondo.
Inoltre, sebbene le regole della «cottura»
abbiano grandi variazioni – al punto che
la cottura di una comunità possa essere
disgustosa o addirittura irriconoscibile per
un’altra – l’assenza di tali regole non esiste
in alcun caso4. Per osservare meglio la ve-
rità di questo punto di vista, si può cercare
di immaginare delle situazioni di ingestione
umana che si avvicinano a un grado zero di
«cottura» o preparazione del cibo. In alcune
circostanze, per esempio, una persona può
uccidere un animale commestibile e nu-
triente e poi – come ogni altro carnivoro –
mangiarne la carne senza alcuna prepara-
zione o alterazione, al di là del taglio e della
lacerazione necessari perché possa giun-
gere nel tratto digestivo e per ricavarne gli
elementi nutritivi. Ma proprio perché gli
uomini producono sempre regole o livelli di
alterazione con cui convivere – la «cottura»
nel senso lato di Lévi-Strauss – l’ingestione
non sarebbe mai semplicemente o segnata-
mente il «mangiare», come per un animale;
piuttosto, avrebbe sempre uno o più signi-
ficati specifici, come nel caso di una «fame
del tempo, il mito sumerico di un’età aurea e il mito degli Andamani di una vita futura corrispondono; il primo colloca la fine della felicità primitiva in un tempo in cui la confusione delle lingue trasformò le parole in proprietà comune, il secondo descrive la felicità del futuro come paradiso in cui le donne non vengano più scambiate, cioè lo spostamento verso un passato o un futuro egualmente irraggiungibili di gioie eternamente negate all’uomo sociale, di un mondo in cui una persona possa mantenersi da sola», cfr. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli, 2003 [Paris, 1949], p. 636. L’am-missione di Lévi-Strauss che la socialità e le istituzioni sociali non siano dei mezzi indirizzati a un fine, ma rappresentino un fine in sé, è presente in commenti come questo, tratto anch’esso da Le strutture elementari della parentela: «la funzione dell’organizzazione dualistica è esclusivamente di produrre le conseguenze che effettivamente produce», cfr. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, cit., p. 128.4 Che altri metodi di cottura possano essere irriconoscibili (o inintelligibili) è illustrato dall’errata perce-zione negli Stati Uniti e in Europa, prima della recente moda globale per il sushi e il sashimi, che i Giap-ponesi mangiassero pesce crudo.
362
disperata» o magari nella «sconvolgente
esplorazione della nostra animalità» di un
esempio di arte performativa5.
Che la «cottura» non sia mai assente dall’in-
gestione umana vale anche per l’atto molto
meno suggestivo del mangiare ciò che, per
convenzione, noi chiamiamo «frutta fre-
sca». Lo stesso fatto di aspettare un partico-
lare culmine per la maturazione, che è allo
stesso tempo un luogo comune e una varia-
bile da una cultura all’altra, comporta una
deviazione da un comportamento naturale
e un’alterazione – cioè un atto di «cottura»
nel senso lato di Lévi-Strauss – del frutto che
si mangia. Pensiamo, per esempio, a tutto il
lavoro che va fatto – applicando pesticidi o
utilizzando mezzi più «naturali» – al fine di
evitare che altri animali, svincolati da re-
gole inventate del genere, mangino il frutto
da noi desiderato prima che «maturi». Sotto
quest’aspetto si pensa alla scrupolosa – ma
completamente culturale – affermazione
di Ralph Waldo Emerson che «nella vita di
una pera esistono solo dieci minuti in cui
è perfetta da mangiare». Il punto di vista
emersoniano è stato adottato nel nostro
momento storico da un autorevole sosteni-
tore dei cibi «naturali», Michael Pollan, che
aggiunge: «nel caso di una pesca, quello
spazio temporale si avvicina probabilmente
più ai sette minuti e, nel caso dei lamponi
forse, a cinque»6.
Ricordiamo che secondo gli standard li-
mitati di maturità della frutta di Emerson
e Pollan da un lato la nostra frutta appa-
rentemente «cruda» viene «cotta» prima
di essere mangiata, dall’altro gli uomini si
allontanano da una «strategia ottimale di
ricerca del cibo»7. Senza dubbio gli inte-
ressi della selezione hanno prodotto altre
specie che mordono o rosicchiano la frutta
appesa agli alberi che noi desideriamo
prima o entro un arco temporale molto
più ampio. Così qui, nella pratica del va-
lorizzare la maturità, troviamo un preciso
parallelo con gli effetti della «divisione tra
cugini» – cioè con gli effetti della differen-
ziazione tra cugini incrociati e paralleli8.
Semplicemente, come la differenziazione
della frutta basata sull’ideale emersoniano
della maturità preclude la ricerca ottimiz-
zata della frutta, in ogni senso biologico
5 Anche nell’arte performativa mangiare un animale crudo sembra una soglia particolarmente difficile da superare. Per la sua video installazione del 2008 dal titolo Primate Cinema: How to Act Like Animal, per esempio, Rachel Myeri ha ingaggiato una troupe di uomini che hanno ricreato sei minuti di movimenti registrati e interazioni di alcuni primati. Quando però si è arrivati alla caccia e all’ingestione, gli uomini hanno utilizzato un animale impagliato e hanno finto di mangiarlo. Per altre notizie su Primate Cinema di Myeri si veda www.soft-science.org/primate.html.6 Alice Waters ha citato Emerson e Michael Pollan in un suo intervento del 9 novembre 2010 allo Scripps College. Pollan è uno dei più noti intellettuali pubblici negli Stati Uniti oggi, e autore tra l’altro di Il dilemma dell’onnivoro, Milano, Adelphi, 2008 [New York, 2007], In difesa del cibo, Milano, Adelphi, 2009 [New York, 2008], e Food Rules: An Eater’s Manual, New York, Penguin Books, 2009. Alice Waters è vicepresidente di Slow Food International.7 Per un’introduzione alla teoria della ricerca ottimale di provviste cfr. R.H. MacArthur, E.R. Pianka, On the Optimal Use of a Patchy Environment, «American Naturalist», 1966, 100, pp. 603-609.8 La definizione antropologica «cugino incrociato» si riferisce al figlio del fratello della madre o al figlio della sorella del padre di una persona; l’«incrocio» è nel sesso del genitore e del suo fratello. Analogamente, «cugino parallelo» è il figlio della sorella della madre o il figlio del fratello del padre di una persona. La «divisione tra cugini» viene introdotta ne Le strutture elementari della parentela, cit., p. 186.
363
obiettivo, così anche la differenziazione tra
cugini si allontana dall’imperativo socio-
biologico di massimizzare «l’idoneità gene-
tica»9. L’aspetto fondamentale sta nel fatto
che questa differenziazione tratta le catego-
rie dei cugini come opposti – mediamente
come partner rispettivamente idealizzati
e proibiti per le unioni riproduttive – an-
che se le categorie dei cugini possiedono
lo stesso «coefficiente di parentela» in re-
lazione all’io10. Per contro, l’imperativo so-
ciobiologico – che appare ben documentato
per altri animali – non fornisce alcuna base
perché un organismo tratti come diversi al-
tri individui della specie, se la parentela ge-
netica dell’organismo con questi individui
è la stessa, come con i cugini, incrociati o
paralleli che siano.
Cibo e rapporti socialiIl cibo, naturalmente, illustra anche la ma-
nifestazione sociale o dimensione del «non
lasciar perdere mai». A livello universale –
ma sempre secondo schemi culturali parti-
colari – il cibo viene utilizzato dalle persone
per spingere altri alla socialità. Da questo
punto di vista il passaggio cruciale nelle
opere di Lévi-Strauss è la sua discussione,
ne Le strutture elementari della parentela,
sullo scambio di bicchieri identici di vino
«modesto» da parte di alcuni clienti delle
trattorie della Francia meridionale. Seduti
vicini l’uno all’altro, gli avventori – entrati
nel ristorante senza conoscersi – provano
un incipiente disagio finché evitano di ri-
conoscersi reciprocamente. Per reagire al
disagio si offre un bicchiere di vino – cioè
un avventore lo versa al suo vicino – e, a
partire da quel momento, il rapporto «non
può più essere che di cordialità o di ostilità».
Inoltre, se l’offerta del vino è ricambiata –
se si sceglie la cordialità anziché l’osti-
lità – allora lo scambio «sanziona un’altra
offerta, quella della conversazione». In que-
sto modo, scrive Lévi-Strauss, «tutta una
cascata di minuti legami sociali viene a sta-
bilirsi in una successione di alterne oscilla-
zioni per le quali, offrendo, ci apriamo un
diritto e, ricevendo, assumiamo un obbligo:
ogni volta, e nelle due direzioni, al di là di
ciò che è stato donato o accettato»11.
Osserviamo inoltre che lo stesso schema
o struttura che Lévi-Strauss riscontra nel
processo di creare rapporti sociali è quello
di cui, nelle sue opere successive, dimostra
il funzionamento in prodotti culturali di
ogni sorta12. Il processo inizia con un’op-
posizione concettuale (nell’esempio del
9 Sull’imperativo sociobiologico del massimizzare l’«adeguatezza genetica» cfr. E.O. Wilson, Sociobiologia: la nuova sintesi, Bologna, Zanichelli, 1979 [Cambridge, Mass., 1975].10 Esaurienti illustrazioni del modo in cui numerose regole umane sulle unioni sessuali dimostrano l’inap-plicabilità della sociobiologia al genere umano si trovano in M. Sahlins, Una critica antropologica della sociobiologia, Torino, Loescher, 1981 [Ann Arbour, 1976], e S. McKinnon, Neo-liberal Genetics: The Myths and Moral Tales of Evolutionary Psychology, Chicago, Prickly Paradigm Press, 2005. Per un’importante dimostrazione del fatto le valenze dei cugini incrociati e paralleli abbiano una contingenza non registrata nelle opere di Lévi-Strauss si veda J. Boon, The Anthropological Romance of Bali, 1597-1972: dynamic perspectives in marriage and caste, politics, and religion, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, in particolare il cap. VI, The Meaning of Marriage and Descent.11 C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela, Milano, Feltrinelli, 19783 [Paris, 1947], pp. 109-110.12 Id., Mitologica, Milano, Il Saggiatore, 4 voll., 1966-1974 [Paris, 1964-1971].
364
versare il vino, si tratta della sconcertante
opposizione tra l’io e una persona ricono-
sciuta come altro), e questa opposizione
viene quindi superata attraverso un atto di
mediazione (il versare del vino in un bic-
chiere): però, cosa molto importante, l’atto
di mediazione non porta una sospensione.
L’atto di mediazione porta piuttosto a qual-
cosa «che va oltre quanto è stato dato e ac-
cettato»; in breve, a una serie indeterminata
di variazioni sul tema – un altro scambio,
un altro mito, o un altro brano musicale13.
Come misura del suo successo – e, in ul-
tima analisi, della sua fedeltà al genere
umano – riconosciamo che, attraverso que-
sta parabola etnografica delle origini della
vita sociale, Lévi-Strauss rimuove radical-
mente il «metodo comparativo» della teo-
ria evolutiva della storia14. Nell’esempio di
una trattoria nella Francia meridionale, le
origini della socievolezza risiedono e sono
illustrate da un’esperienza ricorrente nel
mondo dello stesso Lévi-Strauss. Gli altri
esotici, tribali, non vengono costretti a fare
«i primitivi»; così ci si oppone alla scompo-
sizione dell’umanità.
13 Su Lévi-Strauss e la musica cfr. J. Boon, Lévi-Strauss, Wagner, Romanticism: A Reading-back, in G. Sto-cking (ed.), Romantic Motives. Essays on Anthropological Sensibility, Madison, University of Winsconsin Press, 1989, e R. Launay, Myth and Music: the Musical Epigraphs to The Raw and the Cooked, relazione presentata all’Annual Meeting of the American Anthropological Association, il 19 novembre 2010 a New Orleans.14 Sul «metodo comparativo» dell’evoluzionismo nell’antropologia sociale cfr. G. Stocking, Antropologia dell’età vittoriana, Roma, Ei, 2000 [New York, 1987], e D. Segal, «Western Civ» and the Staging of History in American Higher Education, «American Historical Review», 2000, 3.