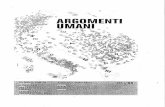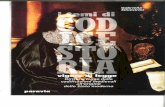La trasparenza contro l’ostacolo. Il mutamento del concetto di «legge» nella Rivoluzione francese
Una legge elettorale inconsulta (sent. 1/2014 - Porcellum)
Transcript of Una legge elettorale inconsulta (sent. 1/2014 - Porcellum)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZESCUOLA DI GIURISPRUDENZA
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Una legge elettorale “inconsulta”
Relatrice:
Prof.ssa Maria Cristina Grisolia
Candidato:
Dott. Giacomo Salvadori
Anno accademico 2013/2014
Indice1. Introduzione
2. La giustizia elettorale
I. Zone franche (e zone d’ombra)
II. La legge n. 207/2005 e gli inviti alla riforma della legge elettorale
3. La sentenza n. 1 del 2014
I. Un’azione di mero accertamento
II. Finzione processuale ed ammissibilità
III. Nel merito della sentenza
4. Considerazioni finali
I. Limiti al futuro legislatore elettorale
II. L’accesso “in via preferenziale”
III. La legge elettorale per il Parlamento europeo
IV. Conclusioni
5. Bibliografia
2
I N T R O D U Z I O N E
Sull’esercizio del diritto di voto
Oggetto del presente lavoro è la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, con la quale sono state dichiarate illegittime alcune disposizioni della legge n. 207/2005: quest’ultima è intervenuta sulla normativa per l’elezione dei membri di Camera e Senato, riformandone profondamente la disciplina, ed ha trovato applicazione in ben tre occasioni (comizi elettorali del 2006, 2008 e 2013) prima di pervenire all’esame di costituzionalità per gli aspetti che presentavano le maggiori criticità, vale a dire la previsione di premi di maggioranza senza alcuna soglia minima e le ccdd. liste bloccate.
Questa breve introduzione non vuole entrare nel merito della legge e delle critiche diffuse di cui è stata oggetto, nonché delle vicende giudiziarie e giuridiche che l’hanno riguardata, fino al percorso che l’ha portata al giudice costituzionale. Quel che si propone è innescare una piccola riflessione su quel che è andato smarrito in questi anni di vigenza della normativa, quel che è stato sottratto al corpo elettorale nel nome della governabilità: il riferimento è al libero esercizio del diritto di voto, consapevole, determinato, d’opinione. Quell’attività fondamentale di uno Stato democratico, dove l’assemblea legislativa si compone di rappresentanti eletti che, pur liberi dal vincolo di mandato, devono comunque rispondere del loro operato di fronte agli elettori, certo ogni giorno, magari a distanza di cinque anni. Negli anni di vigenza della legge Calderoli si è andata perdendo la responsabilità politica, giacché le liste bloccate, lungi dall’assolvere la loro funzione di servire l’elezione di specialisti e di esponenti delle minoranze, sono servite alle segreterie dei partiti per eleggere, talvolta, persone quantomeno discutibili.
3
Il voto è un diritto politico, il più importante dei diritti politici; è un diritto fondamentale di particolare rilevanza, che si collega direttamente al primo articolo della Carta: “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Rappresenta l’essenza stessa della democrazia, il suo rinnovarsi ad intervalli ciclici. Le generazioni più anziane lo custodiscono come un cimelio, perché la memoria potrà anche rarefarsi, ma il profumo della libertà che si respira il giorno delle elezioni è inconfondibile, ha un suo particolare sentimento, tanto da essere vissuto come un appuntamento piuttosto che come un dovere civico. Tra i giovani invece prevale la disaffezione, l’identificazione della chiamata alle urne con un rituale stantio senza una precisa utilità: è andata perduta la cognizione del potere attribuito a ciascuno ed assieme all’astensionismo dilaga la convinzione, sempre più marcata, che il voto non serva a determinare il destino del paese.
Se c’è un risultato che la legge n. 207/2005 può appuntarsi di aver conseguito, attraverso i suoi meccanismi astrusi dai risultati imprevedibili e dalle sue liste blindate di nominati dal seggio assicurato, questo è l’allontanamento del popolo dalla politica, attraverso un voto sempre più scettico, che spesso ha finito per tradursi in una vera e propria rinuncia all’esercizio del diritto.
Il diritto di voto è il suggello della democrazia, la sua articolazione in diritti individuali come quota pro capite del potere un tempo ascritto alla sovranità statale. Limitare il diritto di voto coincide con la negazione della struttura democratica dell’ordinamento, con effetti che vanno ben oltre il concreto esercizio del diritto di voto nelle singole tornate elettorali, per compromettere la stessa collocazione del singolo cittadino, di ciascun cittadino, nel sistema istituzionale. Di pari passo con la mortificazione del diritto di voto, infatti, viene mutata permanentemente la qualità del cittadino come titolare di una quota di sovranità, compromettendone la concreta qualifica al cospetto del sistema istituzionale in ogni momento della vita democratica. Soltanto la deteriorante concezione del diritto di voto e della democrazia come accidenti istantanei da attivarsi il giorno delle elezioni possono far ritenere esauriti i relativi effetti e l’esercizio dei connessi diritti politici in quel singolo momento. Il diritto di voto non conosce tregua, non si ripone così come si fa con la tessera elettorale: è un diritto permanente che resta lì, immanente nelle istituzioni democratiche, risiedendo nella contezza che di esso hanno i cittadini il vero potere di controllo sul Parlamento.
4
Le facoltà giuridiche che compongono gli status della cittadinanza ed i diritti politici sono permanentemente qualificati dalla portata e dall’efficacia, anche soltanto potenziale, del diritto di voto in concreto, anche soltanto come minaccia di esercizio in concreto: sul sistema politico, nei confronti dei partiti e sugli sviluppi dell’ordinamento. Il diritto di voto è un diritto ad esercizio e con effetti permanenti. Cittadino e diritto di voto sono concetti complementari, quindi, con conseguenze evidenti già al solo evocare il possibile esercizio in concreto di tale diritto, come potere di scelta della rappresentanza e come facoltà di sanzione nei confronti dell’azione dei pubblici poteri.
Questi otto lunghissimi anni hanno rappresentato da una parte la grave limitazione, se non addirittura la perdita, di questa fondamentale consapevolezza, cioè il diritto/dovere di pronunciarsi, in qualsiasi momento, per certificare un mandato elettorale e finanche correggerlo; dall’altra l’acquisizione di una sostanziale indipendenza dalla gente comune, attraverso lo scioglimento di qualsiasi legame col corpo elettorale, al prezzo di un asservimento alla volontà politica ed agli interessi della segreteria di partito.
La sentenza n. 1/2014 è prima di tutto questo: la restituzione del voto nella sua espressione più ampia, il ritorno alla sua vera funzione di linfa e pungolo della democrazia rappresentativa. L’elaborato metterà in luce il percorso, invero accidentato e mai battuto prima, che ha condotto ad un importante ripristino della legalità costituzionale: saranno esaminati i tentativi, gli sforzi, gli insuccessi e le forzature di una lotta di civiltà tanto diffusa nella popolazione quanto ignorata dal Parlamento. Con l’auspicio che non vi sia più bisogno di scomodare la Corte costituzionale per un principio così chiaro. Talmente chiaro che ogni tanto fa bene ripeterlo.
5
C A P I TO L O P R I M O
La giustizia elettorale
1. Zone franche e zone d’ombra
Il riconoscimento di un elenco di diritti nella carta fondamentale dello Stato non è, evidentemente, un gesto meramente simbolico, frutto della munificenza di un sovrano illuminato, poiché le odierne costituzioni garantiscono che i diritti ivi previsti trovino una conseguente tutela davanti alla autorità giudiziaria. Come ebbe modo di scrivere Hans Kelsen, “un catalogo delle libertà o diritti dei cittadini forma una parte tipica delle costituzioni moderne”, sull’esempio dei primi dieci emendamenti – costituenti il Bill of Rights – della Costituzione degli Stati Uniti d’America, avvertendo che le prescrizioni contenute in questi emendamenti e dirette verso gli organi dei poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale “attribuiscono all’individuo un diritto nel senso tecnico della parola soltanto se esso ha la possibilità di agire in giudizio contro un atto incostituzionale dell’organo, e specialmente se può mettere in moto un procedimento che porti all’annullamento dell’atto incostituzionale” 1 : pertanto il diritto soggettivo esiste laddove la tutela dello stesso non soltanto parimenti esista, ma sia effettiva.
6
1 H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello stato, traduzione italiana di S. Cotta e G. Treves, Milano, 1952, pp. 241 e 271.
L’obiettivo della sinergia – collaudata da quasi sessant’anni di coesistenza – tra le giurisdizioni comuni e la Corte costituzionale è garantire una effettiva tutela dei diritti riconosciuti dalla Costituzione: attraverso l’accesso in via incidentale – che del modello di giustizia costituzionale italiano rappresenta il carattere distintivo – i giudici comuni possono “aprire le porte” della Corte2 al fine di consentirle il sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni di legge supposte lesive. La legge che regola il funzionamento della Corte prevede infatti che “nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale”3, individuando un primo requisito nella necessaria esistenza di un giudizio a quo dal quale scaturisca il dubbio di costituzionalità. Vi è tuttavia un punto di debolezza nel controllo incidentale, vale a dire l’esistenza nell’ordinamento di leggi ed atti equiparati difficilmente giustiziabili, che per loro natura o precipue caratteristiche, ovvero per la struttura stessa del nostro sistema, tendono ad evadere il controllo giurisdizionale. In passato si sono indicate come esempio
“le leggi di favore, le leggi di spesa, le leggi di organizzazione, e ancora le leggi la cui costituzionalità si consuma, per così dire, in un tempo breve (si pensi ai decreti legge, i cui presupposti di costituzionalità non sono più sindacabili dopo la conversione in legge, secondo l’opinione invalsa), o comunque la cui prima applicazione può consolidarsi in tempo breve, prima che possano essere proposte alla Corte questioni incidentali (come le leggi elettorali)”4.
Postulata l’esistenza di un giudice delle leggi, deve scongiurarsi il rischio che l’ordinamento conosca lacune in merito all’accesso alla giurisdizione comune, poiché altrimenti si avrebbero leggi che, pur applicate, sfuggirebbero al giudizio di legittimità costituzionale. Tale conclusione non sarebbe infatti sostenibile, poiché contraria al principio costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi consacrato dagli articoli 24 e 113 della Costituzione.
7
2 L’espressione è evidentemente ripresa da Calamandrei, il quale rilevava che “La corte costituzionale e l’amministrazione della giustizia ordinaria vivono per così dire in simbiosi, senza poter fare a meno l’una dell’altra: se il giudice ordinario non apre la porta, la Corte non può entrare in funzione”, in P. Calamandrei, La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Milano, 1950, XII.
3 Cfr. l’art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87, “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”.
4 V. Onida, Relazione di sintesi, in Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, p. 301.
Le carenze del sistema di accesso incidentale sono finite sotto l’attenta lente della dottrina sin dai primi anni di funzionamento della Corte, quando già si prefigurava l’esistenza di lacune in merito alla giustiziabilità di leggi elettorali che, come osservava a titolo di esempio Calamandrei, “siano in contrasto col principio costituzionale della uguaglianza di voto, o che modifichino in contrasto con la Costituzione, l’età occorrente per acquistare l’elettorato attivo o passivo; in questi casi il giudizio - cavia non è immaginabile”5. La legge elettorale rappresentava già la lacuna più grave ed evidente di un sistema di giustizia costituzionale appena istituito, ciò stimolando la dottrina ad escogitare soluzioni giuridiche utili a permettere, nel rispetto delle regole del giudizio costituzionale, che una relativa questione potesse giungere alla Corte. In quello stesso periodo, ad esempio, Cappelletti ammetteva, con esclusivo riferimento alle leggi ccdd. auto-applicative, la possibilità di esperire “la domanda di mero accertamento positivo della persistenza, nonostante la legge, di un proprio potere o negativo della sussistenza di un proprio dovere”6; tale rimedio veniva riconosciuto anche da Calamandrei contro quelle leggi che incidessero su rapporti tra privati, occorrendo sempre un “legitimus contradictor contro il quale instaurare il processo-espediente” 7. La questione si è protratta pressoché irrisolta fino ai giorni nostri, coagulando attorno a sé un ampio dibattito in ragione della duplice valenza che riveste ancora oggi: da un lato, era discussa la legittimazione della Corte costituzionale a compiere una valutazione, pur sotto il precipuo parametro di costituzionalità, di una legge ad alto valore politico, la cui riforma avrebbe dovuto essere – per motivi di opportunità politica, oltre che in nome del principio di separazione dei poteri – di esclusiva competenza parlamentare; dall’altro, non era di facile individuazione la sede processuale nella quale sollevare l’eccezione di incostituzionalità, considerata l’acclarata ed oggettiva difficoltà per la legge elettorale di superare il giudizio di rilevanza (della questione di costituzionalità) all’interno di una vicenda giurisdizionale8.
8
5 P. Calamandrei, Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Rivista di diritto processuale, 1956, p. 16.
6 Cappelletti esamina proprio il caso della legge lesiva del diritto di voto – legge che, dunque, sembra essere curiosamente inclusa fra quelle auto-applicative –, evidentemente alla luce della c.d. legge “truffa”, emanata due anni prima M. Cappelletti, La giurisdizione costituzionale delle libertà, Milano, 1955, pp. 11 ss.
7 P. Calamandrei, op. ult. cit., p. 15.
8 F. Sgrò, La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema proporzionale: qualche considerazione sull’equilibrio tra rappresentanza politica e governabilità, in www.forumcostituzionale.it, 7 febbraio 2014.
Per tali motivi la dottrina ha teorizzato nel tempo diverse soluzioni dirette a superare quella che è stata definita una “zona franca” della giustizia costituzionale9, non ultima l’individuazione di un possibile giudizio a quo nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo della legge elettorale10. Non ultimo, la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 284/08 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da singoli cittadini e diretto a sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti tanto del Parlamento (per l’inerzia a modificare una legge ritenuta anti-democratica), quanto dell’ordine giudiziario (per i casi di giustizia negata, a fronte dei numerosi tentativi di sottoporre la legge alla Consulta), dichiarando il difetto di legittimazione dei singoli cittadini a promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato11; così come similmente aveva statuito quando a sollevare il conflitto era stato un partito, ritenendo le associazioni politiche “organizzazioni proprie della società civile” e non “poteri dello Stato ai fini dell’art. 134 Cost.”12.
2. La legge n. 270/2005 e gli inviti alla riforma della legge elettorale
La riforma delle leggi che regolano l’elezione dei membri di Camera e Senato venne approvata negli ultimi mesi della XIV legislatura, con i soli voti della maggioranza che sosteneva l’allora Governo Berlusconi III. La riforma si muoveva in un percorso, invero dalle battute molto serrate, di più articolata riforma dell’architettura istituzionale che comprendeva altresì una imponente riforma costituzionale, approvata anch’essa senza alcun accordo con le opposizioni.
9
9 M. Siclari, Il procedimento in via incidentale, in Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, a cura di R. Balduzzi, P. Costanzo, Torino, 2007, pp. 25 ss.; A. Pizzorusso, “Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana, in www.giurcost.org, 6 settembre 2008.
10 A. Pizzorusso, A margine del dibattito sulla riforma elettorale, in www.astrid-online.it, 8 maggio 2007; L. Trucco, Note minime sul “prima e il “dopo”. La sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2012 di inammissibilità dei referendum in materia elettorale, in www.forumcostituzionale.it, 2 aprile 2012. Da notare che nel 2011, in occasione del referendum “Morrone”, fu lo stesso comitato promotore a sostenere l’illegittimità della legge elettorale e a richiedere alla Corte l’autosollevamento della questione.
11 Nell’ordinanza, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, la Corte ha negato la possibilità per un singolo cittadino di autoqualificarsi “componente dell’organo costituzionale corpo elettorale”, ritenendo il ricorso preordinato “ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di accesso diretto”.
12 Corte cost., ord. n. 79 del 2006.
L’obiettivo espressamente annunciato della riforma elettorale consisteva nell’assicurare la governabilità, prevedendo all’uopo un sistema proporzionale con significative correzioni in senso maggioritario: la legge n. 270/2005 prevede sei distinti sistemi elettorali (uno per diciassette regioni; uno per il Trentino Alto Adige, uno per la Valle d’Aosta, uno per il Molise, tre diversi sistemi per la circoscrizione estero), di cui quello principale è caratterizzato da un premio di maggioranza eventuale e da distinte soglie di sbarramento, di cui una, quella per i partiti al di fuori delle coalizioni, particolarmente alta (4% alla Camera, 8% al Senato); il premio di maggioranza è previsto anche per l’elezione del Senato, da assegnarsi tuttavia su base regionale.
Sin dai lavori parlamentari, la dottrina espresse in maniera piuttosto compatta forti critiche alla normativa in esame, in ragione soprattutto della mancata previsione di alcuna soglia minima di voti per l’attivazione del premio di maggioranza e per la previsione al Senato di un premio di maggioranza su base regionale, dagli effetti non prevedibili e sulla cui idoneità allo scopo della governabilità fioccavano i dubbi13.
Carlassare in particolare sostenne che un sistema proporzionale con siffatti correttivi, analizzati non uno ad uno, bensì nel meccanismo complessivamente disposto, configurasse di fatto un sistema maggioritario, che peraltro non trovava più ragione d’essere a causa della bocciatura, nel referendum confermativo del 2006, della legge di riforma costituzionale alla quale era legato:
“Il premio di maggioranza, presente nel nostro sistema (anche se concepito, per il Senato, in modo stravagante) distorce indiscutibilmente l’esito della consultazione elettorale, falsando il rapporto fra voti e seggi con l’attribuzione alla coalizione che ottiene più voti di un numero di seggi maggiore di quanti gliene spetterebbero in base al criterio proporzionale. Va peraltro ancora sottolineato che, nei meccanismi attuali, all’alterazione successiva al conto dei voti (nella trasformazione in seggi), si accompagna un’alterazione preventiva per la forza deterrente del voto inutile combinato all’elevata soglia di sbarramento qualora i partiti maggiori respingano alcuni dalla coalizione impedendo loro l’accesso effettivo alla competizione”14.
10
13 R. Balduzzi, M. Cosulich, In margine alla nuova legge elettorale politica, in Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 6, 2005, pp. 5179 ss.; M. Croce, “Se non ora quando?”: sui possibili vizi di costituzionalità della legge elettorale (e sui possibili modi per farla valere) in www.forumcostituzionale.it; A. Patroni Griffi, Sistemi elettorali e tenuta del principio democratico: brevi considerazioni a margine della legge elettorale, in www.forumcostituzionale.it.
14 L. Carlassare, Maggioritario, in www.costituzionalismo.it, 23 aprile 2008.
Alle considerazioni della dottrina fecero seguito le prime pronunce giudiziarie, poiché molti elettori e giuristi si attivarono con ogni mezzo previsto dall’ordinamento per poter ottenere la sollevazione della questione di costituzionalità della legge. Così, più di una volta gli atti di avvio del procedimento elettorale sono stati impugnati davanti al giudice amministrativo, con l’esclusivo fine di instaurare il giudizio a quo necessario a contestare la costituzionalità della legge elettorale15. In un secondo momento il Consiglio di Stato negò la propria giurisdizione sull'impugnazione del decreto di convocazione delle assemblee elettorali del 6 febbraio 200816, e la sentenza fu impugnata da un cittadino, che sollevò un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro l'ordine giudiziario ed il Parlamento, chiedendo alla Corte di sollevare davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale della legge n. 207/2005: la Corte, tuttavia, censurò l’insolita via scelta per accedere al giudizio costituzionale e dichiarò il conflitto inammissibile17.
A questo punto novantuno cittadini italiani presentarono diciassette ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, denunciando la legge n. 270/2005 per violazione dell'art. 3 del I Protocollo – “diritto a libere elezioni” – in relazione alle liste bloccate e all'assenza di una soglia minima per il premio di maggioranza, e per violazione degli artt. 6 e 13 – “diritto al giusto processo” e “diritto ad un ricorso effettivo” – per l'assenza di tutela giurisdizionale. La Corte europea respinse i ricorsi nel 2012: pur dando atto che il premio di maggioranza è istituto poco usato dalle legislazioni elettorali dei Paesi membri del Consiglio d’Europa18, negò la violazione dell’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, riconoscendo agli Stati contraenti “un ampio margine di discrezionalità quando si tratta di determinare il modo di scrutinio attraverso il quale viene garantita la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”19.
11
15 V. ad esempio Corte cost., ord. n. 117 del 2006, che dichiarò irricevibile il conflitto promosso dalla “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”, al fine di far affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica delle elezioni politiche, e a far negare quella della Camera dei deputati. Simile questione, sollevata in via incidentale, è stata dichiarata inammissibile con ord. n. 512 del 2000.
16 Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1053 del 2008.
17 Corte cost., ord. n. 284 del 2008, della quale si è già parlato supra in nota 11.
18 L’istituto trova applicazione in Grecia, Malta e San Marino.
19 Corte europea per i diritti dell’uomo, sent. Saccomanno c. Italia del 13 marzo 2012, ric. 11583/08 ed altri 16 ricorsi; sull’argomento v. L. Trucco, Sistema di elezione e di giustizia elettorale (italiani): anche per Strasburgo, tutte le strade portano al legislatore (italiano), in www.forumcostituzionale.it, 5 aprile 2012.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 15/2008, si pronunciò in ordine all’ammissibilità di un referendum abrogativo sulla legge elettorale, evitando di entrare nel merito dei profili di costituzionalità e ribadendo la propria giurisprudenza, nel senso che
“un giudizio anticipato sulla situazione normativa risultante dall'avvenuta, in ipotesi, abrogazione referendaria, verterebbe su norme future e incerte, in palese violazione delle regole del processo costituzionale italiano, che vietano al giudice delle leggi di procedere allo scrutinio di costituzionalità senza che la questione sia sorta in occasione di una concreta vicenda applicativa della norma censurata.”20
Ciò non ostante, colse l’occasione per lanciare, obiter, un segnale al legislatore, espresso in questi termini:
“L'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.”21
Nella sentenza immediatamente successiva, anch’essa relativa alla medesima legge ma nella parte riguardante il sistema elettorale del Senato, la Corte ripeté la medesima, identica, formulazione, con riferimento al premio di maggioranza acquisito a livello regionale22. Cinque anni dopo, la Corte è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità di un altro referendum abrogativo riguardante la legge elettorale, circostanza in cui ha ribadito, anche di fronte ad esplicite affermazioni dei soggetti presentatori del referendum, l’impossibilità di pronunciarsi sui profili di incostituzionalità, respingendo l’ipotesi che tali questioni risultassero pregiudiziali alla definizione del giudizio23.
12
20 Corte cost., sent. n. 15 del 2008, Considerato in diritto n. 6.1.
21 Ibidem.
22 Corte cost., sent. n. 16 del 2008, Considerato in diritto n. 6.1.
23 Corte cost., sent. n. 13 del 2012.
La motivazione riportava la medesima formula utilizzata nelle due occasioni precedenti, ricordando che già nel 2008 era stata segnalata al Parlamento “l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici della legislazione prevista nel 2005, con particolare riguardo all’attribuzione di un premio di maggioranza, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o di seggi”24.
Nel corso della relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2012, svoltasi il 12 aprile 2013, il Presidente della Corte Prof. Franco Gallo ha lamentato la scarsa attenzione riservata dal legislatore agli inviti a modificare la normativa, plurimi ed univoci, rivoltigli dalla Corte nel corso degli anni, richiamando le sentenze appena sopra accennate. In particolare il Presidente ebbe a sottolineare come i solleciti “non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia. È accaduto spesso che il Parlamento non abbia dato séguito a questi inviti” 25. Come ha sottolineato attenta dottrina 26, con tale esternazione il Presidente della Corte sembrò effettuare una vera e propria “chiamata” della questione di legittimità costituzionale, lasciando intendere come probabile una pronuncia di incostituzionalità nel caso in cui la Corte fosse stata messa in condizione di esercitarne il sindacato.
A questa lista di moniti autorevoli si è andato in ultimo ad aggiungere quello del Presidente della Repubblica, espresso nel messaggio alle camere subito dopo il giuramento del 22 aprile 2013. Rivolgendosi severamente ad un Parlamento inerte, evidenziò come “imperdonabile resta la mancata riforma della legge elettorale del 2005. [...] Ed è un fatto, non certo imprevedibile, che quella legge ha provocato un risultato elettorale di difficile governabilità, e suscitato nuovamente frustrazione tra i cittadini per non aver potuto scegliere gli eletti”27.
13
24 Ivi, Considerato in diritto n. 3.
25 Corte cost., Relazione del Presidente Prof. Franco Gallo, in www.cortecostituzionale.it, 12 aprile 2013.
26 E. Rossi, La Corte costituzionale e la legge elettorale: un quadro in tre atti e dall’epilogo incerto, in www.federalismi.it, 5 giugno 2013.
27 Camera dei deputati, Senato della Repubblica, 22 aprile 2013, res. sten., pp. 2-3.
C A P I TO L O S E C O N D O
La sentenza n. 1 del 2014
1. Un’azione di mero accertamento
Come si è giunti alla storica sentenza n. 1/2014, con cui la Corte costituzionale per la prima volta nella sua storia ha potuto esercitare il sindacato di costituzionalità sulla legge elettorale in vigore, dichiarandone peraltro la parziale illegittimità? Un risultato inedito quanto atteso, dalla portata potenzialmente dirompente, che tuttavia prende le mosse da una semplice, ma tutt’altro che banale, azione di accertamento.
Dal momento che le forze politiche in Parlamento non erano state in grado di riformare il sistema elettorale, alcuni cittadini avevano ritenuto di presentarsi dinanzi al giudice ordinario, naturale garante dei diritti, chiedendo di apprestare tutela verso un diritto costituzionale che consideravano leso dalla legge elettorale stessa. Nel novembre 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno sono stati convenuti in giudizio da “un cittadino elettore”, sig. Aldo Bozzi28. L’attore chiedeva che fosse accertato che il suo diritto di voto non aveva potuto esercitarsi in coerenza con i principi costituzionali in occasione delle elezioni del 2006 e del 2008 e – considerando tale lesione permanente e destinata a riprodursi – il ripristino del diritto nella sua pienezza attraverso la dichiarazione di incostituzionalità delle norme censurate.
14
28 Nel giudizio di primo grado sono poi intervenuti ad adiuvandum altri venticinque cittadini elettori.
In particolare, l’impossibilità di esprimere una preferenza verso alcun candidato sarebbe stata incompatibile con le previsioni costituzionali che vogliono il voto “personale” e “diretto”29; il principio di eguaglianza del voto sarebbe invece stato violato dal meccanismo che attribuisce un premio di maggioranza senza una soglia minima di voti o di seggi e dalla diversa entità dei singoli premi di maggioranza per le singole regioni, che avrebbe reso il voto dell’elettore residente in una regione popolosa non eguale a quello dell’elettore residente in una regione meno popolosa. Inoltre, la previsione dell’indicazione del nominativo del capo della lista o coalizione nella scheda elettorale avrebbe avuto l’effetto di coartare la libertà del voto, nonché l’autonomia del Presidente della Repubblica nel nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri. Dunque, a causa di queste presunte violazioni, gli attori hanno chiesto al giudice di dichiarare che il loro diritto di voto non poteva essere esercitato secondo modalità conformi alla Costituzione (e all’art. 3 Prot. 1 CEDU), e di “ripristinarlo secondo modalità conformi alla legalità costituzionale”: a tal fine veniva sollevata eccezione di incostituzionalità di molte disposizioni delle leggi elettorali della Camera e del Senato.
L'azione prospettata, pertanto, sembrava avere come unico oggetto quello della rimozione della legge ritenuta incostituzionale, configurando secondo molti una lis ficta30. Tuttavia, già nei primi due gradi di giudizio, gli attori avevano ottenuto il riconoscimento, da parte del Tribunale prima e della Corte di Appello poi, dell'ammissibilità della propria azione, giacché erano state respinte le eccezioni preliminari per difetto di giurisdizione e insussistenza dell’interesse ad agire presentate dalle amministrazioni convenute. I giudici di merito, infatti, avevano inquadrato il petitum dell'azione civile nell'accertamento di una lesione di un diritto – di cui gli attori erano attualmente e non solo ipoteticamente titolari – ed avevano quindi ritenuto che l'oggetto del giudizio principale fosse più ampio della proposta questione di legittimità costituzionale. Tanto nel primo quanto nel secondo grado, tuttavia, le eccezioni di incostituzionalità erano state ritenute manifestamente infondate e conseguentemente rigettati la domanda ed il susseguente ricorso in appello31.
15
29 Cfr. gli artt. 48, comma secondo, 56, comma primo, e 58, comma primo, Cost.
30 Afferma ad esempio Anzon che “il petitum nell’azione di accertamento sembra in realtà la sola proposizione del dubbio sulla costituzionalità della legge” in A. Anzon-Demmig, “Un tentativo coraggioso ma improprio per far valere l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche (e per coprire una “zona franca” del giudizio di costituzionalità)”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 12 luglio 2013.
31 Trib. di Milano, sent. 18 aprile 2011; Corte di Appello di Milano, sent. 24 aprile 2012.
I ricorrenti hanno infine proposto ricorso davanti alla Suprema Corte. I giudici di Cassazione hanno recepito, limitatamente all'ammissibilità dell'azione principale, le conclusioni dei giudici di merito, osservando che il Tribunale aveva valutato positivamente l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti, implicitamente ritenendo “più ampia [...] la latitudine dell’interesse ad agire, della legittimazione e della facoltà di azione concessa a ogni elettore” 32; che egualmente la Corte d’Appello, nel confermare integralmente la sentenza, aveva anch’essa rigettato la relativa eccezione; che infine le amministrazioni convenute non avevano proposto ricorso incidentale in sede di legittimità, con ciò formandosi il giudicato sul punto.
La Suprema Corte ha quindi riservato una buona parte dell’impianto motivazionale, circa un terzo, allo scopo di evidenziare la diversità concettuale tra quanto richiesto al giudice ordinario ed il contenuto della questione di legittimità costituzionale. Viene rilevato che, diversamente da altre questioni già prospettate all'attenzione dei giudici costituzionali e ritenute inammissibili, nel caso di specie sussisterebbe la condizione richiesta dalla giurisprudenza della Consulta, ovvero che “il petitum del giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non si identifichi con l'oggetto della questione stessa”33. La Cassazione infatti considera che l’azione esperita “si allontana dall’archetipo delle azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni costitutive o di accertamento-costitutive”34 e ritiene che l'autonomia della pronuncia richiesta al giudice ordinario consista nell'accertare la lesione del diritto e nel ripristinarlo nella pienezza della sua espansione: il quid pluris della sentenza civile, rispetto all'eventuale pronuncia della Corte costituzionale, è nell'accertamento di una materiale e concreta lesione del diritto individuale degli attori, sebbene rispetto a tale accertamento non consegua una condanna. Com'è evidente, in questo caso gli oggetti dei due giudizi, principale ed incidentale, sono fortemente legati ma, ad avviso della Cassazione, “non potrebbe ritenersi che vi sia coincidenza (sul piano fattuale e giuridico) tra il dispositivo della sentenza costituzionale e quello della sentenza che definisce il giudizio di merito”35.
16
32 I giudici hanno richiamato Cass., sent. n. 4103 del 1982.
33 Corte cost., sent. n. 84 del 2006, Considerato in diritto n. 4.2.
34 Cass. civ., ord. n. 12060 del 2013, n. 3.1.1 dei Motivi della decisione.
35 Ivi, n. 3.2.1 dei Motivi della decisione.
Per avvalorare la necessità di una interpretazione maggiormente dilatata del requisito della rilevanza, i supremi giudici ricorrono all’argomento delle leggi auto-applicative, considerando come
“In tali casi l’azione di accertamento può rappresentare l’unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela ugualmente efficace e diretta. L’esistenza nel nostro ordinamento di un filtro per l’accesso alla Corte costituzionale, che è subordinato alla rilevanza della questione di costituzionalità rispetto alla definizione di un giudizio comune, di certo non può precludersi in un ostacolo che precluda quell’accesso qualora si debba rimuovere una effettiva e concreta lesione di valori costituzionali primari. Una interpretazione in senso opposto indurrebbe a dubitare della compatibilità del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953 con l’art. 134 Cost.”36
La Suprema Corte sembra con ciò aprire la strada alla possibilità di agire, dinnanzi al giudice ordinario, per la tutela di diritti fondamentali che siano lesi direttamente da una legge auto-applicativa, con l'effetto di costruire un giudizio quasi diretto di legittimità costituzionale.
2. Finzione processuale ed ammissibilità
Nella valutazione dell’ammissibilità della questione, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953, la Corte costituzionale afferma di limitare il proprio controllo all’adeguatezza delle motivazioni sulla corretta instaurazione del giudizio a quo, avente petitum separato e distinto, premettendo anzitutto che “il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza dell’incidente di legittimità costituzionale, sono [...] rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile”37. Ciò è coerente con la giurisprudenza costituzionale, ferma nel ritenere che gli eventuali vizi del processo a quo, salva la loro macroscopica evidenza, non sono rilevabili di fronte alla Consulta, il cui giudizio prende vita non dall’intero giudizio a quo, ma dalla sola ordinanza che solleva la questione pregiudiziale38.
17
36 Ivi, n. 3.2.2 dei Motivi della decisione.
37 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 2.
38 Si tratta del cd. “principio di autosufficienza” dell’ordinanza di rimessione, ribadito recentemente in Corte cost., sent. n. 197 del 2010, Considerato in diritto n. 4.
Il giudice costituzionale riconosce dunque alla Suprema Corte di avere “plausibilmente argomentato” con “motivazione ampia, articolata ed approfondita [...] in ordine sia alla pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia alla rilevanza delle medesime” 39. Nell’uniformarsi sul punto a quanto argomentato dalla Suprema Corte, la Consulta sembra trascurare il passaggio dell’ordinanza in cui viene dichiarato infondato il primo motivo di ricorso – con il quale i ricorrenti lamentavano la mancanza di motivazione della decisione di rigetto nel merito della domanda di accertamento – perché “la Corte territoriale, avendo rigettato le eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme censurate della legge n. 270/2005, ha implicitamente rigettato nel merito la domanda proposta, escludendo la rilevanza giuridica della dedotta lesione del diritto di voto” 40. Tuttavia, così argomentando, i supremi giudici sembrano tradire quanto sostenuto con determinazione successivamente, giacché il ragionamento lascia presumere che il giudizio principale venga meno con il rigetto della eccezione di costituzionalità e, di conseguenza, l’azione di accertamento non abbia un proprio petitum che possa definirsi separato e distinto dalla questione di legittimità.
In passato la dottrina si è spesa a lungo sull’esegesi dell’art. 23 e sui requisiti dell’ammissibilità della quaestio: Zagrebelsky sul finire degli anni Sessanta, sul presupposto di un controllo di legittimità privo di zone d’ombra, suggeriva di intendere il presupposto della rilevanza come condizione “normale” del giudizio di costituzionalità, ma non sempre “necessaria”41, tesi che però non ha avuto riscontro nella giurisprudenza costituzionale, che ha seguito un orientamento rigoroso nel controllo di rilevanza42; tant’è che, in tempi più recenti, lo stesso autore si esprimeva con maggiore rigidità43.
18
39 Ibidem.
40 Cass. civ., ord. n. 12060 del 2013, n. 1.1 dei Motivi della decisione.
41 G. Zagrebelsky, La rilevanza: un carattere normale ma non necessario della questione di legittimità costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1969, pp. 1001 ss.
42 Corte cost., ord. n. 130 del 1971.
43 “Non è ammissibile un’azione di fronte a un giudice comune che abbia come pretesa la (sola) dichiarazione di incostituzionalità della legge. Occorre che l’attore o il ricorrente abbiano di mira il soddisfacimento di una diversa e concreta pretesa; rispetto alla quale la dichiarazione di incostituzionalità si ponga come strumentale. Se non fosse così, si avrebbe un’alterazione di senso del sistema incidentale.” in G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, p. 195.
D’altronde risulta evidente quanto possa essere insidioso e di ardua argomentazione sostenere che il giudizio principale riconosca davvero qualcosa in più rispetto a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sua pronuncia, e che in definitiva residuino margini per un intervento non meramente ricognitivo da parte della Cassazione44. Non risulta affatto di facile individuazione quella tutela di accertamento-costitutiva che si vorrebbe autonoma competenza della Suprema Corte, al netto della intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale: una volta depurate le leggi elettorali delle disposizioni contrarie ai principi della Carta, i ricorrenti avrebbero di per sé ottenuto la completa tutela del proprio diritto di voto, attraverso il ripristino di questo nella sua integrità e la possibilità di poter tornare ad esercitarlo conformemente a Costituzione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, da un punto di vista prettamente sostanziale, l’oggetto del giudizio a quo si riduce alla questione di legittimità costituzionale.
L'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e l'art. 23 della legge n. 87/1953 richiedono che la questione di costituzionalità sia sollevata “nel corso di un giudizio” e la Corte intende l'incidentalità della questione nel senso che il giudizio a quo deve avere un oggetto che non coincide con la questione di costituzionalità: l'eventuale sentenza di accoglimento non deve esaurire la tutela richiesta dall'attore, nel senso che al giudice a quo deve restare qualcosa da decidere relativamente alla domanda originaria. Dal punto di vista formale, l'ordinanza della Cassazione rispetta le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, perché l'attore non ha semplicemente chiesto al giudice ordinario di sollevare la questione di costituzionalità, ma ha chiesto in primo luogo una pronuncia di accertamento di un diritto, oltre alla condanna alle spese45.
19
44 Anzon afferma che “la “riespansione” del diritto asseritamente leso si produrrebbe come automatica conseguenza dell’annullamento del “porcellum” – e cioè dell’eliminazione dei censurati limiti che esso impone al diritto di voto – e che la pronuncia conclusiva del giudizio a quo sarebbe solo ricognitiva dell’effetto ripristinatorio già prodotto dalla sentenza costituzionale”, in A. Anzon-Demmig, Un tentativo coraggioso, cit.; per F. Dal Canto “non è ben chiaro [...] in cosa si sostanzi, in concreto, quella “portata più ampia” che dovrebbe riconoscersi alla decisione della Corte di cassazione rispetto alla “naturale portata” della pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale”, in F. Dal Canto, La legge elettorale dinanzi alla Corte costituzionale: verso il superamento di una zona franca?, in www.forumcostituzionale.it, 14 giugno 2013.
45 Come d’altronde conferma la sentenza pronunciata dalla Cassazione alla riassunzione del giudizio principale, con la quale i supremi giudici hanno ammesso che “la tutela riconosciuta dall’ordinamento ai ricorrenti elettori, oltre all’accertamento per il passato della lesione subita e del diritto al rimborso delle spese sostenute per conseguire tale risultato processuale [...], è quella, pienamente satisfattiva, della riparazione in forma specifica per effetto della sentenza costituzionale che ha ripristinato la legalità costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali”, in Cass. sent. n. 8878 del 2014, n. 5 dei Motivi della decisione.
Nel momento in cui postula una separazione tra le due sfere di giudizio fondata sul diverso grado di diffusione delle due pronunce – limitata al caso di specie l’una, con effetti erga omnes l’altra –, l’ordinanza sembra fare propria un’accezione squisitamente formale del rapporto di incidentalità, che non trova precedenti utili nella giurisprudenza della Corte, per l’ovvia ragione che, ad intenderlo davvero così, esso si rivelerebbe sempre e comunque sussistente e quindi non avrebbe alcun ruolo nel filtrare tra le questioni pretestuose le questioni autenticamente incidentali46.
Altrettanto sminuito, secondo questa dottrina, risulterebbe il requisito della rilevanza, poiché “se per rilevanza si intende il rapporto di necessario condizionamento che, sulla risoluzione della controversia demandata al giudizio principale, esercita il giudizio affidato alla Corte costituzionale, pare evidente che nei casi di lis ficta questo condizionamento non può che esservi sempre e necessariamente”47. D’altronde con la formula fictio litis pure s’intende, in senso lato, la controversia provocata intenzionalmente e strumentalmente per poter sollevare la questione incidentale48: la lite in tal senso congegnata può considerarsi ammissibile sotto il profilo della rilevanza, in quanto una controversia esiste effettivamente, giacché, come si è scritto poc’anzi, non spetta alla Corte costituzionale indagare per quali motivi ultimi essa è venuta a determinarsi49 50.
20
46 G. Repetto, Il divieto di fictio litis come connotato della natura incidentale del giudizio di costituzionalità, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 21 settembre 2013.
47 Ibidem. L’autore sostiene che “il privato lamenta esclusivamente l’incostituzionalità di una legge e solo in ciò si riassumono i termini dell’invocata tutela giurisdizionale. Esaurendosi la sua pretesa nell’accoglimento della questione di costituzionalità, quest’ultima finisce quindi per essere sempre rilevante, quasi per definizione, perché il condizionamento operato sul giudizio a quo dal sindacato di costituzionalità è con tutta evidenza massimo, se non totale”.
48 Sull’argomento è esaustiva Olivito: “le finzioni processuali intervengono, infatti, quando, pur mancando i requisiti formali prescritti dall’ordinamento per l’esperimento di un rimedio processuale ovvero per la corretta instaurazione di un giudizio, il giudice si adopera affinché, tramite un artificio, quei requisiti siano ciononostante ritenuti esistenti. Ciò vuol dire che il ricorso a espedienti di carattere finzionale non solo implica un intervento attivo del giudice, ma soprattutto presuppone l’accettazione di tale pratica da parte di chi ne è destinatario. La finzione, difatti, è in grado di produrre i suoi effetti, a condizione che essa sia riconosciuta e accolta, da coloro ai quali si rivolge, per ciò che è e per gli obiettivi che mediante il suo impiego si intendono raggiungere” in E. Olivito, Fictio litis e sindacato di costituzionalità della legge elettorale. Può una finzione processuale aprire un varco nelle zone d’ombra della giustizia costituzionale?, in www.costituzionalismo.it, 16 settembre 2013.
49 G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, p. 286.
50 Cfr. Corte cost., sentt. n. 62 del 1992, 263 del 1994, 441 del 2006, 241 del 2008.
Dunque, la Corte costituzionale giudica sulla legge, il giudice ordinario sul diritto dell'attore, ed è certo che il giudizio di accertamento non può essere definito “indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” 51. Ciò che conta, in definitiva, è che esistano un giudizio avente un proprio oggetto e la pregiudizialità della questione di costituzionalità, stanti i presupposti processuali e le condizioni dell’azione52: se ciò si verifica, anche in assenza di un precedente atto applicativo o lesivo, vuol dire che la legge ha inciso direttamente sui diritti e che, dunque, la ratio del giudizio incidentale è soddisfatta53.
Per concludere su questo primo punto, emergono con chiarezza gli sforzi della Cassazione di mascherare l’artificio al quale è ricorsa, la giustificazione della lis ficta quale pregevole espediente utilizzato per ottenere un accesso alla Consulta altrimenti impossibile. L’importante differenza rispetto al passato è che, in questo caso particolare, l’esistenza di una lis ficta non ha portato all’inammissibilità della questione di legittimità, bensì ha richiesto una considerazione delle ragioni che hanno spinto a tale passo e, come auspicato da più parti, un cambiamento della giurisprudenza costituzionale sul punto. Non è detto, cioè, che debba sempre esservi automatica corrispondenza tra fictio litis e inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, potendo darsi ipotesi in cui, al contrario, la finzione processuale conduce a un’incidentalità sì artificiosa, ma che la Corte costituzionale a certe condizioni è disposta ad accettare. Condizioni che tanto la Suprema Corte quanto la Consulta non risparmiano di evidenziare nelle rispettive decisioni. Prosegue infatti il giudice costituzionale affermando che “l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso di tale giudizio si desume precisamente dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento; dall’altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata”54.
21
51 Cfr. art. 23 l. n. 87 del 1953.
52 A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano 2012, pp. 152 ss., nel quale l’autore si spinge ad affermare che “la via incidentale del controllo di costituzionalità divide [...] in due competenze (del giudice a quo e della Corte) quella che potrebbe essere una competenza unica (con disapplicazione incidenter tantum della disposizione incostituzionale); ma tale divisione fra due giudici della competenza di decidere non può comportare una dispersione di garanzie, rendendo non proponibile una domanda che lo sarebbe, ove destinata ad esser decisa da un unico giudice”.
53 C. Padula, Spunti di riflessione sull’azione di accertamento e l’incidentalità nel giudizio di costituzionalità, in www.giurcost.org, 6 settembre 2013.
54 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 2.
La Corte, evidentemente, allo scopo di rafforzare la logicità della motivazione adottata55, evidenzia la peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto di voto, di cui è importante evitare lesioni anche solo potenziali che siano frutto di “una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica”56, dovuta all’entrata in vigore della legge n. 270/2005. Tale diritto assume particolare importanza in virtù del suo fungere da collegamento ad un interesse rilevante della società nel suo insieme, rappresentando il modus exprimendi del corpo elettorale, organo costituzionale che per primo è menzionato in Costituzione.
Il diritto di voto viene infatti raccordato all’art. 1, secondo comma, Cost., assurgendo a principio cardine dell’ordinamento costituzionale, in quanto rappresentante la principale proiezione della sovranità popolare sul piano dei diritti: il legame con la prima disposizione costituzionale consente di trascendere il diritto di voto da situazione giuridica soggettiva a fonte di legittimazione delle istituzioni costituzionali. Emerge allora tutta la rilevanza del voto quale elemento che fonda la democrazia rappresentativa e che conferisce il suggello della democraticità all’impianto istituzionale. Infatti, interpretato alla luce dell’art. 1, secondo comma, Cost., il diritto di voto assume una valenza sistemica e, collegandosi direttamente alla sovranità popolare quale sua principale ed immediata esplicazione, consente la proiezione della volontà politica del corpo elettorale in Parlamento. In questa prospettiva la necessità di assicurare la piena realizzazione del diritto di voto coincide con l’esigenza di garantire l’investitura democratica degli organi dello Stato e si realizza apprestando tutte le garanzie idonee tanto ad impedire condizionamenti illegittimi nel processo di formazione della volontà elettorale, quanto ad escludere macroscopiche distorsioni nella sua concreta traduzione in seggi.
Ad ultimo, prima di esaminare nel merito la questione sollevata, la Corte richiama altresì il principio di costituzionalità, secondo il quale il controllo di legittimità costituzionale “deve coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico”57.
22
55 La scelta è stata additata come excusatio non petita da Pertici, il quale ha criticato le ulteriori motivazioni addotte dalla Corte “senza che forse ce ne fosse a quel punto bisogno, ed anzi rischiando così di indebolire la propria precedente argomentazione”, in La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore), in www.forumcostituzionale.it, 4 febbraio 2014; ma v. anche M. Benvenuti, Zone franche che si chiudono e zone d’ombra che si aprono, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 29 gennaio 2014.
56 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 2.
57 Affermato la prima volta in Corte cost., sent. n. 387 del 1996 Considerato in diritto n. 2.2.
Ciò consente alla Corte di affermare il proprio sindacato anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, “che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte”58, perché “diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso si determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato”59.
Dopo aver profuso indubbio impegno nel fornire una motivazione formalmente corretta che permettesse di “tenere aperte le porte” alla finzione processuale ben argomentata dalla Cassazione, la Corte ricorre dunque a due questioni di fondamentale importanza per il diritto costituzionale – quali l’elevato valore del diritto di voto in una repubblica parlamentare e la necessità di coprire una vistosa zona franca del giudizio di costituzionalità – al fine di avvalorare l’inedita scelta di ammettere una questione di legittimità costituzionale sulla legge elettorale.
3. Nel merito della sentenza
1. La Corte costituzionale principia quindi l’esame nel merito delle questioni prospettatele da quella riguardante il premio di maggioranza assegnato per l’elezione della Camera dei deputati. L’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, così come modificato dalla legge 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale nazionale verifichi “se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi”, sulla base dell’attribuzione di seggi in ragione proporzionale, e stabilisce, in caso negativo, che ad essa venga attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza60: la censura riguarda la mancata previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi per il conseguimento del premio di maggioranza.
23
58 Nel percorso argomentativo la Corte richiama le sentt. n. 384 del 1991 e 226 del del 1976, con le quali ha riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di controllo, a promuovere il sindacato di costituzionalità delle leggi di spesa in riferimento ai profili di copertura finanziaria posti dall'osservanza dell'art. 81 della Costituzione.
59 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 2.
60 Cfr. l’art. 83, primo comma, n. 5, e secondo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957.
Tale assenza costituisce una differenza di non poco conto tra la legge n. 270/2005 e le due leggi elettorali più contestate nella storia dell’Italia unitaria, vale a dire la cd. “legge truffa” (n. 148/1953) e addirittura la “legge Acerbo” (n. 2440/1923), le quali prevedevano entrambe (pur soltanto pro forma nel secondo caso) una percentuale minima di voti per l’assegnazione del consistente premio di maggioranza61.
Come prima cosa, la Corte sottolinea che “non c’è, in altri termini, un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico” 62, ricordando come l’Assemblea costituente, pur avendo manifestato favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera, non intese costituzionalizzare alcuna indicazione in proposito63.
I giudici costituzionali affermano quindi che il principio di eguaglianza del voto esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in condizione di parità, senza che ciò si estenda al concreto risultato della manifestazione di volontà dell’elettore, che dipende esclusivamente dal sistema elettorale adottato. La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che tale principio operi solo “in entrata”, ossia nel momento in cui il voto stesso è espresso, e non anche “in uscita” 64: l’art. 48 Cost. non si estende dunque al risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore “che dipende, invece, esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari”65.
24
61 Mentre la legge n. 148 del 1953 subordinava il premio alla lista (od alla coalizione), in misura pari al 64% dei seggi, al conseguimento della maggioranza assoluta dei voti, la legge n. 2440 del 1923, viceversa, prevedeva l’attribuzione dei due terzi dei seggi alla lista che avesse ottenuto almeno il 25% dei voti.
62 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 3.
63 G. T. Barbieri, la spada di Damocle sul porcellum: alcune note sparse in vista dell’imminente pronuncia della Corte costituzionale sulla l. 270/2005, in www.osservatoriosullefonti.it, 3, 2013.
64 Appare opportuno ricordare quanto scritto da Carlassare in merito al combinato disposto del premio di maggioranza e delle elevate soglie di sbarramento, istituti che, analizzati in un’ottica sistematica, opererebbero un’alterazione dell’eguaglianza del voto tanto successiva (nella trasformazione in seggi) quanto preventiva (nel tacito invito al “voto utile”), configurando “una novità in grado di incidere sulla stessa eguaglianza del voto in partenza, considerata ormai fuori discussione”. L’analisi è ripresa da L. Carlassare, Maggioritario, in www.costituzionalismo.it, 23 aprile 2008.
65 Corte cost., sent. n. 43 del 1961, Considerato in diritto n. 2.
Quanto detto, tuttavia, non implica che qualunque correttivo all’esercizio del voto possa tradire la volontà politica del corpo elettorale, operando una distorsione dell’esito delle votazioni tale da rappresentare uno o più partiti in modo sproporzionato, irrazionale ed avulso dalla concreta espressione di voto. L’affermazione costituzionale del voto eguale pone senz’altro un divieto di voto plurimo e multiplo66, senza nulla imporre in merito “al peso concreto che il singolo voto, sulla base del sistema elettorale adottato, assume rispetto a tutti gli altri voti espressi nella medesima consultazione elettorale al fine della determinazione degli effetti”, salvo in ogni caso il controllo di ragionevolezza67. Ed è appunto sotto la lente della ragionevolezza che la Corte scruta la riforma elettorale, puntualizzando che “il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole”68 e richiamando la propria pregressa giurisprudenza69 dove pure aveva invitato il Parlamento a considerare i punti problematici della disciplina ed i relativi profili di irrazionalità70.
La Corte ritiene pertanto che le disposizioni censurate non superino lo scrutinio di proporzionalità71 e ragionevolezza, poiché il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti è stato realizzato “con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale” 72.
25
66 “Nel caso di voto plurimo, l’elettore ha la possibilità di esprimere più voti, cioè un numero di voti superiore rispetto a quello riconosciuto ad altri consociati. Il voto plurimo è stato sperimentato durante la Rivoluzione sovietica, quando il voto degli operai aveva un “peso” superiore al voto dei contadini. Nel caso di voto multiplo, l’elettore può votare in più circoscrizioni, per cui alcuni soggetti (ad esempio, titolari di cariche accademiche o di uffici pubblici) sono legittimati a votare sia nel collegio di residenza, sia nel diverso collegio in cui svolgono la carica o l’ufficio. Il voto multiplo fu utilizzato in Inghilterra fino al 1948 per consentire ad alcuni esponenti dell’aristocrazia, in nome di antichi privilegi, di votare in due collegi”. L’interessante ricostruzione è di F. Sgrò, La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il ripristino del sistema proporzionale: qualche considerazione sull’equilibrio tra rappresentanza politica e governabilità, in www.forumcostituzionale.it, 7 febbraio 2014.
67 Corte cost., sent. n. 107 del 1996, Considerato in diritto n. 2.1.
68 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 3.
69 Corte cost., sentt. n. 242 del 2012, 107 del 1996; ord. n. 260 del 2002.
70 Sono richiamate le tre sentenze con cui la Corte in precedenza aveva dichiarato inammissibile la quaestio, vale a dire Corte cost., sentt. n. 15 e 16 del 2008 e n. 13 del 2012.
71 Il principio di proporzionalità ha una chiara matrice comunitaria e trova esplicito riconoscimento, insieme al principio di sussidiarietà, nell’art. 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE).
72 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 3.
Le disposizioni censurate, non subordinando l’attribuzione del premio al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta73, in una maggioranza assoluta di seggi, hanno per effetto di configurare un meccanismo premiale manifestamente irragionevole, lesivo della rappresentanza democratica e della stessa uguaglianza del voto. Tale distorsione non può essere giustificata con l’esigenza di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale74 perché tali esigenze, pure costituzionalmente rilevanti, possono giustificare una limitata deroga al principio della rappresentanza, e conseguentemente la sottrazione alla minoranza di un certo numero di seggi, ma non una sproporzione talmente grave da risultare irragionevole e, quindi, lesiva dell’art. 3 Cost. Oltretutto, con uno sguardo ai risultati conseguiti, il meccanismo del premio non può impedire che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o alcuni partiti che ne facevano parte ne escano75.
Il correttivo in esame, ulteriore rispetto a quello già costituito dalla previsione di soglie di sbarramento all’accesso, rovescia la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare76. Senza l’imposizione del raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista/coalizione di maggioranza relativa, quest’ultima può ottenere quasi il doppio dei seggi cui avrebbe diritto in un sistema proporzionale puro77, con il risultato di una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare.
26
73 Il pensiero va naturalmente alle elezioni del 2013, quando la coalizione più votata, quella di centrosinistra, ha conseguito il 55% dei seggi alla Camera pur avendo ottenuto appena il 29,55% dei voti nelle circoscrizioni del territorio nazionale: la distorsione dovuta all’attribuzione del premio di maggioranza è stata in questo caso palese, a differenza delle elezioni del 2006 e del 2008.
74 Obiettivo che tuttavia emerge diffusamente dai lavori preparatori, v. ad esempio le schede sul portale http://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=5613.
75 Come si è effettivamente verificato a seguito delle elezioni del 2013, quando SEL ha abbandonato la coalizione di centrosinistra all’alba delle ccdd. larghe intese. Il fenomeno risulta ancora più paradossale se si osserva che senza i voti di SEL la coalizione di centrosinistra sarebbe arrivata seconda.
76 L’art. 1, comma secondo, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede un sistema di trasformazione dei voti in seggi “in ragione proporzionale”.
77 Secondo le analisi di Pinna, “senza premio di maggioranza” per ottenere i 340 seggi attribuiti alla coalizione di centrosinistra “sarebbero stati necessari grosso modo 18.600.000 voti”: ne consegue che “i circa 10.000.000 di voti effettivamente riportati sono stati fatti valere 18.600.000”. L’estratto proviene da P. Pinna, Il premio di maggioranza inutile e incostituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 2, 2013.
La Corte evidenzia che tale alterazione è incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali
“le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.)”78.
Il richiamo all’art. 138 Cost. e alle leggi di revisione della Costituzione è stato da taluni interpretato nel senso che le camere, elette sulla base di una legge elettorale dichiarata incostituzionale per i motivi appena esposti, per quanto legittime, non avrebbero tuttavia la legittimazione per riformare la Costituzione, giacché non rappresentative79.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, la Corte richiama una recente sentenza della Corte costituzionale federale tedesca, il Bundesverfassungsgericht80, in ragione della vicinanza tra i due sistemi di giustizia costituzionale continentali e delle tematiche affrontate nel corso del giudizio, offrendo un perfetto esempio di dialogo tra corti, nella prospettiva di un ordinamento giuridico europeo imperniato su valori condivisi. Scrivono i giudici che
“in ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano [...] il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare”81.
27
78 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 3.
79 Carnevale afferma che “le Camere sarebbero da considerarsi legittimate alla approvazione della sola legislazione necessaria a consentirne il rinnovo – la legge elettorale, appunto – o che, comunque, si presenti come assolutamente improrogabile, parallelamente a quanto alle stesse è consentito in regime di prorogatio ex art. 61 cpv. Cost.” in P. Carnevale, La Corte vince ma non (sempre) convince, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 29 gennaio 2014; v. anche M. Villone, La bilancia della Corte, in Il Manifesto, 21 gennaio 2014; A. Riviezzo, Nel giudizio in via incidentale in materia elettorale la Corte forgia un tipo di dispositivo inedito: l’annullamento irretroattivo come l’abrogazione, in www.forumcostituzionale.it, 10 marzo 2014.
80 Bundesverfassungsgericht, sent. n. 3/11 del 2012.
81 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 3.
Con la dichiarazione di illegittimità costituzionale del premio di maggioranza, tuttavia, la Corte non esprime alcun giudizio sul sistema elettorale più consono a Costituzione e sulla opportunità di correttivi. Deve all’uopo precisarsi che il principio di eguaglianza del voto viene connotato da sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto, e ciò si riflette in un diverso giudizio sul grado di distorsione del voto costituzionalmente compatibile con la complessiva ratio del sistema elettorale in questione. In particolare, nell’ambito di sistemi proporzionali, che privilegiano l’esigenza di rappresentatività dell’assemblea parlamentare, cioè della maggiore aderenza possibile fra le divisioni esistenti in Parlamento e le divisioni politiche presenti nella società, il principio di eguaglianza del voto assume un carattere più stringente che nell’ambito di sistemi maggioritari, i quali, accanto all’esigenza di rappresentatività, fanno valere la legittima esigenza di garantire la stabilità di governo.
Il modello proporzionale, inoltre, genera l’aspettativa che i meccanismi distorsivi del voto non alterino radicalmente il risultato della scelta degli elettori in termini di seggi: in tal caso, infatti, sarebbe contraddetta l’opzione fondamentale sottesa alla formula proporzionale, che è un’opzione per la rappresentatività, e solo subordinatamente per la governabilità82. Il sistema maggioritario, che al contrario privilegia l’esigenza di governabilità su quella di rappresentanza, può incorporare meccanismi di più marcata distorsione del voto. La Corte costituzionale ha semplicemente statuito che, una volta adottato da parte del legislatore un sistema elettorale di tipo proporzionale, non è possibile prevedere correttivi talmente distorsivi da stravolgerne completamente la fisionomia, perché altrimenti verrebbe alterata significativamente la composizione della rappresentanza democratica sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente e ne risulterebbero frustrate le aspettative del corpo elettorale.
2. La medesime argomentazioni sono quindi utilizzate in relazione alle censure rivolte, sulla base degli stessi parametri costituzionali, nei confronti dell’art. 17, commi secondo e quarto, del d.lgs.vo n. 533 del 1993, che disciplina il premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica prevedendo un meccanismo analogo relativamente alla singola circoscrizione, coincidente con il territorio regionale.
28
82 G. Lodato, S. Pajno, G. Scaccia, Quanto può essere distorsivo il premio di maggioranza?, in www.federalismi.it, 22 aprile 2014.
Anche in questo caso lo scrutinio di proporzionalità evidenzia, anzitutto, la mancata previsione di una soglia minima di voti per accedere al premio di maggioranza del 55% dei seggi; tuttavia, quel che balza all’occhio è l’intrinseca irrazionalità dei premi attribuiti su base regionale, che rappresenta emblematicamente l’inidoneità della censurata disciplina al raggiungimento dell’obiettivo perseguito. Infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza avviene su scala regionale, ha per effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale dell’addizione dei singoli premi regionali, che possono a seconda del caso annullarsi l’un con l’altro, arrivando a rovesciare il risultato complessivamente ottenuto dalle liste/coalizioni: pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea, dunque, è ben possibile che il meccanismo dei premi favorisca la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, potendo aversi al Senato una maggioranza appena sufficiente per governare così come una minoranza83. Ciò rappresenta un rischio di particolare gravità secondo la Corte, perché mette a repentaglio “sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato” 84.
Analoghe osservazioni erano state avanzate dalla Cassazione nell’ordinanza di rimessione, in cui aveva parlato di “sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni di lista su base nazionale”85, evidenziando tanto la dannosità della previsione di singoli premi su base regionale quanto l’inutilità in concreto, nella contezza che le diverse maggioranze regionali non avrebbero avuto mai modo di esprimersi e di avvantaggiarsi del premio ottenuto, perché il Senato è un’assemblea unitaria ed il governo è nazionale.
29
83 Questo è quanto si è verificato due volte su tre nelle elezioni che hanno visto alla prova la legge n. 270 del 2005: nel 2006 la coalizione di centrosinistra si è trovata a governare con 158 senatori, appena la maggioranza, pur avendo preso nel complesso meno voti della coalizione avversa al Senato; il 2008 ha visto l’unica applicazione fortunata della legge elettorale, cha ha consegnato una solida maggioranza in entrambe le camere al centrodestra; nel 2013, infine, si è ripetuta la roulette dei premi regionali (il centrodestra ha ottenuto al Senato tre scranni in più del centrosinistra, pur avendo preso meno voti), questa volta con l’ingresso di altri attori politici a rottura del bipolarismo.
84 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 4.
85 Cass. civ., ord. n. 12060 del 2013, n. 8.1 dei Motivi della decisione.
Tale rilievo, come segnala la Consulta, risulta ancora più persuasivo alla luce del modello di bicameralismo perfetto che connota l’assetto parlamentare italiano, con le due camere che esercitano collettivamente la funzione legislativa e sono coinvolte in maniera paritaria nel rapporto fiduciario con il Governo.
Un ultimo rilievo di costituzionalità attiene alla diversa dimensione del premio, in termini assoluti, tra le regioni, essendo maggiore in quelle più popolose86, “con l’effetto che il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) è diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori”87. Deve altresì considerarsi che la disciplina della distribuzione del premio di maggioranza ha contribuito ad accentuare gli effetti perversi della lotteria, anche se in una direzione diversa da quella enunciata dall’ordinanza che, come si è detto, allude ad una diversa dimensione quantitativa del premio tra le diverse regioni. Infatti, la misura del premio regionale, pari al 55% dei seggi, è arrotondata all’unità superiore88. Questa previsione non si è dimostrata affatto neutrale, avendo, tra l’altro, comportato un aumento di fatto del premio nella maggior parte delle regioni89 90. Ciò contribuisce ad accrescere la rilevanza di quelle regioni nelle quali la differenza in termini di seggi tra la coalizione premiata e le altre è maggiore, ancorché il numero di seggi assegnati sia in partenza minore: si tratta quindi di un sistema assolutamente irrazionale che non può che produrre esiti caotici.
È noto che la scelta del legislatore elettorale di prevedere, limitatamente al Senato, il sistema dei premi regionali deriva da un rilievo informale del Capo dello Stato, sul presupposto dell’incostituzionalità della previsione di un premio di maggioranza nazionale per violazione dell’art. 57, comma 1, Cost., ai sensi del quale “il Senato è eletto a base regionale”.
30
86 Tant’è che nella cronaca politica italiana si è parlato diffusamente di “regioni chiave”: nell’esercizio del paragone con gli stati confederati che compongono gli Stati Uniti d’America, si è più volte accostato il decisivo Ohio alla Lombardia ed alla Sicilia.
87 Cass. civ., ord. n. 12060 del 2013, n. 8.2 dei Motivi della decisione.
88 Cfr. art. 17, secondo comma, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dall’art. 4 della legge n. 270 del 2005.
89 Basti pensare che, per effetto dell’arrotondamento per eccesso, il premio di maggioranza è stato in molte regioni ben al di sopra del 55% dei seggi: ha raggiunto il 57% in Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo e Basilicata, il 58% in Veneto, il 59% in Piemonte ed Emilia-Romagna, fino ai picchi del 60% in Calabria e di oltre il 62% in Liguria e Sardegna.
90 G. T. Barbieri, la spada di Damocle sul porcellum: alcune note sparse in vista dell’imminente pronuncia della Corte costituzionale sulla l. 270/2005, in www.osservatoriosullefonti.it, 3, 2013.
Tuttavia, la dottrina maggioritaria ritiene che tale disposizione costituisca la testimonianza di un disegno istituzionale assai più vasto, ma perdente in Assemblea costituente, che vedeva nella camera alta il luogo di rappresentanza delle autonomie territoriali. In tal senso, ormai riferendosi ad una assemblea eletta a suffragio universale ed inserita nel circuito fiduciario e nel procedimento legislativo, nel quadro di un sistema bicamerale paritario, appare priva di ragione una lettura così stringente91.
La scelta di assegnare il premio su scala regionale, in conclusione, tradisce la stessa ratio del premio di maggioranza che, laddove previsto, non può non servire ad agevolare la governabilità; ciò, unitamente alla mancata previsione di una soglia minima di voti per l’attribuzione del premio, porta la Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi secondo e quarto, del d.lgs.vo n. 533/1993, per manifesta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
3. Le ultime censure portate all’attenzione della Corte sono relative all’art. 4, cpv., del d.P.R. n. 361/1957 e, in via consequenziale, all’art. 59, primo comma, dello stesso d.P.R., nonché all’art. 14, primo comma, del d.lgs.vo n. 533/1993 nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere alcuna preferenza, dovendo egli limitarsi a scegliere tra singole liste di candidati predisposte dai partiti: secondo il rimettente, tali disposizioni renderebbero il voto sostanzialmente indiretto, giacché i partiti romperebbero quel legame con l’elettorato di cui all’art. 67 Cost., e risulterebbero altresì violati gli artt. 56, 58 e 48 Cost. che parlano di “suffragio universale e diretto”, nonché di voto personale e libero, e finanche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del protocollo I della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla “scelta del corpo legislativo”. Effettivamente la scelta dell’elettore appare quantomeno mortificata, traducendosi in un voto di preferenza esclusivamente per la lista che, poiché presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, contiene un numero elevato di candidati – talvolta corrispondenti all’intero numero di seggi assegnati alla circoscrizione – e li rende, conseguentemente, difficilmente conoscibili dall’elettore.
31
91 Scrive Barbieri che “l’art. 57, comma 1, Cost. si presta quindi ad essere interpretato più restrittivamente, come un mero vincolo al legislatore elettorale ad individuare circoscrizioni elettorali coincidenti con il territorio regionale, non precludendo la possibilità di prevedere meccanismi di assegnazione dei seggi (o di una quota di seggi) a livello nazionale, purché anch’essi tratti dalle circoscrizioni regionali” in G. T. Barbieri, la spada di Damocle sul porcellum: alcune note sparse in vista dell’imminente pronuncia della Corte costituzionale sulla l. 270/2005, in www.osservatoriosullefonti.it, 3, 2013.
La Corte rileva come una simile disciplina privi l’elettore di ogni margine di scelta nell’elezione dei propri rappresentanti, rimettendola totalmente alle segreterie dei partiti che predispongono le liste e stabiliscono l’ordine dei candidati. Richiamando una precedente pronuncia in merito ai partiti politici, ai quali aveva riconosciuto, pur in assenza di attribuzioni costituzionali, la funzione di “presentazione di alternative elettorali” e di “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” tra quelle loro attribuite dalla legge92, la Corte precisa che “simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati” 93. In una precedente decisione, che pure viene richiamata dal giudice costituzionale, era stata dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, dove questo lascia ai partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature, considerato che non ne deriva alcuna lesione per la libertà di voto del cittadino, a condizione che quest’ultimo sia “pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza”94. Tuttavia è da ritenere che sia il sistema di elezione nel suo complesso ad essere criticato dalla Corte, anziché la sola previsione di liste bloccate, che è del resto sperimentata in molti altri paesi, anche in Europa95. Infatti la Corte punta l’accento sull’aspetto della conoscibilità dei candidati, resa evidentemente incerta dagli elenchi molto lunghi, specialmente nelle circoscrizioni più popolose, e sulle aspettative degli elettori che facilmente possono essere deluse, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà, per l’eletto, di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito.
32
92 Corte cost., ord. n. 79 del 2006.
93 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 5.1.
94 Corte cost., sent. n. 203 del 1975, Considerato in diritto n. 3.
95 In Germania, ad esempio, la metà dei seggi del Bundestag è eletta con un sistema proporzionale basato su liste bloccate; il sistema delle liste bloccate, almeno con riferimento all’elezione di una delle camere legislative, è fatto proprio, in tutto o in parte, da ben tredici stati membri della CEDU su ventidue: Germania, Bulgaria, Croazia, Spagna, Federazione Russa, Georgia, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Serbia, Svezia, Turchia e Ucraina. Anche in Italia, del resto, il sistema elettorale per il Senato non ha mai contemplato la possibilità per l’elettore di esprimere uno o più voti di preferenza.
Dunque, ciò che rende la legge n. 270/2005 assai discutibile non è il sistema in sé delle liste bloccate, quanto, per così dire, il combinato disposto della scelta del legislatore di liste bloccate lunghe, della riconosciuta possibilità di candidarsi in tutte le circoscrizioni ed, infine, della assenza di una legislazione che imponga meccanismi di selezione partecipata delle candidature; le quali tre scelte escluderebbero, tanto in un momento antecedente quanto successivo alla formazione delle liste, alcuna possibilità di intervento partecipativo dell’elettore, col risultato sostanziale che il suo voto, una volta scelta la lista, finirebbe con l’essere la mera ratifica di scelte eseguite a monte e/o a valle dalla segreteria del partito. In questo contesto è opportuno valutare anche il terzo elemento, ormai evidenziato dalla dottrina maggioritaria, ovvero l’assenza di una legge, attuativa dell’art. 49 Cost., che imponga almeno meccanismi di partecipazione e di trasparenza nella determinazione delle candidature96.
La Corte afferma che “è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”, precisando che la disciplina in esame non è “comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali”97. Dal ragionamento pare evidente che se la legge avesse previsto circoscrizioni di ridotte dimensioni avrebbe quantomeno attenuato gli effetti dell’assenza della possibilità di scelta degli elettori, giacché in questo caso liste plurinominali corte avrebbero potuto essere assimilate, dal punto di vista dell’elettore, a collegi uninominali. Se, al contrario, la lunghezza delle liste si accompagna alla facoltà per i candidati di presentarsi in tutte le circoscrizioni, viene impedito agli elettori di avere un’idea anche solo approssimativa di quali avrebbero potuto essere gli eletti nella propria circoscrizione.
33
96 Scrive Ferrari che “l’assenza di una vera democrazia interna nelle associazioni partitiche circoscrive l’ambito di legittimità costituzionale delle scelte elettorali. Ciò che pare astrattamente possibile in assenza di riferimenti normativi precisi – le liste bloccate – diviene costituzionalmente illegittimo preso atto del perdurante stato omissivo della legislazione elettorale e non”, in F. Ferrari, Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità, in www.forumcostituzionale.it, 21 gennaio 2014.
97 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 5.1.
Peraltro nella prassi questa possibilità ha dato luogo ad effetti paradossali e censurabili attraverso il meccanismo dell’opzione, che spesso ha riguardato una pluralità di candidati nella stessa lista98.
Rilevando che le disposizioni censurate sono “tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti” e che, “impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori [...] e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà di voto di cui all’art. 48 Cost.”, la Corte ne dichiara l’illegittimità costituzionale “nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l’elezione”99.
Dopo essersi espressa con una pronuncia di incostituzionalità secca in relazione alle prime due quaestiones, la Consulta sceglie infine una pronuncia manipolativa additiva 100 per quanto concerne il tema delle p r e f e r e n z e , n o n r i s u l t a n d o p o s s i b i l e u n a i n t e r p r e t a z i o n e costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate. La sentenza si preoccupa di precisare, oltretutto, che la normativa che resta in vigore è “complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo”101. La Corte richiama una recente pronuncia in tema di ammissibilità del referendum al fine di ricordare che la costante giurisprudenza costituzionale ritiene le leggi elettorali costituzionalmente necessarie, in quanto “indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali”102: pur essendo le pronunce della Corte ed il referendum due strumenti distinti e dagli effetti diversi, nel caso in cui essi siano rivolti contro la legge elettorale deve essere egualmente assicurata l’immediata possibilità di procedere ad elezioni con la restante normativa.
34
98 Basti pensare che nelle elezioni del 2006 ben 200 deputati e 33 senatori sono stati proclamati solo in sede di apertura della legislatura.
99 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 5.1.
100 Le sentenze manipolative “hanno per effetto di “far dire” alla disposizione cui si riferiscono qualcosa di diverso, e di solito qualcosa di più, rispetto a quello che ne era l’originario significato (sentenze additive). [...] Sentenze di questo tipo, mentre da un lato, segnano il punto estremo di espansione dei poteri della Corte, d’altro lato, essendo “autoapplicative”, tendono a soddisfare per intero l’esigenza di non creare “vuoti” nel diritto oggettivo”, da V. Crisafulli, Giustizia costituzionale e potere legislativo, in Scritti in onore di Costantino Mortati, I, Padova,1985, p. 299.
101 Corte cost., sent. n. 13 del 2012, Considerato in diritto n. 4.
102 Ibidem. Analogamente, Corte cost., sentt. n. 15 e 16 del 2008, 13 del 1999, 26 del 1997, 5 del 1995, 32 del 1993, 47 del 1991, 29 del 1987.
In caso contrario, oltre a porre in essere una lesione permanente ed ancora più grave del diritto di voto, si potrebbe incorrere nel concreto rischio di paralizzare il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere, previsto dall’art. 88 Cost.
Il sistema elettorale venuto a delinearsi a seguito della sent. n. 1 del 2014 è dunque un meccanismo di attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, depurato dall’assegnazione di qualsiasi premio di maggioranza, con l’integrazione delle disposizioni relative all’espressione del voto in maniera tale da consentire un voto di preferenza. In particolare la Corte, cogliendo l’invito della Cassazione a “ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati, senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali”, attraverso “un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo [...], avvalendosi dei suoi poteri (in specie di quelli di cui all’art. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953)” 103, si preoccupa di precisare che eventuali inconvenienti dovuti all’integrazione dell’obbligo di preferenza con la preesistente disciplina legislativa non incidono sull’operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell’organo, e “possono essere risolti mediante l’impiego degli ordinari criteri di interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già vigenti coerente con la pronuncia di questa Corte: [...] ad esempio, [...] dovendosi ritenere l’ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza”104. Precisa inoltre che gli eventuali inconvenienti potranno essere rimossi anche mediante “interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate” 105, fermo restando il potere (dovere) del legislatore, ove lo ritenga, di “correggere, modificare o integrare la disciplina residua”106 107.
35
103 Cass. civ., ord. n. 12060 del 2013, n. 5.1 dei Motivi della decisione.
104 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 6.
105 Ibidem.
106 Corte cost., sent. n. 32 del 1993, Considerato in diritto n. 5.
107 Alcuni autori hanno sostenuto, pur riconoscendo l’impossibilità per la Corte di agire diversamente, ad esempio “accorciando” le liste, che si è in presenza di “un’acrobazia interpretativa che non regge” , per c itare A. D’Aloia , La sentenza n. 1 del 2014 e l ’ I ta l icum , in www.confronticostituzionali.eu, 30 gennaio 2014; Morrone si è chiesto se possono bastare “interventi normativi (anche) di natura regolamentare, inidonei, senza una cornice legale prestabilita, a rispettare la riserva di legge in materia elettorale (è sufficiente a questo fine una sentenza della Corte costituzionale?)” in A. Morrone, Exit porcellum, in www.forumcostituzionale.it, 15 febbraio 2014.
Infine, il giudice costituzionale tiene a sottolineare che la sua pronuncia non va ad inficiare gli atti posti in essere dalle camere elette in base alla normativa giustiziata, né tantomeno la legittimità delle stesse, facendo ricorso sia al principio secondo cui la retroattività delle sue sentenze108 “vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida” 109, dando per assodato che “le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti” 110 111; sia al principio fondamentale della continuità dello Stato, “che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali [...] a cominciare dal Parlamento” 112.
A sostegno di questa sua statuizione, la Corte richiama le previsioni di cui agli artt. 61 e 77 Cost., secondo comma, relative rispettivamente alla prorogatio dei poteri delle camere precedenti finché non siano riunite le nuove camere ed alla convocazione e riunione delle camere, pur sciolte, per la conversione in legge dei decreti-legge adottati dal governo. La scelta tuttavia non sembra delle più felici ed appare anzi contraddittoria 113, poiché, invece di irrobustire le argomentazioni ed i principi richiamati, leva loro autorevolezza: le disposizioni costituzionali anzidette, infatti, attribuiscono limitati poteri alle camere sciolte, tenendo in considerazione il calo di legittimazione politica patito da queste per la scadenza del loro mandato ed altresì la necessità di evitare il prodursi di vuoti ordinamentali.
36
108 Prevista dall’art. 136 Cost. e dall’art. 30 della legge n. 87 del 1953.
109 Corte cost., sent. n. 139 del 1984, Considerato in diritto n. 15.
110 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 7.
111 Sul punto è critico Pasquino, il quale viceversa sostiene che “la composizione delle Camere potrebbe essere anche identificata come un processo che non si compie una volta per tutte con la proclamazione degli eletti, ma intesa come un processo riattivabile, ad esempio nei casi di decadenza, dimissioni, o altre cause che determinano la cessazione dello status di parlamentare, determinando ipotesi di sostituzione e dunque sollecitando ciascuna Camera a giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, ex art. 66 Cost.”, in S. Lieto, P. Pasquino, La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n. 1 del 2014, in www.forumcostituzionale.it, 26 marzo 2014; v. anche G. Guzzetta, La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, in www.forumcostituzionale.it, 14 gennaio 2014.
112 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 7.
113 V. supra, alle note 79 e 111.
Queste ultime disposizioni sono semmai prova della conclusione opposta, che, cioè, in quanto ormai sciolte o cessate le camere vedono i propri margini di operatività depotenziati e limitati alla ordinaria amministrazione e a situazioni di emergenza non rinviabili al successivo Parlamento.
È comprensibile che nelle attuali circostanze politico ed economiche la Corte costituzionale non abbia voluto esprimere una sentenza dall’inevitabile valore politico, facendo quanto più possibile ricorso a quella capacità di self-restraint cui non è mai venuta meno nella sua ultracinquantennale carriera; tuttavia, l'argomento della continuità dello Stato avrebbe dovuto essere invocato, semmai, per attenuare gli effetti retroattivi della sentenza, nel senso di consentire al Parlamento, malgrado il travolgimento degli esiti elettorali discendenti dalla decisione, di operare, seppure in condizioni depotenziate, per compiere gli atti strettamente necessari a ripristinare quanto prima la legalità costituzionale violata, nello specifico attraverso la celere approvazione di una nuova legge elettorale114.
37
114 Le peculiari circostanze politiche e socio-economiche che hanno fatto da contesto alla pronuncia della Corte sono invocate da Ruggeri al fine di giustificare determinazioni meno stringenti: “non potendosi tollerare un vuoto di governo nella presente congiuntura, gli organi che stanno al vertice dello Stato non solo possono ma, di più, devono restare al loro posto e fare tutta quanta la loro parte per assicurare la continuità della vita delle istituzioni, malgrado il diverso indirizzo al riguardo consigliato da una rigorosa (ma, nella presente congiuntura, troppo rigida e perciò irragionevole) lettura del dettato della Carta costituzionale, specificamente nella parte in cui richiede l’attivazione di meccanismi di responsabilità politica al servizio del valore democratico, nel suo fare “sistema” coi restanti valori che stanno a fondamento della Repubblica”, in A. Ruggeri, La riscrittura, in un paio di punti di cruciale rilievo, della disciplina elettorale da parte dei giudici costituzionali e il suo probabile “seguito”, in www.giurcost.it, 10 dicembre 2013; v. inoltre l’articolato ragionamento in P. Carnevale, La Corte vince ma non (sempre) convince, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 29 gennaio 2014.
C A P I TO L O T E R Z O
Considerazioni finali
1. Limiti al futuro legislatore elettorale
La sentenza n. 1/2014 per la prima volta ha posto dei paletti precisi all’ampiezza della discrezionalità legislativa in ambito elettorale, pur se muovendo da quello che era l’oggetto del suo giudizio, cioè una legge elettorale proporzionale. Non si potrebbe in alcun modo sostenere che con tale pronuncia la Corte abbia enucleato dal dettato costituzionale una serie di prescrizioni generalmente valide, giacché singole disposizioni della legge n. 207/2005 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime in quanto irragionevoli e non proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti ed ai valori fondamentali in gioco, ma pur sempre nel complessivo contesto della legge. In altre parole, la Costituzione non prescrive né che i parlamentari debbano essere eletti tramite un sistema proporzionale, né che debbano ineluttabilmente passare attraverso il voto di preferenza: sia l’una che l’altra soluzione sono frutto della ghigliottina costituzionale che ha riportato la legge Calderoli, da “porcata” quale era, nell’alveo del costituzionalmente legittimo. Ciò non implica che il legislatore sia, pro futuro, strettamente vincolato da questa storica sentenza, ma d’altra parte non può nemmeno sostenersi che il Parlamento, ad oggi, possa liberamente tornare ad adottare meccanismi già aspramente ed ampiamente criticati, finalmente dichiarati contrari ai principi costituzionali.
38
D’altronde, è da rilevare certa dottrina che plaude alla sentenza, ritenendo che la Corte abbia dedotto dal dettato costituzionale la necessità di un sistema elettorale proporzionale, con ciò avallando una lettura assai estensiva dello scetticismo manifestato dall’Assemblea costituente verso la forma di governo, spinta fino a coinvolgere anche il modello elettorale115. In realtà la Corte non ha posto un divieto assoluto a correttivi in senso maggioritario (siano essi premi di maggioranza o soglie di sbarramento, od entrambi in combinazione) o finanche ad un sistema elettorale di tipo maggioritario: la sent. n. 1/2014 si è limitata a dichiarare che, istituito un sistema proporzionale, i correttivi non possono stravolgerne le fondamenta, giungendo a sconfessare la scelta di principio. Ben potrebbero quindi superare il vaglio di costituzionalità leggi che prevedano correttivi meno invasivi ovvero sistemi elettorali di tipo maggioritario con le opportune correzioni volte a garantire rappresentanza e pluralismo politico.
Per quanto attiene al premio di maggioranza in sé considerato, incombe dunque sul legislatore l’onere di introdurre una soglia minima ragionevole ai fini dell’attribuzione, e dunque di individuare un meccanismo di distorsione del voto compatibile con l’opzione in favore di una formula proporzionale, che deve privilegiare l’esigenza di rappresentatività, pur potendo perseguire legittimi obiettivi di governabilità e stabilità politica. Conseguentemente il premio “può ritenersi ammissibile ed anzi voluto dalla Costituzione”, ma solo “all’unico scopo pratico di dare alla maggioranza reale una certa stabilità, impedendo che, per circostanze casuali, essa cessi di esser tale”116. Come si è visto, però, la Corte non ha senz’altro ritenuto costituzionalmente illegittimo il premio di maggioranza, né ha imposto di correggere il modello proporzionale solo con premi “di governabilità”, collocando la soglia ragionevole sopra il 50% dei voti, ma ha ritenuto che, per essere proporzionato rispetto al fine suo proprio di garantire la stabilità di governo, esso non possa produrre effetti eccessivamente distorsivi dell’impianto proporzionale in cui si inserisce.
39
115 Ad esempio, Dickmann afferma che “in sostanza la Corte ha voluto sottintendere che, solo riformando la forma di governo vigente spostandone il baricentro dal legislativo all’esecutivo, la questione della governabilità si potrà risolvere pregiudizialmente rispetto a quella della rappresentanza” poiché “nella Costituzione vigente non è leggibile alcuna legittimazione della soluzione opposta”, in R. Dickmann, Rappresentanza vs governabilità, in www.forumcostituzionale.it, 29 gennaio 2014; ma v. anche P. Pasquino, A proposito di regimi elettorali democratici, in il Mulino, n. 1/2012, pp. 33 ss.
116 C. Lavagna, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, II, p. 850.
Questa pronuncia apre la strada a infinite combinazioni numeriche, il cui grado di aderenza alla Costituzione è altamente incerto, perché la Corte non ha fornito parametri precisi per chiarire quando si debba considerare varcato il limite di manifesta sproporzione della soglia e del premio di maggioranza. Il legislatore ha margine di manovra entro questi due ordini di grandezze, vale a dire la soglia che permette l’attribuzione del premio e l’entità del premio stesso; e se un premio del 55% dei seggi non pare presentare caratteri di irragionevolezza, poiché, pur consegnando al vincitore la maggioranza assoluta dell’assemblea, non risulta lesivo delle opposizioni, i cui voti permangono decisivi per il raggiungimento dei diversi quorum di volta in volta richiesti dalla Carta, è assai più complessa l’individuazione della giusta soglia per permettere l’innesco del meccanismo premiale.
Una ragionevole proposta avanzata da alcuni autori117 ritiene non costituzionalmente legittimi meccanismi distorsivi che determinino l’effetto di conferire ai voti espressi a favore della coalizione vincente una valenza in uscita più che doppia rispetto alla valenza dei voti residui, cioè di quelli che confluiscono sulle altre liste o coalizioni. Ciò risulterebbe oltremodo lesivo del principio di eguaglianza del voto, il quale richiede che “ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi”, e che – calato nel contesto di un sistema a base proporzionale – impedisce il prodursi di una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’assemblea e la manifestazione del voto118. La Corte afferma che gli effetti del premio non possono distorcere eccessivamente il contesto di matrice proporzionale in cui esso è inserito: ciò vuol dire che i risultati in termini di seggi ottenuti devono comunque dipendere più dal numero di voti ottenuti che dal premio, altrimenti la logica proporzionale non sarebbe semplicemente corretta dal premio, ma radicalmente tradita.
In sintesi, quindi l’esigenza di stabilità può rendere tollerabile un sacrificio del principio di eguaglianza del voto, e delle particolari vesti che questo assume nel contesto di un sistema elettorale di tipo proporzionale, ma non al punto tale da assegnare alla volontà di alcuni elettori un peso doppio o più che doppio rispetto a quella di altri. Solo in questo modo si può star sicuri che i seggi ottenuti derivino più dai voti che dal premio.
40
117 G. Lodato, S. Pajno, G. Scaccia, Quanto può essere distorsivo il premio di maggioranza?, in www.federalismi.it, 24 aprile 2014.
118 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 3.1.
Se la dichiarazione d’incostituzionalità del premio di maggioranza pone problemi di ordine squisitamente costituzionalistico-matematico al futuro legislatore, non derivando particolari dubbi in merito alla applicabilità della disciplina residua, lo stesso non può dirsi per la possibilità di espressione della preferenza. La Corte, infatti, non potendo procedere autonomamente all’introduzione del voto di preferenza, ha dovuto desumere la norma, ripristinando la legalità costituzionale, dalla disciplina di situazioni analoghe119. Dunque, la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione che non prevede il voto di preferenza non ha un effetto innovativo: la norma integrativa va ricavata dal sistema giuridico, che però sembra offrire diverse soluzioni sul punto, le quali potrebbero portare a ritenere la pronuncia un’additiva di principio120. Attraverso il richiamo ad altri modelli – liste bloccate solo per una parte, circoscrizioni elettorali ridotte –, la Corte sembra confermare che rispetto al sistema censurato il problema reale non è la preferenza, bensì la conoscibilità, tanto da ritenere comunque validi i sistemi alternativi richiamati, in quanto per le loro caratteristiche dimensionali rendono i candidati, appunto, conoscibili.
Come è noto, le sentenze manipolative, al cui genere è da ricondurre quella additiva, “non possono essere, malgrado il loro nome, veramente creative di nuovo diritto, sul medesimo piano della funzione legislativa. Precisamente, si è sottolineato in dottrina che le decisioni additive e sostitutive devono pur sempre contenersi nei termini di una composizione “a rime obbligate” (Crisafulli), limitandosi a trarre dal sistema la norma o le norme destinate a colmare le mancate previsioni censurate dalla Corte” 121. Proprio la tesi della conoscibilità dei candidati inevitabilmente conduce il giudice costituzionale a prospettare una pluralità di soluzioni, tra cui la preferenza residua come una delle soluzioni possibili e forse non necessariamente quella che più garantisce agli elettori una maggiore conoscibilità dei candidati. Resta a questo punto da capire perché la scelta sia ricaduta proprio sul voto di preferenza e, nello specifico, sulla singola preferenza e non diversamente.
41
119 V. supra, nota 94.
120 S. Lieto, P. Pasquino, La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n. 1 del 2014, in www.forumcostituzionale.it, 26 marzo 2014. A tale proposito va ricordato che la Corte, a partire dalla seconda metà degli anni ’80 fa talvolta ricorso alle ccdd. sentenze additive di principio, attraverso le quali, dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione oggetto del giudizio “nella parte in cui non” (come nelle additive classiche), non procede ad individuare il frammento normativo mancante, ma indica il principio generale cui rifarsi nel riempire di contenuti la lacuna riscontrata.
121 L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova, 1991, p. 781.
Si può forse dire che la Consulta abbia fatto di necessità virtù, compiendo una scelta in verità quasi obbligata 122. In presenza di liste lunghe, come quelle previste dalla legge n. 207/2005, è realistico ritenere che la Corte abbia individuato la soluzione del voto di preferenza come quella meno invasiva 123 e soprattutto in grado di assicurare la immediata auto-applicatività della legge dopo il proprio intervento. Viceversa, non sembra possibile individuare, in base al senso fatto palese dal testo, una sorta di gradazione delle modalità con le quali può essere assicurata l’effettività della scelta – che sembra trovare una sufficiente garanzia nella conoscibilità degli eletti –, per cui anzitutto dovrebbe farsi riferimento al voto di preferenza, mentre soltanto in subordine alle liste bloccate corte in quanto corrispondenti a circoscrizioni elettorali ridotte, o al collegio uninominale. L’opzione, nell’ambito del voto di preferenza, per la preferenza unica, è ricondotta dalla Corte all’espressione della volontà popolare nel referendum del 1991 124, che certamente, anche considerata la necessità di trovare comunque una disciplina immediatamente applicabile, può rappresentare un utile appiglio. Deve ad ogni modo segnalarsi come il ricorso al referendum del 1991 a fini argomentativi non vada esente da critiche, a causa sia del tempo da allora trascorso, sia della celebrazione referendaria tenutasi appena due anni dopo, la quale imprimeva un carattere a prevalenza maggioritario alla normativa del Senato: il popolo lo aveva voluto, al pari della preferenza unica nel 1991, ma nella normativa di risulta non ne è fatta menzione.
42
122 Bilancia sostiene, al contrario, che la scelta della Corte sarebbe sì obbligata, ma nel senso di dover ricadere necessariamente sul voto di preferenza all’interno di un sistema proporzionale: “la questione della indefettibilità del diritto dell’elettore ad esprimere una preferenza segue l’opzione di fondo del legislatore per la formula elettorale proporzionale. Mentre resta impregiudicata ogni valutazione della Corte in relazione ai sistemi maggioritari ed ai sistemi misti in cui, vuoi il collegio uninominale, vuoi il collegio plurinominale con esiguo numero di candidati consentano comunque agli elettori di selezionare direttamente almeno in parte i candidati eletti. Sistemi, però, evocati dalla Corte come incomparabili con quello vigente in Italia a seguito dell’entrata in vigore della legge del 2005. Da queste formule non è, pertanto, possibile dedurre la compatibilità a Costituzione dell’opzione per un sistema elettorale con formula proporzionale in cui la totalità degli eletti sia selezionata dai partiti mediante la composizione delle liste, lunghe o corte che siano”, in F. Bilancia, Ri-porcellum, in www.costituzionalismo.it, 24 gennaio 2014.
123 La Corte costituzionale avrebbe altresì potuto, in base all’art. 27 della legge n. 87 del 1953, spingersi a dichiarare l’illegittimità consequenziale di ulteriori disposizioni della legge n. 207 del 2005, ad esempio riformulando l’ampiezza delle circoscrizioni elettorali per ovviare all’eccessiva lunghezza delle liste. D’altra parte è pur vero che inoltrandosi in un simile cammino la Corte avrebbe corso il rischio di sostituirsi al legislatore in una vera e propria riforma della disciplina elettorale.
124 Corte cost., sent. n. 1 del 2014, Considerato in diritto n. 6, che richiama la sent. n. 47 del 1991 con la quale venne ammesso il referendum.
2. L’accesso “in via preferenziale”
Nelle more dell’iniziativa parlamentare, l’ordinanza di rimessione della Cassazione servì a spaccare esattamente a metà la dottrina, che pure sembrava attendere quel momento da anni: la diatriba, come si conviene, non era di poco conto, riguardando niente di meno che l’accesso alla Corte costituzionale, severamente presidiato da oltre cinquant’anni di giurisprudenza quasi granitica ed improvvisamente messo in discussione. La stessa Suprema Corte aveva speso parole precise quanto gravi a riguardo, giungendo addirittura a dubitare della “compatibilità del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953 con l’art. 134 Cost.”125, ovvero, in altre parole, della legittimità costituzionale della disciplina che regola l’accesso in via incidentale. Pur essendovi consenso unanime sulla necessità di giustiziare la legge elettorale, forte era il timore da molti nutrito verso quello che andava delineandosi come un sentiero d’accesso nuovo ed in sostanziale difformità dalle regole processuali costituzionali che fino a quel momento non avevano conosciuto strappi clamorosi. All’indomani dell’ordinanza, c’era la consapevolezza che anche il semplice intervento ablativo del giudice delle leggi – in particolare attraverso l’asportazione chirurgica delle disposizioni che prevedevano l’attribuzione del premio di maggioranza alla Camera e dei premi regionali al Senato – avrebbe mutato il sistema elettorale al punto da realizzare “un vero e proprio radicale mutamento legislativo, che però non può che spettare ad organi rappresentativi”, mentre “la Corte in realtà non dispone della legittimazione a riscrivere i sistemi elettorali” 126; così come, nel volgere del paragone con i referenda in materia elettorale celebrati agli inizi degli anni ’90, era evidenziato come “il soggetto che intervenne fu un soggetto politico (corpo elettorale) direttamente espressivo della volontà popolare”, mentre oggi la decisione sarebbe stata presa da “un «giudice», certamente dotato di una particolare sensibilità politica, ma pur sempre [...] un giudice, che è tenuto a rispettare le regole del proprio processo ed a motivare le proprie decisioni”, con l’auspicio che “il giudice costituzionale mantenga il ruolo di giudice, rispettoso delle regole processuali, sul quale si fonda la legittimazione dello stesso nel nostro sistema costituzionale”127.
43
125 Cass. civ., ord. n. 12060 del 2013, n. 3.2.2 dei Motivi della decisione.
126 U. De Siervo, Alla Consulta un ricorso inammissibile, in La Stampa, 29 novembre 2013.
127 R. Romboli, La costituzionalità della legge elettorale 270/05: la Cassazione introduce, in via giurisprudenziale, un ricorso quasi diretto alla Corte costituzionale?, in Foro italiano, 2013, I, p. 1836.
Grandi erano pertanto le aspettative nei confronti della Corte costituzionale, in ragione della delicatezza della questione sollevata e delle stesse modalità con cui le era pervenuta. A queste la Corte ha replicato con una decisione epocale, che ha prima sorvolato sulla ristrettezza dei requisiti di ammissibilità, mediante l’accettazione della finzione processuale, e dopo dedotto ulteriori argomentazioni a suo sostegno. A ben vedere si tratta di una ratio decidendi del tutto nuova che si pone al di fuori della sfera della connessione tra il giudizio a quo e quello di costituzionalità, cioè dalla sfera della incidentalità, per fornire invece un fondamento diverso ed autonomo ad una modalità sostanzialmente inedita di accesso al sindacato della Corte, che potrebbe definirsi “in via preferenziale”. A tal fine la pronunzia cumula molteplici riflessioni, concomitanti ma non sempre facilmente coordinabili, che si accentrano sui punti seguenti: la natura fondamentale del diritto di voto; la peculiarità della legge elettorale, che sarebbe tra quelle capaci di produrre lesioni dirette di un diritto inviolabile indipendentemente dagli atti applicativi; l’inaccettabilità dell’esistenza di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico.
Ciò che invece non persuade è il fatto che la Corte si sia sentita legittimata a ricavare autonomamente – senza peraltro mettere in discussione esplicitamente il significato sinora attribuito agli artt. 1 della legge cost. n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953 – un rimedio processuale che, di fatto prescindendo dal requisito della incidentalità, si pone come un strumento di accesso sostanzialmente nuovo: e ciò facendolo derivare da due principi di una totale astrattezza e genericità, quali appunto il principio di costituzionalità e quello della necessaria protezione dell’assetto democratico-rappresentativo. Attenendosi strettamente al testo della pronuncia, resta ampiamente incerto se la nuova modalità di accesso alla Corte potrà essere utilizzata in relazione a qualsiasi diritto fondamentale oppure esclusivamente per il diritto di voto, e se per ogni diritto fondamentale si potrà, proponendo un’azione di accertamento dinanzi al giudice ordinario, sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge che lo riguarda come fonte diretta della lesione, senza la necessità di attenderne un provvedimento applicativo. Oppure si dovrà ragionare diversamente e dare un’interpretazione restrittiva della sentenza, ritenendo che sia stata possibile unicamente perché collegata alla tutela del diritto espressione della rappresentanza democratica e diretta alla rimozione di una significativa zona franca.
44
Tuttavia, deroghe alla disciplina processuale effettuate in nome anche della più giusta delle cause sono sempre rischiose per la credibilità di un giudice, soprattutto se questo giudice esercita la propria giurisdizione a Palazzo della Consulta e rappresenta l’organo di chiusura del sistema, mediante la pronuncia di sentenze non appellabili128. Un tale enorme potere deve godere di abbondante credibilità e viene da chiedersi in proposito se non sia stato rischioso per la Corte aver considerato le regole del processo costituzionale in via incidentale “un mero impaccio formalistico alla garanzia dei diritti”129. Inoltre, è evidente che una decisione come questa porta certamente con sé dei problemi, proprio in ragione del suo essere la prima. È innegabile che, con questo precedente, non solo la Corte ha interrotto oltre cinquant’anni di consolidata giurisprudenza sulla rilevanza della questione, ma si è aperta la porta alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale in materia elettorale, con effetti potenzialmente dirompenti, anche sul piano dei numeri130.
Per ogni ordine di ragioni poc’anzi elencate, appare preferibile riservare una lettura ristretta alla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale, come d’altronde non c’è da dubitare che essa stessa farà, se tiene alla propria legittimazione – grande è quella che si è costruita in breve e si è conservata in lungo – ed all’efficienza nelle proprie importanti attribuzioni. L’epocale pronuncia con cui la Corte ha giustiziato la legge elettorale deve dunque essere ascritta ad una giurisprudenza che ha occasionalmente allargato l’accesso “ai limitati fini” di una singola decisione131, potendosi parlare in questo caso di una “nozione di rilevanza più ampia ai limitati fini del superamento di una zona franca”132.
45
128 Anzon ricorda in proposito la “precisa riserva di legge costituzionale disposta dall’art.137 Cost. sulle «condizioni, le forme, i termini dei giudizi di legittimità costituzionale»”, nonché “altri ordinamenti in cui vige un sistema di sindacato accentrato sulle leggi simile al nostro, che prevedono espressamente e disciplinano analiticamente ricorsi diretti al giudice delle leggi per la tutela dei diritti fondamentali [...], compresi gli strumenti-filtro per evitare o almeno ridurre e gestire il conseguente eccesso di lavoro delle Corti”, in A. Anzon-Demmig, Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 4 aprile 2014.
129 F. Ferrari, Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità, in www.forumcostituzionale.it, 21 gennaio 2014.
130 G. Maestri, La legge elettorale dopo la Consulta, in www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 29 gennaio 2014.
131 Tale giurisprudenza è ben illustrata in G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, cit., pp. 276 ss.
132 R. Romboli, Intervento in La tutela dei diritti tra legislatore e giudici, Lectio magistralis del Prof. Paolo Caretti, organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, 16 maggio 2014.
3. La legge elettorale per il Parlamento europeo
Non ostanti gli argomenti appena spesi, sembra che la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale sia destinata ad avere presto seguito, poiché, il 5 maggio 2014, il Tribunale di Venezia ha emesso un’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale relativa alla legge per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; il Tribunale di Cagliari, pochi giorni dopo, ha emesso un’ordinanza avente il medesimo oggetto, pur con censure differenti. Alla base di tutta la vicenda c’è un gruppo di cittadini-elettori, rappresentanti dall'Avv. Felice Besostri133, i quali hanno proposto ricorso a Roma, Milano, Napoli, Trieste, Venezia e Cagliari, domandando l’accertamento del diritto “di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, così come attribuito e garantito nel suo esercizio dalla Costituzione Italiana e da vigenti trattati sull’Unione Europea e il suo funzionamento e norme comunitarie”, previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione europea delle questioni relative all’interpretazione/applicazione del diritto comunitario e previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità dedotte. I ricorrenti hanno censurato gli artt. 12, 21 e 22 della legge n. 18/1979, così come modificata dalla legge n. 10 del 2009, per risultare questi lesivi dell’esercizio del diritto di voto per via della previsione di una soglia di sbarramento del 4% e di una disciplina discriminatoria delle minoranze linguistiche, la quale permette l’accorpamento – e, conseguentemente, maggiori possibilità di superare la soglia – alle sole minoranze linguistiche testualmente nominate. Due dei tribunali aditi hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost., ammettendo però una sola censura ciascuno.
È appena il caso di notare che la struttura del ricorso è pressoché identica, articolandosi in una lis ficta instaurata dalla domanda di accertamento della lesione (permanente) del diritto di voto, la quale serve il sollevamento della questione di legittimità costituzionale. La sentenza n. 1/2014 viene espressamente richiamata nell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, che afferma la possibilità di censurare il sistema elettorale quando questo risulti manifestamente irragionevole.
46
133 Besostri è stato altresì uno dei promotori del giudizio che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 207 del 2005, e non ha esitato a definire la legge elettorale per il Parlamento europeo (legge n. 18/1979) “Europorcellum”.
A sostegno delle loro argomentazioni i ricorrenti sottolineano che l’esistenza di una soglia di sbarramento nella normativa nazionale può trovare giustificazione al fine di evitare l’eccessiva frammentazione dei partiti ed assicurare la stabilità del governo, che dalle Camere elette deve ottenere la fiducia; analoga esigenza non può invece ravvisarsi con riguardo all’elezione del Parlamento europeo, il quale ha funzioni diverse dal Parlamento nazionale e, soprattutto, non ha il compito di eleggere o dare la fiducia ad alcun governo dell’Unione, al quale possa fornire stabilità di indirizzo politico e continuità di azione; né ha un ruolo determinante nella produzione legislativa, collaborando invece con il Consiglio nella discussione e nell’approvazione della normativa europea, ed esercitando il controllo sulle altre istituzioni dell’Unione e concorrendo all’approvazione del bilancio.
La questione è stata affrontata dal Bundesverfassungsgerichtche, il quale, con sentenza del 9 novembre 2011, ha accolto due ricorsi in materia elettorale, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle clausola di sbarramento de 5% fissata dalla legge nazionale tedesca per le elezioni del Parlamento europeo. Recentemente la stessa Corte Costituzionale Federale, con sentenza del 26 febbraio 2014, ha ribadito l’illegittimità costituzionale della soglia di sbarramento, nel frattempo reintrodotta dal legislatore nazionale nella misura del 3%, ritenendo la limitazione della rappresentanza del tutto ingiustificata e in contrasto con i principi di uguaglianza del voto e di pari opportunità per i partiti politici.
A conclusione, se qualcosa di ragionevole è rimasto, questa è la aspettativa che i cittadini nutrono nei confronti della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, a maggior ragione se si considera l’attenzione che, anche in occasione della sentenza n. 1/2014, la Corte ha riservato alla giurisprudenza dell’omologa tedesca.
Merita di essere segnalato che, curiosamente, sembra che l’accesso “in via preferenziale” sia in grado di imporsi anche dove non in presenza di una zona franca: il Parlamento europeo non gode dell’autodichia (garantita al Parlamento nazionale dall’art. 66 Cost.) e il codice del processo amministrativo prevede un apposito ricorso al TAR secondo la disciplina del contenzioso elettorale, che ben può rappresentare il giudizio a quo. La Corte costituzionale, dunque, potrebbe ritenere inammissibili le quaestiones sollevate dai tribunali di Venezia e di Cagliari, proprio perché nel caso di specie non potrebbe ampliare oltremodo la nozione di rilevanza al fine di superare una zona franca, non essendocene.
47
Una decisione di inammissibilità contribuirebbe senz’altro a dissipare qualsiasi dubbio sulla coerenza del giudice delle leggi, ed avrebbe il sicuro merito di restituire autorevolezza e credibilità ad un organo costituzionale impegnato in compiti di siffatta delicatezza e levatura. Inoltre, in tal maniera, verrebbe recuperata quella particolare attenzione alle regole processuali costituzionali, le quali, non va dimenticato, rappresentano una imprescindibile garanzia: lungi dall’essere mera procedura, la legge cost. n. 1/1948 e la legge n. 87/1953 rappresentano il baluardo delle disposizioni sostanziali della Costituzione, poiché regolano il funzionamento della Corte costituzionale. Nel momento in cui la Corte cede terreno sul piano del rispetto delle regole (che la riguardano), è lì che potenzialmente si annida il pericolo per la Costituzione.
4. Conclusioni
Già in altre occasioni la Corte costituzionale si era ritrovata costretta, a causa della prolungata inerzia del legislatore, ad “ad una funzione di supplenza non richiesta e non gradita, per la quale oltretutto non dispone di strumenti necessari, perché non è un organo legislativo”134; tuttavia, mai era stata chiamata a pronunciarsi in una materia così delicata, perché se v’è disciplina positiva che per antonomasia richiede di essere messa a punto dagli organi della rappresentanza politica, questa è proprio quella elettorale, quale asse portante della forma di governo e, ancora più a fondo, della stessa forma di Stato.
A fronte di un’acclarata e d’altronde drammaticamente attuale incapacità delle forze politiche, e delle istituzioni in cui esse si esprimono, ad esercitare i compiti ai quali sono chiamate dalla Costituzione ed il servizio che dovrebbero rendere alla collettività, il ruolo di protagonista, più o meno inaspettatamente, è toccato alla Corte. Non è una novità che l’intervento del giudice costituzionale venga invocato per sopperire alle evidenti mancanze del Parlamento, in tutt’altre faccende affaccendato ed ostinatamente sordo ad ogni sorta di richiamo proferito, in distinte circostanze di tempo e luogo, da tutte le più alte cariche dello Stato, nessuna esclusa.
48
134 Le parole furono proferite dal Presidente della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, in occasione della relazione annuale sulla giustizia costituzionale del 2 aprile 2004, da www.cortecostituzionale.it.
Delle due decisioni contenute nella sentenza in esame – quella processuale sull’ammissibilità delle questioni e quella di merito per l’annullamento parziale della legge n. 270/2005 – la prima non è certo di minor rilievo rispetto alla seconda. Naturalmente non ha suscitato il grande e giustificato clamore prodotto da quest’ultima, intervenuta sulla spinta della necessità di rimuovere una situazione di incostituzionalità non più tollerabile. A prescindere dalle tecniche argomentative poste a supporto della decisione, resta dunque una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge elettorale nella sua oggettiva grandezza e peculiarità. Invero si è, con ogni probabilità, raggiunta la punta più elevata del potere espansivo, o suppletivo, del giudice costituzionale, non tanto per l’ampiezza della riforma della legge, quanto per le specificità della legge in questione.
Difatti, l’intervento ablativo della Corte, di per sé, è stato “minimo” ed estremamente coerente con le perplessità esposte in maniera efficace dalla Cassazione nell’ordinanza di rimessione: Cassazione che pure aveva segnalato alla Consulta la possibilità di ricorrere al potere riconosciutole dall’art. 27 della legge n. 87/1953, al fine di armonizzare la disciplina elettorale residua per mezzo della dichiarazione di illegittimità consequenziali; tuttavia, per quanto l’intervento fosse auspicabile con riferimento, ad esempio, alle soglie di sbarramento, alla possibilità di candidarsi in ogni circoscrizione e finanche alla mancata previsione di una preferenza di genere135, tale suggerimento non è stato preso in considerazione dal giudice costituzionale, che ha limitato l’intervento in materia alle sole questioni sollevate.
L’atteggiamento tenuto dalla Corte deve senz’altro ricondursi a quel tradizionale self-restraint osservato nell’arco della sua lunga carriera, specialmente nei periodi di più marcata sovraesposizione politica, in cui una prudente auto-limitazione le ha permesso di assolvere le funzioni costituzionali mantenendo invariata la propria autorevolezza.
49
135 È appena il caso di ricordare che la legge n. 205 del 2007 prevede soglie di sbarramento particolarmente elevate (specie al Senato), che vengono dimezzate per le liste che entrano a far parte di una coalizione: a seguito della espunzione del premio di maggioranza, tuttavia, il meccanismo viene a perdere di significato in quanto gli accordi elettorali tra liste non hanno più l’obiettivo del conseguimento del premio; in una tale situazione le liste più grandi hanno meno interesse ad accogliere quelle piccole, che conseguentemente rischiano di non ottenere rappresentanza a causa delle soglie (adesso) irragionevolmente elevate. Sulla preferenza di genere v. l’articolo volutamente provocatorio di E. Catelani, “Due pesi e due misure” nella sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: ammette una fictio litis, ma non amplia il parametro di costituzionalità ipotizzando una doppia preferenza di genere, in www.confronticostituzionali.eu, 27 gennaio 2014.
Dopotutto, l’intervento richiestole aveva ad oggetto la legge elettorale, una delle più importanti espressioni dell’assemblea legislativa, un atto che viene a ragione considerato di stretta prerogativa parlamentare in virtù dell’art. 72, quarto comma, Cost.136 La Corte ha giustiziato la legge elettorale, l’ha riformata cambiandole i connotati in maniera netta. Tuttavia, non ha fatto né più né meno che il suo dovere, spettandole il gravoso compito di controllare la conformità a Costituzione della legislazione vigente, tant’è che la pronuncia, se si esclude la dottrina, non ha ricevuto particolari critiche di stampo politico – come pure è accaduto in tempi nemmeno troppo lontani – ed il Parlamento e il Governo, che è da ritenere si fossero da tempo rassegnati, hanno accolto la sentenza senza batter ciglio, continuando in verità a fare quel che han fatto dall’entrata in vigore della legge n. 207/2005: annunciare una nuova legge elettorale.
Ai posteri – come suol dirsi – l’ardua sentenza. Sarà necessario attendere gli sviluppi politici sul terreno delle riforme, nonché le prossime pronunce della Corte costituzionale, in primis quelle cui è chiamata a breve con riguardo alla legge elettorale per le europee, per dire se tutto quanto è stato fatto è stato, ed è, un bene o no, per la salvezza delle istituzioni repubblicane minacciate nel loro credibilità ed attività quotidiana, nonché per il mantenimento del vigore della stessa Carta costituzionale mortificata da comportamenti irresponsabili degli operatori politico-istituzionali. Un bene, tuttavia, la cui custodia ha richiesto il superamento degli argini costituzionali da parte dei suoi stessi massimi garanti.
La giurisprudenza offre numerose testimonianze, nei campi più vari di esperienza, a riguardo del possibile – talvolta necessario – sacrificio di singole norme costituzionali e dei valori di cui esse sono portatrici, laddove imposto dal bisogno di mantenere intatto il rispetto di altri valori cui va prestata, in ragione del caso, prioritaria considerazione. In questa occasione, però, sono state le norme che presidiano il funzionamento della Corte ad essere superate, anche se formalmente tale azzardo è stato ampiamente giustificato, fino quasi a sparire, nelle motivazioni tanto della Cassazione quanto della Corte costituzionale.
50
136 La stessa Corte costituzionale ha fatto riferimento al “divieto - desunto dall'art. 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall'art. 15, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1988, n. 400 - relativo alla materia elettorale” in occasione del ricorso alla decretazione d’urgenza, in Corte cost., sent. n. 161 del 1995, Considerato in diritto n. 4; v. anche R. Bin, Può una legge elettorale essere adottata con un decreto-legge?, in www.forumcostituzionale.it, 18 novembre 2012.
Insomma, che l’incidente di costituzionalità promosso dall’ordinanza della Cassazione potesse incorrere nella censura di aver instaurato una finta lite di costituzionalità non era un’ipotesi remota, anche tenendo conto di una giurisprudenza costituzionale in tema di fictio litis che, pur con le sue incertezze, non sembrava avara di indicazioni in senso contrario. Ebbene, è proprio questa singolare situazione o, più esattamente, il peso e il pregio costituzionale degli interessi sottesi, a fornire la migliore giustificazione della decisione assunta dalla Corte di ammettere allo scrutinio di merito le questioni di costituzionalità ad essa sottoposte. Il giudice costituzionale ne è ben consapevole ed ha articolato l’impianto motivazionale allo scopo, esplicando immediatamente dopo l’accettazione della lis ficta quali fossero le altre, alte ragioni per le quali era d’uopo, ancor prima che giustificabile, porre in essere una (sostanziale) deroga alle regole cui generalmente si informa lo scrutinio. In questa direzione, tutta la vicenda giudiziaria che ha investito le leggi elettorali novellate nel 2005 ed è sfociata nella pronuncia di cui qui si ragiona è un caso paradigmatico di applicazione – però in termini impliciti e non espliciti – di un approccio pragmatico, in funzione del quale, come la dottrina più avveduta non ha mancato di segnalare, “il principio di costituzionalità e le finalità generali del giudizio di costituzionalità” possono “influire sulla configurazione della fase di avvio di questo” 137.
D’altronde, ad un uso duttile degli istituti del processo costituzionale, specialmente con riguardo a quelli relativi all’accesso al giudizio dinanzi alla Corte, quest’ultima è stata non di rado indotta proprio dalla necessità di salvaguardare il principio di legittimità costituzionale, assicurandosi così una possibilità di intervento in ambiti altrimenti preclusi. Il riconoscimento della legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità a soggetti difficilmente qualificabili in termini di autorità giurisdizionale ha portato la Corte a configurare una legittimazione “ai limitati fini” della proponibilità di quaestiones legitimitatis, in presenza della necessità di assicurare presidio a parametri costituzionali che, in ipotesi contraria, ne sarebbero restati privi. Nel contesto storico-politico attuale, caratterizzato dal perdurante immobilismo del legislatore, la Corte si è considerata tenuta a privilegiare, per ragioni di politica costituzionale ed anche a costo di forzature, le ragioni della garanzia del diritto di voto per le assemblee rappresentative rispetto a quelle di una rigorosa applicazione delle regole codificate del sistema di giustizia costituzionale .
51
137 G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Giustizia costituzionale, cit., pp 273-274.
In definitiva, allargare le maglie dell’accesso al proprio giudizio in presenza della evidente (ed esclusiva) necessità di assicurare il massimo rendimento possibile al principio di legittimità costituzionale risponde ad una logica che ha spesso guidato il giudice delle leggi nella sua quasi sessantennale esperienza. Che i giudici di Palazzo della Consulta vi abbiano attinto anche in questo caso – cioè per consentire di vagliare una legge, come quella elettorale, che si atteggia a principale distributore di democrazia, la cui incostituzionalità era affermata, come dire, coram populo – non può che essere motivo per rallegrarsi. Sempre che, come è auspicabile e lecito attendersi, tale pronuncia vada effettivamente a collocarsi nell’alveo della giurisprudenza costituzionale che riconosce la legittimazione come giudice a quo “ai limitati fini” del perseguimento di interessi superiori, in particolar modo del principio di costituzionalità; scongiurando l’idea che un accesso “in via preferenziale” possa in alcun modo trarre forza da ulteriori pronunce, finendo per consolidare un modello di accesso nuovo e pericolosamente avulso dalle regole che presidiano la giustizia costituzionale.
52
BibliografiaMonografie
‣ Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, a cura di A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi, Torino, Giappichelli, 2000
‣ Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, a cura di R. Balduzzi, P. Costanzo, Torino, Giappichelli, 2007
‣ La giustizia elettorale, a cura di E. Catelani, F. Donati, M. C. Grisolia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013
‣ Corso di giustizia costituzionale plurale, A. Cerri, Milano, Giuffrè, 2012
‣ Soggetto privato e processo costituzionale italiano, G. D’Orazio, Torino, Giappichelli, 1988
‣ Giustizia costituzionale, E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Torino, Giappichelli, 2011
‣ Il giudizio in via incidentale, V. Onida, M. D'Amico, Torino, Giappichelli, 1998
‣ Diritto costituzionale, L. Paladin, Padova, CEDAM, 1991
‣ Lezioni di diritto processuale civile, A. Proto Pisani, Napoli, Jovene, 2010
‣ La tutela dei diritti fondamentali davanti alle corti costituzionali, R. Romboli, Torino, Giappichelli, 1994
‣ L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello, a cura di R. Romboli, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2006
‣ Lezioni di giustizia amministrativa, A. Travi, Torino, Giappichelli, 2012
‣ La giustizia costituzionale, G. Zagrebelsky, Bologna, Il Mulino, 1988
‣ Giustizia costituzionale, G. Zagrebelsky, V. Marcenò, Bologna, Il Mulino, 2012
53
Riv!te telematiche
‣ http://www.associazionedeicostituzionalisti.it
‣ http://www.astrid-online.it
‣ http://www.confronticostituzionali.eu
‣ http://www.cortecostituzionale.it
‣ http://www.costituzionalismo.it
‣ http://www.federalismi.it
‣ http://www.forumcostituzionale.it
‣ http://www.giurcost.org
‣ http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it
‣ http://www.osservatoriosullefonti.it
54