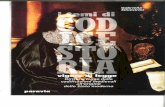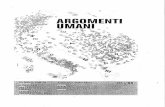La palingenesi della Legge delle XII Tavole e le codificazioni “a domino”
Transcript of La palingenesi della Legge delle XII Tavole e le codificazioni “a domino”
Oliviero Diliberto
La palingenesi della Legge delle XII Tavole e le codificazioni “a domino”
[in “Dallo Stirone al Tigri, dal Tevere all’Eufrate. Studi in onore
di C. Saporetti”, Roma, 2009, pp. 119 – 148
1. “I collegamenti [delle norme tra loro] sembrano fatti come
se si seguisse un’idea, dalla quale ci si lascia distogliere per
seguirne una analoga; si può ritornare poi sulla principale e da
questa passare ad un’altra ancora, attraverso una successione di
elementi comuni: una specie di gioco del «domino», se si concede il
paragone”: Claudio Saporetti1 definiva così – efficacemente – la Ripubblico in questa sede, in larga parte, ancorché con le necessariemodifiche, il testo della relazione da me svolta a Napoli nel corso del seminario(19 marzo 2008) in onore di Bernardo Santalucia (Il diritto “penale” nella legge delle XIITavole: profili palingenetici), di prossima pubblicazione, che dedico con grande piacereanche all’amico e collega Claudio Saporetti: tuttavia, poiché quanto segue èofferto proprio all’insigne studioso di antichità mesopotamiche, approfitterò diquesta gradita occasione per aggiungere al testo alcune ulteriori considerazioni,al fine di riconnettere le mie ipotesi concernenti le XII Tavole della Romaarcaica con gli studi svolti dallo stesso Saporetti sulle antiche leggi di altricontesti e di altre epoche.1 La citazione è tratta da C. SAPORETTI, Antiche leggi. I “codici” del vicino oriente antico,Milano 1998, 55 s.; v. anche ID., Le leggi della Mesopotamia. Tradotte dai testi originali(collaborazione di C. Paladini), Firenze 1984, passim. Alcuni esempi, credoeloquenti. Nel “codice” di Hammurapi (XVIII sec. a.C.), le norme sul processo (1– 5) sono seguite (6 – 26) dal processo in caso di furto, dal furto di schiavi,dall’induzione alla fuga degli schiavi altrui, dalla rapina, dal saccheggio,dalla repressione dello sciacallaggio in caso di guerra; ad esse si congiungono,dunque, le norme (27 – 41) sulla guerra; l’ultima di esse riguarda il possessodei campi da parte dei militari, che è seguita (42 ss.) dalla disciplina dellavoro nei campi (SAPORETTI, Le leggi cit. 49 – 56; ID., Antiche leggi cit. 55 s., 161ss.). Nel medesimo “codice”, le norme sui beni dati in pegno in deposito pressoterzi (122 – 124) sono seguite dalla pena per il furto di beni in deposito (125),da quella sulla falsa denuncia di furto (126), dalla falsa accusa ad unasacerdotessa o ad una donna sposata (127), cui seguono le norme sul matrimonio(128 ss.) (SAPORETTI, Le leggi cit. 66 s.; ID., Antiche leggi cit. 56 s., 176 s.).Nelle leggi ittite (1250 circa a.C.), la sequenza “a domino” è ancora piùevidente: § 107, danneggiamento di una vigna a seguito di pascolo di pecore (§107); furto di tralci da una vigna (§108); furto di alberi da frutto (§109);
1
struttura delle antiche leggi, soprattutto mesopotamiche, da lui
acutamente indagate.
Una struttura, dunque, definita “del domino”: all’interno di
ciascuna delle raccolte normative, le diverse disposizioni di legge
si susseguono l’una dopo l’altra sulla base di una sorta di
reciproca “attrazione”, ratione materiae, e non già in virtù di criteri
“codicistici” moderni, nei quali la collocazione delle diverse
norme avviene sulla base di classificazioni concettuali fondate
sullo schema genus–species.
Anni addietro, la lettura degli studi di Saporetti mi aveva
indotto a formulare una possibile similitudine tra quanto l’autore
sosteneva in relazione alle legislazioni mesopotamiche e quanto
andava emergendo dall’analisi di una (assi più recente, ma pur
sempre antica) raccolta nornativa di Roma: la Lex duodecim tabularum,
promulgata a metà del V sec. a.C.2
Non si tratta, evidentemente, di immaginare – in alcun modo –
una sorta di “derivazione” delle XII Tavole, che pure
inattendibilmente è stata proposta3, da legislazioni mesopotamiche
o vicino-orientali, che non hanno alcun rapporto con la realtà
della Roma del V secolo avanti Cristo. Il punto è un altro. E’
quello di comprendere – attraverso la suggestione dell’analisi di
diverse, antichissime legislazioni – come anche altri criteri
furto di argilla contenuta nelle cavità degli alberi (§110); punizione per chiimpiega l’argilla per farne statuine magiche per sortilegi (§111): cfr. ancoraSAPORETTI, Antiche leggi cit. 75 s., 266 s.2 O. DILIBERTO, Una palingenesi ‘aperta’, in Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, cur. M.HUMBERT, Pavia 2005, 236 ss.3 R. WESTBROOK, Nature and Origins of the XII Tables, in ZSS 105 (1988) 74 ss. Su talelavoro, v. per tutti M. TALAMANCA, Pubblicazioni pervenute alla Direzione, in BIDR 92 – 93(1989 – 1990) 858 ss. Ultimamente, v. a questo proposito L. CAPOGROSSI COLOGNESI,Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell’ ‘800, Roma 1994, 208 nt. 47 (con preziosiriferimenti al dibattito storiografico sul tema, di cui furono protagonistiBonfante e Volterra) e U. AGNATI, Leges Duodecim Tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica.Tabulae I-VI, Cagliari 2002, 9 e ivi nt. 1 con ult. lett.
2
“ordinatori” (se così possono essere definiti, con molta
approssimazione), differenti da quelli moderni a noi noti, possano
essere presi in esame nel momento in cui si procede ad una nuova
ricognizione palingenetica delle XII Tavole.
Dedico, dunque, quanto segue, con grande piacere, proprio a
Claudio Saporetti, le cui suggestioni hanno contribuito a
confortare le riflessioni sulla Legge delle XII Tavole che vado
svolgendo ormai da non pochi anni4.
Poche parole introduttive, dunque.
La legge delle XII Tavole (metà del V sec. a.C.),
contrariamente ad altri “monumenti legislativi” dell’antichità, non
4 O. DILIBERTO, Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole, in Index 18 (1990)403-434; Contributo alla palingenesi delle XII Tavole. Le “sequenze” nei testi gelliani, in Index 20(1992) 229-277; Materiali per la palingenesi delle XII Tavole I Cagliari 1992; Recensione a F.M. D’IPPOLITO, Questioni decemvirali, Napoli 1993, in Iura 44 (1993) 249-260; Idestinatari delle Noctes Atticae, in Labeo 42 (1996) 277-286; Conoscenza e diffusione delle XIITavole nell’età del Basso Impero. Primo contributo, in Nozione formazione e interpretazione del dirittodall’età romana alla esperienza moderna. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo, I, Napoli 1997, 205-227 [pubblicato anche in Ius Antiquum, Accademia Scienze di Mosca, 1 (2) (1997)74-83]; Scheda bibliografica “Ortolan, n. 704”, in I Quaderni di Capestrano 4 (1998)127-128; Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della Legge delle XII Tavole (sec. XVI – XX), Roma2001; Charles Casati de Casatis e gli studi di “diritto etrusco” in Ostraka 10 (2001) 59-65; Di unmodesto e (quasi) sconosciuto tentativo di palingenesi decemvirale del principio del XVI secolo, in Iurisvincula. Studi in onore di M. Talamanca, II Napoli 2002, 447-468; A New Chinese Translation of XIITables Law: Some Reflection on the Situation of Our Researches (in cinese), in Roman Law andModern Civil Law. The Annals of Institute of Roman Law Xiamen University 3 (2002) 51-57; Unaminiatura medioevale in tema di decemvirato legislativo (a margine di Vat. Lat. 3340), in MiscellaneaBibliothecae Apostolicae Vaticanae 9 (2002) 103-114 e in BIDR 100 (1997) 517-523; Unapalingenesi ‘aperta’, in Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, cur. M. HUMBERT, Pavia2005, 217-238; La palingenesi decemvirale: dal manoscritto alla stampa, in Le Dodici Tavole cit.481-501; Le XII Tavole nel Digesto, in Ius Antiquum, Accademia Scienze di Mosca, 2 (16)(2005) 50-54 e in Digesta Iustiniani, VIII, Articuli et indices, Mosca 2006, 49-55;Umanesimo giuridico-antiquario e palingenesi delle XII Tavole. 1. Ham. 254, Par. Lat. 6128 e Ms. Regg. C.398, in AUPA 50 (2005) 83-116; “Lex de magistratibus”. Cicerone, il diritto immaginato e il dirittoreale nella tradizione palingenetica delle XII Tavole, in Tradizione romanistica e Costituzione, dir. L.LABRUNA, cur. M.P. BACCARI e C. CASCIONE, II Napoli 2006, 1469-1482; Unasconosciuta monografia ottocentesca sulle leges regiae. Il Dritto Papisiano di Domenico Cassini, in FidesHumanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna, III Napoli 2007, 1466-1491; Umanesimo giuridicoantiquario e palingenesi delle XII Tavole. 2. Reg. Lat. 450, in M. BUONOCORE – O. DILIBERTO – A.FIORI, Un manoscritto inedito in tema di legge delle XII Tavole, in Miscellanea Bibliothecae ApostolicaeVaticanae 15 (2008) 49-99; La responsabilità nelle XII Tavole: profili palingenetici (in corso distampa); Il “diritto penale” nelle XII Tavole: profili palingenetici (in corso di stampa).
3
ci è pervenuta. Di essa, tuttavia, si sono conservate molteplici
citazioni, riferimenti – diretti o indiretti – all’antica raccolta,
narrazioni: si tratta di testimonianze tutt’altro che esigue, che
hanno indotto gli interpreti, per quanto sappiamo già sin dalla
metà del ‘400, in pieno Umanesimo, a cimentarsi nel tentativo di
ricostruire, per quanto possibile, l’antico testo legislativo,
assemblando tra loro le fonti, disponendo in successione le norme –
la cui menzione è sparsa e disarticolata nell’ambito delle fonti
antiche, greche e latine –, le une dopo le altre, provando infine a
suddividere le materie nelle diverse tabulae della Legge stessa.
A tale scopo, appare particolarmente interessante lo studio
della disposizione delle norme decemvirali di natura “penalistica”
all’interno dell’antica raccolta legislativa: alla luce della
quale, come si vedrà, si potranno anche evincere alcuni criteri
ricostruttivi di ordine generale ai fini della palingenesi della
medesima Legge. A tale tema, sono dunque dedicate le pagine che
seguono5.
2. Pubblicati nel 1915 tra Lione e Parigi, i primi due tomi
degli Études sur le furtum di Paul Huvelin6, ancorché oggi un po’ – ed
ingiustamente, a mio modo di vedere – trascurati dalla più recente
5 L’argomento del presente contributo è intimamente connesso non solo a moltedelle indagini già precedentemente svolte nel corso dei decenni che abbiamo allespalle (cfr. supra nt. 4), ma è soprattutto direttamente correlato alla relazioneda me tenuta (“La responsabilità nelle XII Tavole: profili palingenetici”), lo scorso 7 dicembre2007, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’ambito delConvegno su “Forme di responsabilità in età decemvirale”, su invito di LuigiCapogrossi Colognesi e Floriana Cursi. I due temi dunque – quello del presentecontributo e quello precedentemente svolto a Roma – sono, come ovvio,strettamente connessi l’un l’altro. Non potrò, quindi, che ripercorrere in questasede, non pochi degli argomenti svolti nella menzionata relazione romana,talvolta in misura pressoché coincidente: poiché coincidono, tra loro, appunto,non di rado, i temi affrontati nelle due diverse occasioni.6 P. HUVELIN, Études sur le furtum dans le très ancien droit romain, I – II. Les sources, Lyon –Paris 1915 (reprint Roma 1968).
4
letteratura giusromanistica, rappresentano, viceversa, ancora un
punto di riferimento essenziale per gli studi sul furto nel
diritto romano arcaico: vuoi per l’imponente mole di materiale
raccolto, analizzato e interpretato, vuoi per la schietta
originalità delle soluzioni proposte7.
Il grande studioso, dunque, preliminarmente8, si poneva il
problema della collocazione e dell’ordine delle norme concernenti
il furtum all’interno della Legge delle XII Tavole, cui dedicava
gran parte della propria indagine. In tal senso, dopo una densa
digressione che prendeva le mosse dalle palingenesi decemvirali
correnti nel torno di tempo in cui egli scriveva – in verità ancor
oggi largamente utilizzate in dottrina: tornerò tra breve su
questo punto – l’autore mostrava stupore nel constatare come il
furtum stesso fosse collocato all’interno dell’antica Legge, e cioè
– come ben si sa – nell’ottava tavola, insieme all’intera materia
“penalistica” (pubblica e privata). A suo dire, infatti, tutte le
testimonianze arcaiche avrebbero viceversa deposto per una
collocazione delle norme in esame del tutto diversa. Per Huvelin,
infatti, i versetti decemvirali concernenti il furtum – alla luce
in particolare dell’esame del commento di Gaio alle XII Tavole9 –
si sarebbero dovuti collocare “dans le premières des Douze
Tables”10.
E’ ben noto, invece, che – nelle correnti palingenesi – tutte
le norme concernenti quelle fattispecie che in prosieguo di tempo
7 La monografia sul furtum di Huvelin faceva peraltro seguito alla precedente,dedicata anch’essa ad una diversa fattispecie di illecito privato nel più anticodiritto romano, a testimonianza di una consuetudine certo non comune di studisui temi in esame: P. HUVELIN, La notion de “l’iniuria” dans le très ancien droit romain, Lyon1903 (reprint Roma 1971)8 HUVELIN, Études cit. 16 ss.9 Cfr. infra § 6.10 HUVELIN, Études cit. 22.
5
sarebbero state considerate delicta (e, dunque, anche il furtum) sono
collocate nella tabula ottava, dedicata, come altrettanto è noto
agli studiosi, al “diritto penale”.
3. Ho voluto incominciare questa disamina ricordando la
radicale critica di un grande studioso quale Huvelin alla
“sistematica” corrente della Legge delle XII Tavole in merito al
furtum, al solo scopo di evidenziare – attraverso un esempio
paradigmatico – come in realtà le palingenesi normalmente
utilizzate già un secolo fa reggessero poco all’analisi diretta
delle fonti in nostro possesso, svolta da quanti si cimentavano
nel merito dello studio dei singoli istituti e non in
ricostruzioni complessive dell’antica legislazione decemvirale.
Le fonti in nostro possesso, infatti, come si cercherà di
evidenziare nel corso di questo contributo, inducono a rimeditare
complessivamente – e nel profondo – l’ordine interno dell’antica
legislazione decemvirale quale è comunemente accettato in
dottrina.
A tali problemi ho dedicato nel corso degli ultimi decenni non
poche pagine: e ad esse sono evidentemente costretto, in questa
sede, a rinviare per le considerazioni d’insieme e per tutti i
necessari approfondimenti11. Mi limiterò, pertanto, nel corso di
questo contributo, come detto in precedenza, ai soli profili
concernenti il “diritto penale” (e le norme relative),
sottolineando tuttavia che il tema in esame è, comunque, come
ovvio, connesso alla critica palingenetica più generale, della
quale darò tuttavia solo alcuni, brevi cenni: quelli ora
strettamente indispensabili.
11 Cfr. supra nt. 4.
6
Osserviamo, dunque, come si presentano la struttura e l’ordine
della Legge delle XII Tavole nelle palingenesi correnti, di cui è
esempio illustre quella conservata nel primo volume dei Fontes di
Riccobono12, comunemente utilizzata nell’ambito della nostra
comunità scientifica.
L’ordine delle norme prevede, come ben sanno gli studiosi, che
nelle prime tre tavole sia disciplinato il processo civile; nella
quarta il diritto di famiglia; nella quinta tutela, curatele e
successioni; nella sesta e nella settima i diritti reali;
nell’ottava – a mio avviso la più anomala, come si vedrà appresso,
dal punto di vista palingenetico – è contenuto il diritto penale,
sia quello privato (le fattispecie che diverranno i delicta del
diritto classico), che quello pubblico (i crimina, per quanto
schematica appaia questa distinzione); nella nona tavola sono
raccolte le norme di “diritto pubblico”; nella decima, infine, si
rinvengono le leggi concernenti i funerali e le sepolture. Mi
fermo alle prime dieci tavole perché, com’è noto, solo su di esse
è possibile tentare un’eventuale analisi concernente l’impianto
complessivo dell’antica raccolta legislativa, essendo esse state
promulgate insieme, mentre le ultime due tavole – successive, come
si sa – hanno, rispetto alle prime dieci, carattere aggiuntivo e
integrativo.
La successione delle norme tra loro sembra ricordare, dunque,
un ordine molto simile a quello di un codice moderno: le norme
medesime sono, infatti, collocate nelle diverse tabulae sulla base
di un criterio sistematico, classificatorio, fondato a sua volta
su categorie giuridiche (processo, diritto di famiglia e delle
persone, successioni, diritti reali, diritto penale, diritto
12 DILIBERTO, Bibliografia ragionata cit. 227.
7
pubblico), riconducibili tuttavia ad un’elaborazione concettuale
difficilmente ascrivibile al V secolo a.C.: evidentemente, la
circostanza che Dirksen, come si vedrà appresso, decisivo
ispiratore di tale impianto, operi nella prima metà dell’ ‘800 –
in piena discussione sulle codificazioni civilistiche continentali
– è tutt’altro che irrilevante nella formazione di quello che può
– un po’ sommariamente – essere definito una sorta di “canone”
della palingenesi decemvirale. Il che – per tornare all’inizio
della nostra riflessione – non era sfuggito ad uno studioso quale
Huvelin che definiva quest’impianto della Legge delle XII Tavole
frutto di un’impostazione da legislatore moderno, piuttosto che
della mentalità e delle categorie concettuali ascrivibili al V
secolo a.C.13.
Ora, le ricostruzioni palingenetiche comunemente accolte sono
frutto – è appena il caso di ricordarlo – di una lunghissima
sedimentazione di studi, che ha portato – nel corso di almeno
cinque secoli14, dal XVI secolo ad oggi – alla emersione di quello
che ho definito, appunto, il “canone”: il testo delle XII Tavole
quale generalmente accolto dagli studiosi.
La storia della formazione del “canone” non interessa questa
nostra indagine e vi ho d’altra parte dedicato non pochi recenti
lavori, cui senz’altro rinvio15: giova dunque solo rammentare che
tale progressiva sedimentazione di un modello ricostruttivo delle
XII Tavole è frutto di un intenso lavoro – incominciato da Aymar
du Rivail nel 151516, preceduto peraltro da alcuni modesti13 HUVELIN, Études cit. 20.14 DILIBERTO, Bibliografia ragionata cit. passim.15 Cfr. supra nt. 4.16 Aymari Rivallii Allobrogis Jurisconsulti ac Oratoris Libri de Historia Iuris Civilis et Pontificii. VenundanturValentiae in bibliotheca Ludovici Olivelli bibliopole universitatis Valen. iurati. Databile con certezza,attraverso un privilegio, al verso del titolo: Valentiae, 8 agosto 1515. Daultimo, con letteratura precedente, cfr. DILIBERTO, Umanesimo giuridico antiquario.1.
8
tentativi palingenetici quattrocenteschi, in piena temperie
umanistica17 – che trova una prima sistemazione organica e
criticamente accettabile nel 1616, un secolo dopo, per opera di un
grande giurista quale Jacques Godefroy18. Quest’ultimo – a buon
diritto – può dirsi il precursore di quel modello palingenetico
che ho definito “canone” decemvirale, la cui definitiva
affermazione avverrà tuttavia due secoli dopo, nel 1824, ad opera
di Dirksen19, i cui risultati saranno sviluppati e perfezionati
infine da Schoell nel 186620. Può ben dirsi, infatti, che la gran
parte delle sillogi e delle palingenesi successive – sino ai
giorni nostri – discendono, con poche variazioni, dalle
conclusioni raggiunte da questi ultimi due grandi studiosi. La
restituzione della Legge delle XII Tavole dei Fontes di Riccobono è,
dunque, essa stessa, dipendente in via diretta dal “canone” quale
si è ora, così sommariamente, descritto.
4. Un siffatto impianto palingenetico, anche in astratto, al di
là delle fonti che andremo subito ad analizzare, a me è sempre
parso una forzatura. Per due motivi. In primo luogo, perchè nel V
cit. 107 ss. e ID., “Lex de magistratibus” cit. 1473 ss.17 Cfr. i miei lavori citati supra nt. 4.18 Fragmenta XII. Tabularum suis nunc primum tabulis restituta, Iacobo Gothofredo … auctore,Heidelbergae 1616 (ma citerò l’opera, nel corso di questo contributo, dalla piùcomune edizione contenuta nel terzo volume del Thesaurus Juris Romani di Otto,Basileae 1744), su cui v., con letteratura, DILIBERTO, Bibliografia ragionata cit.127 ss.; ID., Una palingenesi ‘aperta’ cit. 220. Da ultimo, si è interessato dellapalingenesi decemvirale di Godefroy anche A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto inEuropa. Dal medioevo all’età contemporanea, Bologna 2007, 257.19 E. H. DIRKSEN, Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf–Tafeln–Fragmente, Leipzig 1824: cfr. DILIBERTO, Bibliografia ragionata cit. 176 s.; ID.,Una palingenesi ‘aperta’ cit. 220.20 R. SCHOELL, Legis Duodecim Tabularum Reliquiae, Lipsiae 1866: cfr. DILIBERTO,Bibliografia ragionata cit. 203; ID., Una palingenesi ‘aperta’ cit. 220 e ivi lett.precedente. Sulla formazione del “canone”, v. ora anche U. AGNATI, Leges DuodecimTabularum cit. 17 e passim; M.T. FÖGEN, Das Lied vom Gesetz, München 2006, 57 ss. esoprattutto J.-L. FERRARY, Saggio di storia della palingenesi delle Dodici Tavole, in Le DodiciTavole cit. 506 ss. (da Rivail in avanti).
9
secolo a.C., non ritengo potesse ancora esistere a Roma un sistema
classificatorio che presuppone, da un lato, lo schema genus – species
e, dall’altro, la conoscenza di categorie concettuali giuridiche
evolute.
In secondo luogo, una struttura siffatta per la Legge delle XII
Tavole induce a credere che ogni tabula contenesse un argomento (e
solo quello), con la presumibile conseguenza di tavole tra loro
diseguali nella misura, a seconda, appunto, dei temi in esse
contenuti. A seguire tale restituzione, inoltre, si dovrebbe anche
immaginare che, esaurito – per così dire – un certo argomento (che
so? il diritto di famiglia) ed iniziandone un altro, si
incominciasse ad incidere una tabula diversa, per mantenere ben
distinte le materie affrontate in ognuna di esse.
Una tale idea “codificatoria” contraddice però – a mio modo di
vedere – tutto ciò che si sa delle tecniche legislative antiche ed
è peraltro largamente smentita dalla semplice osservazione prima
facie, delle più risalenti testimonianze epigrafiche (non solo di
argomento giuridico), che si fondano su un criterio opposto: e
cioè quello dell’economia del materiale. I testi epigrafici a noi
pervenuti non presentano, infatti, alcuna scansione o soluzione di
continuità tra i differenti temi in essi trattati, utilizzandosi
viceversa – come d’altro canto ovvio – ogni spazio fisico
disponibile per la scrittura, indipendentemente dal passaggio da
una materia all’altra.
Alla luce, dunque, di tali considerazioni critiche di fondo,
proviamo a svolgere un’analisi di natura palingenetica fondata
sulle sole fonti antiche a disposizione, nel tentativo di
collocare quante più leggi sia possibile all’interno delle XII
Tavole stesse, senza alcuna pretesa di esaustività, esclusa – a
10
mio modo di vedere – dall’esiguità delle informazioni in nostro
possesso.
Ora, le fonti antiche che direttamente concernono l’ordine e la
collocazione delle norme all’interno dell’antica raccolta
legislativa non sono, come ben noto, numerose: tutt’altro.
Attraverso una celebre affermazione di Cicerone21, ricaviamo che le
XII Tavole si aprivano22 con la norma sulla in ius vocatio. Festo23,
inoltre, se pure con qualche incertezza della dottrina al
proposito24, ci consente di collocare la disposizione sul dies diffisus
nella seconda legge della seconda tavola. Dionigi di Alicarnasso25,
invece, ricorda come la previsione della liberazione del filius dalla
potestas paterna a seguito della triplice vendita si trovasse nella
quarta tavola. Ancora Cicerone26 asserisce che le norme concernenti
le sepolture e i funerali fossero collocate nella decima tavola.
Infine, pur senza suggerire alcunché in relazione alla tabula
relativa, Ulpiano27 ci informa, infine, che le disposizioni sulla
successione testamentaria precedevano nel testo decemvirale quelle
21 Cic. leg. 2.4.922 Il tema della norma con la quale si aprivano le XII Tavole, tradizionalmenteritenuta, appunto, quella concernente la in ius vocatio, sulla scorta del menzionatotesto ciceroniano, è stato recentemente affrontato, in una prospettiva del tuttonuova, da G. FALCONE, La citazione ‘Si in ius vocat’ in Cic., leg. 2.9, in AUPA 50 (2005) 119 ss.(ivi anche la letteratura precedente). Non è questa, evidentemente, la sede peraffrontare, neppure cursoriamente, tali questioni, ma conto di ritornare quantoprima sulla fonte ciceroniana in esame per confrontarmi diffusamente con ledense ed innovative indicazioni prospettate da Falcone.23 Fest. s. v. reus, 336 L.24 DILIBERTO, Materiali cit. I, 14 s., 198. Sul punto, v. S. CORBINO, XII Tab. 2.2 e lapresenza del magistrato nel processo privato romano in età decemvirale, in Est. hom. J. Iglesias, IIIMadrid 1988, 1180 e 1184; B. ALBANESE, Sulle cause di diffissio diei in XII tab. 2,2, in Brevistudi di diritto romano (II), in AUPA 43 (1995) 178 e ivi note.25 Dion. Hal. 2.27.326 Cic. leg. 2.25.64. Da ultimo, v. B. ALBANESE, Su XII Tab. 10.2 – 4 (regole per i ritifunerari), in SDHI 64 (1998) 397 ss.27 Ulp. 44 ad ed. D. 38.6.1 pr.
11
sulla successione intestata. Non rilevano, in tale analisi, le
notizie concernenti le tavole undicesima e dodicesima28.
Si tratta, con tutta evidenza, di poche e frammentarie
informazioni: il che implica – come ovvio – che si debbano
ricercare vie nuove e metodologie almeno parzialmente differenti,
rispetto al passato, per cimentarsi in ipotesi palingenetiche
fondate esclusivamente sulle fonti antiche e non su un’idea
codificatoria moderna. E’ quanto ho provato a fare sin dalla
monografia del 199229 e poi negli studi ad essa successivi: alla
luce dei risultati in essi raggiunti, proverò anche a ragionare
intorno alle norme decemvirali “penalistiche” e alla loro
collocazione all’interno delle XII Tavole.
5. Veniamo, dunque, al “diritto penale”. Quest’ultimo, si sa, è
accorpato nelle correnti edizioni in un’unica tavola, l’ottava,
che tratterebbe, dunque, sia degli illeciti privati, che di quelli
pubblici.
A parte le già ricordate30 radicali riserve di Huvelin, giova
sottolineare che anche dal punto di vista palingenetico un
siffatto accorpamento di tutta la materia degli illeciti in
un’unica tabula sia stato frutto di un travaglio meno univoco e
scontato di quanto è accaduto per altre fattispecie. Godefroy, a
suo tempo, collocava la disciplina del furtum nella seconda tavola
(intitolata De Judiciis, et de Furtis)31, gli altri illeciti privati (de
Delictis) nella settima32 ed infine inseriva diverse ipotesi di crimina
28 Cfr. supra § 3. Fonti e letteratura essenziale in DILIBERTO, Materiali cit. I, 16ss.29 Cfr. supra nt. 4.30 Cfr. supra § 2.31 GODEFROY, Fragmenta cit. 82 ss. 32 GODEFROY, Fragmenta cit. 114 ss.
12
nella nona tabula, insieme alle norme di “diritto pubblico”33. In
altre parole, l’insigne studioso non proponeva certo un’unica tabula
di “diritto penale”. Anche Dirksen, pur operando per primo un
sostanziale accorpamento della materia ora in esame (illeciti
privati e pubblici), ipotizzava tuttavia che perlomeno il pacisci de
furto andasse collocato nella seconda tavola, prima del pacisci
connesso alla procedura esecutiva34. A ben vedere, dunque, il
totale accorpamento delle norme “penalistiche” nella tavola ottava
è dovuto, successivamente, al già ricordato Schoell35, per entrare
così, in via definitiva, nelle moderne palingenesi36.
Si tratta, dunque, di un’ipotesi – ancorché oggi largamente
accolta in dottrina, ma direi più per convenzione tralatizia, che
per approfondita adesione – non sempre pacifica tra gli studiosi
che più degli altri si sono occupati di palingenesi decemvirale.
Ma è tempo di analizzare direttamente la tavola ottava quale si
presenta nelle ricostruzioni correnti.
Essa consta di ben ventisette norme. E’, dunque, di gran lunga,
la più estesa delle tavole: la settima, infatti, che la segue per
dimensioni, ne conserva meno della metà, dodici leggi.
Il dato è meramente descrittivo, come ovvio, ma evidenzia già
un sostanziale squilibrio all’interno delle palingenesi in esame.
Si può sempre obiettare che ciò dipenda semplicemente dal caso: e
cioè dal maggior numero di informazioni sugli illeciti che le
fonti antiche hanno conservato, rispetto alle altre materie. Ma il
33 GODEFROY, Fragmenta cit. 130 ss.34 DIRKSEN, Uebersicht cit. 215 ss. Su tutto ciò, diffusamente, v. DILIBERTO,Materiali cit. I, 347 ss.35 SCHOELL, Legis Duodecim Tabularum Reliquiae cit. 140-152.36 Rinvio ancora a quanto sostenuto in DILIBERTO, Materiali cit. I, spec. 348 e iviindicazioni bibliografiche.
13
dato – certo in sé non concludente – è tuttavia a mio modo di
vedere comunque significativo.
Ancora. Una trattazione omogenea ed unitaria – degli illeciti
privati e dei crimina insieme – contraddice, a mio avviso, quanto si
sa della successiva evoluzione delle due diverse fattispecie nel
corso della storia del diritto romano sino alla Compilazione
giustinianea, passando per l’editto: ancorché con elementi tra
loro comuni, infatti, la distinzione concettuale (e di relativa
disciplina) tra crimina e delicta – è appena il caso di ricordarlo – è
stata sempre netta.
Può, certo, sostenersi che in età arcaica quella linea di
demarcazione ancora non esistesse. Ma ciò è, ancora una volta,
contraddetto da quanto sappiamo attraverso le fonti relative
proprio all’età più antica.
Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 4.25.2), infatti,
attribuisce già alla legislazione regia37 la distinzione tra
illeciti privati e fattispecie punite direttamente dalla civitas. Non
è in discussione, evidentemente, la maggiore o minore
attendibilità dell’informazione di Dionigi – valorizzata peraltro,
a suo tempo tra gli altri, già da Burdese38 – in merito alla
relativa lex regia. Ciò che rileva invece – ai fini di questa
indagine – è che gli storici romani percepivano la distinzione
(impiego le due successive espressioni molto schematicamente, a
meri fini espositivi) tra crimina e delicta come collocabile alle
scaturigini di Roma, esistente da tempo immemorabile: volerli37 FIRA I. 17 (Servio Tullio, VI.4); G. FRANCIOSI (cur.), Leges regiae, Napoli2003, 186.38 A. BURDESE, Riflessioni sulla repressione penale romana in età arcaica, in BIDR 69 (1966) 349s.; DILIBERTO, Materiali I cit. 351, 353 s.; da ultimo. ID., Una palingenesi ‘aperta’cit. 228 e ivi letteratura ulteriore. Sul punto v. anche le equilibrateconsiderazioni di B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma2, Milano 1998,21, 60 ss. e spec. 67.
14
accorpare in un’unica tavola di contenuto “penalistico” a me pare,
dunque, alquanto arbitrario39.
Ancora. Non possediamo, come ho già ricordato, numerose
testimonianze antiche che direttamente offrono elementi per la
collocazione delle materie nelle singole tavole della Legge. Ma
almeno una di esse, a mio modo di vedere, è di grande rilevanza
palingenetica, perché suggerisce una preziosa indicazione
metodologica.
Si è già ricordato, infatti, come – attraverso Cicerone – si
sappia che nella tavola decima erano disciplinati i riti funebri
(leg. 2.25.64)40. Ora, gli autori delle moderne palingenesi – in
virtù di tale precisa ed esplicita informazione ciceroniana – sono
stati quindi giustamente indotti ad accorpare le regole funerarie
in un’unica tavola: la decima appunto. Ma una siffatta tabula appare
– anche ad un’analisi sommaria – del tutto incongrua rispetto
all’impianto complessivo delle medesime palingenesi, nonché
rispetto alle altre tavole, fondate su categorie concettuali ben
diverse, assai più rispondenti a logiche moderne. La materia delle
regole concernenti i riti funerari non è, infatti, inquadrabile in
alcuna delle partizioni tradizionali del diritto, così come
viceversa accade per tutte le altre tabulae delle correnti
palingenesi (processo, diritto di famiglia e delle persone,
successioni, diritti reali, diritto penale, diritto pubblico). Le
regole funerarie nel loro insieme non sono infatti ascrivibili, in
39 V. GIUFFRE’, La repressione criminale nell’esperienza romana. Profili4, Napoli 1997, 27, hagiustamente osservato, in tal senso, che proprio le XII Tavole avrebberoaccentuato e “reso più netta” la distinzione tra illeciti penali privati ecrimini repressi dall’intervento pubblico.40 Da ultimi, cfr. B. ALBANESE, Su XII Tab. 10.2-4 (regole per i riti funerari), in SDHI 64(1998) 397 ss.; DILIBERTO, Una palingenesi ‘aperta’ cit. 223; O. SACCHI, Sub asciadedicare e tab. X.2: rogum ascea ne polito. Alla ricerca di un’antica ratio, in Fides Humanitas Ius cit.VII 4861 ss. e ivi ult. lett.
15
quanto tali, ad alcuna categoria giuridica tradizionale, perchè
concernono aspetti che, per così dire, attraversano le diverse
partizioni del diritto. Tra le norme sui funerali e sulle
sepolture vi sono, infatti, prescrizioni e divieti, regole da
rispettare e responsabilità in caso di loro violazione; vi sono,
altresì, disposizioni che un moderno interprete definirebbe di
“diritto pubblico”, altre di “diritto privato” o di “diritto
penale”: quasi tutte, peraltro – direi trasversalmente –, anche
ascrivibili al ius sacrum.
Ciò che induce, dunque, all’accorpamento delle norme funerarie
in una stessa tabula non sembra essere un criterio classificatorio
astratto, bensì l’oggetto materiale della disciplina e la tutela dei
relativi interessi (in questo caso, la regolamentazione giuridica
di ciò che accade dopo la morte), che prescindono, a mio modo di
vedere, da ogni forma di inquadramento di natura sistematica.
Ed è bene rilevare che questa tabula è l’unica la cui
indicazione contenutistica sia frutto di una precisa informazione
tratta direttamente dalla documentazione antica e non sia,
viceversa, conseguenza di un lavoro palingenetico moderno.
6. Queste prime risultanze, di per sé, inducono a ragionare
sulla collocazione delle norme relativi agli illeciti con maggiore
cautela e con un’ottica almeno parzialmente diversa rispetto a
quella che ha ispirato le palingenesi decemvirali correnti. Ma
anche le altre fonti in nostro possesso depongono per conclusioni
assai differenti rispetto a tali palingenesi41.
41 In questo e nel prossimo § riproduco – salvo poche, ininfluenti modifiche – iltesto della relazione romana di cui si è già dato conto (cfr. supra nt. 5), népotrebbe essere altrimenti, considerata l’identità dei temi trattati nei duetesti.
16
Confrontiamo, dunque, queste prime indicazioni di carattere
generale con ciò che si ricava dal commento di Gaio alle XII
Tavole, valorizzato per la ricostruzione palingentica soprattutto
da Mario Lauria42, che riprendeva e sviluppava un criterio
metodologico già impiegato a suo tempo dal già menzionato Jacques
Godefroy43. L’idea di fondo – del tutto condivisibile – è che
l’ordine interno del commento segua quello del testo commentato44.
Mi limiterò, evidentemente, in questa sede, a poche
considerazioni, utili ai fini della nostra indagine, rinviando a
quanto già sostenuto, a più riprese, in altri luoghi45.
Del commento di Gaio alle XII Tavole conosciamo non pochi
frammenti46 e la lunghezza complessiva (sei libri): le rubriche del
Digesto, peraltro, consentono di collocare ogni passo in un libro
determinato dell’opera. Proviamo, quindi, seguendo Lenel,
rapidamente ad individuare le materie trattate nel commento
gaiano. Nel primo libro, oltre alla notissima praefatio (D.1.2.1)
nella quale si presenta il principium del diritto come potissima pars
del tutto47, si trova la disciplina della in ius vocatio (D.2.4.18,42 M. LAURIA, Ius Romanum I.1 Napoli 1963, 22 e ID., Iura, leges, in Atti Accad. Napoli 81(1970) 21 ss. Su tutto ciò, v. diffusamente DILIBERTO, Materiali cit. I 10 ss.,107 ss., M. H. CRAWFORD, Roman Statutes (BICS. Supplement) II London 1996, 564; F.DE MARINI AVONZO, Lezioni di storia del diritto romano, Padova 1999, 51; F.M. D’IPPOLITO,Problemi storico-esegetici delle XII Tavole, Napoli 2003, 126 ss., 142 ss.; DILIBERTO, Unapalingenesi ‘aperta’ cit. 223 e ivi nt. 32. Tema connesso è quello – ancora una voltasuggerito dal Lauria – se l’ordine edittale seguisse a sua volta quello delleXII Tavole: sul punto, per tutti, v. D. MANTOVANI, Gli esordi del genere letterario adedictum, in Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Attiseminario S. Marino (1993), cur. D. MANTOVANI, Torino 1996, 67 s e ivi nt. 19.43 Cfr. supra § 3.44 DILIBERTO, Una palingenesi ‘aperta’ cit. spec. 223 ss.45 Cfr. supra nt. 4.46 Da ultimo, sul commento di Gaio alle XII Tavole, v. O. LICANDRO, Domiciliumhabere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano, Torino 2004, 414, 428, 442 s.Sulla storia del diritto nell’opera gaiana, oltre a DILIBERTO, Materiali cit. I 54ss., v. ora anche L. PELLECCHI, La praescriptio. Processo, diritto sostanziale, modelli espositivi,Padova 2003, 124 e ivi nt. 55. 47 DILIBERTO, Materiali cit. I 57 ss. e ivi lett. Da ultimi, v. S. SCHIPANI,Principia iuris. Potissima pars principium est. Principi generali del diritto. Schede sulla formazione di un
17
2.4.20, 2.4.22)48, quella del vadimonium (D.2.11.6), dell’actio
arborum furtim caesarum (D.47.7.2, 47.7.4) e l’analisi del lemma telum
(D.50.16.233.2)49 che, come credo di aver dimostrato a suo tempo50,
si riferisce all’ipotesi del fur qui se telo defendit.
Il primo libro del commento di Gaio, dunque, se da un lato
sembra confermare che la in ius vocatio si trovava all’inizio delle XII
Tavole51, insieme ad altra materia processuale, dall’altro induce a
credere che il furtum fosse trattato anch’esso all’inizio
dell’antico testo legislativo: e ciò, di per sé, costituisce
novità di non poco momento, rispetto all’ordine delle materie
quale proposto nelle palingenesi decemvirali comunemente accolte.
Nel secondo libro dell’opera, Gaio affronta le tematiche del
dies diffisus (D.50.16.234 pr.) e della manus iniectio (D.50.16.234.1).
Nel terzo libro, oltre a frammenti di più incerta collocazione52,
si analizza il lemma tignum (D.50.16.235.1)53, senza che ciò offra
ulteriori indicazioni in merito all’ordine delle norme. Privi di
rilievo – ovviamente, solo dal punto di vista palingenetico –
anche i libri quinto e sesto.
concetto, in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alla esperienza moderna.Ricerche dedicate al prof. F. Gallo, III Napoli 1997, 649 ss. e R. QUADRATO, Gaio e la “leguminterpretatio”, in Fides Humanitas Ius cit. VII 4557 s.48 Da ultimi, cfr. P. GARBARINO, Un’ipotesi di lettura di D. 47.10.23 (Paul. 4 ad ed.). Brevi note aproposito di in ius vocatio e presunta violazione di domicilio, in Scritti in ricordo di B. Bonfiglio, Milano2004, 231 ss.; D. MANTOVANI, Un’integrazione alla palingenesi leneliana dei digesta di Giuliano(Paul. 1 ad ed. D. 2.4.19 e l’in ius vocari de dono sua), in AUPA 50 (2005) 145 ss.; A. DEFRANCESCO, Autodifesa privata e ‘iniuria’ nelle XII Tavole, in Parti e giudici nel processo. Dai dirittiantichi all’attualità, cur. C. CASCIONE, E. GERMINO, C. MASI DORIA, Napoli 2006, 40ss., 64 ss.; A. TRISCIUOGLIO, Sul vindex della in ius vocatio in età decemvirale. In margine a XIITab. 1.4, in Studi per G. Nicosia, VIII Milano 2007, 285 ss.49 Sul punto v. anche L. PEPE, Furto e giustizia privata nelle XII Tavole e nel diritto attico:un’indagine comparativa, in Scritti in ricordo di B. Bonfiglio cit. 273 ss. e spec. 275 e ivint. 17, 304 nt. 93; DE FRANCESCO, Autodifesa cit. 61 s.; QUADRATO, Gaio cit. 4566ss.50 DILIBERTO, Materiali cit. I 357 ss.51 Ma v. quanto già rilevato supra nt. 22. 52 LENEL, Palingenesia I 244 nn. 430 – 432.53 Cfr. QUADRATO, Gaio cit. 4574.
18
Viceversa, per quanto qui interessa, appare di grande
importanza il contenuto del quarto libro. Si tratta di materie,
apparentemente, assai disomogenee tra loro: in esso, il giurista
tratta, infatti, delle norme concernenti l’incendio doloso della
casa colonica o del raccolto altrui (punito con la
vivicombustione: D.47.9.954); analizza il lemma venenum
(D.50.16.236 pr.), da ascrivere – come è stato autorevolmente
dimostrato55 – alla disciplina e alle relative sanzioni degli
incantesimi contro il raccolto (fruges excantare)56; vi si affrontano,
poi, l’actio finium regundorum (D.10.1.13)57, l’actio de glande legenda
(D.50.16.236.1) ed infine la norma concernente la liceità
associativa per i collegia (D.47.22.4)58.
Gli argomenti ora ricordati sono, evidentemente, assai
disomogenei tra loro se considerati alla luce delle sistematiche
moderne. Appare singolare, infatti, che Gaio tratti nel medesimo
libro quarto materie di natura squisitamente “penale” – quali
54 Su cui v. A. BIGNARDI, Frangere e rompere nel lessico normativo e nell’interpretatio prudentium,in Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alla esperienza moderna. Ricerchededicate al prof. F. Gallo I Napoli 1997, 34 e ivi note; L. MINIERI, Norme decemvirali intema di incendio, in Ius Antiquum 2 (7) (2000) 42; G. SANTUCCI, Pacta adversus leges. Traccedella Legge delle XII Tavole nel commento edittale ulpianeo, in Tradizione romanistica e Costituzionecit. II 1205 s.55 B. ALBANESE, Su alcuni frammenti di Gaio “ad legem XII Tabularum”, in Labeo 44 (1998)spec. 189. Cfr. già diffusamente DILIBERTO, Materiali cit. I 112, 223 s. e ivifonti e lett. in merito.56 B. ALBANESE, Note sulle XII Tavole 2. Carmina conviviali e incantare, excantare, occentare, inMinima Epigraphica et Payrologica 7-8 (2004-2005) 123 ss.57 Ultimamente, v. M. VINCI, Fines regere. Il regolamento dei confini dall’età arcaica a Giustiniano,Milano 2004, 154 ss.58 Cfr. da ultimo M. BUONOCORE – O. DILIBERTO, L’album e la lex della familia Silvani diTrebula Mutuesca. Nuove considerazioni, in Rendiconti Pontificia Accademia Romana di Archeologia 75(2002-2003) 327 ss. ed in Minima Epigraphica et Papyrologica 9 (2006) 211 ss. e iviletteratura. Sul testo, v. anche – in una prospettiva diversa, tesa a ragionaresulla derivazione greca delle XII Tavole (su cui v. ultimamente CRAWFORD, RomanStatutes cit. II 560, lo stesso R. MARTINI, XII Tavole e diritto greco, in Labeo 45 (1999)20 ss. e ivi lett. e D’IPPOLITO, Problemi cit. 28 e ivi nt. 36, 93 s.) – R.MARTINI, Terminologia greca nei testi dei giuristi romani, in Scientia iuris e linguaggio nel sistemagiuridico romano, cur. F. SINI e R. ORTU, Milano 2001, 151 s.; B. ALBANESE, Brevistudi di diritto romano (III), in AUPA 47 (2002) 88 ss.
19
l’incendio del raccolto e l’incantesimo contro le messi – e, al
contempo, temi privatistici quali quelli concernenti i rapporti di
vicinanza. Tale disomogeneità ha dunque indotto i moderni
interpreti a collocare le medesime materie in luoghi tra loro
diversi delle palingenesi decemvirali: le azioni a difesa dei
rapporti di vicinanza sono inserite nella settima tavola; mentre
le norme ascrivibili al “diritto penale” si trovano nell’ottava
(così come anche – un po’ incomprensibilmente – la norma sui
collegia), evidentemente in ossequio al criterio della presunta
unitarietà del diritto penale (pubblico e privato) romano in età
decemvirale.
Tale diversa collocazione non mi convince. L’unico dato certo,
infatti, è che Gaio tratta di tali materie – apparentemente,
ripeto, disomogenee – nel medesimo libro dell’opera, il che
implica che nel testo commentato – e cioè quello delle XII Tavole
posseduto (o comunque studiato) dal giurista – quegli argomenti si
trovassero a loro volta accorpati tra loro.
Il punto è che occorre ragionare su tali temi – a mio modo di
vedere – in un’ottica profondamente diversa da quella che ha
contribuito alla formazione del “canone”: nessun criterio
classificatorio moderno potrà, infatti, mai riuscire a spiegare
l’accorpamento tra loro, in un contesto unitario, di norme così
concettualmente differenti come quelle ora in esame.
L’apparente disomogeneità di tali disposizioni legislative può,
viceversa, trovare una spiegazione – a mio avviso convincente – se
le si analizza, appunto, con un’ottica nuova e diversa. Cosa
accomuna, infatti, tra loro le norme decemvirali commentate da
Gaio nel quarto libro? Ritengo che il criterio “attrattivo” sia
rappresentato – in misura che a me pare chiarissima – dalla tutela
20
della terra, del libero esercizio dell’agricoltura ed in
definitiva della proprietà fondiaria, principale forma di
produzione antica. Non a caso, nello stesso contesto sono
conservate norme che sanzionano comportamenti illeciti contro il
raccolto altrui (incendio e incantesimi) e disposizioni
concernenti i rapporti tra campi limitrofi. Ciò che conta,
insomma, ai fini dell’accorpamento e della successione delle leggi
decemvirali tra loro, non è l’appartenenza di una norma (o di un
istituto) ad una categoria concettuale astratta, ma la materialità
dell’interesse di volta in volta tutelato in un certo contesto della Legge delle
XII Tavole59.
Il che sembrerebbe in sintonia con quanto si è rilevato in
precedenza a proposito delle norme contenute nella decima tavola60,
concernenti i riti funerari, accorpate tra loro – ancora una volta
– sulla base dell’interesse tutelato (in questo caso il destino
dell’uomo dopo la morte) e non in base a categorie giuridiche
astratte.
7. Veniamo ad un altro testo – molto conosciuto anch’esso – che
può offrire ulteriori spunti in relazione al tema qui affrontato.
Mi riferisco a Gell. noct. Att. 16. 1061.59 Resta da chiarire il motivo per cui, nel medesimo quarto libro di Gaio, ètrattata anche la disciplina dei collegia: si potrebbero a questo proposito, sullabase del ragionamento appena svolto, proporre diverse ipotesi, poiché i collegiamedesimi – soprattutto nell’età più antica – erano costituiti o a scopolavorativo o a scopo di culto: ed entrambe tali attività possono essereagevolmente ricondotte ala disciplina della terra. Ma si tratterebbe,evidentemente, di congetture che non sarebbero, in questo caso, suffragate dariferimenti testuali. Il problema resta, dunque, a mio modo di vedere, almomento, irrisolto.60 Cfr. supra §§ 4-5.61 ‘Ego vero’ inquit ille ‘dicere atque interpretari hoc deberem, si ius Faunorum et Aboriginum didicissem.Sed enim cum proletarii et adsidui et sanates et vades et subvades et viginti quinque asses et talionesfurtorumque quaestio lance et licio evanuerint omnisque illa duodecim tabularum antiquitas nisi in legisactionibus centumviralium causarum lege Aebutia lata consopita sit, studium scientiamque ego praestare
21
Il passo è notissimo per più di un motivo62. Gellio, insieme ad
una cerchia di amici e sodali, è intento a leggere pubblicamente,
nel foro, gli Annales di Ennio. Ad un certo punto, si imbatte nel
termine proletarius, di cui asserisce non conoscere63 il significato.
Passa, dunque, di lì un giurista, non meglio identificato, al
quale Gellio chiede spiegazione del termine medesimo, trattandosi
di linguaggio giuridico: il giurista, tuttavia, risponde di non
essere tenuto a conoscere la terminologia arcaica decemvirale,
poiché essa, se si eccettuano le cause centumvirali nelle quali si
applicano ancora le legis actiones, è stata superata (consopita) dalla
legge Aebutia64. Per giustificare, dunque, la propria ignoranza, il
medesimo giurista cita in sequenza ben otto lemmi (o comunque
verba) tratti dalle XII Tavole che, ai suoi occhi, sarebbe stato
inutile conoscere poiché, appunto, non più in vigore (evanuerint):
proletarii, adsidui, sanates, vades, subvades, XXV asses, taliones, furtorum
quaestio lance et licio.
Ora, in altra sede ho avuto occasione di sostenere (e, spero,
dimostrare) che Gellio – quale che sia il giudizio sulla qualità
letteraria della sua opera – aveva certamente accesso a fonti
debeo iuris et legum vocumque earum, quibus utimur’.62 Letteratura e contesto in DILIBERTO, Materiali cit. I 360 ss.; CRAWFORD, RomanStatutes cit. II 566; V. anche, più recentemente, G. FALCONE, Ricerche sull’originedell’interdetto uti possidetis, Palermo 1996, 182; G. POMA, Gaio, Gellio e le “XII Tabulae”, inLabeo 43 (1997) 288; B. ALBANESE, Osservazioni su XII tab. 1.4: il “vindex” per “adsidui” e“proletarii”, in Index 26 (1998), 15 ss. e passim. A. MANZO, L’organizzazione gentilizia nelleDodici Tavole, in Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, cur. G. FRANCIOSI, IIINapoli 1995, 115; D’IPPOLITO, Problemi cit. 74 s., 157; DILIBERTO, Una palingenesi‘aperta’ cit. 231 ss.63 La finzione – per così dire – “scenica” di Gellio è evidente. L’asseritaignoranza è solo il pretesto, piuttosto scoperto, per mostrare viceversa lapropria erudizione: cfr. infra in questo stesso paragrafo.64 Sul testo e il riferimento alla legge Ebuzia, v. la letteratura citata inDILIBERTO, Una palingenesi ‘aperta’ cit. 231 nt. 64. Ultimamente, misurate parole inL. FRANCHINI, La desuetudine delle XII Tavole nell’età arcaica, Milano 2005, 38 ss.
22
documentarie antiche ed affidabili65, tra le quali spiccano, per
ciò che ci interessa, sicuramente materiali giurisprudenziali di
ascendenza sabiniana66.
Il testo ora in esame dimostra, tra l’altro, che – in sintonia
con il gusto antiquario del tempo in cui vive – il nostro autore
intende dare sfoggio d’erudizione proprio relativamente al diritto
romano più antico: menziona infatti lemmi decemvirali tra i più
bizzarri e obsoleti, non a caso facendo riferimento a quella65 Per tutti, ultimamente, v. L. CANFORA, Libro e libertà, Roma-Bari 1994, 89. Piùdubitativamente, cfr. POMA, Gaio cit. 290.66 DILIBERTO, Materiali cit. I 226 ss. e spec. 237 ss. (concorda POMA, Gaio cit. 283s. e 286: per le fonti gelliane e i rapporti con Gaio, v. diffusamente 285 ss.).Ultimamente, su Aulo Gellio v. Le Notti Attiche di Aulo Gellio, cur. G. BERNARDI –PERINI, I Torino 1992, 32 ss. (con letteratura) e M. L. ASTARITA, La cultura nelle“Noctes Atticae”, Napoli 1993 (da me diffusamente recensita in DILIBERTO, I destinataricit. passim). Cfr. ancora M. L. ASTARITA, Un’evoluzione nei recenti studi su Aulo Gellio, inBoll. St. Lat. 25.1 (1995) 172 ss. Sulle citazioni giurisprudenziali conservate inGellio e il suo rapporto con il diritto romano, v., tra i moltissimi autori chese ne sono, a vario titolo, occupati, J. ZABLOCKI, Appunti sul ‘testamentum mulieris’ inetà arcaica, in BIDR 94-95 (1991-1992) 160 ss. e ivi note, 172 ss., 199; V.GIUFFRE’, La traccia di Quinto Mucio. Saggio su “ius civile”/“ius honorarium”, Napoli 1993, 33(ivi anche lett. essenziale), 44, 69 e ivi nt. 141; L. PEPPE, Note sulla risalenza delc.d. “anulus pronubus”, in Iura 44 (1993) 169 s.; G. MELILLO, Il latino giuridico quale tramitetra il II e IV secolo e i suoi rapporti con l’età del primo Principato, in Labeo 39 (1993) 162, 164 s.;S. CORBINO, La capacità deliberativa dei ‘comitia curiata’, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, S.CORBINO, L. LABRUNA, B. SANTALUCIA, Le strade del potere, Catania 1994, 67, 77 ss.,81; M. A. LEVI, Adriano. Un ventennio di cambiamento, Milano 1994, 101 ss.; 108 s.; L.MANNA, Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell’editto de mancipiis venundis, Milano1994, 3 ss., 23 ss., 33 ss. e passim; B. ALBANESE, Tracce di diritto precivico nello statutodei fratres arvales?, in ID., Brevi studi cit. 123 e ivi nt. 2 e 125; A. BOTTIGLIERI, Sualcuni aspetti dell’ “interpretatio” di Q. Elio Tuberone il giovane, in Labeo 42 (1996) 368 e ivinote (con lett.), 372; G. VIARENGO, L’excusatio tutelae nell’età del Principato, Genova 1996,73 e ivi nt. 223; M. F. CURSI, La struttura del ‘postliminium’ nella repubblica e nel principato,Napoli 1996, 237, 53 ss. e 104; FALCONE, Ricerche cit. 182, 239 s.; I. PIRO, Unioniconfarreate e “diffarreatio”. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia, inIndex 25 (1997) 18, 22 s.; 46 e ivi note; U. BARTOCCI, Le species nuptiarumnell’esperienza romana arcaica. Relazioni matrimoniali e sistemi di potere nelle testimonianze delle fonti,Roma 1999, 5, 64, 85 e 108 s.; v. anche E. STOLFI, Studi sui “libri ad edictum” diPomponio I. Trasmissione e fonti, Napoli 2002, 267 nt. 7 e ivi ult. lett. e M. GARCIAGARRIDO, La tradizione nel pensiero giurisprudenziale (le coincidenze tra i Digesta di Celso e i Commentiad Sabinum), in Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi principe e diritto nel primo impero (AttiCopanello 1998), cur. F. MILAZZO, Napoli 2003, 229; S. RONCATI, Caio Ateio Capitone e iConiectanea (Studi su Capitone, I), in SDHI 71 (2005) 286 ss. e passim; sulla conoscenzagelliana di materiali giurisprudenziali, v. ora da ultima S. QUERZOLI, Giuristi edesperti di diritto nelle Notti Attiche di Aulo Gellio, in Biblioteche del mondo antico. Dalla tradizione oralealla cultura dell’Impero (cur. A. M. ANDRISANO), Roma 2007, 146 ss.
23
particolarissima procedura in tema di furto (quaestio lance licioque) che
nello stesso torno di tempo Gaio definiva ridicula (Gai. 3.193)67.
Torniamo, dunque, al testo.
I primi cinque lemmi68 appartengono alla materia del processo
privato. Gli ultimi tre, invece, vengono collocati dai moderni
editori, come più volte ricordato, nella tavola ottava, quella
“penalistica”, di cui si è detto: si tratta, peraltro, di tre
diverse espressioni (pena di venticinque assi, taliones, quaestio lance
licioque) tra loro legate, perché configurano evidentemente
fattispecie che nel diritto classico saranno i delicta. A me
parrebbe, dunque, piuttosto singolare che Gellio menzionasse, per
così dire, due “blocchi” di norme così distanti e diversi (dal
nostro punto di vista) tra loro (processo civile e illeciti
privati), se non avesse ravvisato in essi elementi di
correlazione. Bene, io credo che l’elemento unificante di tale
sequenza di citazioni sia rappresentato intrinsecamente proprio dal
processo. Non è un caso che Gellio – attraverso le parole del
giurista – affermi che tutti questi verba decemvirali fossero stati
abrogati dalla legge Ebuzia: il che implica che, almeno in una
certa misura, fossero anche tutti ricollegabili all’antica
procedura delle legis actiones.
D’altro canto, ho già evidenziato come nel commento di Gaio
alle XII Tavole il furtum sia trattato nel primo libro dell’opera69.
Altri indizi, di cui mi sono occupato a suo tempo, vanno nella
medesima direzione, tra i quali mi limito ad osservare che la
disciplina dello stesso furtum è affrontata da Labeone nel secondo
67 Da ultima, v. M. ZABLOCKA, Quaestio cum lance et licio, in Iura 54 (2003) 109 ss.68 Sull’incongruenza di proletarius prima di adsiduus nella sequenza v. laspiegazione in DILIBERTO, Materiali cit. I 366 s.69 Cfr. supra § 6.
24
libro del commento alle XII Tavole70, dunque, presumibilmente,
anche in questo caso, nella parte iniziale dell’opera71. Le
indicazioni tratte da Gell. noct. Att. 16.10 depongono, dunque, per
un’analoga conclusione.
Tutto ciò, in fondo, si ricorderà72, non era sfuggito alla
dottrina più antica per quanto concerne la disciplina decemvirale
del furtum. Il punto è, tuttavia, che – alla luce dell’ultimo testo
di Gellio analizzato – non solo il furtum, ma anche gli altri
illeciti ricordati (iniuria punita con la pena di XXV assi e legge
del taglione, che richiama evidentemente il membrum ruptum),
sembrerebbero da collocare, insieme alla materia processuale, all’inizio
delle XII Tavole.
Un’ultima – ancorché provvisoria – suggestione. Ove fosse
accolta tale ipotesi, un siffatto regime originario degli illeciti
privati – unitario e intimamente connesso alla regolamentazione
delle actiones –, e cioè delle fattispecie che saranno, di lì a
poco, definite delicta, ne spiegherebbe anche agevolmente la
successiva evoluzione, nonché la netta distinzione rispetto agli
altri illeciti oggetto di persecuzione pubblica.
8. Quando, per la prima volta, avanzavo queste critiche
all’impianto del “canone” generalmente accettato in dottrina per
la ricostruzione delle XII Tavole – l’ho già rammentato – era
l’ormai lontano 199273. Ero consapevole, come scrivevo allora, di
quanto “eversive” fossero tali considerazioni rispetto alle
opinioni consolidate nel tempo, sia sul piano della pars destruens,
70 Da ultimo, v. DE FRANCESCO, Autodifesa cit. 61 e ivi nt. 43.71 Cfr. ultimamente DILIBERTO, Una palingenesi ‘aperta’ cit. spec. 226 ss. e iviletteratura precedente.72 Cfr. supra §§ 2 e 5.73 DILIBERTO, Materiali cit. I spec. 333 ss.
25
sia, tanto più, in relazione alle nuove proposte ricostruttive che
discendevano da quelle stesse critiche.
Grande fu, dunque, la mia soddisfazione quando, pochi anni
dopo, Crawford, nei suoi Roman Statutes, accolse, almeno per grandi
linee, le miei ipotesi ricostruttive, collocando tutta la materia
degli illeciti privati all’inizio delle XII Tavole, insieme al
processo civile: il membrum ruptum è inserito, infatti, da Crawford
in tab. I.13, segue (I.14) l’os fractum, viene poi l’iniuria punita con
la pena di XXV asses (I.15), mentre da tab. I.17 a tab. I.21 sono
collocate le norme concernenti il furtum74.
Ora, è vero che, dopo Crawford, si sono susseguite negli anni
più recenti altre ricostruzioni palingenetiche75 che non si
discostano invece da quello che ho definito il “canone”
decemvirale. Ritengo tuttavia si sia fatta strada nella
giusromanistica una consapevolezza diversa o – perlomeno – qualche
dubbio, rispetto alla tradizione palingenetica consolidata76.
In definitiva, ritengo che nelle XII Tavole la materia del
“diritto penale”, e cioè la previsione di attività illecite e le
relative sanzioni non possa essere collocata unitariamente in
un’unica tabula. L’attuale ottava tavola, così come ricostruita
nelle correnti palingenesi decemvirali non credo, insomma, sia mai
esistita. Tale restituzione è, infatti, contraddetta – come non
era sfuggito ad Huvelin77 – dal complesso delle testimonianze in
nostro possesso, nonché dalla concezione complessiva che sembra
informare la composizione dell’antica raccolta legislativa.
74 CRAWFORD, Roman Statutes cit. II 578.75 Cfr. DILIBERTO, Bibliografia ragionata cit. 256 ss.76 Da ultimi, v. R. SCEVOLA, La responsabilità del iudex privatus, Milano 2004, 21 ss. eivi nt. 4; FRANCHINI, La desuetudine cit. 20 e ivi nt. 5; DE FRANCESCO, Autodifesacit. 68.77 Cfr. supra § 2.
26
Credo, viceversa, che la successione delle norme tra loro,
all’interno delle XII Tavole, possa dipendere dal criterio
osservato a proposito delle regole funerarie e della terra: non in
virtù di un “sistema” di natura classificatoria, che i decemviri
non mi sembra potessero conoscere, bensì per attrazione successiva
– l’una norma con l’altra –, in forza di un criterio fondato sulla
materialità degli interessi di volta in volta regolati e tutelati.
Ritengo altresì, come ho avuto occasione anche di recente di
sostenere78, che la responsabilità di natura penale non possa
essere distinta (e diversamente collocata all’interno delle XII
Tavole) dalla disciplina sostanziale degli interessi di volta in
volta disciplinati. Un esempio per tutti: le norme sulla tutela
(collocate dai moderni interpreti nella quinta tavola) non
dovrebbero, a mio modo di vedere, essere separate dalla legge che
sanzionava il crimen suspecti tutoris (viceversa inserita nelle correnti
palingenesi, in ossequio all’idea della tavola “penalistica”
onnicomprensiva, in tab. VIII.20).
Un siffatto criterio ricostruttivo potrebbe essere applicato –
evidentemente con la necessaria cautela, in assenza di precise
indicazioni delle fonti79 – anche alle altre materie trattate nelle
XII Tavole. Mi limito, ancora, ad un esempio. Nell’antica raccolta
legislativa sono conservate – per ciò che sappiamo – norme che
disciplinavano (e sanzionavano) la falsa testimonianza e il
rifiuto della stessa per gli atti librali (le cui rispettive
punizioni erano rappresentate, come noto, dalla precipitazione
dalla rupe Tarpea e dall’intestabilitas80): si tratta, come notissimo,
di disposizioni a tutela della parola data e della fides. A me non78 Cfr. supra nt.* e nt. 5.79 Ulteriori spunti – tratti soprattutto dalle fonti gelliane – in DILIBERTO, Unapalingenesi ‘aperta’ cit. 233 ss.80 Da ultimo, v. M. HUMBERT, Intestabilis, in Fides Humanitas Ius cit. IV 2543 ss.
27
sembra dunque ipotesi inverosimile che esse si trovassero,
all’interno del testo delle XII Tavole, accorpate insieme alle
altre leggi che punivano la violazione della fides (si pensi alla
stessa procedura esecutiva nel caso del debitore insolvente, ma
anche alla norma che prevedeva la sacertà per il patrono che
avesse compiuto fraus ai danni del cliente81).
Le suggestioni potrebbero evidentemente continuare.
E’ tempo però di concludere.
Quanto sin qui sostenuto mi sembra possa indurre a credere che
l’antica raccolta legislativa fosse stata concepita con criteri di
attrazione (e di successione) delle norme tra loro non troppo
dissimili da quanto si è ricordato, in apertura di questo lavoro,
a proposito delle codificazioni “a domino” studiate da Saporetti82.
Nessuna dipendenza diretta, come ovvio, ma criteri analoghi:
criteri, questi ultimi, che preesistevano rispetto a quelli che
informeranno nei secoli successivi le meno antiche raccolte
legislative, giungendo infine sino ai codici moderni. Si trattava
di criteri di natura non classificatoria, privi del supporto
concettuale dello schema genus-species, rispondenti, tuttavia, a
esigenze di società remote che, nel momento in cui si dotavano di
regole giuridiche, le ancoravano alla materialità degli interessi
di volta in volta da queste ultime tutelati.
81 Per tutti, v. le equilibrate considerazioni di L. GAROFALO, Appunti sul dirittocriminale nella Roma monarchica e repubblicana3, Padova 1997, 14 s., poi in ID., Studi sullasacertà, Padova 2005, 24 ss. e ivi note per la precedente letteratura.Ultimamente, v. sul punto L. PEPPE, Note minime di metodo intorno alla nozione di Homosacer, in Fides Humanitas Ius VI cit. 4107 e ivi letteratura ulteriore.82 Cfr. supra § 1.
28