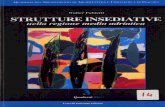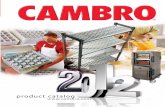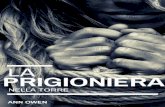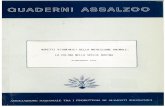Tradizione ellenistica nella moneta di Flavio Costantino e persistenze “flavie” nella moneta...
Transcript of Tradizione ellenistica nella moneta di Flavio Costantino e persistenze “flavie” nella moneta...
AntiCHitÀ AltOAdRiAtiCHe
lXXViii
COStAntinO il GRAnde A 1700 Anni
dAll’“edittO di milAnO”a cura di
Giuseppe Cuscito
tRieSteeditReG 2014
CentROdi AntiCHitÀ
AltOAdRiAtiCHeCASA BeRtOli
AqVileiA
le immagini di proprietà dello Stato italiano sono state pubblicate su concessione del miBACt - dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici - direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia - Soprintendenza per i Beni archeo- logici del Friuli Venezia Giulia ed è vietata l’ulteriore riproduzione e duplicazione con ogni mezzo senza l’autorizzazione della Soprintendenza.
«Antichità Altoadriatiche»© Centro di Antichità AltoadriaticheVia Patriarca Poppone 6 - 33053 Aquileia (ud)www.aaadaquileia.it; e-mail:[email protected] responsabile: Giuseppe CuscitoAutorizzazione del tribunale di udine n. 318 del 27 ottobre 1973
© editreg di Fabio PrencSede operativa: via G. matteotti 8 - 34138 triestetel./fax ++39 40 362879, e-mail: [email protected]
iSSn 1972-9758
iniziativa promossa in collaborazione con:
Dipartimento di Scienze Umanisticheuniversità degli Studi di trieste
Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici università di trieste, udine e Venezia
e con il sostegno di:
Soprintendenza per i Beni archeologici del FVG
5
PremeSSA
È con grande piacere che accogliamo nel numero 78 della rivista gli Atti della XLIV Settimana di Studi Aquileiesi dedicata al XVII centenario dell’“Editto di Costantino”.
Nonostante le gravi difficoltà finanziarie che attanagliano il nostro Paese, il volu-me può finalmente uscire grazie al contributo della Fondazione Aquileia e all’attenzio-ne da parte dell’Assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti, convinti del lavoro svolto e dell’impegno profuso dal Centro di Antichità Altoadriatiche per promuovere l’immagine di Aquileia nell’ambito della comunità scientifica nazionale e internazio-nale: perciò a Lui e ai Suoi collaboratori desideriamo esprimere i sensi della nostra gratitudine.
A conferma di questo laborioso impegno nel corso degli anni, vi è l’ampia adesione alle Settimane di Studi Aquileiesi e l’assidua partecipazione ai lavori nel più assoluto volontariato da parte di collaudati studiosi di antichistica che qui giungono dall’Italia e dalle nazioni contermini.
E anche questo volume delle nostre «Antichità Altoadriatiche» rimarrà pilastro nel mondo scientifico!
Arnaldo Marcone nelle sue Conclusioni scrive infatti: “Va riconosciuto a merito degli organizzatori di questa Settimana di Studi Aquileiesi... di aver vinto una sfida di non piccolo conto, vale a dire quella di aver saputo organizzare un ciclo di lezioni costantiniane, che si segnalano per un alto grado di specificità e innovatività scienti-fica, proprio in quest’anno 2013 in cui il giubileo dell’editto di milano è occasione di una serie impressionante di convegni, seminari, incontri di studio”. A lui va il mio personale ringraziamento per la disponibilità, per i consigli e per il sostegno genero-samente elargitimi in vista di una buona riuscita del Convegno e dei relativi Atti che oggi siamo in grado di offrire al pubblico dei lettori.
prof. Giuseppe CuscitoPresidente del
Centro di Antichità Altoadriatiche
7
introduzione ai lavori ....................................................................................diario ............................................................................................................elenco degli iscritti .......................................................................................
Studi
GiuSeppe CuSCito, Costantino fra editto di tolleranza e vocazione cristia-na: i riflessi sull’ambiente di Aquileia .........................................................
Rita Lizzi teSta, Le forme della cristianizzazione nell’Italia Ssttentrionale in età costantiniana ......................................................................................
SeRGio tavano, Aquileia nelle celebrazioni costantiniane del 1913 ..........
FRançoiSe theLamon, Constantin religiosus princeps. La construction d’un modèle dans l’Histoire ecclésiastique de Rufin d’Aquilée ...........................
Rajko BRatož, Costantino tra l’Italia nordorientale e l’Illirico (313-326)
umbeRto RobeRto, Aquileia tra Massenzio e Costantino: l’assedio della tarda estate 312 ............................................................................................
andRea peLLizzaRi, Tra adventus imperiali e bella civilia. L’Italia setten-trionale e Aquileia nei Panegyrici latini di età tetrarchico-costantiniana .
aLFRedo buonopane, pieRGiovanna GRoSSi, Costantino, i miliari dell’Ita-lia settentrionale e la propaganda imperiale ...............................................
CLaudio zaCCaRia, Costantino ad Aquileia: tra epigrafia e retorica ........
GioRGio bonamente, Dalla Gallia a Roma: Costantino e l’assedio di Verona ...........................................................................................................
RoBeRt Matijašić, La fine di Crispo prope oppidum Polam (Amm. Marc. 14, 10, 20) .....................................................................................................
p. 9» 11» 13
» 17
» 35
» 63
» 81
» 95
» 129
» 145
» 161
» 179
» 193
» 219
INDICe
8
paoLa ombRetta Cuneo, Alcune Costituzioni di Costantino emanate ad Aquileia .........................................................................................................
CeCiLia RiCCi, Protendere per protegere. Considerazioni sul carattere della presenza militare ad Aquileia tra Massimino e Costantino .........................
miCheLe aSoLati, Tradizione ellenistica nella moneta di Flavio Costantino e persi stenze “flavie” nella moneta altomedievale: segni di un’eredità .....
antonio SaRtoRi, L’età tetrarchica o della fine dell’epigrafia ..................
FRanCeSCa Ghedini, aLeSSandRa didoné, maRta noveLLo, L’edilizia privata in età tardoantica in Cisalpina; gli aspetti strutturali e le decora-zioni pavimentali e parietali .........................................................................
miCheLe bueno, vaneSSa CentoLa, Le domus di Aquileia e le loro evolu-zioni architettonico-funzionali in età tardoantica: i casi delle domus delle Bestie ferite e di Tito Macro presso i fondi ex-Cossar .................................
moniCa SaLvadoRi, CRiStina boSChetti, “Lavorare stanca”: la disor-ganizzazione di una bottega di mosaicisti in età tardoantica. Il caso del mosaico delle Bestie Ferite ..........................................................................
Gemma Sena ChieSa, Costantino a Milano. Riflessioni su una mostra recente ...........................................................................................................
eLiSabetta GaGetti, Trasparente bellezza, oscure identità. Un ritratto rilavorato di dama in cristallo di rocca .......................................................
aRnaLdo maRCone, Costantino il Grande a 1700 anni dall’“Editto di Milano”: conclusioni ....................................................................................
p. 229
» 239
» 255
» 283
» 291
» 317
» 335
» 351
» 367
» 387
255
nel contesto delle celebrazioni del diciassettesimo centenario del cosiddetto editto di milano ci sembra opportuno ricordare come questo momento, pur così significativo nella storia di questa personalità e della cultura occidentale, non comporti una rinuncia completa alla cultura classica che continua a pervadere molti aspetti della sua attività politica. la moneta, con il suo portato iconografico ed epigrafico, rappresenta in questo senso un ottimo filo conduttore che testimonia come istanze derivate dalla tradizione trovino cittadinanza fin quasi al termine della sua vita. Chiaramente è impossibile in questa sede trattare com-plessivamente questa materia, ma crediamo giovi ugualmente dar cenno di alcuni di questi aspetti riconducibili alle fasi avanzate del suo regno, anche in considerazione del pesante condizionamento sulle scelte monetarie non solo dei suoi successori al soglio imperiale romano e bizantino, ma anche ben oltre la fine del dominio romano in Occidente.
la monetazione di Costantino sotto il profilo iconografico è una straordinaria somma di fattori differenti, data dalla tensione continua tra tradizione e innovazione, dalla ripropo-sizione di temi tipici dei secoli precedenti, in particolar modo militari, e di istanze innovati-ve, soprattutto in termini religiosi, destinate ad avere un’enorme ricaduta sulla monetazione successiva. Vibrante e accesa è stata fino ad un passato recentissimo la discussione sull’uso del cristogramma sulla monetazione costantiniana a partire dal ben noto medaglione argen-teo con busto armato di Costantino 1 (fig. 1), la quale ultimamente si è arricchita di una nuova ipotesi che ha messo in dubbio l’autenticità di quest’ultimo manufatto, prospettando l’eventualità di un’invenzione rinascimentale 2. tuttavia, non vanno trascurate anche le
Michele Asolati
tRAdiziOne elleniStiCA nellA mOnetA di FlAViO COStAntinO e PeRSi Stenze “FlAVie” nellA mOnetA AltOmedieVAle: SeGni di un’eReditÀ
1 Su questo medaglione si vedano da ultimi beRnaRdeLLi 2007 e bLeCkmann c.s., entrambi con ampia bibliografia precedente, che però propongono ipotesi cronologiche differenti (post 324 il primo e 315 il secondo).
2 aRSLan 2012, p. 200. in questo contributo tali medaglioni sono stati ritenuti delle elaborazioni rinascimentali sulla base di ragioni stilistiche e di considerazioni su aspetti ideologici assai sfuggenti, come l’impressione di “una perfetta definizione prospettica dell’elmo” che apparirebbe improbabile in età costantiniana, mentre possiamo ricordare come si trovino confronti puntuali in un solido dello stesso Costantino i coniato a ticinum (RIC, Vii, p. 369, n. 57A e cfr. aLFöLdi m.R. 1963, pp. 39-40), nonché in emissioni di multipli aurei e argentei di Costanzo ii (toynbee 1986, tav. XlViii, n. 7; baStien 1992-94, iii, tav. 191, nn. 3-4). l’elemento più incisivo di questa discussione riguarda, a nostro giudizio, la costruzione complessa della tipologia del rovescio, effettivamente anomala nel panorama delle emissioni monetarie imperiali, soprattutto tardo antiche, e non dissimile da creazioni cinquecentesche. tuttavia, malgrado scene affollate di personaggi, disposti su quinte differenti, trovino confronti in epoca rina-scimentale, non va dimenticato che lo stile dei multipli argentei costantiniani non ha la profondità e la plasticità tipiche dei prodotti rinascimentali, mentre si adatta perfettamente all’epoca in cui questi tradi-zionalmente vengono ascritti. d’altro canto, per quanto rari, sono documentate emissioni soprattutto di medaglioni, ma non solo, di fine III-IV secolo molto affollati e/o caratterizzati da tentativi prospettici non dissimili dal caso costantiniano. Possiamo ricordare innanzi tutto i folles di Costanzo i e di massenzio, coniati a Roma e a Ostia tra il 308 e il 312 d.C., con il tipo adLoCvtio avG n, per i quali si veda RIC, Vi,
256
contaminazioni di epoca augustea 3 (figg. 3-4) o di età traianea evidenziate in analisi ormai non troppo recenti 4, ma rese nuovamente attuali dalla scoperta di tipi costantiniani nuovi 5 (figg. 5-12).
entro tale contesto va evidenziato come anche la tradizione tipologica greca venisse accolta nell’elaborazione di alcune matrici monetali, nel segno di un rinascimento artistico di notevole impatto. tale gusto sembra prendere piede nel corso della seconda metà del iii
p. 377, n. 206, p. 382, n. 242 (Roma), p. 404, n. 23 e Cohen 1880-92, p. 58, n. 1 oltre che ntantaLia 2001, tav. 7, Abb. 7 (Ostia): soprattutto nelle coniazioni ostiensi la costruzione del rovescio è molto simi-le a quella del medaglione di Costantino e vi compare anche un ufficiale che trattiene un cavallo collocato nella stessa posizione di quello presente sul multiplo argenteo all’estrema sinistra; non vanno dimenticati poi il ben noto medaglione plumbeo di Lugdunum, della fine del III secolo (baStien 1989), o il multiplo aureo battuto per l’adventus di Costanzo i a londinium, appartenente al ripostiglio di Arras e databile tra il 295 e il 305 d.C. (toynbee 1986, tav. VIII, n. 4). Altri casi ancora, pur essendo meno stipati di figure, danno però la medesima impressione del caso costantiniano, come per esempio il multiplo aureo da quat-tro solidi e mezzo con legenda innvmeRi tRivmFi avG n databile al 326 d.C. (toynbee 1986, tav. iV, n. 3). A sostegno della genuinità dei medaglioni argentei di Costantino con cristogramma va rammentato che l’esemplare in condizioni peggiori tra i tre finora conosciuti, ossia quello conservato a Vienna, è frutto di una scoperta effettuata a Salonicco attorno al 1831 da parte di Ésprit-Marie Cousinéry il quale donò il medaglione al museo viennese: CouSinéRy 1831, I, p. 31 (con riproduzione del pezzo; cfr. fig. 2) e cfr. GneCChi 1912, i, p. 59, n. 18, aRSLan 2012, p. 199 e WiLLiamS 2012, p. 33; d’altro canto, l’esemplare di monaco proviene con ogni probabilità dall’ambito balcanico: bLeCkmann c.s. A sfavore dell’ipotesi citata va ricordato che i tre pezzi conosciuti sono riconducibili a due coni di dritto e a tre coni di ro-vescio, contrariamente a quanto documentato per le produzioni medaglistiche a imitazione dell’antico certamente rinascimentali, come quelle di Giovanni da Cavino o di Valerio Belli che erano soliti incidere una sola coppia di matrici per ciascuna medaglia: nell’eventualità di una produzione cinquecentesca, la varietà dei coni dei medaglioni costantiniani implicherebbe l’idea dell’analisi dei coni della moneta antica, ossia di uno strumento definito e utilizzato in realtà solo nel XIX secolo (de CaLLataÿ 2007), e presupporrebbe un’eccessiva perizia da parte dell’eventuale autore rinascimentale, data da un intento che non potrebbe essere qualificato altrimenti che fraudolento. Inoltre, questi medaglioni si conoscono a partire dalla scoperta di Cousinery e non a caso proprio l’esemplare viennese è preso in considerazione solo nella seconda edizione dell’opera di Cohen sulla monetazione imperiale (Cohen 1880-92, Vii, p. 285, n. 484), mentre non compare in opere precedenti, simili a quest’ultima (mionnet 1815 e mionnet 18473): Gnecchi nel 1912 conosce ancora solo l’esemplare scoperto a Salonicco (GneCChi 1912, i, p. 59, n. 18), mentre notizie del pezzo ora a leningrado si hanno a partire dal 1930 (pRidik 1930, p. 78 e tav. 3, n. 18); infine il pezzo ora a Monaco fu acquisito nel 1954 (kRaFt 1954-55). Se fossero stati effettivamen-te realizzati in età rinascimentale, sembrerebbe per lo meno improbabile che tali manufatti non fossero illustrati in alcuna opera a stampa prima dell’Ottocento, considerata anche la presenza del cristogramma al dritto, che tanta attenzione ha suscitato nel corso del novecento.
3 Cfr. il probabile riferimento a produzioni augustee come modello dei medaglioni coniati per i vicennalia di Costantino ii (v. LaFauRie 1949. V. anche baStien 1988, p. 81, con discussione a nota 10). in questi beLLinGeR 1958, p. 135 ha ravvisato un disegno ispirato a modelli monetari dell’epoca di Augusto, in modo particolare alle coniazioni bronzee provinciali emesse a efeso poco prima della sua riforma mo-netale: per questi modelli cfr. RIC, i, p. 80, n. 486; RPC, i, n. 2235. del medesimo avviso bRuun 1992, p. 225. Cfr. inoltre alcuni tipi riferibili a modelli traianei (aLFöLdi m.R. 1963, p. 59).
4 aLFöLdi m.R. 1963, p. 59.5 Cfr. aSoLati 2012, p. 56 e p. 34, n. 30 in riferimento ad un solido inedito rispetto a RIC, Vii, per
il quale si rinvia a http://www.notinric.hox.pl/7tic-49.html (cfr. fig. 9). Cfr. inoltre il follis per Crispo (cfr. http://www.forumancientcoins.com/notinric/7con-15.html; cfr. fig. 11), anch’esso mancante in RIC, Vii, contraddistinto al rovescio dalla legenda SpqR optimo CaeSaRi e da una figura a cavallo, il quale riproduce un prototipo presente su monete auree, argentee e bronzee di traiano (cfr. RIC, ii, p. 264, n. 291 e p. 286, nn. 598-599).
miCHele ASOlAti
257
secolo d.C., grazie al revival dell’elmo corinzio con pennacchio sui busti imperiali 6 (fig. 13), e particolarmente su quelli di Probo (fig. 14), simile a quelli dell’Atena delle emissioni auree di Alessandro magno e dei successori (fig. 15); va ricordato peraltro l’ampio reperto-rio di rappresentazioni di ercole presente sulla monetazione del tetrarca massimiano (figg. 16, 18, 20, 22), molte delle quali riprendono la tradizione monetaria greca 7 (figg. 17, 19, 21, 23), reinterpretata secondo il gusto, le capacità incisorie e le necessità produttive del tempo. di notevole interesse è il fatto che queste rivisitazioni dei temi greci riguardavano quasi esclusivamente nominali aurei o medaglioni di altri metalli (fig. 24), ossia le fasce più alte della monetazione, destinate a una distribuzione selettiva tra ceti sociali elevati, con evidenti implicazioni sia di natura culturale, sia di natura propagandistica. Altrettanto interessante, però, è evidenziare come le vie di trasmissione di tali modelli alludano a pos-sibili percorsi collezionistici.
Seguendo tale gusto Costantino i dà vita a una particolarissima serie di medaglioni argentei, che si ritiene essere stata realizzata in relazione alla dedicazione di Costantinopolis nel 330 d.C. 8: questa non trova paragone nella produzione precedente e successiva, né sotto l’aspetto stilistico, né sotto quello tecnico-realizzativo, né ancora sotto quello ponde-rale. Ci riferiamo ai medaglioni che presentano al dritto una testa diademata di Costantino a destra e che al rovescio si contraddistinguono per due tipologie differenti:1- Constantinopolis, turrita, seduta a destra in trono, con ramo e cornucopia, con il piede
destro su una prora di nave 9 (fig. 25).2- Roma seduta a destra in trono, con globo e scettro, con piede sinistro su uno sgabello;
appoggiato al trono, uno scudo rotondo con umbone 10 (fig. 26).entrambe le varianti presentano la stessa legenda, ossia d n COnStAntinVS –
MAX TRIVMF AVG, la quale non segue però l’andamento circolare del bordo del ton-dello, ma è suddivisa in due righe parallele e verticali, leggibili in ogni caso da sinistra, poste ai lati della tipologia. tuttavia, mentre sul tipo con Constantinopolis la legenda inizia di fronte alla personificazione seduta, su quello con Roma la legenda comincia alle spalle della dea e termina di fronte.
in esergo compare l’indicazione della zecca mCOnS, seguita, con l’eccezione di un solo caso nella tipologia 1, dal numero dell’officina monetaria 11. Per la variante 1 sono note le officine B, Γ, Δ, Є, ς, Z, Θ, I, IA, per la variante 2 si conoscono solo le officine ς e I.
Va precisato che la prima variante era l’unica nota fin dagli inizi del Settecento 12 (fig. 27), mentre la seconda è venuta a conoscenza del mondo scientifico soltanto nel
6 Cfr. baStien 1992-94, i, pp. 204-210.7 in questa sede vengono proposte alcune derivazioni da modelli di Heraclea Lucaniae, Abdera in
thracia e Phaistos a Creta (per i dettagli su queste emissioni cfr. infra le didascalie delle illustrazioni), ma il tema meriterebbe ulteriori approfondimenti.
8 Su questa serie cfr. da ultimi aSoLati 2012, pp. 17-34 e RamSkod, LenSki 2012.9 RIC, Vii, p. 578, n. 53.10 questa varietà è inedita in RIC: cfr. infra, nota 13.11 Va sottolineato che anche questa particolare indicazione di zecca, che premette la lettera m (=
Moneta) alla sigla COn, non trova riscontro nella produzione monetaria costantinopolitana di Costantino i, fatta eccezione per lo straordinario medaglione aureo da trenta solidi a legenda Gavdivm RomanoRvm (cfr. RIC, Vii, p. 576, n. 42), anch’esso coniato nel 330 d.C. per la dedicazione della nuova Roma.
12 un esemplare di questo tipo è pubblicato in SpeRLinG 1700a e SpeRLinG 1700b; cfr. anche SpeR-LinG 1717, p. 78, n. 397 e beCkeR 1801, pp. 361-363.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
258
1996 13 grazie a un solo esemplare, al quale successivamente se ne sono aggiunti almeno altri due 14.
Come dicevamo, questa produzione è particolare poiché il tondello non supera i 30 millimetri pur pesando mediamente circa g 17. in altre parole si tratta di un disco di metal-lo spesso e stretto contrariamente a quanto avviene per i medaglioni in metallo nobile di epoca costantiniana e successiva, per i quali si prediligono tondelli sottili e larghi 15. questo aspetto rende unica la nostra emissione non solo in confronto alle coniazioni di Costantino i e dei suoi figli, ma anche a quelle di tutto il iV secolo e di quello successivo.
tale particolare diviene ancora più interessante quando si esaminano le tipologie prescelte, poiché anch’esse sono del tutto singolari. il dritto ospita un ritratto diademato di Costantino i di grandezza straordinaria, il quale occupa gran parte del conio: il collo è tagliato poco al di sotto del mento in modo da dare l’impressione che l’altezza del ritratto sia simile alla larghezza. Assente è la legenda.
Come già osservato, i tipi del rovescio sono due e sono accompagnati da una legenda che, anche questo fatto unico nella monetazione romana imperiale, si dispone su due righe parallele ai lati della tipologia.
Constantinopolis è rappresentata come una figura femminile turrita e velata con cor-nucopia, secondo quelle che erano le modalità tipiche con cui si raffigurava sin dall’età ellenistica la tyche 16. Va osservato come proprio nel contesto della dedicazione della nuova capitale viene definendosi l’iconografia della personificazione della nuova Roma, pur secondo canoni che non sono univoci 17. infatti, oltre al modo con cui la vediamo raffigurata sui medaglioni argentei, essa appare come una divinità elmata e laureata, con manto imperiale e lancia sulla diffusissima serie bronzea dei folles anonimi a legenda Con-StantinopoLiS, coniati dal 330 al 347 d.C. (fig. 28). tale rappresentazione, assai simile al modo in cui viene delineata Roma, è impiegata con alcune variazioni anche su una serie di monete anepigrafe e anonime d’argento, coniate nel 330 d.C. ancora per lo stesso even-to 18 (fig. 29), della quale, peraltro, fanno parte anche alcuni argenti anch’essi anepigrafi, caratterizzati da busto femminile diademato di perle (fig. 30). inteso variamente come la raffigurazione di Fausta o elena o teodora 19, il tipo invece può essere ragionevolmente interpretato ancora una volta come una personificazione della nuova Roma, in base alla somiglianza con il busto dei folles della medesima serie, recanti però la legenda ConStan-tinopoLiS attorno a quest’ultimo 20 (fig. 31).
13 dembSki 1996.14 Cfr. aSoLati 2012, pp. 33-34, nn. 12-13.15 Anche per i “miliarensi”, oltre che per i medaglioni d’argento, si prediligono tondelli con queste
caratteristiche: cfr. RIC, Vii, p. 4.16 toynbee 1947a, p. 136. una variante di questo tipo ricorre sui medaglioni di bronzo battuti a
Roma ancora nel 330 d.C. per la dedicazione della nuova capitale, sui quali Constantinopolis-tyche, oltre ad essere turrita, è anche alata (RIC, Vii, p. 340, n. 356; kent 1978, p. 108, n. 1; ntantaLia 2001, p. 253, gruppo 1). Con questa caratteristica è rappresentata anche su quella che probabilmente è una prova di conio in bronzo per un medaglione aureo, di cui finora non si conoscono esemplari, peraltro ignota anche al RIC: numismatica Ars Classica, 15, 1999, lotto n. 489; vaGi 1999, n. 3055; RamSkoLd 2011, p. 135 e fig. 5C. Su questo esemplare compare al dritto il busto di Constantinopolis turrita e drappeggiata rivolta a sinistra.
17 toynbee 1947a, p. 136.18 bendaLL 2002, p. 140, n. 1.19 bendaLL 2002, p. 143.20 bendaLL 2002, p. 142, tipo A.
miCHele ASOlAti
259
questi tre modelli fondamentali sono destinati a differenti fortune, soprattutto in ambito monetario, comunque anche ben oltre la morte di Costantino i 21. in termini stretta-mente numismatici la raffigurazione di Constaninopolis con diadema è quella che incontra minore successo 22, mentre la caratterizzazione più duratura è senz’altro quella con elmo allo stesso modo di Roma 23. la rappresentazione di Constantinopolis con corona turrita quanto a longevità del tipo monetale si pone a metà di questi due estremi. l’ultima emis-sione che possiamo documentare con certezza è quella di eugenio prodotta a treviri nel 392-394 d.C. 24. tuttavia, possiamo ricordare una serie di argenti prodotti in Occidente nel secolo successivo, i quali recano al rovescio una figura turrita stante a sinistra, con scettro e cornucopia, con il piede destro su una prora di nave. queste monete si attribuiscono a Giulio nepote, Basilisco, Romolo Augustolo e zenone 25 (fig. 32) e l’interpretazione del tipo è controversa. Per alcuni studiosi, stanti gli attributi che lo caratterizzano, si tratta di Constantinopolis 26, mentre secondo altri, i quali sottolineano come le coniazioni siano esclusivamente occidentali e come anche Ravenna fosse città affacciata sul mare, propon-gono un’identificazione con Ravenna 27: quest’ultima eventualità sembrerebbe confermata
21 Cfr. toynbee 1947a; toynbee 1953. Si veda anche CaStRizio 2010. Per una probabile raffigura-zione di Roma elmata alla fine del IV secolo presente su monete anonime v. anche bendaLL 2003. quando questi modelli trovano realizzazione in una figura intera, questa comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, risulta distinguibile da qualunque altra personificazione per la presenza di una prora di nave, sulla quale normalmente Constantinopolis pone un piede: toynbee 1953, p. 188; GRieRSon, mayS 1992, p. 83.
22 Oltre alle emissioni tipicamente costantiniane, poche altre coniazioni recano una rappresenta-zione con una caratteristica simile a quest’ultima, ossia con un tipo di diadema definito genericamente stephane, in particolare con i Costantinidi: si tratta del medaglione da quattro solidi prodotto in diverse zecche da Costante e da Costanzo ii per sé stesso e per Costanzo Gallo (RIC, Viii, p. 275, nn. 285-286, Roma; p. 388, n. 54, Sirmium; p. 416, n. 141, thessalonica; p. 480, n. 99, nicomedia; p. 517, nn. 69-71A, e p. 525, nn. 157-160, Antiochia). Altre rappresentazioni del genere sono inquadrabili nelle fasi imme-diatamente successive: si veda il medaglione da nove solidi di Gioviano battuto proprio a Costantinopo-lis nel 363-364 d.C. (RIC, Viii, p. 463, n. 168; cfr. toynbee 1986, tav. Xi). un tipo molto simile a quello impiegato da Costanzo ii viene inoltre utilizzato da Valente per dei multipli aurei battuti a Roma (RIC, iX, p. 122, n. 26; GneCChi 1912, i, p. 36, n. 6). questo, malgrado la presenza della prora di nave, viene interpretato come Roma in relazione alla indicazione di zecca presente in esergo, la quale recita appunto Roma esplicitamente (cfr. bibliografia citata sopra e Cohen 1880-92, Viii, p. 102, n. 6). tuttavia, questa tipologia, stante la strettissima similitudine citata, può essere intesa unicamente come Constantinopolis e Roma va quindi interpretata unicamente come segno di zecca (cfr. toynbee 1953, p. 188): in questo caso, l’ultima raffigurazione monetaria di questa personificazione con testa diademata andrebbe datata al 375-378 d.C. Contemporanea a questa o poco più tarda potrebbe essere la ripresa di questo tipo, che notiamo abbinata alla sigla CS (= SC), su alcuni contorniati: aLFöLdi A. e e. 1976-90, tav. 85, nn. 7-9 (nerone) e tav. 182, nn. 8-12 (diva Faustina i).
23 nell’ambito della monetazione romana imperiale, gli ultimi esempi del genere sono riconducibili a leone i che emise multipli di solido e solidi a Constantinopolis tra il 457 e il 468 d.C. circa: RIC, X, nn. 601-602.
24 RIC, iX, p. 33, n. 99.25 Cfr. RIC, X, n. 3216, zecca di Ravenna (per Giulio nepote); nn. 3307-3308, zecca di Ravenna
(per Basilisco); n. 3413, zecca di Ravenna (per Romolo Augustolo); nn. 3616-3620, zecca di Mediolanum e nn. 3644-3646, zecca di Ravenna (per zenone).
26 LaFFRanChi 1941, pp. 34-35; toynbee 1953, p. 269.27 RIC, X, p. 58 ricorda come Ravenna fosse una capitale imperiale con pedem dextrum super
mare, sinistrum super terram. la citazione è tratta da Andrea Agnello che, descrivendo un mosaico che or-nava il palatium di Ravenna, ricorda come Teodorico fosse raffigurato tra Roma e Ravenna: Agnelli, Liber
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
260
dall’uso in scultura della tyche turrita per delineare Ravenna. Ad ogni modo, anche questa rappresentazione è certamente derivata da quella di Constantinopolis vista come tyche ed è destinata a influenzare in modo determinante i tratti delle personificazioni monetali di Ravenna e di ticinum che saranno tipiche dell’epoca ostrogota 28.
quanto al tipo con Roma, questa viene rappresentata sui nostri medaglioni secondo canoni già recepiti in ambito monetale all’inizio del iV secolo 29, anche se la visione quasi frontale di questa tipologia trova rari riscontri nella monetazione precedente 30, divenendo però un prototipo per quella successiva.
Gli aspetti sin qui delineati, oltre a qualificare questa serie di medaglioni argentei come assolutamente unica, chiaramente rinviano a modelli di epoca ellenistica. tale matri-ce, già individuata nell’Ottocento in particolare per l’aspetto epigrafico 31, è stata riconside-rata nell’ambito di studi tematici recenti, in parte condotti da chi vi parla 32, dei quali vale la pena di ribadire gli elementi essenziali 33. Ad esempio, il ritratto di Costantino i presenta gli occhi rivolti verso l’alto 34, i quali gli conferiscono uno “sguardo ispirato” simile a quello di altre coniazioni costantiniane d’oro, d’argento e di bronzo (cfr. per esempio fig. 33), nelle quali però anche un’accentuata angolazione del capo rispetto al collo, molto più lungo che nel nostro caso, conferisce meglio l’idea dell’“estasi eroica” 35. inoltre, sul capo è posto un diadema 36. entrambi questi elementi rientrano in uno schema di imitatio Alexandri, legato a una concezione del potere di tipo orientale, emanazione della volontà divina, e direttamente influenzato da prototipi di età ellenistica 37. questo particolare svi-
Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, De Sancto Petro Seniori XXVIII, 94, in MGH, Scriptores rerum Lango-bardicarum et Italicarum, a cura di O. Holder-egger, Hannoverae 1878, pp. 337-338. Cfr. anche GRieRSon, mayS 1992, p. 84, dove si precisa che questa interpretazione è molto più probabile anche per le coniazioni della zecca di Mediolanun.
28 Cfr. infra. non va comunque dimenticato che, al di là delle rappresentazioni monetali, Constanti-nopolis con elmo oppure con corona turrita ricorre almeno fino agli inizi del VI secolo sui dittici consolari tardo antichi: cfr. deLbRueCk 1929, con elmo nn. 16, 22, 32, con corona turrita n. 38; bühL 1995, passim. Mancano in questo ambito rappresentazioni di Constantinopolis con diadema. Infine, ancora sul soggetto della Tyche di Constantinopolis e sul suo successo fino al VI secolo cfr. anche StRzyGoWSki 1893. Si veda inoltre SteRn 1953, pp. 133-134 con bibliografia citata.
29 dembSki 1996, pp. 99-100.30 SteRn 1953, p. 131.31 vöLkeL 1801, p. 13; beCkeR 1801, pp. 361-363. Più di recente su questo stesso punto cfr. aLFöL-
di m.R. 1963, p. 116; aLFöLdi m.R. 2003; CaRLà 2010, p. 129; aSoLati 2012, pp. 17-34 .32 aSoLati 2012, pp. 17-34. Cfr. anche RamSkoLd, LenSki 2012 che in modo indipendente sono
giunti alle stesse conclusioni di chi scrive.33 Con l’espressione “hellenisierenden Silbermultipla” si fa riferimento ai medaglioni con Constan-
tinopolis in aLFöLdi m.R. 1963, pp. 149-150, per i quali alle pp. 115-116 si suggerisce la derivazione da modelli ellenistici, peraltro accostandone la foto (tav. 18, n. 225) a quelle di monete di lisimaco (224) e di Antioco (226).
34 aLFöLdi m.R. 2003.35 Che questo tipo di ritratti monetali sia ispirato a coniazioni ellenistiche e in particolare dell’età
dei diadochi è esplicitamente indicato in aLFöLdi m.R. 1963, pp. 128-129, nota 5. Cfr. anche WRiGht 1987, pp. 505-506 e La RoCCa 2000, p. 2. Più cauta haRRiSon 1967, pp. 95-96.
36 Sull’uso del diadema da parte di Costantino i cfr. innanzi tutto baStien 1992-94, pp. 156-159.37 toynbee 1947b, p. 148; RIC, Vii, p. 33; baStien 1992-94, pp. 58-59; aLFöLdi m.R. 2003. lo
“sguardo ispirato” avrebbe implicazioni di natura religiosa secondo una parte della critica numismatica (cfr. buRnett 1987, p. 145) influenzata dal noto passo di Eusebio (Vita Const., iV, 15): cfr. toynbee (loc. cit.).
miCHele ASOlAti
261
luppo imitativo che aveva ispirato le scelte di molti imperatori da Augusto a Caracalla 38 e oltre 39, coinvolge molti aspetti anche della politica di Costantino i e vede nella fondazione di Costantinopolis forse il momento più pregnante 40.
Peraltro, nel caso specifico del nostro medaglione, crediamo si possano riconoscere, più che in altre emissione costantiniane 41, dei richiami evidenti ad alcuni ritratti monetali di epoca ellenistica. la testa grande che occupa buona parte del tondello, la mascella molto pronunciata, il taglio del collo poco sotto il mento sono elementi che ricorrono a Pergamo sui ritratti monetali di Filetero proposti dai suoi successori 42 (fig. 34). Analogie riguardanti le proporzioni della testa rispetto al tondello e al taglio del collo, ma soprattutto agli occhi rivolti verso l’alto ricorrono anche in taluni ritratti di Alessandro coniati da lisimaco (fig. 35). la capigliatura trova poi stringenti confronti con alcuni ritratti di demetrio Poliorcete coniati in macedonia 43 (fig. 36) e con alcuni altri di Seleuco ii battuti in una zecca mesopotamica incer-ta, oppure in quella di nisibi 44 dalla sorprendente somiglianza con alcuni volti di traiano.
quanto ai rovesci, la tyche di Constantinopolis sembra trovare un prototipo in un’emis-sione di demetrio i Sotere di Siria, nella quale una tyche seduta a sinistra tiene uno scettro e una cornucopia (fig. 37): la legenda si dispone su righe parallele ai lati del tipo, mentre altri elementi epigrafici spesso caratterizzano l’esergo 45. Per la raffigurazione di Roma ricono-sciamo dei modelli romani 46, ma nella composizione di tipo e legenda non sfugge la somi-glianza con i coni di lisimaco, i quali ispirano anche altre monetazioni ellenistiche 47.
Ovviamente, queste analogie non possono essere casuali, ma debbono dipendere, considerata anche l’eccezionale occasione per la quale questi medaglioni furono prodotti, da una chiara volontà di Costantino I che con ogni probabilità dettò personalmente le linee
Per i termini della questione cfr. anche baStien 1992-94, pp. 58-59, il quale però rifiuta questa interpre-tazione che sarebbe frutto di speculazioni successive alla morte di Costantino i; a tal proposito cfr. anche La RoCCa 2000, p. 2. Cfr. inoltre beRnaRdeLLi 2007, p. 226 e nota 22. Riguardo al diadema ripreso dalla tradizione ellenistica v. nota precedente. Sulla ripresa di tipologie di epoca ellenistica da parte di Costantino I e i suoi figli si veda anche RuGGia 1998.
38 FRuGoni 1978, pp. 5-9.39 Cfr. per esempio baStien 1992-94, pp. 143-147 riguardo all’uso del diadema da parte di nume-
rosi predecessori di Costantino i.40 Cfr. puGLieSe CaRateLLi 1979. A questo proposito va ricordato che Costantino i aveva posto
nello Strateghion di Costantinopoli una statua equestre di Alessandro magno in precedenza collocata a Crisopoli: baRSanti 1992, p. 127; La RoCCa 1993, p. 557.
41 Sullo sviluppo del ritratto monetale in età costantiniana cfr. haRRiSon 1967; bRuun 1991a; bRu-un 1991b. Cfr. anche WaLteR 2006, pp. 11-34.
42 Cfr. WeSteRmak 1961, tavv. 1-3, gruppi ii-iii.43 neWeLL 1978, n. 137.44 SC, nn. 746-747 e soprattutto 748b. Si veda inoltre la moneta coniata da Antioco Hierax con il
ritratto di Seleuco ii: SC, n. 905.45 Cfr. SC, tavv. 12-16. lo stesso tipo ricorre anche nella monetazione di demetrio ii: cfr. SC, n.
1984.46 Cfr. dembSki 1996, pp. 99-100.47 Cfr. il tipo della tetradracma di lisimaco con Atena seduta a sinistra con nike e lancia e con il go-
mito sinistro appoggiato su uno scudo: thompSon 1968. lo stesso tipo è ripreso anche da Antioco Vii nella zecca di Seleucia ad Calycadnum: SC, nn. 2050, 2052. Si pensi nuovamente alla monetazione pergamena con il ritratto di Filetero, la quale propone al rovescio Atena seduta a s. con corona e lancia e con il gomito s. appoggiato su uno scudo: WeSteRmaRk 1961.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
262
per la realizzazione dei coni di questa emissione. in buona sostanza, più che ispirarsi gene-ricamente a tipologie monetali ellenistiche, in questo caso sembra che l’autorità emittente abbia voluto riprodurre schemi iconografici precisi e abbinarli con tondelli dalle caratteri-stiche particolari, come abbiamo visto, in modo da creare dei medaglioni così insoliti che fossero chiaramente riconducibili a un passato greco legato ad Alessandro magno e ai suoi successori.
in altre parole, sembra che Costantino i abbia cercato di creare dei medaglioni che sotto l’aspetto formale richiamassero specificamente talune tetradracme di età ellenisti-ca 48.
Se diamo credito a questa eventualità, viene da chiedersi se anche in termini sostan-ziali, ossia metallici, questi medaglioni possano imitare una tetradracma ellenistica, invece che essere tagliati su standard più tipicamente tardo romani. A questo proposito, va innanzi tutto precisato che si tratta della serie di medaglioni d’argento più pesante tra quante ne produsse Costantino i per sé o per i propri figli, le quali se mediamente pesavano tra g 4 e >6 circa 49, con l’emissione a celebrazione dei vicennalia di Costantino ii del 336-337 d.C. giunsero a pesare al massimo g 13 50.
il più leggero degli esemplari della nostra emissione, invece, supera di 2 grammi il più pesante pezzo di quest’ultima coniazione. Peraltro il peso medio della nostra emissione si è notevolmente incrementato negli ultimi decenni, grazie a nuovi esemplari apparsi sul mercato antiquario. i pesi noti fino agli anni ’90 del secolo scorso non erano mai al di sopra dei g 17, essendo compresi tra g 15 e 16,9 51, mentre ora la maggioranza dei dati ponderali noti si pone nella fascia dei g >17, con una punta di g 18,18. Se in precedenza la media era pari a g 16 circa, ora sfiora g 17 52.
48 aSoLati 2012, pp. 23-25 e pp. 32-33, nn. 1-17.49 RIC, Vii, pp. 7-8; toynbee 1986, p. 168; baStien 1988, pp. 73-81.50 LaFauRie 1949. V. anche baStien 1988, p. 81, con discussione a nota 10.51 nel corso del novecento le considerazioni pondometriche relative a questi medaglioni si sono ba-
sate unicamente sui dati editi in GneCChi 1912 (cfr. RIC, Vii, p. 578, n. 53; toynbee 1986, p. 168), il quale però ignorava il peso dell’esemplare del Museo di Treviri, pur edito in FRiedLändeR 1876, p. 125, n. 5.
52 la seguente tabella è desunta da aSoLati 2012, p. 19.
no. off. 17,62 B 16,82 Γ 16,61 17,36 Δ 15,15 16,66 Є 17,55 17,56 ς 15,00 *16,99 *17,88 z 15,48 17,49 Θ 16,65 i *16,17 17,49 17,50 18,10 iA 18,18
tabella 1. I pesi dei medaglioni suddivisi per officina (i pesi contrassegnati da un asterisco (*) si riferiscono ai medaglioni del tipo Roma)
miCHele ASOlAti
263
la grande varietà dei pesi per la monetazione argentea è caratteristica dell’età costan-tiniana, quando le differenze tra pesi massimi e minimi appaiono marcate anche nel caso della cosiddetta siliqua e del cosiddetto miliarense, ossia i due principali nominali allora coniati in metallo bianco. Anzi percentualmente queste differenze sono ancora maggiori se confrontate con i nostri medaglioni: i due estremi della forbice ponderale differiscono del 17,5% nel nostro caso, mentre in quello della “siliqua” il divario aumenta al 22,3% e in quello del “miliarense” sale addirittura al 37,1% 53. da questo andamento possiamo trarre due distinte indicazioni: innanzi tutto, che la carenza di informazioni relativamente a questo periodo è generalizzata circa tutte le emissioni argentee; in secondo luogo, che comunque era ammessa una certa tolleranza, altrettanto generalizzata, nell’emissione della moneta d’argento, qualunque ne fosse il peso.
dunque, considerando valida l’ipotesi che lo standard impiegato per la produzione dei medaglioni con i tipi di Constantinopolis e di Roma fosse unico, i dati ponderali in nostro possesso sono i seguenti:
peSo minimo
peSomaSSimo
peSo medio
mediana maGGioRe add.
dev. StandaRd
15,00 18,18 16,96 17,36 17,40-17,58 0,94
da questi traiamo l’impressione che lo standard teorico di riferimento per questi medaglioni fosse al di sopra di g 17, ma con ogni probabilità al di sotto anche di g 18: a questo proposito, appare significativo che il maggiore addensamento ponderale si registri tra g 17,40 e 17,58. Sulla base di questi dati risulta destituita di fondamento l’ipotesi formu-lata in passato che si tratti di un’emissione da cinque silique 54, mentre risulta più convin-cente l’eventualità che i medaglioni fossero multipli da 4 “miliarensi” 55, con uno standard teorico a circa g 18, certamente compatibile con i dati recentemente emersi.
53 Cfr. RIC, Vii, p. 6. Anche nel caso dei medaglioni argentei prodotti per i vicennalia di Costantino ii (cfr. supra, nota 3) il peso è piuttosto variabile e oscilla tra g 10,97 e 13,50, con uno scarto pari a circa il 17,5%, strettamente comparabile con quello dei nostri medaglioni. i pesi sono desunti da RIC, Vii (cfr. ad indicem alle voci avGvStvS e CaeSaR, per i seguenti pesi: g 10,97 11,90 11,92 12,08 12,33 12,45 12,70 12,70 12,80 13,00 13,00 13,10 13,17 13,22 13,50 13,50). Si vedano inoltre i pesi dei due esemplari battuti rispettivamente presso Baldwin’s Auctions ltd dmitry markov Coins & medals m&m numismatics ltd, the new York Sale iV, 17 January 2002, lotto n. 402 (g 13,20) e presso Gemini, llC, Auction iii, 9 Janua-ry 2007, lotto n. 460 (g 12,87).
54 RIC, Vii, pp. 8 e 578, nota 53; dembSki 1996, p. 100; beRk 2008, p. 111. l’ipotesi di questi testi però prendeva in considerazione i dati ponderali editi fondamentalmente dallo Gnecchi nel 1912: calco-lando lo standard ponderale della “siliqua” di età costantiniana pari a g 3,41 (RIC, Vii, pp. 4-7), il peso di riferimento dei medaglioni argentei corrispondeva a g 17,05 circa. in toynbee 1986, p. 168, si ritiene fossero multipli da 5 ½ -6 ½ silique.
55 Questa eventualità non è ancora entrata nel dibattito scientifico, ma se ne ha eco nelle aste che hanno posto in vendita di recente questi medaglioni. nella scheda che accompagna il medaglione in vendita presso la Compagnie Générale de Bourse si propone che l’esemplare corrisponda a 4 “miliarensi” leggeri (cfr. http://vso.numishop.eu/fiche-v34_0934-vso_mo-1-CONSTANTIN_Ier_LE_GRAND_Medaillon_d_argent_de_4_ miliarense_legers_330.html), ossia dell’unico tipo prodotto in età constantiniana: il miliaren-se pesante si afferma infatti solo successivamente.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
264
A nostro giudizio rimane comunque percorribile un’ulteriore possibilità: stante l’evi-dente volontà di Costantino i di replicare l’aspetto di monete di chiara ascendenza attalide, seleucide e lisimachea, è credibile che nella scelta del piede di questi medaglioni abbia preso in considerazione standard non romani, o per lo meno che l’eventuale individuazione di uno standard romano sia stata influenzata da modelli verosimilmente ellenistici.
È assai più probabile che Costantino i abbia scelto avendo a disposizione monete reali di epoca ellenistica, monete che sarebbero servite agli incisori per disegnare i coni dei medaglioni. infatti, verosimilmente poteva disporre di una raccolta di monete imperiali cui si sarebbe ispirato per alcuni dei suoi ritratti monetali, in taluni dei quali si sono rico-nosciute delle evidenti reminiscenze di età augustea 56 o piuttosto traianea 57, sottointese anche nella proposizione di alcuni rovesci 58.
A nostro giudizio, altrettanto verosimilmente assieme a queste poteva disporre anche di esemplari più antichi, in particolare dei re ellenistici, predecessori di Roma in Oriente. È ragionevole ipotizzare che queste monete giungessero nella disponibilità di Costantino i grazie a rinvenimenti di singoli esemplari o più probabilmente di ripostigli 59, oppure grazie, almeno in parte, a non improbabili percorsi collezionistici. in ogni caso, appare plausibile che l’imperatore avesse a disposizione esemplari particolarmente belli e ben con-servati, ossia di conio fresco e quindi tra i più pesanti. da questi avrebbe potuto ricavare, oltre che degli schemi iconografici, anche dei dati ponderali 60.
in quest’ottica, la verifica dell’andamento del peso di alcune serie di tetradracme ellenistiche, in particolare di quelle che potrebbero avere costituito anche dei modelli tipo-logici 61, sembra dare indicazioni interessanti:- tetradracma seleucide: g 15-17,49 62
- tetradracma attalide: g 15,03-17,35 63.
56 L’oRanGe 1933, pp. 56-57; WRiGht 1987.57 aLFöLdi m.R. 1963, pp. 57-69. Cfr. RIC, Vii, pp. 32-33.58 V. supra, nota 4.59 il rinvenimento di monete sporadiche e/o di ripostigli non doveva essere nella tarda antichità ro-
mana meno frequente di oggi. A tal proposito ricordiamo il rinvenimento ad Antiochia di un tesoro di oltre 3.000 darici d’oro menzionato da Filostrato (ca. 170-245 d.C.): v. CLain-SteFaneLLi 1965, p. 6. Peraltro ricordiamo che le specie monetarie ellenistiche su menzionate si possono rinvenire ancora oggi assieme negli stessi ripostigli: cfr. touRatSoGLou 1995, pp. 89-107, in part. nn. 4-6, 57-77.
60 Possiamo escludere, infatti, che abbia tenuto conto di quelle unità di conto e monetate argentee, di matrice greca, integrate da secoli nel sistema romano, poiché anche queste avevano subito una forte sva-lutazione conseguente a quella del denario cui erano necessariamente rapportate e comunque, con la sola eccezione della tetradracma alessandrina, non erano effettivamente più prodotte dalla metà del iii sec. d.C.: huLtSCh 1882, pp. 250-253; hoWGeGo 1985, pp. 52-53.
61 escludiamo da questo novero la tetradracma tolemaica a causa del peso incompatibile con quello dei medaglioni oggetto di questo studio e concentriamo l’attenzione, invece, su quelle coniate in ambito tracio, soprattutto su quelle di lisimaco, e asiatico, particolarmente seleucide e attalide prima della riforma di Eumene II: per lo sviluppo ponderale di queste monete cfr. la bibliografia indicata nelle note successive. Per le scelte ponderali operate già dal primo dei tolomei cfr. møRChoLm 1991, p. 10.
62 Fortunatamente, riguardo alla monetazione seleucide, disponiamo di studi piuttosto approfonditi. i rilievi ponderali condotti sulla tetradracma coniata presso la zecca di Antiochia hanno evidenziato come tra il 300 e il 161 a.C. questo nominale subisca variazioni piuttosto significative, ma entro margini che van-no da g 15 a g 17,49: cfr. møRChoLm 1982; Le RideR 1999; hooveR, ioSSiF 2008, in particolare la tabella riassuntiva a p. 5.
63 Per la monetazione attalide disponiamo del repertorio delle tetradracme con ritratto di Filetero,
miCHele ASOlAti
265
- tetradracma di lisimaco: g 16,02-17,26 64.Dunque, in termini generali si può affermare che i margini ponderali entro cui possia-
mo collocare la stragrande maggioranza delle tetradracme di queste serie va da un minimo di g 15,00 a un massimo di g 17,50 circa, anche se mediamente queste si addensano tra g 16,80 e 17,30 circa.
tornando ora ai medaglioni di Costantino i, dei diciannove pesi registrati, tredici rientrano nei limiti su indicati, tre eccedono per pochi centesimi di grammo l’indicazione ponderale superiore, mentre due la superano rispettivamente per quattro e per sette deci-mi di grammo. In buona sostanza si può sostenere che quasi il 90% dei pesi sono com-patibili con quelli della tetradracma prodotta in tracia e in Asia tra il iii e la metà ii sec. a.C. A nostro giudizio, questi dati vanno intesi nel segno di quanto emerso dalla lettura delle tipologie, della legenda e della struttura stessa del tondello di questi medaglioni, ossia come espressione della volontà di riproporre anche sotto il particolare aspetto del peso il più tipico nominale argenteo prodotto da Alessandro magno e dai suoi successori: la tetradracma.
non possiamo escludere che lo standard di riferimento fosse romano (quattro miliarensi = g 18,14), anzi, considerando lo sviluppo della monetazione imperiale in questo periodo, riteniamo che la preferenza verso un’unità monetaria allora in uso risponda all’eventualità più probabile, anche se la cosa di per sé non ci sembra del tutto significativa, se non in senso tecnico. quello che pare piuttosto evidente, invece, è che in ogni caso la scelta del peso di questi medaglioni sia stata operata consapevolmente con il proposito di realizzare quanto di più simile a una tetradracma attica di età ellenistica (= g 16,8-17,3 circa).
dunque, Costantino i avrebbe dato vita a questa emissione nell’intento di riprodurre qualcosa che sotto ogni aspetto desse l’idea del principale nominale argenteo di età elleni-stica, proponendo sé stesso come un continuatore ideale del potere regale di Alessandro e dei suoi successori.
l’eccezionale occasione per cui questa fu realizzata potrebbe offrire una chiave di lettura particolarmente suggestiva per comprendere i motivi di questa preferenza. Come i basileis ellenistici, anche Costantino i fondava una città cui dava il proprio nome, definendo così un nuovo ordine imperiale, e ne celebrava la dedicazione per l’appunto attraverso la distribuzione non di monete romane, ma di tetradracme, accostando in que-sto modo la propria figura a quella dei più prolifici fondatori di poleis di età ellenistica. in questo senso, suggestiva è l’eventualità, a nostro giudizio tutt’altro che improbabile, che il creatore della nuova Roma potesse distribuire questi medaglioni assieme proprio
redatto dalla Westermak (WeSteRmaRk 1961): i 494 esemplari ivi censiti (ma non tutti con il peso) ri-spondono a valori ponderali compresi tra g 15,03 e 17,27. Si registrano pesi eccezionalmente bassi (13,80, 14,08, 14,10) e uno eccezionalmente elevato di g 18,97, ma la maggioranza dei pezzi va posta tra g 16,50 e 17,10. inoltre, viene in aiuto il gruzzolo di meydancikkale che contiene 58 tetradracme di questa serie (da-veSne, Le RideR 1989, nn. 2998-3057) ovviamente non registrate dalla Westermark, e pesanti tra g 16,12 e 17,21, con una prevalenza di esemplari il cui peso si situa tra g 16,75 e 17,06. Risposte simili vengono dai 28 esemplari di questo tipo presenti nel ripostiglio di mektepini: oLCay, SeyRiG 1965, nn. 259-267. Peral-tro, valutazioni personalmente condotte su 75 tetradracme del regno attalide con ritratto di Filetero hanno dato come risultato un intervallo ponderale compreso tra g 16,13 e 17,35, con una netta preponderanza di monete collocabili tra g 16,60 e 17,00: cfr. il sito web www.coinarchives.com (alla data 30 luglio 2010).
64 tale valutazione è basata ancora una volta sul ripostiglio di meydancikkale (daveSne, Le RideR 1989, pp. 119-131): le 117 monete ivi presenti, che appaiono tutte particolarmente fresche, sono comprese tra gli estremi ponderali indicati, con un addensamento evidente tra g 16,60 e 17,10.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
266
a tetradracme ellenistiche 65, dal cui confronto trasparissero immediatamente le simili-tudini dei nuovi con gli antichi manufatti e dunque la sua colleganza ideale con coloro che li avevano emessi.
Considerato il significato e il portato di queste tipologie, non sorprende la loro ripresa da parte delle autorità monetarie ostrogote che assai più tardi le reinterpretarono entro un quadro molto più esteso di richiami monetali alla produzione costantiniana e constantini-de, soprattutto riferibile al momento della dedicazione di Constantinopolis. in un recente contributo lo scrivente ha cercato di delineare gli elementi essenziali di questa imitatio che sembrerebbe interessare a livello di scelte tipologiche la maggioranza delle emissioni bronzee e argentee ostrogote 66. non è possibile in questa sede riprendere quelle argomen-tazioni, tuttavia va sottolineato come proprio nella coniazione dei tipi anonimi ostrogoti per inviCta Roma (cfr. per esempio fig. 38-39) e FeLix Ravenna (fig. 40) sia possibile ravvi-sare più immediatamente e puntualmente il richiamo ai prototipi ellenistici rivitalizzati da Costantino i in occasione della dedicazione della nuova Roma. Va rammentato che se nelle tipologie dei medaglioni argentei la tradizione greca tarda trova la rievocazione più organi-ca e compiuta, Costantino i declina queste personificazioni in una serie di altre emissioni strettamente legate a quell’evento secondo modalità che prevedono l’impiego solamente del busto di queste figure. Per ovvi motivi queste ultime ebbero una diffusione maggiore non solo all’epoca dei Costantinidi, ma anche oltre. infatti, i bronzi del tipo vRbS Roma (cfr. figg. 41-42) e del tipo ConStantinopoLiS (cfr. fig. 28) godettero di un’enorme fortuna anche perché la loro produzione durò per circa quindici anni dopo il 330, mentre i piccoli argenti anonimi con i busti delle due personificazioni furono periodicamente rivisitati per emissioni celebrative della fondazione di Constantinopolis battute ogni cento anni, con minime variazioni stilistiche e tipologiche (figg. 43-45), e costituirono dei modelli anche per coniazioni per altre città imperiali 67 (fig. 47).
in particolare i bronzi rappresentarono indiscutibilmente dei modelli per la monetazione bronzea ostrogota, anonima e regale, emessa a Roma, talvolta con un’aderenza così stretta al prototipo da riprodurne persino gli elementi tipologici accessori presenti in campo 68.
quanto al tipo anonimo per FeLix Ravenna, con busto turrito, potrebbe dipendere direttamente dai medaglioni argentei con Constantinopolis, ma in realtà sembra essere molto più aderente alla prova di aureo costantiniana con busto con corona murale e con legenda ConStantinopoLiS, (fig. 48) di cui riporta fedelmente alcuni particolari come l’acconciatura e la collana con pendenti. Va peraltro ricordato come la raffigurazione di Constantinopoli turrita, quasi sempre in antitesi/accoppiamento con Roma elmata, perman-ga vitale anche su altri supporti per lo meno fino al Vi secolo 69, veicolando altrimenti le scelte iconografiche costantiniane già proposte sulle monete.
65 A tal proposito ricordiamo che anche Augusto, in occasione dei Saturnalia “modo munera di-videbat, vestem et aurum et argentum, modo nummos omnis notae, etiam veteres regios ac peregrinos” (Svetonio, De vita Caesarum, ii, 75).
66 aSoLati 2012, pp. 53-111.67 questa ricostruzione è formulata su basi stilistiche in bendaLL 2002 ed è in parte confermata dal-
la recente proposizione in un’asta pubblica di un esemplare a nome di Giustiniano i con al rovescio la let-tere K (fig. 46). In questo contributo, peraltro si ricordano anche altri tipi accomunabili a quelli di Roma (P o R) e Constantinopolis (K), alcuni dei quali certamente identificabili come personificazioni di Antiochia, mentre altri rimangono di difficile interpretazione, come la personificazione accostata alle lettere CV.
68 aSoLati 2012, pp. 74-75 con bibliografia precedente.69 Cfr. bühL 1995, passim.
miCHele ASOlAti
267
L’elemento di fondo di maggiore interesse, però, è che alle due capitali costantiniane, Roma e Constatinopolis, corrispondono due capitali ostrogote, Roma e Ravenna, ciascuna con una propria dignità monetale, individuate attraverso schemi iconografici del tutto simili a quelli impiegati dal fondatore della nuova Roma.
Come abbiamo già cercato altrimenti di dimostrare, questi sono solo due aspetti di un più complesso sistema di richiami iconografici che rinviano non soltanto alla dinastia di Costantino i ma anche a quella di Vespasiano, nel segno di una comune, ancorché forse fraintesa, ascendenza “flavia” 70.
in questo contesto non va trascurato che molte delle scelte iconografiche e epigrafiche proposte sulla monetazione ostrogota dimostrano un interesse evidente verso il repertorio mitologico romano e verso elementi che implicano l’esaltazione di Roma e di Ravenna, e che non a caso queste interessano quasi esclusivamente la monetazione bronzea, ossia quel-la d’uso più frequente e diffuso. la lupa con i gemelli e forse l’aquila, il busto di Roma con la legenda che lo attornia, la sigla SC che ricorre anche sull’argento, il busto di Ravenna e il monogramma che lo accompagna, pur rinviando a modelli e suggestioni di matrice flavia e dunque rientrando facilmente negli schemi che abbiamo individuato, manifestano la presenza di un elemento aggiuntivo, di un senso sotteso più strettamente attinente con il territorio controllato dagli Ostrogoti, o per meglio dire con parti fondamentali del territorio italico, e con la componente romana ivi insediata. in questi casi il linguaggio impiegato sembrerebbe dunque caricarsi di ulteriori significati che andrebbero individuati nel tenta-tivo di suscitare il consenso degli interlocutori locali del potere ostrogoto, nella fattispecie le élite cittadine di Roma e Ravenna e tra queste soprattutto del Senato romano. tuttavia, se si concorda con quanto sin qui illustrato, questo messaggio diviene aggiuntivo e acces-sorio 71, mediato attraverso il recupero di schemi prioritariamente inseriti in un quadro di riferimento più ampio che sembra avere una funzione differente e più specifica. una funzione appunto strettamente connessa con il recupero della tradizione flavia nella sua più ampia accezione, nell’intento di legittimare l’emissione e dunque indirettamente anche l’autorità delegata all’emissione stessa. infatti, in questo contesto, non va taciuto il fatto che questa rievocazione per immagini si accompagna a un percorso di istituzionalizzazione del titolo di Flavius che contraddistingue la dinastia Amala, persino nella sua componente femminile, e che diviene sinonimo di regalità, trasmettendosi con questo significato anche ai re longobardi, successori dei Goti nel regno d’italia, e ai re visigoti, attraverso il legame con i re ostrogoti d’italia 72. Per quanto non sussista testimonianza diretta dell’adozione di tale titolatura da parte dei successori di teodorico, sembra dunque che con quest’ultimo prendesse forma una terza dinastia flavia, dopo la prima inaugurata da Vespasiano e la seconda iniziata da Claudio ii/Costanzo i/Costantino i 73.
70 aSoLati 2012, pp. 53-111.71 tanto più accessorio se si ritiene plausibile l’eventualità che nel momento in cui queste produzio-
ni ostrogote furono attuate non era presente a Roma il simbolo che incarnava la romanitas, ossia la lupa Capitolina. Secondo un’ipotesi recentemente formulata da maria Alföldi, infatti, la statua bronzea sarebbe stata depredata durante la razzia vandala di Roma del 455 d.C. e utilizzata come un trofeo nella Cartagine da poco conquistata dai Vandali; in seguito alla riconquista bizantina la scultura fu portata a Constantinopo-lis e collocata sulla spina del circo giustinianeo (baSSet 2004, p. 231, n. 147) dove probabilmente rimase fino al momento della sua distruzione, avvenuta nel 1204 secondo Niceta Koniata: cfr. aLFöLdi m.R. 2011, pp. 98-104.
72 Cfr. aSoLati 2012, pp. 92-93 con bibliografia precedente.73 WoLFRam 1967, p. 61.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
268
A sostanziare ulteriormente l’eventualità che la scelta delle tipologie monetali ostro-gote in chiave flavia fosse condizionata da un’ideale continuità con il potere costantinia-no interviene anche un altro elemento che potrebbe in qualche modo individuare il desti-natario di questi messaggi. la distribuzione dei ritrovamenti di monete ostrogote entro i confini del Regno ostrogoto è fortemente caratterizzata 74. le monete di bronzo di valore superiore al nummo si rinvengono in prevalenza in ambito italico centro-settentrionale, normalmente al di sopra della linea definita dalla via Salaria lungo il versante adriatico, ed entro i confini del lazio lungo quello tirrenico; rinvenimenti sporadici sono segnalati in istria e in dalmazia 75, ma, a parte un decanummo da loc. Cipassi in Calabria 76, non sono documentati in italia meridionale e in Sicilia. Va precisato che da questo schema esce completamente il più piccolo dei nominali enei ostrogoti, ossia il nummo, il quale è fortemente presente in ambito centro-meridionale, ma va anche sottolineato come questo si raccolga prevalentemente in gruzzoli assieme a moneta omologa di emissione giustinianea: la maggioranza dei dati di cui disponiamo, dunque, sembrerebbe riferibile a fasi di circolazione non propriamente ostrogote, bensì successive alla riconquista bizan-tina 77. la diffusione della moneta di metallo prezioso, se allarga la prospettiva ad ampie porzioni dei comprensori dalmata e illirico, non eccede i limiti già osservati nell’italia peninsulare 78. il quadro dei ritrovamenti corrisponde all’area in cui si distribuiscono i rinvenimenti archeologici di matrice ostrogota in italia, concentrati essenzialmente in ambito settentrionale, in Romagna e nelle province adriatiche fino alla via Salaria: tale diffusione conferma le indicazioni delle fonti storiche (Cassiodoro e Procopio) che definiscono una distribuzione degli insediamenti e delle fortificazioni stabili ostrogoti in italia settentrionale e centrale fino alla linea Roma-Perugia, mentre più a sud predomi-navano formazioni militari mobili piuttosto deboli e senza insediamenti veri e propri 79. Da questa sovrapposizione si può desumere che la moneta ostrogota avesse una distribu-zione e un utilizzo prevalenti, se non esclusivi, tra la popolazione di origine germanica, con funzioni probabilmente connesse con l’esercizio militare 80. Se ammettiamo questa probabilità, questa stessa popolazione doveva essere la principale destinataria anche del messaggio sotteso alle scelte tipologiche: queste non sarebbero state dettate dunque dal proposito di accondiscendere all’elemento romanzo per ottenerne il consenso, ma dalla volontà di legittimare il potere regale di fronte alla componente germanica della popo-lazione, secondo una sintassi tipicamente ellenistico-romana desunta principalmente dai modi espressivi di matrice costantiniana.
Prima di chiudere, giova ricordare in questo contesto come circostanze simili a quelle appena descritte ricorrano anche in ambiente anglosassone, dove ancora una volta tipi costantiniani rappresentano un potente richiamo evocativo anche molto più tardi del Vi secolo. il tipo prescelto è quello dell’vRbS Roma, impiegato sia per oggetti decorativi, come il medaglione aureo bratteato da undley di V-Vi secolo (fig. 49), sia per la stessa monetazione di Viii secolo (fig. 50-51), anche se in realtà su quest’ultima è documentato
74 A questo proposito cfr. da ultimo aSoLati c.s.75 Cfr. demo 1994, passim.76 FioReLLi 1884, p. 53.77 aSoLati c.s.78 Cfr. aSoLati c.s. e, in particolare per l’ambito toscano, SaCCoCCi c.s.79 bieRbRaueR 1975, pp. 209-215; bieRbRaueR 1994, pp. 174-176. Cfr. anche paRibeni 2008.80 Cfr. aRSLan 1988, pp. 231-232; aSoLati c.s.; SaCCoCCi c.s.
miCHele ASOlAti
269
esclusivamente l’uso del tipo della lupa con i gemelli 81, connesso alla personificazione di Roma. questa scelta operata in east Anglia si riteneva fosse dettata dalla volontà di richia-mare la dinastia dei Wuffingas, fondatori del regno e predecessori quasi mitici dei regnanti di quel periodo 82; tuttavia, il recente rinvenimento di un denaro di Offa, re di mercia (fig. 53), con le stesse caratteristiche tipologiche dei denari di Aethelberht, re di east Anglia (fig. 51), ha comportato la necessità di riconsiderare questa ipotesi, almeno per l’emissione di Offa che non vantava ascendenze da quella genia. il ricorso al tipo della lupa dunque andrebbe letto come l’appropriazione “di un potente simbolo di romanitas” 83. il disegno dei denari di Aethelberht, però, è così aderente a quello di alcune emissioni di età costan-tiniana battute a treviri (figg. 42, 51 e 53), da non potersi negare la derivazione diretta da quei modelli, così come non si può eludere la somiglianza del denaro di Offa con quello di Aethelbertht, cui è immediatamente successivo. in questi casi, pertanto, la chiave di lettura sembrerebbe essere non un generico richiamo alle nobili origini di Roma, ma l’evocazione di Costantino: di un Costantino rifondatore di Roma in chiave cristiana 84, fondatore di Constantinopolis e principio di un nuovo ordine imperiale.
81 la rivitalizzazione del tipo tradizionale della lupa con i gemelli è tipico dell’età costantiniana ed è legata non soltanto ai comunissimi folles, cui si è già accennato, ma anche ai medaglioni argentei con il cri-stogramma (cfr. supra, nota 1), nei quali questo motivo è ripreso al dritto sullo scudo tenuto da Costantino: cfr. da ultimo aLFöLdi m.R. 2011, p. 90 che ritiene che questo particolare sia stato inserito in risposta alla scelta di massenzio, che in precedenza aveva coniato monete d’argento e di bronzo anch’egli con la lupa e i gemelli (RIC, Vii, p. 375, nn. 190-191 e pp. 402-405, n. 13, 20, 39-40, 52), e per proporre Costantino stesso quale salvatore di Roma dalla tirannia dello sconfitto al Ponte Milvio.
82 Gannon 2003, pp. 144-147.83 Gannon 2004, p. 158.84 LiveRani 2005. Per l’edilizia non religiosa cfr. RinaLdi tuFi 2005, pp. 93-97.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
270
didaSCaLie deLLe iLLuStRazioni e ReFeRenze FotoGRaFiChe
1. medaglione da due “silique” di Costantino i, RIC, Vii, p. 364, n. 36 (foto da Imperator Flavius Constantinus. Konstantin der Grosse, Ausstellung trier 2007, catalogo della mostra in Cd, mainz 2007, n. i.1.3=i.13.120)
2. incisione relativa al medaglione di Costantino con cristogramma rinvenuto a Salonicco attorno al 1831 (CouSinéRy 1831, i, p. 31)
3. medaglione da quattro “silique” di Costantino i, RIC, Vii, p. 529, n. 221 (foto da Gemini, llC, Auction iii, 9 January 2007, lotto n. 460 via www.coinarchives.com)
4. Bronzo di Augusto con legenda in corona al rovescio, RPC, i, n. 2235 (foto da Classical numismatic Group, mail Bid Sale 78, 14 may 2008, lotto n. 1631)
5. Solido di Costantino i con al rovescio aquila legionaria tra due insegne militari e legenda SPqR OPtimO PRinCiPi, RIC, Vi, p. 222, n. 815 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 54, 24 march 2010, lotto n. 613)
6. Aureo di traiano con al rovescio aquila legionaria tra due insegne militari e legen-da SPqR OPtimO PRinCiPi, RIC, ii, p. 264, n. 296 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 49, 21 October 2008, lotto n. 196)
7. Solido di Costantino i con al rovescio prigioniero franco prostrato e trofeo, RIC, Vi, p. 223, n. 824 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 49, 21 October 2008, lotto n. 461)
8. denario di traiano con al rovescio prigioniero dacio prostrato e trofeo, RIC, ii, p. 258, n. 221 (foto da Classical numismatic Group, electronic Auction 226, 27 January 2010, lotto n. 516)
9. Solido di Costantino i con legenda SRqR / OPtimO / PRinCiPi in corona al rove-scio, RIC, Vii manca (foto da numismatica Ars Classica, Auction 25, 25 June 2003, lotto n. 591)
10. Aureo di traiano con legenda SPqR / OPtimO / PRinCiPi in corona al rovescio, RIC, ii, p. 254, n. 150 (foto da uBS Gold & numismatics, Auction 64, 24 January 2006, lotto n. 187)
11. Follis per Costanzo ii cesare con legenda SRqR OPtimO CAeSARi e con Costanzo ii a cavallo con lancia, RIC, Vii manca (foto da numismatica Ars Classica, Auction 25, 25 June 2003, lotto n. 591)
12. Sesterzio di traiano con legenda SPqR OPtimO PRinCiPi e con traiano a cavallo con lancia, RIC, ii, p. 286, nn. 598-599 (foto da uBS Gold & numismatics, Auction 64, 24 January 2006, lotto n. 187)
13. Aureo di Postumo con ritratto recante l’elmo corinzio, RIC, V, ii, p. 336, n. 3 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 49, 21 October 2008, lotto n. 382)
14. Aureo di Probo con ritratto recante l’elmo corinzio, RIC, V, ii, p. 78, n. 579 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 51, 5 march 2009, lotto n. 401)
15. Statere di Alessandro iii, zecca di memphis (Aegyptus), ca. 332-323 a.C., pRiCe 1991, n. 3966 (foto da Gemini, llC, Auction iX, 9 January 2012, lotto n. 67)
16. Aureo di massimiano erculeo seduto su roccia, zecca di Roma, ca. 287 d.C., CaLiCò 2002, n. 4681 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 67, 17 October 2012, lotto n. 215)
17. Statere argenteo di Abdera (thracia) con eracle seduto su roccia, ca. 411-385 a.C., cfr. may 1966, p. 234, nn. 391-392 (foto da Baldwin’s Auctions ltd, Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, dmitry markov Coins & medals, m&m numismatics ltd, the new York Sale XX, 7 January 2009, lotto n. 117)
miCHele ASOlAti
271
18. Aureo di massimiano erculeo con ercole che combatte con il leone nemeo, zecca di Roma, ca. 287 d.C., CaLiCò 2002, n. 4732 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 49, 21 October 2008, lotto n. 425)
19. Statere argenteo di Heraclea /lucania con eracle che combatte con il leone nemeo, ca. 390-340 a.C., HN, Italy, n. 1377 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 54, 24 march 2010, lotto n. 15)
20. Aureo di massimiano erculeo con ercole che abbatte l’idra, zecca di Roma, ca. 294 d.C., CaLiCò 2002, n. 4662 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 67, 17 October 2012, lotto n. 219)
21. Statere di Phaistos (Creta) con eracle che combatte l’idra, ca. 300-270 a.C., Le RideR 1966, p. 94, n. 52 (foto da Gemini, llC, Auction Vi, 10 January 2010, lotto n. 802)
22. Aureo di massimiano erculeo con ercole che abbatte l’idra, zecca di Roma, 294-295 d.C., CaLiCò 2002, n. 4661 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 72, 16 may 2013, lotto n. 753)
23. Statere di Phaistos (Creta) con eracle che combatte l’idra, ca. 322-300, Le RideR 1966, p. 95, n. 56 (foto da lHS numismatik AG, Auction 100, 23 April 2007, lotto n. 279)
24. medaglione di bronzo di massimiano erculeo con raffigurazione di ercole seduto, cfr. GneCChi 1912, ii, p. 127, n. 2 (foto da Classical numismatic Group, triton Xii, 6 January 2009, lotto n. 761)
25. medaglione/“tetradracma” di Costantino i tipo Constantinopolis: segno di zecca mCOnSiA (foto da http://www.tantaluscoins.com/coins/5334.php)
26. medaglione/“tetradracma” di Costantino i tipo Roma: segno di zecca mCOnSi (foto da numismatica Ars Classica, Auction 33, 6 April 2006, lotto n. 597)
27. medaglione di Costantino i tipo Constantinopolis (foto da SpeRLinG 1700a, tav. V, n. 1)
28. Follis anonimo per Constantinopolis, RIC, Vii, p. 456, n. 241 (foto da numismatik lanz münchen, Auction 123, 30 may 2005, lotto n. 898)
29. Argento anonimo battuto per la dedicazione di Constantinopolis, bendaLL 2002, tipo 1 (foto da Classical numismatic Group, triton Viii, 11 January 2005, lotto n. 1250)
30. Argento anonimo battuto per la dedicazione di Constantinopolis, bendaLL 2002, tipo 4 (foto da numismatica Ars Classica, Auction 64, 17 may 2012, lotto n. 1310)
31. Bronzo anonimo battuto per la dedicazione di Constantinopolis, RIC, Viii, p. 256, n. 106 (zecca di Roma) = bendaLL 2002, tipo A (zecca di Constantinopolis; foto da Gorny & mosch Giessener münzhandlung, Auction 170, 13 October 2008, lotto n. 2962)
32. mezza “siliqua” di Giulio nepote con al rovescio la tyche di Ravenna su prora di nave, RIC, X, n. 3216 (foto da http://www.acsearch.info/record.html?id=81267)
33. medaglione da solidi 1 e ½ con ritratto “ispirato” di Costantino i, RIC, Vii, p. 451, n. 206 (foto da Classical numismatic Group, Auction 85, 15 September 2010, lotto n. 1211)
34. tetradracma di eumene i con ritratto di Filetero, WeSteRmak 1961, gruppo ii, V.i-R.- (foto da lHS numismatik AG, Auction 102, 29 April 2008, lotto n. 267)
35. tetradracma di lisimaco con ritratto di Alessandro iii, thompSon 1968, n. 193 (foto da Classical numismatic Group, mail Bid Sale 81, 20 may 2009, lotto n. 236)
36. tetradracma di demetrio Poliorcete di zecca macedone, neWeLL 1978, n. 136 (foto da Gorny & mosch Giessener münzhandlung, Auction 164, 17 march 2008, lotto n. 125)
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
272
37. tetradracma di demetrio i Sotere con personificazione della tyche, SC, n. 1641.5a (foto da Classical numismatic Group, electronic Auction 191, 9 July 2008, lotto n. 27)
38. 40 nummi anonimi del tipo inviCta Roma/lupa, CoI, n. 82a (foto da http://www.cngcoins.com/Coin.aspx? Coinid=117849#)
39. 20 nummi anonimi del tipo inviCta Roma/lupa con cristogramma al rovescio, CoI, n. 84b (foto da Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auction 143, 6 October 2008, lotto n. 834)
40. 10 nummi anonimo del tipo FeLix Ravenna/monogramma in corona, CoI, n. 78a (foto da numismatica Ars Classica, Auction P, 12 may 2005, lotto n. 2257)
41. Follis della famiglia di Costantino i per urbs Roma con cristogramma al rovescio, zecca di Arelate, 336 d.C., RIC, Vii, p. 277, n. 400 (foto da http://www.cngcoins.com/Coin.aspx? Coinid=110095)
42. Follis della famiglia di Costantino i per urbs Roma, zecca di treviri, 333-334 d.C., RIC, Vii, p. 218, n. 553 (foto da Classical numismatic Group, electronic Auction 238, 11 August 2010, lotto n. 607)
43. Frazione di “siliqua” del tipo busto di Constantinopolis/K coniato nel ca. 530 d.C., bendaLL 2002, tipo 8b (foto da Auktionshaus H. d. Rauch GmbH, Auction 88, 17 may 2011, lotto n. 715)
44. Frazione di “siliqua” del tipo busto di Constantinopolis/K coniato nel ca. 530 d.C. e dopo, bendaLL 2002, tipo 8c (foto da Classical numismatic Group, electronic Auc-tion 300, 10 April 2013, lotto n. 321)
45. Frazione di “siliqua” del tipo busto di Roma/R nel ca. 530 d.C., bendaLL 2002, tipo 9 (foto da ira & larry Goldberg Coins & Collectibles, Auction 65, 6 Septem-ber 2011, lotto n. 4133)
46. Frazione di “siliqua” di Giustiniano i per Constantinopolis (K) coniato nel ca. 530 d.C., inedito (foto da Roma numismatics ltd, Auction V, 23 march 2013, lotto n. 931)
47. Frazione di “siliqua” del tipo busto di Constantinopolis/monogramma tX coniato alla fine del VI secolo d.C., bendaLL 2002, tipo 12 (foto da. numismatik lanz mün-chen, Auction 153, 12 december 2011, lotto n. 667)
48. Prova di bronzo per medaglione aureo con personificazione di Constantinopolis, zec-ca di Constantinopolis, ca 330 d.C., RIC, Vii, manca (foto da http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?Coinid=231872)
49. medaglione aureo, bratteato da undley (Suffolk, inghilterra), con Roma e la lupa con i gemelli simile al tipo dei folles constantiniani, V-Vi sec. d.C. (foto da http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/g/gold_brac-teate-1.aspx)
50. East Anglia, penny (rovescio) raffigurante la lupa con i gemelli, Serie V, ca. 720-730 d.C. (foto da http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/anglosaxon/theme1.html)
51. East Anglia, Aethelberht, penny raffigurante la lupa con i gemelli, 779 (?)-794 d.C., Gannon 2004, p. 160, fig. 3A (foto da http://en.academic.ru/dic.nsf/enwi-ki/4340764)
52. Mercia, Offa, penny raffigurante la lupa con i gemelli, ca. 794-797 d.C., Gan-non 2004, p. 160, fig. 3B (foto da http://www.wuffings.co.uk/education/programmes/2011/11_04_09-MornCapper.html)
53. i tipi dei rovesci delle monete nn. 51 e 42 a confronto
miCHele ASOlAti
277
BiBliOGRAFiA
aLFöLdi A. e e. 1976-90 = A. e e. aLFöLdi, Die Kontorniaten-Medaillons, Antike münzen und Gesch- nittene Steine, Vi, 1-2, Berlin-new York.
aLFöLdi m.R. 1963 = m.R. aLFöLdi, Die Constantinische Goldprägung, mainz.aLFöLdi m.R. 2003 = m.R. aLFöLdi, Multiplo d’argento, in 387 d.C. Ambrogio e Agostino le sorgenti
d’Europa (Catalogo della mostra, milano), a cura di P. paSini, milano, p. 380.aLFöLdi m.R. 2011 = m.R. aLFöLdi, The Fate of the LUPA CAPIToLINA. Its Possible Route to
Constantinopole and Its End in 1204, in m.R. aLFöLdi, e. FoRmiGLi, J. FRied, The Lupa Romana. An Antique Monument Falls from her Pedestal, Stuttgart, pp. 77-104.
aRSLan 1988 = e.A. aRSLan, Monete, «Archeologia medievale», 15, pp. 226-236.aRSLan 2012 = e.A. aRSLan, Medaglione in argento di Costantino, in L’editto di Milano e il tempo
della tolleranza. Costantino 313 d.C. (Catalogo della mostra, milano), a cura di G. Sena ChieSa, milano, pp. 199-200.
aSoLati 2012 = m. aSoLati, Praestantia nummorum. Temi e note di numismatica tardo antica e alto medievale, numismatica Patavina, 11, Padova.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
278
aSoLati c.s = m. aSoLati, La disponibilità della moneta enea nell’Italia ostrogota. Emissioni inedite, in La monetazione di Taranto. Le monete degli ostrogoti e Longobardi in Italia (Atti del 4° Congresso nazionale di numismatica, Bari, 16-17 novembre 2012), in corso di stampa.
baRSanti 1992 = C. baRSanti, Costantinopoli: testimonianze archeologiche di età costantiniana, in Costantino il Grande 1992-93, i, pp. 113-150.
baSSet 2004= S. baSSet, The Urban Image of Late Antique Constantinople, Cambridge.baStien 1988 = P. baStien, Monnaie et donativa au Bas-Empire, numismatique Romaine, essais,
Recherches et documents, 17, Wetteren.baStien 1989 = P. baStien, Le médaillon de plomb de Lyon, numismatique Romaine, essais, Recherches
et documents, 18, Wetteren.baStien 1992-94 = P. baStien, Le buste monétaire des empereurs romaines, i-iii, numismatique
Romaine. essais, Recherches et documents, 19, Wetteren.beCkeR 1801 = C.d. beCkeR, Commentarii Societatis Philologicae Lipsiensis, i, lipsiae et Plaviae, in
comm. Grau, bibl. Cur. et maurer bibl. Berol.beLLinGeR 1958 = A.R. beLLinGeR, Roman and Byzantine Medallions in the Dumbarton oaks Collection,
«dumbarton Oaks Papers», 12, pp. 125-156.bendaLL 2002 = S. bendaLL, Some comments on the anonymous silver coinage of the fourth to sixth
centuries A.D., «Revue numismatique», 158, pp. 139-159 e tav. Xi-Xii.bendaLL 2003 = S. bendaLL, Anonymous western half-siliquae of the later fourth century, «Revue
numismatique», 159, pp. 457-461.beRk 2008 = H.J. beRk, 100 Greatest Ancient Coins, Atlanta.beRnaRdeLLi 2007 = A. beRnaRdeLLi, Il medaglione d’argento di Costantino con il cristogramma.
Annotazioni sulla cronologia, «Rivista italiana di numismatica», 108, pp. 219-236.bieRbRaueR 1975 = V. bieRbRaueR, Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in Italien, Biblioteca di
Studi medievali, 7, Spoleto (PG).bieRbRaueR 1994 = v. bieRbRaueR, Archeologia degli ostrogoti in Italia, in I Goti (Catalogo della
mostra, milano), milano, pp. 170-177.bLeCkmann c.s. = B. bLeCkmann, Costantino dopo la battaglia presso il ponte Milvio: note sul medaglio-
ne di Ticinum, in Costantino il Grande. Alle radici dell’Europa (Atti del Convegno internazionale di Studio, Città del Vaticano, 18-21 aprile 2012) (testo disponibile sul sito web: http://www.zenit.org/it/articles/costantino-dopo-la-battaglia-presso-il-ponte-milvio-note-sul-medaglione-di-ticinum).
bRuun 1991a = p. bRuun, Portrait of a Conspirator. Constantine’s Break with the Tetrarchy, in Constantinian Numismatics 1991, pp. 107-117.
bRuun 1991b = p. bRuun, The Source Value of Imperial Coin Portraits (the Fourth Century A.D.), in Constantinian Numismatics 1991, pp. 151-155.
bRuun 1992 = p. bRuun, Una permanenza del “sol invictus” di Costantino nell’arte cristiana, in Costan- tino il Grande 1992-93, i, pp. 219-230.
bühL 1995 = G. bühL, Constantinopolis und Roma: Stadtpersonificationen der Spätantike, Kilchberg.buRnett 1987 = a. buRnett, Coinage in the Roman World, london.CaLiCò 2002 = X. CaLiCò, Catalogo. Los aureos romanos 196 A.C. - 335 D.C., Barcelona.CaRLà 2010 = F. CaRLà, Le monete costantiniane: propaganda politica e rassicurazione economica, in
F. CaRLà, m.G. CaSteLLo, Questioni tardo antiche. Storia e mito della “svolta costantiniana”, Roma, pp. 31-143.
CaStRizio 2010 = d. CaStRizio, La personificazione di Costantinopoli sulle monete di Costantino I, in Salvatore Calderone (1915-2000): la personalità scientifica (Atti del Convegno internazionale di studi, messina-taormina, 19-21 febbraio 2002), a cura di V. aieLLo e L. de SaLvo, Pelorias, 17, messina, pp. 169-173.
CLain-SteFaneLLi 1965 = e.e. CLain-SteFaneLLi, Numismatics, an Ancient Science. A Survey of its History, Contribution from the museum of History and technology, Paper 32, Washington.
Cohen 1880-92 = H. Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l’empire romain com-munément appellées médailles impériales, 2 ed., voll. i-Viii, Paris
CoI = m.A. metLiCh, The coinage of ostrogothic Italy, Wien 2004.Constantinian Numismatics 1991 = Studies in Constantinian Numismatics. Papers from 1954 to 1988,
Acta instituti Romani Finlandiae, 12, Roma.Costantino il Grande 1992-93 = Costantino il Grande dall’Antichità all’Umanesimo (Colloquio sul
Cristianesimo nel mondo antico, macerata, 18-20 dicembre 1990), a cura di G. bonamente e F. FuSCo, vol. i, 1992; vol. ii, 1993; macerata.
miCHele ASOlAti
279
Costantino il Grande 2005 = Costantino il Grande. La civiltà antica al bivio tra occidente e oriente (Catalogo della mostra), a cura di A. donati e G. GentiLi, Cinisello Balsamo (mi).
CouSinéRy 1831 = É.-m. CouSinéRy, Voyage dans la Macédoine, contenant des recherches sur l’histoire, la géographie et les antiquités de ce pays, voll. 1-2, Paris.
daveSne, Le RideR 1989 = a. daveSne, G. Le RideR, Le trésor de Meydancikkale (Cilice Trachée, 1980), Gülnar, 2, Paris.
de CaLLataÿ 2007 = F. de CaLLataÿ, L’historique de l’etude des liaisons de coins (XVIIIe - XXe siècle), «Bolletin de la Société française de numismatique», 62, 4, pp. 86-92.
deLbRueCk 1929 = R. deLbRueCk, Die Consulardiptychen und verwandte Denkmäler, Berlin.dembSki 1996 = G. dembSki, Constantinopolis und Roma. Eine Medaillonserie zur Einweihung von
Constantinopolis, in Charakter. Aphieroma ste Manto oikonomidou, Athens, pp. 97-102.FioReLLi 1884 = G. FioReLLi, Saracena, «notizie degli Scavi di Antichità», pp. 53-54.FRiedLändeR 1876 = J. FRiedLändeR, Die auf die Gründung von Constantinopel geprägte Denkmünze,
«zeitschrift für numismatik», 3, pp. 125-128.FRuGoni 1978 = C. FRuGoni, La fortuna di Alessandro dall’antichità al Medioevo, Firenze.Gannon 2003 = A. Gannon, The Iconography of Early Anglo-Saxon Coinage, Oxford.Gannon 2004 = A. Gannon, Animali sulle prime monete anglosassoni. Simboli di potere spirituale o tem-
porale?, in L’immaginario e il potere nell’iconografia monetale (dossier di lavoro del seminario di studi, milano, 11 marzo 2004), a cura di L. tRavaini e a. boLiS, Collana di numismatica e Scienze Affini, 5, milano, pp. 153-160.
GneCChi 1912 = F. GneCChi, I medaglioni romani, i-iii, milano.GRieRSon, mayS 1992 = P. GRieRSon, m. mayS, Catalogue of Late Roman Coins in the Dumbarton oaks
Collection and in the Whittemore Collection. From Arcadius and Honorius to the Accession of Anastasius, Washington.
haRRiSon 1967 = e.b. haRRiSon, The Constantinian Portrait, «dumbarton Oaks Papers», 21, pp. 81-96.
HN, Italy = Historia Nummorum. Italy, a cura di n.k. RutteR, a.m. buRnett, m.h. CRaWFoRd, a.e.m. JohnSon e m.J. pRiCe, london 2001.
hooveR, ioSSiF 2008 = o.d. hooveR, p.p. ioSSiF, Metrological study of Seleucid tetradrachms of Antiochia and Phoenicia, in SC, parte ii, 2, pp. 1-8.
hoWGeGo 1985 = C.J. hoWGeGo, Greek Imperial Countermarks, london.huLtSCh 1882 = F. huLtSCh, Griechische und Römische Metrologie, 2 ed., Berlin (ristampa anastatica,
Graz 1971).kent 1978 = J.P.C. kent, Urbs Roma and Constantinopolis medallions at the mint of Rome, in Scripta
Nummaria Romana. Essays presented to Humphrey Sutherland, a cura di R.a.G. CaRSon e C.m. kRaay, london, pp. 105-113.
kRaFt 1954-55 = K. kRaFt, Das Silbermedallion. Constantins des Grossen mit dem Christus-monogramm auf der Helm, «Jahrbuch für numismatik und Geldgeschichte», 5-6, pp. 151-178.
LaFauRie 1949 = J. LaFauRie, Une série de médaillons d’argent de Constantin I et Constantin II, «Revue numismatique», s. V, 11, pp. 35-48.
LaFFRanChi 1941 = l. LaFFRanChi, Appunti di critica numismatica. 1 La data finale della personifica-zione di Costantinopoli ed i medaglioni aurei del tempo teodosiano, «numismatica», 7, 2, pp. 31-39.
La RoCCa 1993 = e. La RoCCa, La fondazione di Costantinopoli, in Costantino il Grande 1992-93, ii, pp. 553-583.
La RoCCa 2000 = e. La RoCCa, Divina Ispirazione, in Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristia-na, a cura di e. enSoLi e e. La RoCCa, Roma, pp. 1-37.
Le RideR 1966 = G. Le RideR, Monnaies cretoises du V au I siècle av. J. C., Paris.Le RideR 1999 = G. Le RideR, Antioche de Syrie sous les Séleucides. Corpus des monnaies d’or et
d’argent, i, De Séleucos I à Antiochos V c. 300-161, mémoires de l’Académie des inscriptions et Belle-lettres, n.s., 19, Paris.
LiveRani 2005 = P. LiveRani, L’edilizia costantiniana a Roma: il Laterano, in Vaticano, Santa Croce in Gerusalemme, in Costantino il Grande 2005, pp. 74-81.
L’oRanGe 1933 = h.p. L’oRanGe, Studien zur Geschichte des spätantiken Portraits, Oslo.may 1966 = J.m.F. may, The Coinage of Abdera (540-345 B.C.), london.mionnet 1815 = t.e. mionnet, De la rareté et du prix des médailles romaines, à Paris, tertu, imprimeur
de ll.AA.SS. monseigneur le duc d’Orléan et monseigneur le Prince de Condé.mionnet 18473 = t.e. mionnet, De la rareté et du prix des médailles romaines, voll. i-ii, à Paris.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”
280
møRChoLm 1982 = O. møRChoLm, The Attic Coin Standard in the Levant during the Hellenistic Period, in Studia Paulo Naster oblata, i, Numismatica Antiqua, a cura di S. SCheeRS, Orientalia lovaniensia Analecta, 12, leuven, pp. 139-149.
møRChoLm 1991 = O. møRChoLm, Early Hellenistic Coinage, Cambridge.neWeLL 1978 = e.t. neWeLL, The coinages of Demetrius Poliorcetes, Chicago.Nova Literaria 1700 = Nova Literaria Maris Balthici & Septentrionis, edita mense Majo, Lubecae, apud
iohannem Wiedemeyer, Bibliopolam, typis Cristoph. Gothofr. Jaegeri.ntantaLia 2001 = F. ntantaLia, Bronzemedaillons unter Konstantin dem Großen und seinen Söhnen.
Die Bildtypen der Constantinopolis und die kaiserliche Medaillonprägung von 330-363 n. Chr., Saarbrücken.
oLCay, SeyRiG 1965 = n. oLCay, h. SeyRiG, Le trésor de Mektepini en Phrygie, Paris.paRibeni 2008 = a. paRibeni, Teoderico in Italia centro-meridionale: fonti e testimonianze archeologiche,
in Rex Theodericus. Il Medaglione d’oro di Morro d’Alba, a cura di C. baRSanti, a. paRibeni e S. pedone, Roma, pp. 81-89.
pRiCe 1991 = m.J. pRiCe, The coinage in the name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus. A British Museum catalogue, zurich-london.
pRidik 1930 = e. pRidik, Neuerwebungen römischer Münzen im Münzkabinett der Ermitage, «zeitschrift für numismatik», 40, pp. 69-86 e tavv. 3-4.
puGLieSe CaRateLLi 1979 = G. puGLieSe CaRateLLi, L’imitatio Alexandri costantiniana, «Felix Ravenna», 118, pp. 81-91.
RamSkoLd 2011 = l. RamSkoLd, Coins and Medallions Struck for the Inauguration of Constantinopolis 11 May 330, «Ниш и Византија» («Niš and Byzantium»), 9, pp. 125-158.
RamSkoLd, LenSki 2012 = l. RamSkoLd, n. LenSki, Constantinople’s Dedication Medallions and the Maintenance of Civic Traditions, «numismatische zeitschrift», 119, pp. 31-58.
RIC = The Roman Imperial Coinage, i-X, london 1923-2007.RinaLdi tuFi 2005 = S. RinaLdi tuFi, La grande architettura fra Diocleziano e Costantino a Roma e nel
mondo romano, in Costantino il Grande 2005, pp. 92-105.RPC = Roman Provincial Coinage, voll. i-, london-Paris ecc. 1992-RuGGia 1998 = A. RuGGia, Recuperi ellenistici nelle monete celebrative dell’inaugurazione di
Costantinopoli (330 d.C.) e altre considerazioni, «Panorama numismatico», 125, pp. 19-24.SaCCoCCi c.s. = A. SaCCoCCi Rinvenimenti monetali nella Tuscia dell’alto medioevo: i flussi (secc. VI-X),
in corso di stampaSC = a. houGhton, C. LoRbeR, o. hooveR, Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue, parti i-ii, new
York-lancaster-london 2002-2008.SpeRLinG 1700a = O. SpeRLinG, otthonis Sperlingii, Consiliarii Regii & JCti, de Nummo CoNSTANTINI
MAXIMI rarissimo Dissertatiuncula, in Nova Literaria 1700, pp. 148-152 e tav. V, n. 1.SpeRLinG 1700b= O. SpeRLinG, Continuatio Dissertatiunculae otthonis Sperlingii, JCti & Consiliarii
Regii, de Nummo Constantini Maximi rarissimo, in Nova Literaria 1700, pp. 177-183.SpeRLinG 1717 = O. SpeRLinG, Thesaurus numismatum antiquorum a B. M. otthone Sperlingio J. H. D.
Sac. Reg. Maj. Dan. & Norv. Consiliario in Academia Equestri Hafniae quondam Professore & illustris Societatis Anglicanae Collega relictus, Cujus Auctio habebitur Hafniae in aedibus Christiani Reitzeri, Hamburgi die 12 Octobris Anni 1717.
SteRn 1953 = h. SteRn, Le Calendrier de 345. Étude sur son texte et sur ses illustrations, Paris.StRzyGoWSki 1893 = J. StRzyGoWSki, Die Tyche von Konstantinopel, «Analecta Graeciensia», pp. 141-
153.thompSon 1968 = m. thompSon, The mints of Lysimachus, in Essays in Greek Coinage presented
to Stanley Robinson, a cura di C.m. kRaay e G.k. JenkinS, Oxford, pp. 163-182 e tavv. 16-22.
touRatSoGLou 1995 = i. touRatSoGLou, Disiecta membra. Two New Hellenistic Hoards from Greece, Bibliotheca of the Hellenistic numismatic Society, 3, Athens.
toynbee 1947a = J.m.C. toynbee, Roma and Constantinopolis in Late-Antique Art from 312 to 365, «the Journal of Roman Studies», 37, pp. 135-144 e tavv. V-Xiii.
toynbee 1947b = J.m.C. toynbee, Ruler-Apotheosys in Ancient Rome, «the numismatic Chronicle», pp. 126-149.
toynbee 1953 = J.m.C. toynbee, Roma and Constantinopolis in Late-Antique Art from 365-to Justin II, in Studies presented to David Moor Robinson... on his seventieth birthday, ii, a cura di G.e. myLonaS e d. Raymond, Saint louis, pp. 261-277 e tavv. 64-65.
toynbee 1986 = J.m.C. toynbee, Roman Medallions, numismatic Studies, 5, new York.
miCHele ASOlAti
281
vaGi 1999 = d. l. vaGi, Coinage and History of the Roman Empire c. 82 B.C. - A.D. 480, voll. i-ii, Sidney (Ohio).
vöLkeL 1801 = l. vöLkeL, Beschreibung einer seltenen Silber-Münze von Constantin d. G. im Fürstl. Hessen-Casselischen Cabinet, Göttingae, bey Heinrich dieterich.
WaLteR 2006 = C. WaLteR, The Iconography of Constantine the Great, Emperor and Saint with associa-ted studies, leiden.
WeSteRmaRk 1961 = u. WeSteRmaRk, Das Bildnis des Philetairos von Pergamon. Corpus der Münzprägung, uppsala.
WiLLiamS 2012 = d. WiLLiamS, Ésprit-Marie Cousinéry (1747-1833), «international numismatic Council. Compe Rendu», 59, pp. 27-37.
WoLFRam 1967 = H. WoLFRam, Intitulatio, i, Lateinische Königs- und Fürstentitel bis zum Ende des 8. Jahrhunderts, mitteilungen des instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 21, Graz.
WRiGht 1987 = d.H. WRiGht, The true face of Constantine the Great, «dumbarton Oaks Papers», 41, pp. 493-507.
TRADIzIoNE ELLENISTICA NELLA MoNETA DI FLAVIo CoSTANTINo E PERSI STENzE “FLAVIE”