TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL'AMMIRAGLIO RUGGERO DI LAURIA
Transcript of TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL'AMMIRAGLIO RUGGERO DI LAURIA
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINIDELL’AMMIRAGLIO RUGGERO DI LAURIA (*)
Personaggio controverso ed apparentemente contraddittorio,Ruggero di Lauria (Regno di Sicilia 1245/1250 c.ca - Valénza 1305)è noto quale attore di primo piano della storia militare del Vesprosiciliano (1282-1302).
Già Helene Wieruszowski (1) e poi Alberto Boscolo (2), in rela-zione agli studi intesi ad illuminare gli antefatti del Vespro, lo indi-cavano tra gli esponenti di origine siciliana presenti alla corte arago-nese. Qui, il Lauria era giunto insieme alla madre, Bella Lancia d’A-michi o de Amicis (3), nel lontano 1262, in occasione delle nozze
(*) Questo breve saggio anticipa parte dei risultati della tesi di dottoratoRuggero di Lauria nel contesto del Mediterraneo bassomedievale, discussa pres-so la Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi della Basilicata nell’annoaccademico 2009/2010, nell’ambito del corso dottorale interuniversitario in Sto-ria dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea (XXIII ciclo),coordinatore prof. Aurelio Musi, tutor prof. Francesco Panarelli.
(1) H. WIERUSZOWSKI, La corte di Pietro d’Aragona e i precedenti dell’im-presa siciliana, «Archivio Storico Italiano», CVI, 1938, pp. 141-162 e 200-217(ma poi anche in EAD., Politics and Culture in Medieval Spain and Italy, Roma,Edizioni di storia e letteratura, 1971, pp. 187-222), nella fattispecie, pp. 148-151.
(2) A. BOSCOLO, L’eredità sveva di Pietro il Grande, re d’Aragona, in Lasocietà mediterranea all’epoca del Vespro, Atti dell’XI Congresso di Storia dellaCorona d’Aragona (Palermo-Trapani-Erice 23-30 aprile 1982), Accademia diScienze Lettere ed Arti, Palermo, Stampatori Tipolitografi Associati, 1983, 4voll., vol. 1, pp. 83-99, nello specifico, pp. 88-90.
(3) Bella è diminutivo di Isabella, per quanto la donna venga costante-mente indicata nella documentazione unicamente come “Bella”. Il cognome“Damichi” si trova in un diploma dell’Archivio della Corona d’Aragona di Bar-cellona (e, da ora, ACA), Real Cancilleria (e, da ora, RC), Reg. 19, f. 75v. Sulceppo dei De Amicis, si vedano L. SCIASCIA, Le donne e i cavalier, gli affanni egli agi. Famiglia e potere in Sicilia tra il XII e XIV secolo, Messina, Sicania, 1993,p. 44 e EAD., Nome e memoria: i De Amicis dalla conquista normanna al Vespro,in Puer Apuliae: mélanges offerts à Jean-Marie Martin, Édités par E. CUOZZO -V. DÉROCHE - A. PETERS-CUSTOT - V. PRIGENT, Paris, ACHCByz, 2008 (Mono-graphie, Centre de Reserche d’Histoire et civilitation de Byzance, 30), 2 vols.,vol. 2, pp. 615-622.
dell’infante Pietro con Costanza, figlia di Manfredi, re di Sicilia (4). Effettivamente, nei Registri dell’Infante successivi al 1262 – in
particolare, nei libri di conto di quest’ultimo –, i nomi di Bella e diRuggero risultano ricorrenti insieme a quelli di altri personaggi ecavalieri, non esclusivamente siciliani, quanto piuttosto catalano-ara-gonesi, che formano il seguito sia di Costanza (5), sia di Pietro (6).
Il rinnovo degli studi sul Vespro, in occasione del VII Centena-rio (1982), e la contestuale veicolazione della ricerca storica lungopiù promettenti ed interessanti percorsi d’indagine non hanno poidato luogo a ricerche ulteriori sulla figura di Ruggero.
Difatti, se si prescinde dal lemma di Andreas Kiesewetter per ilDizionario biografico degli Italiani (7), negli ultimi decenni l’Ammi-raglio del Vespro è stato consegnato o all’interesse esclusivo di unastoriografia municipalistica e polemica sia di parte lucana, sia diparte calabrese, protese a rivendicarne i natali, o ad una vulgata sto-riografica che, se ne rileva la fama conquistata sul campo, nondi-meno lega la stessa ad una coloritura negativa – quella cioè di unpersonaggio sanguinario ed efferato – quando non propriamenteall’accusa di tradimento, che a Ruggero veniva dunque mossa inspecial modo da parte siciliana, per il supposto cambiamento difronte nella quæstio Siculorum (8).
16 ROSANNA LAMBOGLIA
(4) Sul matrimonio tra Pietro e Costanza, si vedano L. PUGLISI, Le nozze diCostanza di Sicilia e Pietro II d’Aragona, «Archivio Storico Siciliano», III.10, 1959,pp. 199-214; D. GIRONA LLAGOSTERA, Mullerament de l’Infant En Pere de Cata-lunya ab Madona Costança de Sicilia, Barcelona 1920, utile soprattutto per l’ampiaappendice diplomatica che accompagna il saggio e, da ultimo, M. BRANTL, Studienzum Urkunden- und Kanzleiwesen König Manfreds von Sizilien (1250) 1258-1266,Inaugural Dissertation zu Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an derLudwig-Maximilians-Universität, München 1994, doc. 344, p. 397.
(5) Su Bella, si vedano ad esempio ACA, RC, Reg. 17, f. 113r; Reg. 18, f.72r (ma sul folio segnato 36v per via di una numerazione invertita); Reg. 28, ff.85v, 108r - 109r, 112v - 114r, 189r; Reg. 29, ff. 1r, 169r, ff. 188r - 188v [ma tra-scritto anche nella recente riedizione di F. SOLDEVILA, Pere el Gran. Primerapart: el Infant, a cura de M.T. FERRER MALLOL, Barcelona, Institut d’EstudisCatalans, 1995 (Memòries de la Secció històrico-arqueòlogica, LXVIII/1) doc.25, p. 455], 189r; Reg. 30, ff. 6v, 7v, 10v, 71v, 104v; Reg. 31, ff. 35v, 58r e 58rbis; Reg. 32, ff. 23v, 92r, 94r - 95r, 97v; Reg. 33, ff. 19v, 35r.
(6) Relativamente a Ruggero valgano esemplarmente le seguenti menzioniin ACA, RC, Reg. 33, ff. 8v, 20r, 53r-53v (parzialmente trascritto in SOLDEVILA,Pere el Gran. Primera part: el Infant, p. 291n), 62v; Reg. 34, f. 1r, 5v, 7r-7v, 36r,52r, 64v, 66r, 83r, ma oltre a quelle qui indicate chi scrive ha individuato altresettanta referenze di questo tipo comprese nei Regg. 33-37.
(7) A. KIESEWETTER (a cura di), Lauria, Ruggero di, in Dizionario biograficodegli Italiani (e da ora DBI), 64, 2005, pp. 98-103.
(8) Si rimanda, per tutti i riferimenti bibliografici del caso, a R. LAMBO-
Del resto, lo stesso Kiesewetter già anni addietro aveva finitocol lamentare la mancanza, nel panorama degli studi medievisti-ci, di una monografia critica sul Lauria (9) e tanto più a ragione,quanto maggiore sembrava essere, nello stesso torno di anni, ilritorno d’interesse di alcuni settori della storiografia italiana percondottieri ed uomini in arme (10).
A proposito del Lauria, era poi nondimeno difficile sovvertireuna tendenza generale che inquadrava il personaggio negli scom-partimenti stagni della storia militare o dell’ambito enciclopedico e,dunque, con ciò avere un riscontro diverso e differente da quelloche si poteva trovare in singoli saggi di qualificata storia militare, inlemmi di dizionari, in articoli di giornale e di riviste tematiche, oancora in profili telematici di valore vario ed opinabile.
Non meno ardua risultava parimenti essere la ricerca intesa afar emergere i legami familiari e territoriali del Lauria, conside-rando che occorreva districare e confrontare quanto anche gli sto-rici del Regno di Napoli ed i genealogisti cinque-seicenteschi com-posero e variamente riuscirono a mettere insieme su Ruggero, inuna temperie culturale cioè che, tra Cinque e Seicento, in Italia,faceva «della Storia (…) un culto diffuso» (11).
Un culto, questo, della storia, che se nei primi – gli storici delRegno –, dalla «fervorosa perlustrazione del passato locale (vicendetrascorse di questa o quella città d’Italia)», si estendeva largamente«alla investigazione delle cose dell’intera penisola, e anche dei paesistranieri» (12), nei secondi – i genealogisti – trovava altra e diffe-rente risposta, su un altro terreno e con altri strumenti, alle mede-sime esigenze alle quali intendevano prospettare soluzione le Istorie.
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 17
GLIA, Sedimentazioni storiografiche a proposito della figura dell’ammiraglio Rug-gero di Lauria, «LEUKANIKÀ. Rivista lucana di varia cultura», VII.4, 2007, pp.44-50.
(9) A. KIESEWETTER, Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard vonParma und Robert II. von Artois im Königreich Neapel 1285 bis 1289, in For-schungen zur Reichs-, Papst- und Landegeschichte. Peter Herde zum 65. Geburt-stag von Freuden, Schülern und Kollegen dargebracht, Hg. von K. BORCHARDT undE. BÜNZ, Stuttgart, A. Hiesermann, 1998, 2 Teile, Teil 1, p. 489, nota n. 60.
(10) Si veda, da ultimo, Condottieri e uomini d’arme nell’Italia del Rinasci-mento, a cura e con un saggio introduttivo di M. DEL TREPPO, Napoli, Liguori,2001 (Europa Mediterranea, GISEM, Quaderni, 18).
(11) R. DE MATTEI, Storia e politica in Italia tra il Cinque e Seicento, in Sto-riografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè Theseider, Roma, BulzoniEditore, 1974, 2 voll., vol. 2, pp. 867-878, qui, p. 867.
(12) DE MATTEI, Storia e politica in Italia tra il Cinque e Seicento, p. 868.
Più di queste, le storie genealogiche sembravano infatti benvalere a determinare un diritto di preminenza dei ceti nobiliari delRegno sulla base alle aristocrazie di sangue di più lontana e sicuraascendenza, al fine di rivendicare a queste un proprio ruolo, vinco-landolo alla nobiltà di schiatta all’interno di un medesimo contestonobiliare, che avvertiva invece come minacciosi gli elementi di re-cente nobiltà (la nobiltà di seggio) (13).
Indubbiamente, molti di questi Autori – come, ad esempio,Angelo Di Costanzo (14), Scipione Ammirato (15), Carlo de Lel-
18 ROSANNA LAMBOGLIA
(13) In proposito, si veda soprattutto G. MASI, Dal Collenuccio a TommasoCosto: vicende della storiografia napoletana fra Cinque e Seicento, Napoli, Edito-riale Scientifica, 1999 e, da ultimo, Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regnidi Napoli e di Sicilia in età moderna, a cura di A. LERRA, Manduria-Bari-Roma,Piero Lacaita Editore, 2004 (Europa Mediterranea, 6) e all’interno particolar-mente i saggi di A. MUSI, Storie “nazionali e storie locali”, pp. 13-26, di A.L.SANNINO, Le storie genealogiche, pp. 109-159 e di G. CIRILLO, “Generi” contami-nati. Il paradigma delle storie feudali cittadine, pp. 165-169.
(14) A. DI COSTANZO, Istoria del Regno di Napoli, Napoli-L’Aquila, 1572-1582, 5 voll. (si cita però dall’edizione di Milano, Società tipografica dei Clas-sici italiani, 1805, 3 voll.). L’opera venne pubblicata in due parti, inizialmentecome Dell’istorie della sua Patria del Signor Angelo di Costanzo gentil’uomonapolitano. Parte prima, In Napoli Appresso Mattio Cancer, 1572, VIII libri epoi, riveduta ed ampliata, fino a XX libri, nel 1581-1582, presso la stamperiaCacchi dell’Aquila. Sul Di Costanzo, già C. MINIERI RICCIO, Memorie storichedegli scrittori nati nel Regno di Napoli, Napoli, Tipografia dell’Aquila, 1844 (orain ristampa anastatica, Sala Bolognese, A. Forni Editore, 1990), pp. 109-110, daultimo però si rinvia a Di Costanzo, Angelo, a cura di P. FARENGA, in DBI, 39,1991, pp. 742-747. Sulla storiografia del Di Costanzo, si rinvia ai recenti inter-venti su problemi specifici di G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Società e culturadel Mezzogiorno moderno, in Storia d’Italia, vol. XV, tomo VI, Torino, UTET,20112 (1a ed. 2010), pp. 1035-1039 e ID., L’immagine della nobiltà napoletananella «Istoria» di Angelo di Costanzo, in Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo.Studi in onore di M. Del Treppo, a cura di G. ROSSETTI e G. VITOLO, 2 voll, vol.2, Napoli, Liguori Editore, 2000, pp. 189-198 [ma anche come ID., L’image dela noblesse chez les historiens napolitains du XVIe siécle, in La noblesse dans lesTerritoires angevins à la fin du Moyen Âge, Actes du colloque internationalorganisé par L’Université d’Angers. Angers-Saumur, 3-6 juin 1998, sous ladirection de et réunis par N. COULET et J.-M. MATZ, Rome, École française deRome, 2000 (Collection de l’École française de Rome, 275), pp. 737-747]. Piùin generale, invece, si vedano i precedenti studi di E. FUETER, Storia della sto-riografia moderna, trad. di A. SPINELLI, Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1944(1a ed. or. E. FUETER, Geschichte der neueren Historiographie, München-Berlin,Druck und Verlag von R. Oldenbourg, 1911), 2 voll., vol. 1, p. 148; E. COCH-RANE, Historians and Historiography in the Italian Reinassance, Chicago andLondon, The University of Chicago Press, 1981, pp. 272-275; R. COLAPIETRA,La storiografia napoletana del secondo Cinquecento, I, «Belfagor», XV, 1960, n.
lis (16) – non erano nuovi alla considerazione delle corrispondenzediplomatiche, almeno nella misura in cui erano accessibili, lungoquella linea che, da Guicciardini a Flavio Biondo e agli altri storicifiorentini, aveva principiato a considerare la documentazione archi-vistica come fonte storica, in concomitanza degli stimoli e dei fervoriculturali che venivano dagli studi del Valla e dagli altri umanisti.
Molte però erano, a proposito del Lauria, le imprecisioni cheveicolava questa storiografia e per la quale deponevano a favore leattenuanti che il napoletano Giovan Antonio Summonte (17) evi-
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 19
3, pp. 415-436, continuato poi ancora su «Belfagor», XVI, 1961, n. 3, pp. 416-431 e, quindi, ristampato in ID., Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di storiaMeridionale nell’età moderna, Salerno, Edizioni Beta, 1972-1973 (edizione dacui si cita), pp. 61-121, e segnatamente, sul Di Costanzo, pp. 96-112.
(15) L’Ammirato citava Ruggero unicamente in riferimento alla discen-denza del Lauria nell’opera genealogica Delle famiglie nobili napoletane di Sci-pione Ammirato parte prima, le quali per leuar’ogni gara di precedenza sono stateposte in confuso, In Fiorenza, appresso Giorgio Marescotti, 1580, la cui secondaparte fu pubblicata ancora con lo stesso titolo Delle famiglie nobili napoletanedi Scipione Ammirato. Parte seconda. Poste in confuso con due tauole, In Firenze,per Amadore Massi da Furlì, 1651, ma da Scipione Ammirato il Giovane (oraentrambe, in ristampa anastatica, come S. AMMIRATO, Delle famiglie nobili napo-letane, Sala Bolognese, Forni Editore, 1973, 2 voll.), Parte Prima, p. 9; Parteseconda, pp. 184, 312 e 376. Sull’Ammirato, si veda Ammirato, Scipione, a curadi R. DE MATTEI, in DBI, 3, 1961, pp. 1-4.
(16) Come l’Ammirato, anche Carlo de Lellis menzionava Ruggero in rela-zione ai vari rami della discendenza, essendo l’interesse del Napoletano nonvolto prioritariamente al Lauria, quanto alla possibilità di far discendere dallacasata eredi che potessero vantare patenti di nobiltà d’antico lignaggio, tra lepiù vetuste famiglie del Regno. Cfr. C. DE LELLIS, Discorsi delle famiglie nobilidel Regno di Napoli, Napoli 1654-1671, 3 Parti (attualmente in ristampa ana-statica come ID., Famiglie nobili del Regno di Napoli, Sala Bolognese, ArnaldoForni Editore, 2003, 3 parti), Parte I, pp. 122 e 309, Parte II, p. 174, Parte III,pp. 149, 150 e 340. La quarta parte fu stampata postuma come Discorsi postumidel Signor Carlo De Lellis di alcune poche nobili famiglie, con l’Annotationi inesse, e Supplemento di altri Discorsi Genealogici di Famiglie Nobili della Città, edel Regno di Napoli, del dottor dignor Domenico Conforto, In Napoli, nellaStamparia di Antonio Gramignani, 1701 (ora, in ristampa anastatica come ID.,Famiglie nobili della città e Regno di Napoli, Sala Bolognese, Arnaldo ForniEditore, 1977), nella quale però solamente la trattazione di quattro famiglierisale al De Lellis, le rimanenti sono del Conforto. Sul De Lellis, si veda M.CERESA, De Lellis, Carlo, in DBI, 36, 1988, pp. 502-504.
(17) Sul Summonte, già un’insolitamente ampia voce di F. SORIA, Memoriestorico critiche degli storici napoletani, Napoli, Stamperia Simoniana, 1781-1782(ma ristampa anastatica, Sala Bolognese, Forni Editore, 1967), 3 t., t. II, pp.570-576 e MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittori, p. 340 ed una Vita diGiannantonio Summonte scritta da Scipione Di Cristoforo prete napoletano era
denziò proprio sul nostro personaggio, ovvero la penuria di notizieche concernevano Ruggero e l’impegno che egli vi aveva nondi-meno profuso per rintracciarle (18).
A voler infatti prestar fede al Summonte, Ruggero di Lauria –nominato dell’Oria secondo un ricamo ortografico che può ragione-volmente ritenersi una libera, quanto originale iniziativa summon-tiana (19) – si sarebbe precocemente ribellato a Carlo I d’Angiò, inseguito all’uccisione del padre. Questa ribellione sarebbe altresì dapresupporre insieme ad una residenzialità del Lauria nel Regno,poiché successivamente ad essa il Nostro si costituirebbe, per il tra-mite di Giovanni da Procida, tra gli affiliati di re Pietro, già III d’A-ragona, il quale lo investe del ruolo di ammiraglio e lo pone a capodella sua armata (20).
20 ROSANNA LAMBOGLIA
posta a corredo del primo tomo della Historia della città e Regno di Napoli. Ovesi trattano le cose piu notabili accadute dalla sua edificazione fin’a tempi nostri.Con l’origine, sito, forma, religione (...) oltre gli imperadori greci, duchi (...) conle gesta, e vite de’ suoi re (...) di Gio. Antonio Summonte napoletano (…) TomoPrimo dedicato all’eccellentissima città di Napoli, In Napoli, a spese di RaffaelloGessari, nella stamperia di Domenico Vivenzio, 1748, pp. 1-70. Recente è peròl’articolo di S. DI FRANCO, Giovanni Antonio Summonte: linee per una biografia,«Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXII, 2004 (ma stampa2005), pp. 67-165.
(18) L’opera di revisione e di pesante manipolazione a cui fu indotto ilSummonte già pubblicati i primi due tomi, e che non gli valsero né a tutelarlodalla condanna penale, né a scampare nuove messe all’indice dell’Historia,resero particolarmente complessa la vicenda editoriale di una storia suddivisa inparti – le cui prime due videro la luce a Napoli nel 1601-1602, presso la stam-peria di Giovanni Giacomo Carlino e facevano giungere la narrazione fino al1442; la terza fu stampata postuma, nel 1640, ancora a Napoli, per DomenicoMontanaro, e continuava le vicende fino al 1500; quindi, la quarta ed ultimaparte fu edita nuovamente per il Montanaro tre anni dopo, e si arrestava al1582. Qui, come nei luoghi a seguire, si cita tuttavia dall’edizione Dell’Historiadella città, e Regno di Napoli di Gio. Antonio Summonte napolitano (…), Se-conda editione, In Napoli, a spese di Antonio Bulifon Libraro all’insegna della Sirena, 1675, 4 tomi, t. II, l. III, pp. 294-295.
(19) La forma ortografica dell’Oria non si riscontra infatti nella storiogra-fia precedente al Summonte, sebbene numerose siano le oscillazoni dell’onoma-stica relativa al “cognome” Lauria.
(20) Si trascrive per intero il passo summontiano: «In questo mentre il Rè[sic] Pietro, che del mese di Luglio similme[n]te era partito di Catalogna conl’armata, la quale era di cinquanta Galere armate d’ottocento Cavalieri, & altrimolti Legni di carrico [sic], della quale he havea costituito Ammiraglio MesserRuggiero dell’Oria, valente Cavaliere di Calabria (così scri[ve]ne il Villaniribello del Rè Carlo, e per dar’io notizia di questo valoroso soldato hò [sic] fati-gato un pezzo per ritrovar la sua Patria, e la causa della sua ribellione, la Patrianisciun Scrittore la nomina salvo che Prospero Parisio, in quella sua dotta tipo-
Stando ancora al racconto summontiano, Ruggero sarebbe statoun gran Signore di Sicilia, e nel Regno di Napoli, possedendo molteterre particolamente Terranova (21). Nondimeno, precedentementeai fatti del Vespro ed ancora presumibilmente di stanza nel Regno,fin da giovane, egli avrebbe avuto delle galee proprie con le qualipoi avrebbe militato in Grecia (…) contr’il Paleologo e che con ciòsi fosse acquistato fama e nomea, nelle battaglie navali. Proprioquesta fama sarebbe stata quindi oltraggiata da Carlo, quando que-sti pose un genovese – Arrighino de’ Mari – e non lui alla testadella flotta angioina, per la qual cosa poi il Lauria sarebbe passatoal servizio di re Pietro, il quale, a sua volta, per ingraziarselo, gliavrebbe conferito proprio quella dignità – l’ammiragliato –, negata-gli da Carlo.
In realtà, il Summonte, realizzando un’opera destinata «a di-ventare la più autorevole e compiuta rappresentazione della vita,della fede religiosa, della crescita urbana, della “civiltà” dellagrande capitale» (22), ripeteva sull’Ammiraglio le imprecise notizie
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 21
grafia [sic] di Calabria, ove che egli fu Cosentino, il Collenuccio quinto Scrit-tore delle cose del Regno, non ne dice altro se non quello che il Villani, e loloda chiamandolo huom’espertissimo, animoso e prudente sopra tutti i Capitanidel mare di quei tempi, il Maurolico Scrittor delle cose di Sicilia nel 4. lib.chiama Ruggiero Calabrese, Cui Galli Patrem interfecerant, & accenna tacita-mente che per aver li Franzesi ammazzato il Padre havesse abbandonato Carloe preso le parti del Rè Pietro, poiche [sic] lo và à [sic] ritrovar fin’à Catalogna,dove da quello è costituito Ammiraglio della sua Armata; scrive il Costanzo,ch’era Ruggiero gran Signore di Sicilia, e nel Regno di Napoli, possedea mol-te terre particolamente Terranova, e da gioventù avea tenuto in mare alcuneGalere proprie, con le quali militando in Grecia, à defensione de Despoti, con-tr’il Paleologo, havea fatto molt’honorate imprese, e s’avea acquistato grannome nella militia [sic] marittima, e disdegnato, che Carlo havesse prepostoArrighino de’ Mari Genovese à lui, e fattolo General della sua armata, egli permezo [sic] di Giovannni di Procida era divenuto fautor del re Pietro, il qualeper farselo benevolo, l’haveva conferita la dignità che Carlo l’havea denegato(…)», in SUMMONTE, Dell’Historia della città, e Regno di Napoli, t. II, l. III, pp.294-295.
(21) Una Terranuova di Aita, insieme a Lauria (PZ), Tortora (CS), Lago-negro (PZ) ed altre terre, riferisce anche G. SAMBIASI, Ragguaglio di Cosenza edi trent’una sue nobili famiglie, Sala Bolognese, Forni Editore, 1969 (ristampaanastatica della 1a ed. Ragguaglio di Cosenza, Ragguaglio di Cosenza e di tren-t’una sue nobili famiglie. Scritto dal molto rev. P. maestro fra Girolamo Sambiasicosentino (...) Coll’aiuto delle scritture del signor Pier Vincenzo Sambiasi cavaliercosentino, In Napoli, per la vedova di Lazaro [tip.], 1639), p. 94, con possibileconfusione tra le due diverse località cosentine, Terranova (feudo) e Aieta.
(22) GIARRIZZO, Erudizione storiografica, pp. 545-547. Sull’opera del Sum-
che già furono del Di Costanzo (23), e prima di lui quelle più veraci
22 ROSANNA LAMBOGLIA
monte, già COCHRANE, Historians and Historiography in the Italian Reinassance,pp. 285 e 290-292, poi R. SIRRI, Di Gio. Antonio Summonte e della sua “Histo-ria”, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXXVIII, 1971, pp.7-24 e, da ultimo, G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo(1494-1622), in Storia d’Italia, diretta da G. GALASSO, vol. XV, tomo II, Torino,UTET, 2005, pp. 547-551 e ID., Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzo-giorno moderno, pp. 1044-1047. Hanno però rinnovato l’interesse di studio peril Summonte anche due recenti tesi di dottorato di A. D’ANDRIA, Roma e la tra-dizione classica nell’esperienza storiografica di Giovanni Antonio Summonte, di-scussa presso l’Università degli Studi della Basilicata, il 30 marzo 2005 (XVIIciclo), pp. 43-80 e S. DI FRANCO, Giovanni Antonio Summonte riforma dell’E-letto e difesa dell’autonomia napoletana, discussa ancora presso l’Universitàdegli Studi della Basilicata, anno accademico 2005/2006 (XIX ciclo), Cap. I -Note per una biografia politica, pp. 1-83, Cap. III - La fortuna dell’opera, pp.281-315. Si vedano anche i successivi contributi del DI FRANCO (supra, nota n.17) e di A. D’ANDRIA, Storia della città, storia del potere. Note sulla struttura“politica” dell’«Historia della Città e Regno di Napoli» di Giovanni AntonioSummonte, in «Bollettino Storico della Basilicata, XX.20, 2004, pp. 253-266 eID., “Optimus princeps. Federico II e Carlo V nella «Historia della Città e Regnodi Napoli di Giovanni Antonio Summonte, in «Bollettino Storico della Basili-cata», XXIII.23, 2007, pp. 307-321.
(23) Si confronti il seguente testo del Summonte: «Ritornando hora aCarlo Martello primogenito del Rè [sic] già coronato del Regno D’Ungaria,have[n]do co[n]cluso il matrimonio co[n] la figliuola di Ridolfo Imperatore(come si fè menzione) al ritorno del padre da Roma se ne passò in Germania(come segue il Costanzo) co[n] grandissima compagnia de Baroni, e Cavalieri,ove celebrare le nozze, se ne andò in Ungaria, e benche [sic] conducesse secomolte forze, non perciò hebbe tutto quel Regno, perche [sic] mentre Andreasuo aversario visse, sempre ne tenn’occupata una parte, pur da suoi parteggiani[sic] fu accolto con real pompa, e co[n] grandissima amorevolezza; partitoCarlo Martello da Napoli il Rè [Carlo II d’Angiò] suo padre per mantenersiRuggiero dell’Oria in fede li co[n]cedette gra[n] Privilegij donandogli terre inCalabria con il privilegio del co[n]tado di Co[n]sentanea in Sicilia, & ordinòalli governatori delle Provincie, che ubedissero à [sic] gli ordini suoi per l’ap-parecchio dell’armata; onde segue il Villani nel suddetto capo, che saputo dalRè Federico qua[n]to si faceva, tolse à Ruggiero tolse tutte le rendite & honori,c’haveva in Sicilia dichiarandolo ribello (secondo il Costanzo) & à Giovannisuo nepote, imponendoli [sic] tradimento fè troncar la testa», in SUMMONTE,Dell’Historia della città, e Regno di Napoli, t. II, l. IV, pp. 340-341, con il pre-cedente paragrafo del Di Costanzo: «Ma tornando a Re Carlo, subito ch’eigiunse in Napoli, fe’ grandisssimi privilegi ed onore a Ruggiero di Loria, alquale non solo restituì tutte le Terre antiche sue in Calabria, in Basilicata ed inPrincipato, ma glie (sic) ne donò molte altre, e gli fe’ anco privilegio del Con-tado di Consentanea in Sicilia, che gli fu dimandato da lui; ordinò ancora a tuttii Governatori di Provincie (sic), ed altri officiali, ch’ubbidissero agli ordini diRuggiero per l’apparecchio dell’armata», in DI COSTANZO, Istoria del Regno diNapoli, l. III, pp. 189-190.
del Fazello (24) e del Maurolico (25), costituendosi il Summonteemulo amplificatore, nel positivo, come nel negativo, dei predecessori.
In proposito, già si è avuto modo di anticipare nell’introdurrela figura di Ruggero, come il riscontro delle fonti primarie – in par-ticolare, le fonti d’archivio, piuttosto che gli accenni isolati nellecronache a riguardo (infra) – smentisca buona parte del raccontosummontiano che, in ultimo, si rivela essere una stratificazione d’in-formazioni derivate da altri autori.
Nondimeno si comprende altrettanto bene come la veicolazionedi queste notizie non infici il valore intrinseco di queste Storie diRegno. Per esempio quello del Costanzo sarà un testo cruciale ed unmodello strutturale per le sorti della storiografia napoletana fra Cin-que e Seicento (26) e a questa si rifarà ampiamente – come s’è visto
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 23
(24) T. FAZELLO, Storia di Sicilia, presentazione di M. GANCI, introduzione,traduzione e note di A. DE ROSALIA e G. NUZZO, Palermo, Regione siciliana,Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 1990, 2voll. (1a ed. or. F. THOMAE FAZELLI SICULI (...) De rebus Siculis decades duae, nuncprimum in lucem editae. His accessit totius operis index locupletissimus, Pa-normi, apud Ioannem Matthæum Maidam, et Franciscum Carraram, 1558, ora in ristampa anastatica, Palermo, Oftes, 2006), cui seguirono numerose edi-zioni presso vari stampatori e traduzioni (cfr. Della storia di Sicilia Deche due.Del R. P. M. Tommmaso Fazello Siciliano tradotte in lingua toscana dal P. M.Remigio fiorentino, Palermo, dalla Tipografia di Giuseppe Assenzio, 1817, 3tomi). Sul Fazello, si vedano, da ultimo, R. CONTARINO, Fazello, Tommaso, inDBI, 45, 1995, pp. 493-496 e Convegno di studi in onore di Tommaso Fazello peril quinto centenario della nascita, Sciacca, Chiesa di Santa Margherita, 12 e 13dicembre 1998, a cura di N. ALLEGRO, Sciacca, Aulino, 2003; sulle fonti, si rin-via invece a S. SCOPELLITI, Le fonti del “De rebus Siculis” di Tommaso Fazello perl’età normanna. (Metodologia di ricerca di uno storico del XVI sec.), in Scritti inmemoria di Pasquale Morabito, a cura di P. SANTORO, La Grafica, Messina 1983,pp. 455-492.
(25) Sicanicarum rerum compendium Maurolyco abbate Siculo authore,Messanae in freto Siculo, impressit Petrus Spira (…), 1562, l. IV, p. 137. Sullefonti e la storiografia del Maurolico, si veda V. LABATE, Le fonti del “Sicanicarumrerum compendium” di Francesco Maurolico, Tipografia D’Amico, Messina 1898e, da ultimo, Miscellanea in onore di Francesco Maurolico nel quinto centenariodella nascita (1494-1575), Messina, EDAS, 1994. Sul Maurolico, invece sivedano R. MOSCHEO, Maurolico, Francesco, in DBI, 72, 2009, pp. 404-411; ID.,Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana, Messina, Società Mes-sinese di Storia Patria, 1988 e ID., Mecenatismo e scienza nella Sicilia del ‘500. IVentimiglia di Geraci ed il matematico Francesco Maurolico, Messina, SocietàMessinese di Storia Patria, 1990 (ma stampa 1991) e M. PAVONE, Saggio criticosulle opere di Francesco Maurolico, Ragusa, Centro studi Feliciano Rossitto,1987 (poi, in ristampa, anche presso Leggio e Diquattro, 1988).
(26) Per i temini generali della storiografia napoletana si veda, da ultimo,A. LERRA, Un genere di lunga durata: le descrizioni del Regno di Napoli, in Il
– anche il Summonte per la sua Historia della Città e Regno diNapoli; un’opera cioè che, negli intenti, si qualificava come «moltopiù ambiziosa di tutte le precedenti» e «senz’altro più ricca di parti-colari originali e munita di tutti gli optionals paratestuali» (27).
Tuttavia il problema sussiste, in quanto a leggere le opere delCostanzo e del Summonte furono in molti e ad esse si rifeceroquanti cercavano notizie anche su Ruggero ed il suo status; né,come problema, è di secondo momento se esso si ripropone ancoraoggi, qualora s’intenda affrontare il discorso dei legami territoriali edel ceppo familiare del Lauria.
In tal caso, occorre sgombrare il campo da tutte quelle incro-stazioni e superfetazioni che debbono molto più alla tradizionesulle fonti, che non alle fonti stesse, ma delle quali è necessario tut-tavia dar conto, secondo ciò che Jacques Le Goff definiva propria-mente «obbligo di erudizione» dello studioso che vuole essereanche biografo (28). Esse infatti costituiscono, al medesimo tempo,una risorsa ed una complicazione.
1. Falsi problemi sulla territorialità cui il nome dei Lauria si lega.
«Lo dit senyor infant En Pere havia en casa sua dos fills de cavallersqui eren venguts ab madona la reina Costança muller sua, e la u havia nomEn Roger de Lòria, qui era de honorat llinatge de senyors de senyeres; e samare havia nom madona Bella, qui nodrí la dita reina madona Costança, eab ella vene en Catalunya, e era molt sàvia dona e bona, e no es partí nulltemps, mentre fo viva, de madona la reina; e així mateix lo fill, que haviaper nom Roger de Lòria, no es partí d’ella ans nodrí en la cort: així que ellera molt fadrí con venc en Catalunya. (…) E el dit En Roger de Lòria ja enaquest temps fo creegut e fo gran e aut a feïa’s molt amar al senyor infante a madona la reina e a tots» (29).
24 ROSANNA LAMBOGLIA
libro e la piazza, pp. 27-50 e tra alcuni interventi precedenti anche S. BERTELLI,Storiografi, eruditi antiquari e politici, in Storia della letteratura italiana. Vol. V.Il Seicento, Milano, Garzanti, 1967, pp. 376-386, ma segnatamente, sul DiCostanzo, pp. 379-381, sul Summonte, pp. 381-383; T. PEDIO, Storia della sto-riografia del Regno di Napoli nei secoli XVI e XVII (Note ed appunti), Chiara-valle Centrale, Frama Sud, 1973. Sulla storiografia napoletana cinquecentesca,sempre utile, soprattutto per gli storici cosiddetti minori, risulta il saggio diCOLAPIETRA, La storiografia napoletana del secondo Cinquecento, pp. 66-96 e110-123.
(27) MASI, Dal Collenuccio a Tommaso Costo: vicende della storiografianapoletana fra Cinque e Seicento, pp. 201-202.
(28) J. LE GOFF, Storia e Memoria, Torino, Einaudi, 1982, p. XI.(29) MUNTANER, Crònica, in JAUME I - B. DESCLOT - R. MUNTANER - PERE
III, Les quatre grans cròniques, revisió del text, pròlegs i notes per F. SOLDEVILA,
Secondo il resoconto di Ramon Muntaner, il legame di Ruggerocon il Regno di Sicilia sembra non sussistere già da oltre una die-cina d’anni, fin cioè dal 1262, avendo il Lauria almeno con unasorella, Margherita (30), seguito – molto probabilmente a ragionedella giovane età dei due – la madre, presso la corte aragonese. Edè un legame, quello di Bella con la regina Costanza (31), moltostretto, attestato tanto dalle fonti cronachistiche, quanto dagli stes-si documenti archivistici aragonesi, i quali designano Bella comedama di rango, attribuendole il titolo di “madonna” (32), di “dama”(33) o di “doña” (34).
Problematico invece è il legame di Bella con il clan dei Lanciaper via dei rapporti non sempre definiti di quest’ultimi (35), e per
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 25
Barcelona, Editorial Selecta, 1971, cap. XVIII, p. 682. Per quanto il testo cata-lano sia abbastanza comprensibile, si seguita tuttavia la traduzione a cura di chiscrive: «Detto signore, infante don Pietro, aveva nel suo palazzo due figli dicavalieri che erano venuti con la regina donna Costanza sua moglie, e uno, cheera di onorato lignaggio di signori di bandiere, aveva nome don Ruggero diLauria; e sua madre chiamavasi Bella, la quale educò la detta regina, donnaCostanza, e con lei era venuta in Catalogna, ed era donna molto saggia e buona,e non si allontanò mai, finché fu viva, dalla regina; e così il figlio stesso, cheaveva nome di Ruggero di Lauria, non si allontanò da lei prima che fosse edu-cato a corte: poiché egli era molto giovane quando era venuto in Catalogna.(…) E il detto don Ruggero di Lauria già durante questi tempi fu allevato edivenne adulto e fu molto amato dal signore infante e dalla regina e da tutti [acorte]».
(30) ACA, RC, Reg. 35, f. 45v.(31) Tanto nelle cronache catalane, quanto nei documenti archivistici,
Costanza è indicata, ancora prima dell’avvento al trono aragonese, come regina.Tale singolarità già sottolineava la WIERUSZOWSKI, La corte di Pietro d’Aragona ei precedenti dell’impresa siciliana, p. 144, che spiegava come dunque Costanzafosse a tutti gli effetti considerata, a corte, regina in pectore in ragione della ere-dità sveva di Manfredi. È bene però tenere presente che la pratica archivisticaregistri Costanza anche come “infanta”, sia pure in forme non ricorsive (cfr.ACA, RC, Reg. 29, f. 189r). Forte è invece sulla base dell’argomentazione dellarivendicazione dell’eredità sveva il medesimo appellativo di regina nei cronistiMuntaner e Desclot. Pertanto, in questa sede, si continuerà a designare Co-stanza come regina anche per il periodo interinale, antecedente all’incorona-zione aragonese, che darà alla donna sanzione formale di regalità.
(32) ACA, RC, Reg. 28, f. 189r.(33) ACA, RC, Reg. 13, f. 254r. (34) ACA, RC, Reg. 16, f. 211r.(35) PISPISA, Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, Messina,
Sicania, 1991, p. 13. Il doppio cognome Lancia-d’Agliano, col quale sovente èindicata Bianca da un lato, e i dati non sempre coincidenti dei cronisti dall’al-tro hanno dato luogo a non pochi equivoci circa la genealogia dell’amante del-l’imperatore Federico; nondimeno, su questo tema si veda, ora, la disamina di
il quale occorre necessariamente risalire almeno a Bianca, amantedell’imperatore Federico II, sposata pare poi in punto di morte, emadre dell’“illegittimo” Manfredi, secondo una ben attestata tradi-zione archivistica (36), prima ancora che da una vulgata letteraria,diffusa da Dante in poi.
Bianca era infatti legata al clan piemontese dei Lancia per viamaterna – nella fattispecie, Manfredi I Lancia (il Vecchio) ne fu ilnonno e Manfredi II Lancia lo zio (37) – e derivava il secondocognome – d’Agliano – dal matrimonio che la madre contrasse conun signore d’Agliano nel primo decennio del XIII secolo; tra il1226 ed il 1230, poi passò con la madre e con tutti i parenti pie-montesi nel Regno di Sicilia a seguito del rapporto che ormai legavaManfredi II Lancia all’Imperatore (38).
Bella seguiva di una generazione ed era ancora legata al clanLancia – sembrerebbe – mediante uno dei rami cadetti – i Lanciade Amicis – la cui vicinanza alla casa sveva era già da lungo corsodeterminata, se un suo fratello pare essere stato Ruggero de Amicis,vale a dire uno dei più fedeli burocrati al servizio di Federico II enondimeno, successivamente da questi esiliato insieme ad un suoconsanguineo, Guglielmo: tanto il primo, quanto il secondo sareb-bero stati discendenti di un conte de Amico, cantato da Guglielmodi Puglia (39) come compagno del Guiscardo e di Ruggero d’Alta-villa, e capostipite di una longeva e vigorosa dinastia feudale, cuiafferivano non solo i discendenti di Guglielmo de Amicis, ma anchei conti di Giovinazzo (40).
26 ROSANNA LAMBOGLIA
N. FERRO, Chi fu Bianca Lancia di Agliano, in Bianca Lancia D’Agliano. Fra ilPiemonte e il Regno di Sicilia, Atti del Convegno (Asti-Agliano, 28/29 aprile1990), a cura di R. BORDONE, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1992, pp. 55-80.
(36) In proposito, denunciano già una lettera di papa Urbano IV del 26aprile 1262 e il pronunciamento di papa Clemente IV del 18 novembre 1266,entrambi citati in FERRO, Chi fu Bianca Lancia di Agliano, pp. 55-56.
(37) Sui Lancia piemontesi, si rinvia al vecchio e ancor valido studio di C.MERKEL, Manfredi I e Manfredi II Lancia. Contributo alla storia politica e lette-raria italiana nell’epoca sveva, Torino, E. Loescher, 1886; ma si vedano, daultimo, gli atti del recente convegno di Asti-Agliano, 28/29 aprile 1990, BiancaLancia D’Agliano. Fra il Piemonte e il Regno di Sicilia (supra).
(38) Per le discrepanze tra le genealogie relative a Bianca, cfr., in propo-sito, i due alberi genealogici ancora in FERRO, Chi fu Bianca Lancia di Agliano,p. 80. Sulla figura di Bianca, si veda altresì la successiva voce di R. BORDONE (acura di), Bianca Lancia, in Enciclopedia Fridericiana (EF), Roma, Istituto dellaEnciclopedia Italiana, 2002, 3 voll., vol. 1, pp. 174-176.
(39) Sul cronista, cfr. M. FUIANO, Guglielmo di Puglia, in ID., Studi di sto-riografia medievale ed umanistica, Napoli, Giannini Editore, 1975, pp. 1-103.
(40) Tale genealogia è stata ricostruita, per altro contesto ed altre circo-
Da ciò risulterebbe dunque confermato lo status di Bella nelRegno, come pure successivamente alla corte aragonese, ove, se-condo vari diplomi, la donna è indicata come nutrice di Costanza(41) – da cui, poi, anche la condizione di Ruggero quale “fratello dilatte” della Regina (42) – o, secondo altre, come dama di compa-gnia e confidente particolare della medesima (43).
Oltre ciò, risulta però difficile determinare tutto il resto, al-meno per quanto riguarda i primissimi anni di vita del futuroAmmiraglio. Più arduo ancora è stabilirne il luogo e la data dinascita, vuoi perché, nel Medioevo, si dava importanza ad altre da-te della vita, vuoi perché la registrazione della propria venuta almondo, ancora nel XIII secolo, è privilegio di pochi. E ancorchéRuggero appartenga alla piccola-media nobiltà del Regno di Sicilia,le sue origini erano ancora troppo modeste, perché possano fon-darsi sui dati d’archivio.
Gli storici hanno poi fatto dei calcoli e avanzato supposizionisull’anno di nascita del Lauria; infine, hanno proposto una data cheoscilla tra il 1245 ed il 1250, ma nulla di più preciso dicono ariguardo. In effetti, il termine a quo (1245-1250) è più che altroindicativo, diretta conseguenza della situazione documentale riferi-bile piuttosto ai decenni successivi, sulla cui base, poi, ne è statacalcolata la nascita, la quale però, ad ogni modo, non potrebbeessere più alta.
Controverso è pure il luogo che gli dette i natali. Qui, i parti-giani di Ruggero hanno indicato variabilmente Lauria, Scalea eCosenza – la prima attualmente in territorio lucano, le seconde interritorio calabrese –, ed hanno polemizzato non poco in passato.
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 27
stanze, da SCIASCIA, Le donne e i cavalier, pp. 43-44. Sul ceppo dei De Amicis,si rinvia ancora a EAD., Nome e memoria: i De Amicis dalla conquista normannaal Vespro, pp. 615-622.
(41) Il termine “nudrissa” è in ACA, RC, Reg. 28, ff. 108r - 109r, 112v -114r; una variante “noyrisa” è in ACA, RC, Reg. 29, f. 169r; Reg. 30, ff. 6v, 10v; Reg. 32, ff. 94r, 94v.
(42) ACA, RC, Reg. 35, f. 45v. Il documento concerne una concessionedell’infante Pietro a Margherita di Lauria, figlia di Bella Lancia ed in questodiploma definita “sorella di latte” dell’Infante, di una rendita vitalizia da de-durre dai proventi della città di Osca.
(43) ACA, RC, Reg. 13, f. 254r. Che Bella poi assuma un rango particolaretra le dame di compagnia di Costanza, e sia quindi degna di particolare fiducia,è evidente dal documento ACA, RC, Reg. 17, f. 113r, in cui alla presenza diBella si procede alla revisione dei gioielli della Regina. A Bella, era forsedemandata anche l’amministrazione della cassa della Regina (ACA, RC, Reg.31, f. 71v).
Tuttavia, anche in questo caso, nulla di più certo si può affermare,sia perché l’unico elemento dirimente sarebbe potuto giungere dauna carta inviata a Giacomo II d’Aragona il 19 di luglio del 1297citata dal Quintana (44), ma della quale non vi è traccia negliarchivi – specialmente in quello della Corona a Barcellona –, siaperché la domanda circa l’origine lucana o calabrese di Ruggero,mediante l’individuazione del relativo ceppo familiare, è alquantospeciosa, se riferita al contesto geografico di età normanna.
Non essendoci pertanto alcuna fonte che risolva a riguardo senon la tradizione, di Ruggero ancora oggi viene indicata la nascitain Calabria (45) o in Lucania (46), e viene detto variamente cala-brese o lucano non solamente in molti libri di divulgazione (47) edopuscoletti, quanto pure in voci in dizionari (48) e in storie divalore accreditato (49).
Propendere per l’una a scapito dell’altra significherebbe ripro-porre i termini della polemica che fu già ottocentesca, senza checon ciò si venga poi a comprendere l’assetto di un territorio limi-nale – qual è quello su cui operano i familiari del Lauria –, la cuidefinizione amministrativa non è perfettamente coincidente tra etànormanna e sveva.
Relativamente a quest’area, il Muntaner dice infatti che «labaronia sua era in Calabria, nella quale vi erano ventiquattro castelliriuniti, e il centro della detta baronia aveva nome Lauria» (50);
28 ROSANNA LAMBOGLIA
(44) J.M. QUINTANA, Vidas de los españoles célebres, Madrid, Calpe, 1922,(1a ed. Madrid, Imprenta Real, 1807-1833), V tomi, tomo I, p. 78, nota n. 1.
(45) Cfr. J. MORANT CLANXET, Estàtua i monument a Roger de Llúria, (Edi-ciò commemorativa del Centenari, 1889-1989), Tarragona, Ind. Gràf. GabrielGilbert, 1989, p. 10.
(46) L. RANIERI, Basilicata, Torino, UTET, 1961 (Le Regioni d’Italia, XV),p. 381.
(47) A. AVIGNONE - L. DE ROSE, L’età antica e medievale: da Stesicoro almonachesimo, in Gioia Tauro. Storia cultura economia, a cura di F. MAZZA, pre-sentazione di F.A. LUCIFERO, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubbettino, 2003(Le Città della Calabria, 17), p. 48.
(48) KIESEWETTER (a cura di), Lauria, Ruggero di, pp. 98-103.(49) A. PLACANICA, Storia della Calabria dall’Antichità ai nostri giorni,
Roma, Donzelli, 1999 (1a ed., Catanzaro, Meridiana libri, 1993), p. 149: «egli[Pietro II Ruffo, conte di Catanzaro] trova in un altro ardimentoso calabrese,Ruggero di Lauria da Scalea, invincibile ammiraglio della flotta aragonese, l’av-versario più temibile».
(50) MUNTANER, Crònica, cap. XVIII, p. 682: «E la baronia sua era enCalàbria, qui són vint-e-quatre castells en un tinebt, e el cap de la dita baroniahavia nom Lòria».
notizia, questa, relativa al centro più eminente che dal Muntaners’estende poi a tutta la storiografia successiva.
I “ventiquattro castelli riuniti”, accennati approssimativamen-te dal Muntaner, insistevano piuttosto su un’area geografica cherimanda a una baronia nel Regno normanno, le cui terre, in proba-bile continuità con l’antico tema bizantino di Lucania, erano statecomprese nel distretto di Val Sinni. In età normanna, infatti, taledistretto raccoglieva ormai sotto un unico giustiziere le terre dellaLucania meridionale a confine con l’attuale Calabria, e coincidevain massima parte con i domini dei Chiaromonte (51).
Ben inoltrata l’età sveva e nel nuovo assetto amministrativovoluto da Federico II, tale area continua ad essere un territorioliminale tra la Basilicata meridionale e la Calabria settentrionale,costituendo esso, in parte, il limite sud-occidentale del Giustizieratodi Basilicata, il quale – come è noto – solamente a partire dall’etàprimo-angioina si definirà, territorialmente, con limiti quasi coinci-denti con quelli dell’attuale regione italiana (52).
Esemplari di questa situazione di liminarità sono infatti i ruoliassunti via via dai diversi esponenti della famiglia Loria a cavalieretra il Giustizierato di Basilicata e le terre più settentrionali del Giu-stizierato di Val di Crati (e di Valle Gioradana) ad esso confinante.La particolare situazione amministrativa di queste terre, nel passag-gio dall’età normanna all’età sveva e quindi primo-angiona, puònondimeno rendere ragione della estrema facilità delle sovrapposi-zioni – anche terminologiche –, che la vasta e varia bibliografiaschiude al biografo dell’Ammiraglio.
Pertanto proprio su Lauria, ovvero su ciò che dal Muntanerviene definito centro della baronia, vale la pena spendere qualcheparola, in particolare circa lo status giuridico di feudo e di baroniaprima ancora. Entrambi i dati, infatti, sono suffragati dalla docu-mentazione archivistica e da essi risulta chiara la dimensione diLauria quale feudo baronale dalla fine del XII secolo e da qui con-
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 29
(51) Per una distrettuazione del territorio in età normanna e poi sveva sirimanda a F. PANARELLI, La vicenda normanna e sveva. Istituzione ed organizza-zione, in Storia della Basilicata. 2. Il Medioevo, a cura di C.D. FONSECA, Roma-Bari, Editori Laterza, 2006, pp. 86-124.
(52) Cfr. I Registri della Cancelleria angioina, ricostruiti da Riccardo Filan-gieri con la collaborazione degli archivisti napoletani (e, da ora, solamentecome RCA), Napoli, Arte Tipografica Editrice, 1950- (Testi e documenti di sto-ria napoletana pubblicati dall’Accademia Pontaniana, I-), vol. XVII, pp. 47-48,n. 78.
tinuata, sia pure con avvicendamenti di feudatari, secondo quantoattestato dalla successiva documentazione.
Romolo Caggese cita un diploma angioino, in cui si riferisce diuna vertenza, nel 1318, tra Berengario di Lauria, figlio ed eredelegittimo di Ruggero, e le Università ribellatisi alla sua autorità, peraverlo le seconde defraudato e spogliato del suddetto feudo (53).Di una baronia e non solamente di feudo, si parla invece in unacarta dell’Archivio della Badia della S.ma Trinità di Cava dei Tir-reni, datata 1353 e relativa a Tommaso <III> Sanseverino conte diMarsico, indicato come signore delle baronie di San Severino, diLauria, del Cilento e di Castel S. Giorgio e gran connestabile delRegno di Sicilia (54).
Entrambe le notizie infatti rinviano per un verso alla funziona-lità del termine feudo, nella sua valenza di qualifica generale nonnecessariamente dirimente nella gerarchia delle costituzioni comi-tali, baronali e suffeudali, e per l’altro alla condizione ambigua diquei territori che stavano immediatamente a ridosso della conteadei Chiaromonte, la quale, insieme ai feudi comitali di Tricarico, diMontescaglioso e di Marsico Nuovo, si stagliava in età norman-na tra i vari distretti e gli altri territori soggetti al principato diTaranto, alla contea di Andria e a quella di Conversano (55).
30 ROSANNA LAMBOGLIA
(53) R. CAGGESE, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, Firenze, R. Bemporad &Figlio, 1922 (qui, nell’ed. Bologna, Il Mulino, 2001 [Istituto italiano per gliStudi Storici, Ristampe anastatiche, 17), 2 voll., vol. 1, p. 461, nota n. 1. Riferi-sce il Caggese che il documento era contenuto nel Reg. 220, ff. 333r-333v.
(54) AC, arca LXXIII, n. 4, citata in I Regesti dei Documenti della Certosadi Padula (1070-1400), a cura di C. CARLONE, Salerno, Carlone Editore, 1996, p.177.
(55) In proposito, si veda la Carte I. Le paysage féodal en Basilicate à la findu XIIe siècle: les espaces comtaux, approntata da S. POLLASTRI, La féodalité dela région de Matera sous Les Angevins (XIIIe-XIVe siècles), in Archivi e retimonastiche tra Alvernia e Basilicata: il priorato di Santa Maria di Juso e laChaise-Dieu, Atti del Convegno internazionale di Studi Matera-Irsina, 21-22aprile 2005, a cura di F. PANARELLI, Galatina, Congedo Editore, 2007, p. 133.Per un discorso più ampio e generale sulle ripartizioni amministrative, rivoltocioè all’intero Regno di Sicila in età normanna, si vedano E. CUOZZO, Intornoalla prima contea normanna nell’Italia meridionale, in Cavalieri alla conquista delSud. Studi sull’Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager, a cura di E.CUOZZO e J.-M. MARTIN, Roma-Bari, Editori Laterza, 1998, pp. 171-193; ID., Leistituzioni politico-amministrative legate alla conquista. Le ripartizioni territoriali:i comitati, in I caratteri originari della conquista normanna. Diversità ed identitànel Mezzogiorno (1030-1130), Atti delle sedicesime giornate normanno-sveve,Bari, 5-8 ottobre 2004, a cura di R. LICINIO e F. VIOLANTE, Bari, EdizioniDedalo, 2006, pp. 287-304 e J.-M. MARTIN, Les institutions politico-administrati-
Se poi in quello che era il centro della baronia/feudo – vale adire Lauria – Ruggero avesse un castello (56), che da lui mutuava ilnome secondo una consuetudine ed un’affezione della popolazionelocale, è questa notizia che si basa unicamente sulla tradizione –verosimile, ma non certa –, poiché a riguardo occorre richiamare leprecisazioni di genere di Gina Fasòli, per le quali castello e feudo«non costituiscono (…) un binomio, un sistema inscindibile: moltiantichi castelli non furono mai infeudati e rimasero sotto il con-trollo dell’autorità pubblica, alcuni furono costruiti da un proprie-tario terriero per propria difesa, altri dalla collettività degli abitantidi un luogo aperto per mettere al sicuro se stessi e le proprie cose,altri ancora dai comuni cittadini che volevano difendere una posi-zione importante, altri infine dai “signori” cittadini» (57). E cheanzi, in proposito, vale piuttosto la condizione per la quale, a pre-scindere dall’origine, «l’ubicazione dei castelli non è mai casuale, ementre caratterizza pittorescamente certi aspetti del paesaggio, assaispesso segna i punti chiave di tutto un sistema difensivo» (58).
Ben oltre però la facile polemica, la difficoltà di individuare illuogo che dette i natali a Ruggero – non già la “patria” originariasulla quale tutti convengono, finanche gli autori catalani più anti-chi, ai quali è patente il Lauria essere un personaggio d’adozione –solleva un problema relativo all’attuale penuria documentale, circauna particolare area geografica del Regno.
Difatti, l’intero territorio in cui si circoscrivono la nascita ed ipossedimenti di Ruggero indicati en passant come ventiquattrocastelli dal Muntaner – e segnatamente quello più settentrionale,coincidente, oggi, con il cosiddetto Lagonegrese (59) – sconta la-
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 31
ves liées à la conquète. Le duché, ancora in I caratteri originari della conquistanormanna, pp. 305-333.
(56) Né un castello di Lauria è menzionato tra quelli bisognevoli di ripa-razioni in E. STHAMER, L’amministrazione dei castelli nel Regno di Sicilia sottoFederico II e Carlo I d’Angiò, presentazione di C.D. FONSECA, con prefazione ea cura di H. HOUBEN, traduzione di F. PANARELLI, Bari, M. Adda Editore, 1995(ed. or. E. STHAMER, Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unterKaiser Friedrich II. und Karl I. von Anjou, Leipzig, Hiersemann, 1914).
(57) G. FASOLI, Feudo e castello, in Storia d’Italia Einaudi, coordinata da R.ROMANO - C. VIVANTI, vol. 5, t. I, I Documenti, Milano, Einaudi, 1973, pp. 263-308, alla citazione, p. 267.
(58) FASOLI, Feudo e castello, p. 267.(59) Le difficoltà relative a questo territorio tuttavia non concernono sola-
mente il Medioevo. Non meno problematiche sono le indagini in Età Moderna.Cfr., da ultimo, V. CAPODIFERRO, Il Lagonegrese borbonico. Note economichesulla situazione preunitaria, «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania»,
cune documentarie significative soprattutto per quanto riguarda isecoli centrali del Medioevo.
Pertanto non stupisce come anche la pregevolissima Storia dellaBasilicata. 2. L’Età Medievale, pubblicata qualche anno fa dall’edi-tore Laterza e curata da Cosimo Damiano Fonseca, non possa piùdi tanto indugiare su quelle terre situate a contermine con la Cala-bria settentrionale e coincidenti, in età normanna, in massima partecon i domini della signoria lucana dei Chiaromonte (60). Questeterre non entrarono a far parte del Catalogus Baronum (61) per ilfatto di riferirsi, il Catalogus, solamente al Ducato di Puglia e alPrincipato di Capua, e le seconde – comprese nel pur longevodistretto di Val Sinni –, in sostanza, al territorio calabrese.
Se complicato risulta il quadro dei possedimenti, non è dameno quello delle relazioni parentali riferibili a Ruggero (62). In
32 ROSANNA LAMBOGLIA
LXXIV, 2007, Roma, Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiornod’Italia, pp. 189-229.
(60) Sui distretti feudali lucani e della Basilicata, si rimanda ancora aPANARELLI, La vicenda normanna e sveva. Istituzione ed organizzazione, p. 103,ma si veda anche S. POLLASTRI, La féodalité de la région de Matera, pp. 129-158.
(61) Catalogus Baronum, a cura di E. JAMISON, Roma, ISIME, 1972 (Fontiper la Storia d’Italia, 101*). Sul Catalogus, oltre allo studio preliminare pre-messo dalla Jamison, si vedano EAD., Additional Work by E. Jamison on the“Catalogus Baronum”, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evoe Archivio Muratoniano (e da ora BISIMEAM)», 83, 1971, pp. 1-63 e Com-mentario, a cura di E. CUOZZO, Roma, ISIME, 1984 (Fonti per la Storia d’Italia,101**). Cfr., altresì, E. MAZZARESE FARDELLA, Il contributo di Evelyn Jamisonagli studi sui Normanni d’Italia e di Sicilia, «BISIMEAM», 83, 1971, pp. 65-78.
(62) Gli studi relativi ai processi di formazione delle genealogie solo daqualche decennio a questa parte hanno cominciato ad interessare alcuni settoridella storiografia italiana, per la quale si segnala soprattutto R. BIZZOCCHI,Genealogie impossibili. Scritti di Storia nell’Europa Moderna, Bologna, il Mu-lino, 1995 (Monografia, 22). Da più tempo, questi studi sono stati condotti da frange significative della storiografia tedesca da una parte e da quella fran-cese dall’altra. Relativamente alla prima, tra i contributi più significativi si vedaG. MELVILLE, Vorfahren und Vorgänger. Spätmittelalterliche Genealogien alsdynastische Legitimation zur Herrschaft, in P.-J. SCHULER (Hg.), Die Familie alssozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter und zurfrühen Neuzeit, Sigmaringen, J. Thorbecke Verlag, 1987, pp. 203-309 e i lavoridi B. KELLNER, Ursprung und Kontinuität. Studien zum genealogischen Wissenim Mittelalter, München, W. Fink Verlag, 2004; EAD., Zur Konstruktion vonKontinuität durch Genealogie. Herleitungen aus Troja am Beispiel von Heinrichsvon Veldeke “Eneasroman”, in G. MELVILLE und K.-S. REHBERG, Beiträge zurinstitutionellen Konstruktion von Kontinuität, Köln Weimar Wien, Böhlau Ver-lag, 2004, pp. 37-59. Quanto invece alla storiografia francese, un primo approc-cio introduttivo al tema della genealogia già veniva alla metà degli anni Settanta
proposito, le Memorie storico-genealogiche di Ruggiero ed AndreottoLoria (63) offrivano sia un albero genealogico, sia una geografia deipossedimenti bell’e definiti.
Più dettagliatamente, secondo una prassi consolidata che dalSeicento faceva risalire la genealogia familiare ai più antichi ceppidella stirpe normanna, anche l’Autore (64) delle Memorie indivi-duava per il lignaggio dei Lauria un’origine normanna in UgoneTudextefen (65). Costui, a sua volta, innestava il proprio sangue a
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 33
del ‘900 con i lavori di L. GENICOT, Les Génealogies. Typologie des Sources duMoyen Âge Occidental, Directeur L. GENICOT, Fasc. 15, Brepols, Turnhout,1975 (poi come ID., Les Génealogies. Mise à jour du fascicule n° 15, Brepols,Turnhout, 1985). Da ultimo, si vedano però i contributi di H. BLOCH, Etymolo-gies and Genealogies. A Literary Anthropology of the French Middle Ages, Chi-cago-London, The University of Chicago Press, 1983 [ed. in trad. francese, ID.,Étymologie et généalogie. Une anthropologie littéraire du Moyen Age française,traduite de l’anglais par B. BONNE et J.-C. BONNE, Paris, Édition du Seuil,1989], nonché ID., Genealogy as a Medieval Mental Structure and Textual Form,in La littérature historiographique des origines à 1500, I (Partie historique),Directeurs: H.U. GUMBRECHT - U. LINK-HEER - P.-M. SPANGENBERG, Heidelberg,Karl Winter · Universitätsverlag, 1986 (Grundriß der Romanischen Literaturendes Mittelalters, Band XI/1, 1 Teilband), pp. 135-156.
(63) Memorie storico-genealogiche di Ruggiero ed Andreotto Loria. Rispostaal quesito: La famiglia di Ruggiero Loira è Catalana, Siciliana, o Calabrese? PerD. A. L. [sic], Napoli, Stabilimento Tipografico di S. Marchese, 1878.
(64) Sotto l’acronimo “per D. A. L.”, si cela infatti il redattore, ovveroquel Davide Andreotti Loria, già autore di una Memoria del Comune di Cosenzaa sua eccellenza il Ministro dell’Interno e di una Storia dei Cosentini, rispettiva-mente, degli anni 1863 e 1869-74 [cfr. D. ANDREOTTI, Memoria del Comune diCosenza a sua eccellenza il Ministro dell’Interno, Cosenza, dalla tip. Bruzia, 1863(poi anche come Cosenza, Tip. Municipale, 1869) e ID., Storia del Cosentini,Napoli, Stabilimento Tip. di S. Marchese, 1869-74, 3 voll., poi in varie ripro-duzioni fotomeccaniche, tra cui ID., Storia del Cosentini, Cosenza, Editrice Casadel Libro, 1958-1959, 3 voll., e con prefazione di S. DI BELLA, è D. ANDREOTTI,Storia del Cosentini, Cosenza, Pellegrini, 1978, parimenti in 3 voll.] Ulterioreconferma della coincidenza d’identità viene anche da uno stesso stile di scrit-tura ed una stessa modalità di argomentazione tra alcuni passi del vol. I dellaStoria ed il testo delle Memorie [cfr. ANDREOTTI, Storia dei Cosentini, vol. 2, p. 3 (qui, citata nell’edizione e ristampa anastatica, Cosenza, Brenner, 1987, 3voll.).
(65) In proposito, si vedano invece L.-R. MÉNAGER, Inventaire des famillesnormandes et franques emigrées en Italie méridionale et en Sicile (XIe-XIIe siè-cles), in Roberto il Guiscardo e il suo tempo, Atti delle prime giornate nor-manno-sveve, Bari, 28-29 maggio 1973, Bari, Edizioni Dedalo 1991, pp. 279-410 [ovvero ristampa della prima edizione, Roma, Il centro di ricerca, 1975(Fonti e Studi del “Corpus membranarum italicarum”, XI), pp. 260-390, saggio,questo, ristampato anche in L.-R. MÉNAGER, Hommes et institutions de l’Italienormande, London, Variorum reprints, 1981, pp. 260-390] e successiva integra-
quello della stirpe longobarda, i cui prìncipi quindi lo rendevano«signor d’Oria, di Paduli, di Montefusco, di Terrarossa, e di Apice,feudi che trasmise dietro il suo decesso a Ruggiero, che in prosie-guo possedè Oria col titolo di conte» (66).
Tracciando poi le fila di un racconto che variamente procedevada una non meglio precisata edizione della cronaca del Telesino,segnatamente laddove costui veniva a parlare di un Ruggero, contedi Ariano (67), e soprattutto facendo propria un’equivalenza ono-mastica tra Oria-Loria / dell’Oria-di Loria, chiaramente derivatadalla lettura del Summonte, l’Autore delle Memorie poteva dunquefar coincidere i dati parentali del Catalogus Baronum, strettamenteriferiti ai conti dell’Oria, con quelli dei Loria, mediante le figure di un Ruggero conte dell’Oria, sposo di Bulfanaria de Oria, edentrambi genitori tanto di un Roberto di Oria, quanto di un Gibelde Loria, con evidente confusione o interpolazione di notizie, poi-ché relativamente a Bulfanaria, nel Catalogus, solamente è detto:
229 ¶ Bulfanaria mater Robberti de Oria sicut dixit tenet in Oria feu-dum unius militis et cum | augmento obtulit milites duos (68).
Suddetta Bulfanaria, che è da identificare secondo appunto ilCatalogus esclusivamente con la madre di un Robbertus Mustacze(infra ¶ 178) (69), tenuto alla riparazione del castello di Oria, dal-l’Autore delle Memorie viene presentata invece come madre anchedi un Gibel, del quale, tuttavia, ancora nel Catalogus, è riferito uni-camente:
34 ROSANNA LAMBOGLIA
zione, ID., Additions à l’inventaire des familles normandes et franques émigréesen Italie méridionale et en Sicile, ancora in ID., Hommes et institutions, pp. 1-17; L. MUSSET, L’aristocratie normande au XIe siècle, in La noblesse au moyenage. XIe-XVe siècles. Essais à la memoire de Robert Boutruche, réunis par Ph.CONTAMINE, Presses Universitaires de France 1976, pp. 71-96.
(66) Memorie genealogiche, p. 4. Sulla questione del precoce innesto dellanobiltà normanna con quella longobarda, si veda E. CUOZZO, La cavalleria nelRegno normanno di Sicilia, Atripalda (AV), Mephite, 2002, segnatamente, pp.203-214.
(67) Alexandri Telesini abbatis Ystoria Rogerii Regis Sicilie Calabrie atqueApulie, testo a cura di L. DE NAVA, commento storico a cura di D. CLEMENTI,Roma, ISIME, 1991 (Fonti per la Storia d’Italia, 112), l. I, c. 7, pp. 9-10, cc. 10-12, pp. 11-13, c. 23, p. 20; l. III, c. 6, pp. 62-63. Si confrontino i sovramenzio-nati passi del Telesino con i frammenti citati nelle Memorie storico-genealogiche,pp. 4-6.
(68) Catalogus, p. 56.(69) Catalogus, p. 52.
419 ¶ Gibel sicut dixit Guarrerius(…) tenet feudum unum(…) militis etcum augmento obtulit militites duos (70).
Come poi il Gibel sovramenzionato, suffeudatario di Guerreriodi Monte Fuscolo (71), potesse essere, per omonimia, identificatocon Gibel de Loria, col quale propriamente, invece, si avrebbe noti-zia del ramo dei Lauria, ciò risulta da un’acrobazia delle Memorie,verosimilmente sulla base della già citata equivalenza summontiana.
Allo stesso modo, per effetto di quest’acrobazia, l’Autore delleMemorie attribuiva a Gibel de Loria i possedimenti dell’altro omo-nimo, in una fusione che prendeva dell’uno e dell’altro e ponevatutto insieme (72), la cui ovvia conseguenza era l’attribuzione di unterritorio al ceppo dei Lauria, molto più vasto dell’effettivo.
Spiluccando poi dai genealogisti cinque-seicenteschi e dalla platea di Luca Campano (73), l’Autore delle Memorie pervenivaquindi a parlare del nostro Ruggero, presentandolo come figlio diRiccardo di Loria, figlio, a sua volta, di Gibel di Loria, poco, ineffetti, curandosi – anche a dispetto della ribadita precisione – delsalto di generazione che anche un calcolo approssimativo avrebbedovuto necessariamente contemplare, escludendo sia a Riccardo,quanto a Gibel, una longevità biblica.
Tuttavia proprio il riferimento alla Platea cosentina ben chiarisce latradizione sulle fonti, che dunque si evincono essere state non di prima
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 35
(70) Catalogus, p. 76. Sulle modalità con cui i vassalli prestavano serviziomilitare, si veda, ancora CUOZZO, La cavalleria nel Regno normanno di Sicilia,pp. 145-159 e pp. 167-177.
(71) Catalogus, p. 74.(72) Memorie genealogiche, p. 12: «V. Ultimo figlio di Ruggiero conte del-
l’Oria è Gibel, di cui è memoria nel citato Catalogo de’ Baroni, del quale sidice: Gibel de Loria sicut dicit Guerrerius tenet feudum I [sic] militis et cum aug-mento obtulit milites II [sic]. Idem Gibel tenet de eodem Gisulpho sicut dixitfeudum II [sic] militum, et cum augmento obtulit milites IV [sic]. Idem GibelLoriae de Policastro tenet villanos III [sic]. Il primo de’cennati (sic) feudi era inMontefusco – in Paduli il secondo – ed in Policastro il terzo. Ignorasi chi fossela moglie di Gibel; ma se ne sanno con tutta precisione i figli – e di essi si par-lerà nell’altro capitolo».
(73) La Platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227), a cura di E.CUOZZO, Avellino, Elio Sellino Editore, 2007. Sull’arcivescovo Luca, originariodi Campagna, parte del Lazio meridionale (cfr. La Platea di Luca, p. XLVII) ed appartenente all’ordine cistercense, insignito poi della dignità arcivescoviledella diocesi di Cosenza nel 1202 (o agli inizi del 1203) e stante, nella carica,fino al 1227, si veda N. KAMP, Kirche und Monarchie im staufischen KönigreichSizilien. I. Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des König-reichs 1194-1166. 2. Apulien und Kalabrien, München, Wilhelm Fink Verlag,1975, pp. 833-839.
mano per l’Autore delle Memorie (74), che le derivava con buona pro-babilità da un passo quasi identico di Girolamo Sambiasi (75).
Il confronto con il testo de La Platea di Luca non riscontrainfatti la notizia di una prebenda alla chiesa di S. Anna in Cosenzada parte di un qualche esponente della famiglia Loria, né tanto-meno di un Giovanni e anche di un Giacomo (76) e quindi anchedi un Riccardo (77). La lettura della fonte diretta conferma inveceil perpetuarsi della confusione onomastica che ha finito coll’identi-ficare il ceppo dei Loria con un dominus Johannes de Ullia. Questiè infatti, proprietario di un terreno, citato nella Platea come puntodi riferimento di confine territoriale per un campo coltivato, dettodi Molara, afferente alla prebenda de Modio, le cui rendite deriva-vano, tra altre chiese, anche da quella di S. Anna in Cosenza.
Secondo il registro dei nomi redatto dal Curatore della mo-derna edizione della Platea, tale Johannes de Ullia sarebbe un probabile esponente della famiglia de Ollia (78). Ciò dunque con-ferma nuovamente come dall’originale ricamo ortografico del Sum-monte – Ollia – si sia determinata per tradizione sulle fonti l’equi-valenza Ollia/de Ollia/ de Loria, nonostante nel Napoletano non vifosse alcuna confusione di sorta tra i due rami familiari.
36 ROSANNA LAMBOGLIA
(74) Memorie genealogiche, p. 13: «Di Giovanni [figlio di Gibel] fa ri-cordo l’Aceti nelle Annotazioni al Barrio, che lo appella Miles clarissimus. Di lui ancora si parla nella Platea di Luca Campano, Arcivescovo cosentino del1223, come un di coloro che pagavano una prebenda a S. Giacomo e a S. Annadi Cosenza».
(75) SAMBIASI, Ragguaglio di Cosenza e di trent’una sue nobili famiglie, pp.90-91: «Di più si trova nella sagrestia del nostro Duomo una molto antica Pla-tea composta prima, come altrove altra fiata si è detto su gl’anni mille centoottanta quattro [sic] dell’Arcivescovo Pietro, e quindi appresso rifatta da Lucagl’anni mille ducento venti tre [sic], nel qual libro come vengon notati tutticoloro, che rispondevano di qualche somma alla mensa Arcivescovale, cosìannoverati vi sono tra’ nobili Cosentini Riccardo, Giovanni, e Giacomo di Loriaper cagione di una prependa, che pagavano ogni anno à San Iacomo, & à San-t’Anna in Cosenza».
(76) Memorie genealogiche, p. 13: «Nella stessa platea si fa motto di Gia-como, il quale, secondo Filiberto Campanile, ebbe per l’attaccamento che portòa Carlo I. [sic] in feudo Abbatemarco ed altre terre in Basilicata, ove diggià eraBarone di Castelluccia [sic]».
(77) Memorie genealogiche, p. 14: «Di Riccardo, poi, altro figlio di Gibel,e primogenito, fan motto la citata platea di Luca Campano del 1223 e l’Acetinelle Annotazioni al Barrio ed altri patrî scrittori».
(78) Cfr. La Platea di Luca, pp. 45, 232.
2.1 Legami familiari nel Regno normanno-svevo ed angioino
Al di là delle arbitrarietà genealogiche delle Memorie – quiriprese sia per enunciare i termini di una tradizione, o piuttosto diuna libera interpretazione delle fonti, sia per sgombrare il campoda una genealogia del tutto fuorviante nondimeno riproposta inpubblicazioni anche recentissime (79) –, sembra proprio che unGibel de Loria o Gibellus de Loria sia uno dei primi sicuri rappre-sentanti del ceppo familiare a cui poi il nostro Ruggero sarebbericonducibile, ma che sia cosa diversa ed azzardata porlo comecapostipite (80). Gibel, infatti, è unicamente il primo dei Loria delquale si ha una qualche notizia documentale, sia nel Catalogus Baro-num, sia in due documenti del monastero di S. Elia ed Anastasio diCarbone (81).
Gibel de Loria è poi una figura significativa almeno per la terri-torialità cui è legata, nel Catalogus, il suo nome. Egli è, infatti, indivi-
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 37
(79) In proposito, recente è un albero genealogico evidentemente falsa-to sulla base delle notizie offerte dai genealogisti seicenteschi in Lauri Antica.Tracce di storia, Catalogo della mostra, a cura di A. BOCCIA e G. PETRAGLIA,Lagonegro, Grafiche Zaccara, 2008, p. 35. Su notizie veicolate da travasi biblio-grafici è pure la genealogia approntata in W. FITTIPALDI, Lauria, percorsi di artefede e storia, Lauria, ed. dell’Autrice, 2010, p. 47. Altresì, non sempre puntualisono anche le molte notizie rintracciabili in Genealogie delle famiglie nobili ita-liane, a cura di D. SHAMÁ, al seguente URL: <www.sardimplex.com>.
(80) In proposito, una prima messa a punto sugli studi relativi ai ceppifamiliari sono gli atti del convegno Famille et Parenté dans l’Occident Médiéval,Actes du Colloque de Paris (6-8 Juin 1974), organisé par l’École Pratique deHautes Études (VIe Section) en collaboration avec le College de France et l’É-cole Française de Rom, Communications et débats présentés par G. DUBY et J.LE GOFF, Rome, École Française, 1977 e G. DUBY, Structures de parenté etnoblesse dans la France du Nord aux XIe et XIIe siècles, in ID., Hommes et Struc-tures du Moyen Âge, Paris - La Haye, Mouton Éditeur, 1973, pp. 267-285.
(81) History and Cartulary of the Greek Monastery of St Elias and St Ana-stasius of Carbone, edited by G. ROBINSON, Roma, Pont. Istitutum OrientaliumStudiorum, 1928-1930 (Orientalia Christiana, voll. XI-5; XV-2; XIX -1), 2 voll.,vol. II, II, docc. XXXVII-XXXVIII, pp. 30-42; Commentario, 601 ¶, p. 162.Relativamente al Monastero, una recente rassegna di studi è Il Monastero di S.Elia di Carbone ed il suo territoro dal Medioevo all’Età Moderna: nel millenariodella morte di S. Luca abate, Atti del Convegno internazionale di studio pro-mosso dall’Università degli Studi della Basilicata in occasione del decennaledella sua istituzione, Potenza-Carbone, 26-27 giugno 1992, a cura di C.D. FON-SECA e A. LERRA, Galatina, Congedo, 1996. Sulle vicende dei monasteri di fon-dazione greca sotto i Normanni, si veda, da ultimo, A. PETERS-CUSTOT, LesGrecs de l’Italie méridionale post-byzantine. Une acculturation en douceur,Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 420),2009, segnatamente, pp. 268-285.
duato come colui che tiene tre villani in Policastro (82) e come coluiche ricopre l’incarico di giustiziere regio del distretto di Val Sinni nel1144 insieme a Roberto di Cles (83), entrambi chiamati a dirimere,presso l’abate Ilario, una questione che coinvolge il Monastero diCarbone, minacciato nelle sue proprietà da un non meglio precisatonobile Gillius, signore di Calabra (84). I due sono poi legati al contedi Principato: Roberto di Cles, quale suffeudatario di Lampus deFasanella (85), e Gibel quale suffeudatario del conte di Marsico (86),mediante ancora il tramite di un Gisulfo de Palude (87).
Con Gibel si delinea, dunque, un primo legame col territorio,secondo il quale il ceppo familiare dei Loria insisterebbe per unverso con l’area più occidentale che dal Vallo di Diano (Campania)conduce fino almeno a Policastro e, per l’altro, con l’area più cen-tro-meridionale dell’antica Lucania, corrispondente appunto al di-stretto di Val Sinni.
La notizia che vuole, invece, padre di Ruggero, un Riccardo diLoria o de Lauria, “gran privado” del re Manfredi, tanto da seguirequest’ultimo nella rotta di Benevento, deriva esclusivamente daJeronimo Zurita (88) e dall’annalista si diffonde a tutta storiografia
38 ROSANNA LAMBOGLIA
(82) Catalogus, 586 ¶, p. 106. (83) Commentario, 607 ¶, p. 164. Sulla carica di giustiziere regio si rinvia
a E. CUOZZO, «Quei maledetti Normanni». Cavalieri ed organizzazione militarenel Mezzogiorno normanno, prefazione di F. CARDINI, Napoli, Guida Editori,1989 (L’altra Europa, 4), segnatamente, pp. 86 e 135. Sull’amministrazione nor-manna, si vedano E. JAMISON, The Norman Administration of Apulia and Capua,more especially unter Roger II. and William I., 1127-1166, reprint of the ed.1913 edited by D. CLEMENTI and T. KÖLZER, Aalen, Scientia Verlag, 1987 [ed.orig. in «Papers of the British School at Rome», VI (1913), pp. 211-401] e J.-M. MARTIN, L’administration du Royaume entre Normands et Souabes, in DieStaufer im Süden. Sizilien und das Reich, hg. von T. KÖLZER, Sigmaringen, J.Thorbecke Verlag, 1996, pp. 113-140. Una discussione sul ruolo mediatoredelle contee tra l’autoritarismo della Corona e le autonomie locali è in E. MAZ-ZARESE FARDELLA, Problemi preliminari allo studio del ruolo delle contee nelregno di Sicilia, in Società, potere e popolo nell’età di Ruggero II, Atti delle terzegiornate normanno-sveve, Bari, 23-25 maggio 1977, Bari, Edizioni Dedalo,2007, pp. 41-54 (ma ristampa dell’ed. Bari, Dedalo, 1979).
(84) History and Cartulary of the Greek Monastery of St Elias and St Ana-stasius of Carbone, docc. XXXVII-XXXVIII, pp. 31 e 39.
(85) Catalogus, 607 ¶, p. 110.(86) Catalogus, 597 ¶, p. 108.(87) Catalogus, p. 109: «601 ¶ Gibel de Loria tenet de eodem Gisulfo sicut
dixit feudum(…)(…) duorum militum et cum augmento obtulit milites quatuor(sic)».
(88) J. ZURITA CASTRO, Anales de Aragón, Edicion preparada por A.CANELLAS LOPEZ, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” (CSIC), 1967-
catalano-spagnola successiva. L’altra notizia che vuole, quale madredi Ruggero, un’esponente della nota famiglia Lancia – Isabella Lan-cia d’Amichi o de Amicis –, deriva, al contrario, dalle cronachecatalane coeve, e dal Muntaner segnatamente.
Mentre però la prima è una notizia che si fonda esclusivamentesulla tradizione, giacché non vi è un riscontro documentale cheleghi la figura di Riccardo a quella di Manfredi e alla battaglia diBenevento (89), più volte comprovata, si è già vista invece esserel’attestazione di una “dompne Bela” nei diplomi dei registri dell’In-fante Pietro, e quindi indicata inequivocabilmente quale madre delLauria in quelli di Giacomo I il Conquistatore (90), relativamentealle concessioni feudali elargite da quest’ultimo.
Tra le due figure genitoriali, dunque, più problematico è risalirealla figura del padre, il cui legame parentale è posto unicamentedalla tradizione (91). In proposito, le fonti non dirimono la que-
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 39
1980 (1a ed. J. ZURITA, Anales de la Corona de Aragón, Impressos en Caragoca[Saragozza], en el Colegio de S. Vicente Ferrer, 1610, 4 voll., e voll. 5 e 6 pub-blicati come Historia del Rey Don Hernando el Catolico; il vol. 7 come Indice delas cosas mas notables, que se hallan en las quatro partes de los Anales, y las dosde la Historia de La Corona de Aragón), 8 vols, vol. 1, l. III, c. LXXXI, p. 698.Sullo Zurita e la sua storiografia, si vedano G. CONIGLIO, Il regno di Carlo Id’Angiò nell’opera di Jeronimo Zurita, in Storiografia e storia, vol. I, pp. 289-309e A. BOSCOLO, I cronisti catalano-aragonesi e la storia d’Italia del basso Medioevo,in Nuove questioni di storia medievale, Milano, Marzorati, 1964, pp. 304-306,sullo Zurita, pp. 317-309. Sulle fonti dello Zurita, si veda, in particolare, X. DE
SALAS BOSCH, Fuentes de Zurita. Inventarios del Fondo documental que pertene-ció a Gerónimo Zurita, Zaragoza, Tip. «La Académica» - F. Martínez, 1940.
(89) Sulla battaglia di Benevento, si rinvia al resoconto che ne fa il croni-sta [PSEUDO]N. DE JAMSILLA, Historia de rebus gestis Friderici II imperatoriseiusque filiorum Conradi et Manfredi Apuliæ et Siciliæ regum ab anno MCCXusque ad MCCLXVIII, in Rerum Italicarum Scriptores, Prima Serie (RIS1),Mediolani 1726, coll. 607-608. Quanto a studi, si rimanda invece a B. PETROC-CIA, La battaglia di Benevento nella tradizione dei cronisti, con nota introduttivadi F. ROMANO, Napoli, Edizioni Secolo Nuovo, 1957 e, per quanto tendentiall’enfatico, anche a A. ZAZO, La battaglia del 26 febbraio 1266, in La Battagliadi Benevento, Benevento 1967 (Saggi e studi del Museo del Sannio - Bibliotecae Archivio storico provinciali di Benevento, 1), pp. 61-74 e L. MAIO, La batta-glia di re Manfredi e la fine del dominio svevo sul territorio beneventano, «Rivi-sta Storica del Sannio», II.4, 1995.
(90) ACA, RC, Reg. 16, f. 211r e Reg. 19, f. 92r: qui, a titolo esemplare, iprimi due diplomi relativi alle concessioni feudali, in cui si legge il legame traBella e Ruggero.
(91) Andreas Kiesewetter, il quale pure ha considerato una vasta biblio-grafia, non pone la questione relativa alla tradizione e risolve, dicendo che ilpadre di R. era un piccolo feudatario calabrese di cui non si conosce il nome.Cfr. KIESEWETTER (a cura di), Lauria, Ruggero di, p. 98.
stione, semmai palesano unicamente l’esistenza di un Riccardo diLauria (92), attivo nel Regno, in date che soltanto non smentisconodel tutto la cronologia di una possibile paternità di Ruggero. Ana-logamente, aperto rimane pure il problema del legame parentale traRiccardus de Loria ed il precedente Gibel de Loria (93), il cui ceppofamiliare comunque si trovava legato a relazioni vassallatiche già inetà normanna (94).
Indubbiamente, c’è un momento in cui questo Riccardo diLauria acquista preminenza. Infatti, il 25 dicembre del 1239 è tragli uomini incaricati da Federico II di recapitare agli undici giusti-zieri del Regno le istruzioni relative alla riscossione della collettaper l’anno corrente pari a quella riscossa l’anno precedente, e per laquale viene raccomandato di aver particolare cura affiché non nefosse diminuito il gettito (95) – nella fattispecie, Riccardo è inviatopresso il giustiziere di Val di Crati e di Terra Giordana ed anchepresso il giustiziere di Calabria (96). Ed ancora un documento fede-
40 ROSANNA LAMBOGLIA
(92) CH. FRIEDL, Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II. im Köni-greich Sizilien (1220-1250), Wien, Verlag der österrreichischen Akademie derWissenschaften, 2005, pp. 312 e 316.
(93) Concorda su questo punto anche FRIEDL, Studien zur BeamtenschaftKaiser Friedrichs II., p. 316, nota n. 49. Sul ceppo familiare anche il Friedl simantiene cauto, definendone probabile l’origine da Lauria: »Die Familie durftewahrscheinlich aus Lauria, nordöstlich von Maratea (Prov. Potenza), stammenund war schon unter den Normannen Lehnsträger«, in Studien zur Beamten-schaft Kaiser Friedrichs II., p. 316. Chi scrive aggiunge tuttavia, come suscetti-bile di un qualche rilievo, il fatto che questo ceppo familiare proponga nomi odi origine normanna o comunque legati alla tradizione normanna.
(94) Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II., p. 316, secondoquanto al Friedl è stato possibile desumere dalle carte del Fondo Kamp, Kar-teikasten I.4.7 (Familiae officialium), presso l’Archivio dell’Istituto Storico Ger-manico di Roma (Archiv des DHI = Deutsches Historisches Institut in Rom).
(95) Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C.CARBONETTI VENDITELLI, Roma, ISIME, 2002 (Fonti per la Storia d’Italia medie-vale, 19* e 19**), 2 voll., vol. 1, pp. 351-354. Sul registro di Federico II, sullasua accidentata vicenda editoriale, cfr. l’Introduzione, a cura di C. CARBONETTI
VENDITELLI all’Edizione, pp. XVII-LXXXII. Nondimeno, si vedano i precedentiinterventi di J. MAZZOLENI, La registrazione dei documenti delle cancellerie meri-dionali dall’epoca sveva all’epoca viceregnale, Napoli, Libreria Scientifica Edi-trice, 1971, pp. 12-25 che descriveva fisicamente il registro, e di W. HAGEMANN,La nuova edizione del Registro di Federico II, in VII Centenario della morte diFederico II imperatore e re di Sicilia – (10-18 dicembre 1959), Atti del ConvegnoInternazionale di Studi Federiciani, a cura del Comitato Esecutivo, Palermo,Arti Grafiche A. Renna, 1952, pp. 315-336, per una storia del Registro, delle suediscutibili messe a stampa prima dell’edizione Carbonetti-Venditelli.
(96) Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240, vol. 1, docc.342-343, p. 354. Sull’evoluzione delle cariche, rispetto alla precedente età nor-
riciano di appena qualche giorno prima annovera Riccardo tra itrentadue feudatari del giustizierato di Basilicata ai quali vengonoaffidati gli ostaggi lombardi (97), presi in consegna, su mandatodell’Imperatore, dal giustiziere di Capitanata Riccardo di Montefu-scolo (98) con l’incarico di tradurli via mare nel Regno e, qui, poismistarli tra i vari giustizieri a cui erano stati destinati (99).
Nel successivo marzo del 1240, Riccardo di Lauria è di nuovotra gli ufficiali a cui Federico II fa pervenire una comunicazione,nella quale ingiunge loro di presentarsi al cospetto dell’Imperatore,in occasione della sua prossima venuta nel Regno di Sicilia e dellaconvocazione di un’assemblea generale che si terrà a Foggia ilgiorno della Domenica delle Palme – apud Fogiam in festo Palma-rum primo venturo conloquium indixerimus generale (100).
Nondimeno, Riccardus de Loria sembra essere stato giustizieredi Basilicata solamente al tempo di Federico II (101), poiché dopoil 1240, se ne perdono del tutto le tracce. È possibile che a partireda questa data intervenga un periodo di disgrazia, per il quale nonè da escludere un provvedimento di destituzione dalla magistratura
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 41
manna ed in particolare su quella del Maestro Giustiziere e dei giustizieri, sirinvia a E. CUOZZO, La “Magna Curia” Al tempo di Federico II di Svevia,«Radici. Rivista lucana di storia e cultura del Vulture», 16, 1995, pp. 23-71 e aA. KIESEWETTER, Il governo e l’amministrazione centrale del Regno, in Le ereditànormanno-sveve nell’età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno, Attidelle quindicesime giornate normanno-sveve, Bari, 22-25 ottobre 2002, a curadi G. MUSCA, Bari, Edizioni Dedalo, 2004, pp. 25-68.
(97) Il Registro della Cancelleria di Federico II del 1239-1240, vol. 1, doc.335, pp. 323-350; il nome del Lauria è a p. 340. Il documento, però, era già inJ.A. HUILARD-BRÉHOLLES, Historia Diplomatica Friderici II, Paris 1852-1861, 6voll., 12 tomi, vol. V, t. 1, pp. 617-618. Circa la natura del documento, si leg-gano le note esplicative della CARBONETTI VENDITELLI, Il Registro della Cancelle-ria di Federico II del 1239-1240, vol. 1, pp. 324-328.
(98) CARBONETTI VENDITELLI, Il Registro della Cancelleria di Federico II del1239-1240, vol. 1, doc. 317, pp. 317-318.
(99) CARBONETTI VENDITELLI, Il Registro della Cancelleria di Federico II del1239-1240, vol. 1, docc. 328-333, pp. 320-323.
(100) CARBONETTI VENDITELLI, Il Registro della Cancelleria di Federico IIdel 1239-1240, vol. 2, docc. 657-668, pp. 620-622; il nome di Ruggero è al doc.660, p. 621. Sulla circostanza della convocazione, si veda A. CARUSO, Indaginesulla legislazione di Federico di Svevia per il Regno di Sicilia. Le leggi pubblicatea Foggia nell’aprile del 1240, in Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevianella storiografia, Antologia di scritti a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Bolo-gna, Pàtron Editore, 1987, pp. 145-168. Sulla feudalità del Regno, si rinvia allenote di G. FASOLI, La feudalità siciliana nell’età di Federico II, in TROMBETTI
BUDRIESI (a cura di), Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia, pp. 403-421.(101) FRIEDL, Studien zur Beamtenschaft Kaiser Friedrichs II., p. 312.
o anche un ordine di probabile esecuzione contro costui (102),entrambi come risultanze, parimenti verosimili, delle contromisureimperiali prese a seguito della congiura di Capaccio (103).
Tuttavia, anche una situazione così lacunosa sul vincolo fami-liare specifico è per altro verso indicativa di una certa posizione diprestigio di Riccardo, sia che fosse egli propriamente il padre diRuggero, sia che fosse un personaggio omonimo, legato da unaqualche affinità parentale. Né in un caso, né nell’altro si smentisceinfatti la circostanza per la quale il padre di Ruggero doveva essereuna figura di discreta considerazione, se era potuto rientrare nellefitte ed intricate relazioni familiari dei Lancia con la piccola emedia nobiltà regnicola, mediante un secondo matrimonio conquella Bella Lancia, di cui si diceva nel precedente paragrafo.
Non si perdono invece le tracce di un Giacomo, di un Roberto edi un altro Riccardo di Lauria, fratelli, citati in un diploma angioinodel 21 luglio 1269 e detti custodi del Castello di Laino (104).
I tre erano infatti ricorsi all’autorità di Carlo d’Angiò per chie-dere la riscossione delle paghe loro (e di 25 servienti) sino a quelmomento non percepite, avendo i Lauria prima espugnato il ca-stello di Laino, in mano ai partigiani di Corradino, e successiva-mente anche ottenutone la custodia dal Giustiziere di Val di Crati.
Evidentemente i Loria non si erano reputati affatto soddisfatti,né era bastato loro il provvedimento per il quale re Carlo, il 13 giu-gno 1269, aveva già designato Roberto castellano del Castello diLaino, se quel Roberto di Laveria citato nel diploma (105) sembraessere, sulla fede del contenuto specifico, una regestazione onoma-stica impropria, già peraltro assunta dal Minieri Riccio (106) o intal forma a lui derivata da un errore di scrittura del cancelliere.
42 ROSANNA LAMBOGLIA
(102) Concorda su questo punto anche FRIEDL, Studien zur BeamtenschaftKaiser Friedrichs II., p. 316: «Ebenso wie sein Vorgänger Philippus [de Zunculo]ist Riccardus als Justitiar dieser Provinz nur durch Friedrichs II. Schreiben hin-sichtlich der Aufführung der Unterbeamten greifbar. Auch er war zu diesem Zeit-punkt am kaiserlichen Hof, was auf ein gereiftes Vertrauensverhältnis zwischenihm und dem Kaiser hinweist. Leider sprechen die Quellen nicht weiter von him».
(103) Sulla congiura del 1246 e sulle sacche di resistenza nelle fortezze diSala e Capaccio, si rinvia a D. ABULAFIA, Federico II. Un imperatore medievale,Torino, Einaudi, 200616, (ed. or. D. ABULAFIA, Frederick II. A medieval emperor,London, Allen Lane The Penguin Press, 1988), pp. 314-315. Una informazionesintetica della congiura è poi anche alla voce Capaccio (1246), congiura di, acura di E. CUOZZO, in EF, vol. 1, pp. 222-223.
(104) RCA, vol. I, p. 306, n. 23. (105) RCA, vol. II, p. 99, n. 364. (106) C. MINIERI RICCIO, Alcuni fatti riguardanti Carlo I d’Angiò dal 6 ago-
Non è neppure da escludere che la designazione risponda adun provvedimento a caldo a favore di Roberto, mostrando infatti ladocumentazione collaterale un singolare avvicendamento di cari-che con un Guglielmo di La Forest milite (107), già castellano del Castello di Laino al 1269 (108), declassato, nello stesso anno,quindi a custode (109). Tuttavia, tal Roberto di Laveria sembraessere stato insediato nella carica soltanto in via provvisoria, poichéGuglielmo è ancora indicato come castellano in documenti dellaXIV Indizione (1270-1272) (110) e della XIV-XV Indizione (1271-1272) (111), e nel ruolo pare rimanere fino almeno alla sua nuovadestituzione a favore, questa volta, di un Erberto di Aureliano(112), che diventa anche signore feudale della terra di Laino (XVIndizione, anni 1271-1272) (113).
Sicuramente, però, Roberto di Lauria è titolare di feudo, se nelterzo registro Iustitiariorum della XIII indizione (1269-1270) questiè indicato tra i feudatari del Giustizierato di Basilicata (114), men-
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 43
sto 1252 al 30 decembre [sic] 1270, Napoli 1874, p. 54: «In questo stesso dì reCarlo crea Giovanni di Scordyon in castellano del castello di Pietra del Roseto(257), e Roberto de Laveria a castellano del castello di Laino, in premio del suovalore, avendo preso quel castello debellando i proditori che lo tenevano inloro potere (259)».
(107) Guglielmo La Forest, milite, era signore di Pietramala e per viamatrimoniale deteneva, secondo un documento datato 1272, anche la metà delcastello di Castelluccio (prov. di Pz.) in Basilicata: RCA, vol. IX, p. 274, n. 360(I Indizione, anni 1272-1273). È possibile pensare, però, che queste terre fos-sero oggetto di frequenti mutamenti e/o concessioni reali, se poi la medesimanotizia di cui si diceva sembra essere contraddetta da un documento della IIIndizione (anni 1273-1274), nel quale si dice che il castello di Castelluccio eradi pertinenza dello stesso Erberto di Aureliano, mentre gli uomini della terra diLaino erano vassalli di La Forest: cfr. RCA, vol. XI, p. 76, n. 252 (II Indizione,anni 1273-1274) e RCA, vol. XXXII, p. 138, n. 42 (III Indizione, anni 1289-1290). Analogamente, altri avvicendamenti, con altri protagonisti, sono regi-strati prima e dopo il La Forest, in RCA, vol. XXVI, p. 17, n. 122 (XI Indi-zione, anni 1282-1283); RCA, vol. XLV, p. 30, n. 40 (VI Indizione, 22 gennaio1293) e p. 94, n. 18 (VI Indizione, 22 gennaio 1293).
(108) RCA, vol. III, p. 25, n. 170.(109) RCA, vol. II, p. 129, n. 494 e p. 130, n. 500 (duplicato del n. 494).
Per i legami di Guglielmo di Foresta con l’attuale Valle del Mercure, successi-vamente alla destituzione da castellano, cfr. RCA, vol. IX, p. 274, n. 360; vol.XI, p. 76, n. 252.
(110) RCA, vol. VI, p. 150, n. 761 e p. 152, n. 785.(111) RCA, vol. VII, p. 208, n. 179 e p. 160, n. 369.(112) RCA, vol. VIII, p. 57, n. 150; p. 124, n. 77 e p. 296, n. 47. (113) RCA, vol. VIII, p. 296, n. 47; p. 284, n. 1 e p. 299, n. 62.(114) RCA, vol. IV, p. 68, n. 438.
tre i rimanenti Jacobo (Giacomo) e Riccardo vengono esentati, dalprestar servizio militare in Acaia in soccorso di Guglielmo II di Vil-leharduin (115), poiché non posseggono un intero feudo (116).
Di Giacomo di Lauria – comunque feudatario, sia pure di unaporzione di feudo – nulla si dice invece nei documenti di cancelle-ria superstiti, se non quel poco che si ricava da un regesto di undocumento, fatto a suo tempo dal Minieri Riccio, e datato 18 lugliodel 1271. In esso, re Carlo ordina al Giustiziere di Basilicata di far pagare a Giacomo di Lauria, dai suoi vassalli, la sovvenzionedovuta secondo le consuetudini del Regno, poiché questi dovevaesser cinto cavaliere ed insieme a Ruggero Sanseverino, conte diMarsico e vicario del Re a Roma, portarsi in quella città per fac-cende non ulteriormente precisate (117).
Sul finire dell’età sveva e lungo tutta la breve età di Manfredi,un momento di disgrazia deve però aver coinvolto anche i tre fra-telli ed il relativo ceppo familiare se questo, ad un certo punto, nonrisulta essere più titolare dei possedimenti precedentemente ascrit-tigli, secondo infatti quanto è dato appurare dalla inchiesta ordinatada Carlo I d’Angiò, fin dal 1274, allo scopo di reintegrare dei benifeudali quanti ne erano stati spogliati dai sovrani svevi (118).
Si apprende infatti che, a seguito della confisca, le terre diLagonegro e di Lauria furono concesse da Federico II ad Alemagnode Fallucca in cambio di alcune terre in Calabria, e che detto Ale-magno le mantiene fino all’avvento di re Corrado (119).
Le medesime terre non ritornano ai Loria neppure in età man-frediana, poiché un Guglielmo Villano ottiene la terra di Lagonegroe un non meglio precisato dominus Albertacius la terra di Lau-
44 ROSANNA LAMBOGLIA
(115) Cfr. il recente volume, già tesi di dottorato, di G.L. BORGHESE, Carlod’Angiò e il Mediterraneo. Politica, diplomazia e commercio internazionale primadei Vespri, Roma, École française de Rome, 2008 (Collection de l’École fran-çaise de Rome, 411), pp. 24-29.
(116) RCA, vol. IV, p. 69, n. 447.(117) RCA, vol. VI, p. 89, n. 336 e C. MINIERI RICCIO, Il Regno di Carlo I
d’Angiò negli anni 1271 e 1272, Firenze 1875, p. 28: «[Carlo I] Al Giustizierodi Basilicata ordina di far pagare a Giacomo di Lauria, da’ suoi vassalli, la sov-venzione dovuta secondo le consuetudini del regno, dovendo cingersi cavalieree poi in compagnia di Ruggiero (a) [sic] conte de’ Marsi e suo Vicario in Romaportarsi in quella città pro nostris servitiis».
(118) E. STHAMER, V. Lehensrestitutionen in der Basilicata. c.ca 1277, in ID.Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Königreich Sizilien imMittelalter, Hg. und eingeleitet von H. HOUBEN, mit Registern von A. KIESE-WETTER, Aalen, Scientia Verlag, 1994, p. 623.
(119) STHAMER, V. Lehensrestitutionen in der Basilicata, p. 624.
ria (120) tra il 1255 ed il 1266 (121); sicché non trova sufficientepatente di plausibilità la fedeltà di Riccardo per proprio partito aManfredi nella battaglia di Benevento, tramandata dagli Annaleszuritani, se non a patto di legarla unicamente alla situazione matri-moniale di costui, giacché i dati delle fonti dimostrano l’insussi-stenza di un vincolo di fedeltà su base patrimoniale.
Solamente infatti con l’avvento dell’Angioino e nel 1277, perordine di Ferrerium vel Sperronum, allora giustiziere di Basilicata,tali possedimenti ritornano definitivamente ai Loria, nella fattispe-cie, un Roberto, un Giacomo ed un Riccardo Loria. Il Giustiziereafferma infatti che su queste terre servivano per designazione dellacuria imperiale gli antenati dei Loria (122).
Quale legame parentale specifico intrattengano i personaggisovramenzionati con l’Ammiraglio del Vespro è arduo dirlo. Ancoraazzardato è infatti considerare Roberto un fratellastro di Ruggero,mentre maggiore ragionevolezza vi è nel ritenere i tre fratelli suoi ziipaterni e meno cugini o nipoti, non potendo considerare, a que-st’altezza, una nuova generazione adulta come discendenza propriadei tre fratelli.
Confermerebbe la prima ipotesi – quella cioè che individue-rebbe Roberto, Giacomo e Riccardo di Lauria quali zii paterni diRuggero – un documento angioino del 1306-1307 recante la Formacommissionis officii viceamiracie, che nell’ultimo capoverso annota:PRESCRIPTA [sic] forma concessa fuit de novo dom. Riccardo deLauria patruo dom. Rogerii de Lauria antiquitus tamen predecessori-bus fuit in alia forma concessa (…) (123).
Ciò spiegherebbe anche perché accanto agli stessi Iacopo (Gia-como), Roberto e Riccardo, un diploma angioino dell’8 gennaio1276, menzioni poi anche un Ruggero, quale signore di Lauria, diLagonegro e di Castelluccio. Il documento riferisce chiaramenteinfatti che Riccardo di Lauria presta servizio militare a Capua persé, per Giacomo, Roberto e Ruggero e aliis de Lauria, in ragioneappunto della titolarità dei sovramenzionati feudi.
La notizia è infatti qui doppiamente significativa, valida adimostrare cioè oltre il grado di parentela tra i quattro, anche la
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 45
(120) STHAMER, V. Lehensrestitutionen in der Basilicata, p. 624.(121) Secondo la data apposta al regesto del diploma perduto (cfr.
BRANTL, Studien zum Urkunden- und Kanzleiwesen König Manfreds von Sizilien,doc. 522, pp. 478-479).
(122) STHAMER, V. Lehensrestitutionen in der Basilicata, p. 623.(123) RCA, vol. XXXI, pp. 71-74, n. 41.
reintegrazione di Ruggero negli aviti possedimenti, per quanto eglinon fosse propriamente di stanza nel Regno (124).
Ferme infatti restando le riserve cautelari del caso, può esseredata come altamente probabile la coincidenza di identità tra il Rug-gero del diploma angioino del ’76 ed il Nostro, sulla base dell’unicoelemento ma abbastanza persuasivo per il quale, a questa data, lefonti non presentano doppioni omonimi a proposito di un Ruggerodi Lauria, così come invece si è riscontrato per più di un Riccardodi Lauria, quello di età federiciana cioè e l’ultimo di età angioina.
Nulla, infatti, vale l’incertezza generata da possibile confusio-ne onomastica a proposito del nostro Ruggero, il quale appare inogni caso distinto anche rispetto ad un Guglielmo Ruggiero di Lau-ria – con buona probabilità altro esponente collaterale della fami-glia – citato in un precedente documento del 26 giugno 1270, nelquale è riferito in forma di regesto che tal Guglielmo Ruggiero eraricorso al Re, insieme ad altri interessati, relativamente alla manca-ta quaternazione di un campo già oggetto di compravendita (125).
Quanto al valore economico delle terre, antichi possedimentidei Lauria (126) e la causa della confisca, il Giustiziere nulla dice disapere a riguardo. Su di esse vengono solo ribadite le prerogativecuriali e la giurisdizione dei Loria (127). Ma che in queste terre vifosse un sistema di insuffeudazione sembra più che certo, sia perquanto si diceva a proposito della designazione a cavaliere di Gia-como di Lauria alcune righe addietro, sia per ciò che si evincerebbe
46 ROSANNA LAMBOGLIA
(124) RCA, vol. XIII, p. 211, n. 65.(125) RCA, vol. IV, p. 164, n. 1093.(126) Dalla Cedola Taxationis generalis subventionis in Iustitieratus Basili-
cate [sic] e relativa ancora al 1277, si apprende che la terra di Lagonegro deveper 120 fuochi 30 once, quella di Lauria deve per 241 fuochi 40 once, 8 tarì e8 grani, in RCA, vol. XIII, pp. 310-314, n. 400. Sul confronto dei fuochi perciascun altro centro menzionato, si deduce per le terre di Lagonegro un popo-lamento medio e per Lauria un popolamento medio-alto. Su questi temi già ilG. RACIOPPI, Geografia e demografia della Provincia di Basilicata nei secc. XIII eXIV, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XV, 1890, pp. 565-582 eS.N. CIANCI, I campi pubblici in alcuni castelli del Medioevo in Basilicata. Studiogiuridico-feudale con documenti, Napoli, Tip. R. Pesole, 1891. Relativamente,invece, alle modalità di esazione dei vari distretti, le indagini propografichesono tuttora in corso; nondimeno, per i primi risultati, si vedano S. MORELLI,Giustizieri e distretti fiscali nel Regno di Sicilia durante la prima età angioina, inMedioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo, a cura diG. ROSSETTI e G. VITOLO, 2 voll, vol. 2, Napoli, Liguori Editore, 2000, vol. 1,pp. 301-323, segnatamente, pp. 303-312.
(127) STHAMER, V. Lehensrestitutionen in der Basilicata, p. 624.
da un altro diploma angioino perduto e transuntato dal De Lellis(128), nel quale si inviava al giustiziere di Val di Crati e di TerraGiordana, tra il 1278 ed il 1279, l’ordine di definire i confini delleterre sul versante meridionale del Giustizierato di Basilicata, evi-dentemente per il sorgere di controversie tra i vari piccoli feudatari,ivi titolari (129).
L’indagine condotta sulle fonti ha, dunque, mostrato una pre-coce separazione di storie personali tra Ruggero che vive alla cortearagonese ed i membri della sua famiglia, i cui esponenti in parterestano sicuramente di stanza nel Regno e diventano filo-angioini.
Già dal luglio 1269, infatti, re Carlo affida a Roberto di Lauriae ad Egidio de Vinetta il compito di catturare i ribelli del Giusti-zierato di Calabria, di Val di Crati e di Terra Giordana e di tenereprigionieri i principali proditori (130).
Dal settembre 1270 (XIV Indizione, anni 1270-1271), a Ro-berto di Lauria è quindi affidata anche la custodia di alcune strade e passi nel Giustizierato di Basilicata (131). La designazio-ne sanciva probabilmente una funzione esercitata già da qualchetempo, ma in via già formale, se precede nel Registro della XIVIndizione l’ordine di pagare le somme impiegate per la suddettacustodia e se, a Roberto, ci si riferisce come statuto super custodiastratarum et passuum Basilicate (132). In tale ruolo, egli viene poi
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 47
(128) Gli atti perduti della Cancelleria angioina transuntati da Carlo De Lel-lis, Parte I, Il regno di Carlo I, vol. I, a cura di B. MAZZOLENI, Roma, ISIME,1939 (Regesta Chartarum Italiae, XVII), p. 382, n. 96: «Terrisio de Gant milititenenti castrum Mercuri, Raynaldo et Fanuel tenentibus terram Ursomartis,Girardo de Arenis tenenti terras Brahalle et Sancti Donati, Rogerio tenenti ter-ram Berbicarii, Riccardo tenenti terram Sancti Blasii, et Giliberto tenenti terramPapasideri, provisio pro ponendis confinibus inter dictas terras (fol. 29 t.)».
(129) RCA, vol. XX, p. 248, n. 662. Quanto alle terre suffeudatarie facenticapo alla baronia di Lauria in un arco temporale compreso tra il 1269 ed il1343, si veda la carta Feudataires de Basilicate (1269-1343), approntata da S.POLLASTRI, L’aristocratie napolitaine au temps des Angevins, in N.-Y. TONNERRE
et E. VERRY (sous la direction de), Les Princes angevins du XIIIe au XVe siècle.Un destin européen, Actes des journées d’étude des 15 et 16 juin 2001 organi-sées par l’université d’Angers et les Archives départementales de Maine-et-Loire, Rennes, Presses universitaires de Rennes-Conseil général de Maine-et-Loire, 2003, p. 179. I dati archivistici elaborati cartograficamente individuano,nei confini della baronia di Lauria, le terre suffeudatarie di Lagonegro, Rivello,Trecchina, Avena (sulla costa tirrenica), Maratea, Papasidero, Rotonda nellavalle di Laino e Castelluccio.
(130) RCA, vol. II, pp. 100-101, n. 369 e p. 101, n. 372.(131) RCA, vol. VI, p. 197, n. 1036.(132) RCA, vol. VI, p. 89, n. 331.
riconfermato con un diploma del novembre successivo (XIV In-dizione, anni 1270-1271) (133) e nuovamente ricompensato dellespese sostenute, in un documento della XIV-XV Indizione (1271-1272) (134).
Oltre a ciò, Roberto di Lauria deve aver ricoperto per un certoperiodo anche la carica di inquisitore per la Calabria, se tale è de-signato insieme ad altri personaggi – tra cui lo stesso Egidio deVinetta, milite, citato poche righe innanzi – in un provvedimento,ancora del 1272, contro un tal Giacomo Ferramondo di Scalea (135).
La scelta di campo filo-angioina è poi ulteriormente evidentecon Riccardo di Lauria – con ragionevole probabilità anagrafica, ilminore dei tre fratelli Loria – citato, in un documento della VIIIndizione (1293-1294), quale capitano della gente di Laino Borgo,coinvolta negli episodi che avevano portato alla rottura della treguastipulata con i Catalano-siciliani, ben inoltrata cioè la guerra delVespro (136).
La figura di questo Riccardo di Lauria di età primo-angioina è poi oltremodo interessante per il biografo di Ruggero, poichémostrerebbe nuovamente come sia stata plausibile la sovrapposi-zione di notizie di cui si diceva all’inizio, poi riversatasi in vari tra-vasi bibliografici.
Per tradizione genealogica seicentesca, infatti, si è attribuito alRiccardo di Lauria di età sveva – padre, dunque, del nostro Rug-gero – un primo matrimonio con una Paliana di Castrocucco (137).Nondimeno, la documentazione archivistica attesta come sia statoparimenti il Riccardo di Lauria di età primo-angioina a contrarrematrimonio, nel 1277, con una Palearia de Castrocucco (138), figlia
48 ROSANNA LAMBOGLIA
(133) RCA, vol. VII, p. 18, n. 48.(134) RCA, vol. VII, p. 206, n. 157.(135) RCA, vol. XLIV, p. 550, n. 95.(136) RCA, vol. XLVII, p. 121, n. 372.(137) F. CAMPANILE, De’ nobili della famiglia di Loria, in ID., L’armi overo
insegne de’ nobili, Napoli, Stamperia Tarquino Longo, 1610 (recente, però, è laristampa anastatica, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 2007), pp. 67-71, alpunto, p. 67. Notizia poi ripresa in Memorie storico-genealogiche, pp. 14-15, eda qui passata a tutta la bibliografia otto-novecentesca, con o senza variazioneed aggiunte onomastiche del tipo: Palliana di Castrocucco, Paliana Pascale diCastrocucco o Palliana Pascale di Castrocucco. Cfr., a titolo esemplare, uno deipiù recenti tentativi di biografia su Ruggero: F. AUGURIO - S. MUSELLA, Ruggierodi Lauria. Signore del Mediterraneo, Quaderni dell’Associazione Mediterraneo,Lauria-Napoli, Associazione Mediterraneo, 2000, p. 25.
(138) RCA, vol. XIX, p. 250, n. 480.
di un tal Rinaldo, anch’egli signore feudale nel Giustizierato diBasilicata.
Ora, che vi fossero due donne con un nome molto simile, anziidentico, in età diverse ed appartenenti allo stesso ceppo familiare,è possibile, così come pure non fa specie che vi fossero due fratelliomonimi a distanza di generazioni, soprattutto se l’uno può esserestato il maggiore e l’altro il minore di una serie numerosa di figlisopravvissuti o prematuramente scomparsi. Nondimeno, queste sin-golari coincidenze non sgombrano il campo dalla eventualità che visia stata proprio una sovrapposizione di figure per via dell’omoni-mia. E che dunque debba essere quantomeno ventilato il dubbioche il padre di Ruggero fosse quel Riccardo di età sveva, tantoaccreditato dalla tradizione, e che tale anche si chiamasse.
La situazione documentale non consente di risolvere l’aporia suRiccardo, il quale sarebbe da indicare, a questo punto del discorso,più correttamente solo come presunto padre di Ruggero, secondoun’opzione metodologica che preferisce considerare i dati della tra-dizione e il perché del consolidarsi di una tradizione, rispetto allasoluzione più economica di Andreas Kiesewetter, secondo cui delpadre di Ruggero non si conosce il nome (139).
Analogamente, la medesima situazione documentale, mo-strando vuoti d’informazione difficilmente colmabili, non con-sente di gettare ulteriore luce sulle vicessitudini della famiglia diRuggero prima e dopo i fatti del Vespro, né permette di stabilireuna cronotassi genealogica certa ed inequivocabile tra i suoi mem-bri, se non a patto di accogliere le notizie delle fonti indirette, checitano e riferiscono di particolari ulteriori (140), oggi, non più evi-denti dai regesti dei Registri angioini ricostruiti.
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 49
(139) Cfr. KIESEWETTER (a cura di), Lauria, Ruggero di, p. 98.(140) In proposito, esemplare è il documento citato da Giacomo Racioppi,
opportunamente confrontato col regesto presente in RCA, vol. XIII, p. 211, n.65: «[Ruggero] Crebbe in corte di Aragona(…); ove il re gli die’ sposa unafigliuola dei Lancia, parenti della regina e zii a Manfredi; ed ivi si segnalò capi-tano di navi catalane in fatti audacissimi sopra i Saraceni(…). Ma vivendo in Ara-gona aveva suoi possessi feudali nel Napoletano: un diploma del 1275 di CarloII [sic] parla del servizio feudale prestato in Capua da Riccardo Lauria per sé,Giacomo, Roberto e Ruggiero, e per due donne della stessa famiglia che avevanodiviso tra loro i castelli di Lauria, di Lagonegra e di Castelluccio(…). Ci è noto daaltro titolo(…) che pel possesso dei castelli di Aieta e di Tortora surse litigio traRiccardo e Ruggiero; e fu composto con patto che, alla morte del primo, tornas-sero nel patrimonio della famiglia del secondo. La quale non ebbe il casato diCloria, come altri hanno detto (…), o per isbaglio, o per artifizi di genealogisti,
Eppure anche una situazione così lacunosa relativamente allafamiglia del Lauria, nelle uniche tessere che è possibile ricostruire,permette per un verso di superare la vulgata storiografia esistentesu Ruggero.
Conclusioni
La vulgata storiografica vuole infatti Ruggero di Lauria parti-giano filo-svevo secondo un vincolo di fedeltà alla casa degliHohenstaufen che si rafforza dopo la battaglia di Tagliacozzo (23agosto 1268) (141) e la conseguente esecuzione di Corradino,quando, cioè, con la definitiva affermazione del dominio di Carlo Id’Angiò in Italia meridionale, diventa consapevolezza la necessità dirivendicare l’eredità siciliana dell’erede legittima di Manfredi. Econ tale eredità, avocare parimenti i possedimenti dei Loria nelRegno ad un’altezza – il 1282 –, che invece lo spoglio delle fonti hamostrato in tutta la sua pretestuosità, giacché l’Angioino – lo si èappena visto – aveva, fin dal 1277, provveduto a reintegrare i Loriadei possedimenti confiscati sul finire dell’età federiciana.
Tale sentimento di fedeltà alla casa sveva, infatti, mantiene unasua plausibilità solo se viene diversamente connotato e riferito allanuova condizione vassallatica di Ruggero nel Regno catalano-arago-nese ed al rapporto intrattenuto con re Pietro, piuttosto che ad unsentimento nostalgico per la passata dinastia, o ancora a sentimentidi rivalsa contro l’Angioino.
In terzo luogo, la medesima lacunosità delle fonti relativamenteal legame parentale paterno, mette in risalto quello materno e conesso induce ad una riflessione anche sui rapporti di natura politico-feudale della breve età di Manfredi e sulle strategie di potereattuate da costui (142), quando cioè sul finire dell’età sveva, per
50 ROSANNA LAMBOGLIA
ma sì di Lorìa, che è parola stessa di Laurìa, con fonetismo francese, come è rite-nuto fosse pronunziato il temuto nome nella corte francese dei re angioini(…)»,in G. RACIOPPI, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, Ristampa ana-statica dell’edizione di Roma 1902, Deputazione di Storia Patria per la Lucania,Roma 1970, (1a ed., Roma, Loescher, 1889), 2 voll., vol. 2, p. 180.
(141) Cfr. P. HERDE, Die Schlacht bei Tagliacozzo, Eine historisch-topogra-phische Studie, «Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte», 25, 1962, pp.679-744.
(142) In proposito, si rimanda, soprattutto alle ricerche di E. PISPISA, Ilregno di Manfredi. Proposte di interpretazione (vd. nota n. 35) e ID., I Lancia, gliAgliano e il sistema di potere organizzato nell’Italia meridionale ai tempi di Man-fredi, in Bianca Lancia D’Agliano, pp. 165-181, e segnatamente, pp. 165-173 (ri-
fronteggiare un baronaggio nuovamente in espansione e al fine dipoggiare il potere del nuovo sovrano su ristretti e fedeli clan nobi-liari (in prima linea, i Lancia), si spostò, inequivocabilmente, l’assepolitico e decisionale dalla Sicilia al Continente, determinando, nonin ultimo, l’emarginazione dei ceti dirigenti locali siciliani e la pro-mozione di quelli continentali (143).
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 51
stampato anche in ID., Medioevo meridionale. Studi e ricerche, Messina, IntillaEditore, 1994, pp. 121-144). Sulle dinamiche politiche messe in circolo da Man-fredi all’indomani della morte di Federico II, volte a costituire un nucleo dibaroni fedelissimi, si veda anche il precedente articolo di M. FUIANO, Vicendepolitiche e classi sociali in Puglia dopo la morte di Federico II nelle cronache delcosiddetto Jamsilla e di Saba Malaspina, «Archivio Storico Pugliese», XXX, 1977,pp. 155-167 [ma anche in Atti delle quarte giornate federiciane (Oria, 29-30 otto-bre 1977), Bari, Grafica Bigiemme, 1980 (Società di Storia Patria per la Puglia,Convegni, X), pp. 81-93]. In attesa che vengano pubblicati gli atti delle XIXGornate normanno-sveve, svoltesi a Bari dal 12 al 15 ottobre 2010 e dedicateproprio a questi temi – ovvero Eclisse di un Regno. L’ultima età sveva (1251-1268) –, una discussione dello stato delle ricerche condotte sino ad ora è in E.PISPISA, Federico II e Manfredi, in Federico II e le nuove culture, Atti del XXXIConvegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 1994, Spoleto, CISAM,1995, pp. 303-31 (poi, ristampato anche come ID., L’eredità dell’imperatore:Federico II e Manfredi, in ID., Medioevo Fridericiano ed altri scritti, Messina,Intilla Editore, 1999, pp. 179-192). A dispetto del titolo, un confronto tra ladistanza tra Manfredi e Federico II che lo pseudo-Jamsilla intese tracciare nellasua Cronaca è pure l’articolo di F. DELLE DONNE, La cultura di Federico II: genesidi un mito. Il valore della «memoria» e della «philosophia» nell’«Historia» dellopseudo-Jamsilla, in ID., Politica e letteratura nel Mezzogiorno medievale. La crona-chistica dei secoli XII-XV, Salerno, Carlone Editore, 20042 (1a ed. 2001; Immaginidel Medioevo, 4), pp. 75-109. Vastissima è la bibliografia sulla casa sveva perpoterne dare, qui, una informazione esaustiva. Valgano, in questa sede, sola-mente alcuni riferimenti, utili per una puntualizzazione dello stato degli studi: E.PISPISA, Gli Svevi nel Sud. Un bilancio dal punto di vista italiano, in Die Stauferim Süden. Sizilien und das Reich, hg. von T. KÖLZER, Sigmaringen, J. ThorbeckeVerlag, 1996, pp. 229-238 (ma successivamente ristampato con pochi migliora-menti formali come ID., Gli Svevi nel Mezzogiorno d’Italia, in ID., Medioevo Fri-dericiano, pp. 85-98), T. KÖLZER, Die Staufer im Süden – eine Bilanz aus Deut-scher Sicht, ancora in Die Staufer im Süden, pp. 239-262 e M. DEL TREPPO, Tramiti e ricerca storica, in Nel segno di Federico II. Unità politica e pluralità cultu-rale nel Mezzogiorno, Atti del IV Convegno internazionale di studi della Fonda-zione Napoli Novantanove, prefazione di M. DEL TREPPO, Napoli 30 settembre -1 ottobre 1988, Napoli, Bibliopolis, 1989, pp. 11-28. Su Manfredi una rassegnacompleta ed esaustiva degli studi è in E. PISPISA, Manfredi nella storiografia del-l’Otto e Novecento, in Mediterraneo medievale. Scritti in onore di FrancescoGiunta, a cura del Centro di studi tardoantichi e medievali di Altomonte, Sove-ria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore, 1989, 3 voll., vol. 3, pp. 1017-1044(anche in ID., Medioevo meridionale. Studi e ricerche, pp. 55-88).
(143) L’estraneità dell’Isola alle nuove direttive politiche si era già manife-stata con Federico II e, prima ancora, con Enrico VI. In proposito, si leggano i
Difatti, attraverso una serie di concessioni feudali un po’ ovun-que nel Regno di Sicilia e nell’apparato amministrativo, Manfrediponeva un gruppo familiare di indubbia fedeltà – soprattutto i Lan-cia e gli Agliano – a perno e garanzia del proprio potere, raffor-zando uno statu quo nel Regno che vedeva segnatamente i Lan-cia già attivi per proprio partito in una fitta rete di legami parentalicon la piccola nobiltà regnicola, avendo sapientemente maritato ledonne dei rami cadetti prima e dopo l’avvento di Manfredi (144).Pertanto l’età manfrediana (145) rimane cruciale ai fini della com-prensione delle dinamiche interne al Regno, poiché viene a definirein un brevissimo torno di anni – circa un terzo dell’età federiciana– una nuova geografia del potere baronale, in specie nella partecontinentale – giacché qui si concentravano prevalentemente gliinteressi di Manfredi –, ma pure nella stessa Sicilia, mediante lapromozione di una nuova nobiltà cittadina, legata ai Maletta e tra-mite questa ai Lancia-Agliano (146).
Da questo contesto esce diversamente connotato pure il temadel cosiddetto fuoriuscitismo (147). Occorre in proposito ricordarecome l’affermazione monarchica nel Regno di Sicilia avesse, già inprecedenti circostanze, creato una fazione di nobili ostili ad essa,che divennero perno di macchinazioni contro l’autorità centrale che
52 ROSANNA LAMBOGLIA
saggi di E. PISPISA, La Sicilia federiciana e ID., Migrazioni e realtà cittadine nellaSicilia fridericiana, ora, entrambi in ID., Medioevo Fridericiano ed altri scritti,rispettivamente, pp. 147-166 e pp. 167-177, oltre alla ormai imprescindibileLettera ad un tesoriere di Palermo sulla conquista sveva in Sicilia, a cura di S.TRAMONTANA, Palermo, Sellerio Editore, 1988, pp. 122-127.
(144) PISPISA, Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, pp. 49-50 e55-72; ID., I Lancia, gli Agliano e il sistema di potere organizzato nell’Italia meri-dionale ai tempi di Manfredi, pp. 178-179.
(145) Più in generale, sull’età manfrediana, vi è la raccolta di saggi varia-mente articolati di P.F. PALUMBO, Contributi alla storia dell’Età di Manfredi,Roma Le edizioni del lavoro, 1959. Nello specifico, su Manfredi si vedanoancora i saggi in ristampa anastatica di A. FRUGOLI, Scritti su Manfredi, con unapresentazione di E. PISPISA, Roma, ISIME, 2006 (Nuovi studi storici, 72), F.GIUNTA, Manfredi e Manfredonia, in ID., La coesistenza nel Medioevo, Bari,Dedalo Libri, 1968, pp. 81-96, ma su Manfredi, segnatamente, pp. 84-89.
(146) PISPISA, Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, pp. 66-67; L.GATTO, Sicilia e siciliani nell’opera di Jamsilla, in ID., Sicilia medievale Siciliamedievale. Eventi e personaggi di un’isola che ha rappresentato nei secoli dell’età dimezzo il crocevia tra Occidente, Oriente bizantino e mondo arabo, Nuova edizioneaggiornata, Roma, Newton Compton Editori, 2002 (1a ed. 1992), pp. 92-108.
(147) Per quanto il racconto sia molto enfatizzato, il passaggio di moltifilo-svevi agli Angioini veniva già sottolineato da M. AMARI, La guerra delVespro, a cura di F. GIUNTA, Palermo, Flaccovio, 1969, 3 voll., vol. I, pp. 84-85.
furono punite duramente già da Ruggero II (148) e poi dai suoisuccessori sino a Federico ed in specie negli ultimi anni del regnodi quest’ultimo (149) e poi quindi anche da Manfredi (150), insostanza determinando esecuzioni, confische ed esilî ai danni dellafeudalità autoctona o anche di recente promozione, che attentava alpotere dei sovrani della casa normanna e sveva (151).
Il problema si ripropose e si aggravò ancora con l’affermazioneangioina del 1266, che portò soprattutto dopo la sollevazione del1268 alla condanna di alcuni esponenti delle famiglie più legate al-la casa di Svevia e quindi rimpolpò, su schieramento opposto, ilgruppo di nobili puniti o esiliati. Tra questi, spicca da sempre ilnome esemplare di Giovanni da Procida – grande tessitore e media-tore al servizio degli svevi prima, ancora per un breve periodo sotto
TESSERE DOCUMENTALI PER LE ORIGINI DELL’AMM. RUGGERO DI LAURIA 53
(148) In merito, si veda H. HOUBEN, Ruggero II di Sicilia. Un sovrano traOriente e Occidente, traduzione di F. PANARELLI, Roma-Bari, Editori Laterza,1999 (ed. or. H. HOUBEN, Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient undOkzident, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997), pp. 79-89. SuRuggero II, si veda nondimeno la biografia di E. CASPAR, Ruggero II (1101-1154) e la fondazione della monarchia normana di Sicilia, con un saggio intro-duttivo di O. ZECCHINO, traduzione italiana di L.M. IACONO e M. MUSETTI, con-sulenza di M. MARSCH, Roma-Bari, Editori Laterza, 1999 (ed. or. E. CASPAR,Roger II. 1101-1154, und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie,Innsbruck, Verlag der Wagner’schen Universitats-Buchhandlung, 1904).
(149) Manca, in proposito, una ricerca prosopografica sul bando e sul con-fino politico per l’età di Federico II, se non a patto di rintracciare elementi distudio in pubblicazioni di varia tematica. L’interesse si infatti è per lo più con-centrato sul dissenso delle città all’interno, come all’esterno del Regno di Sicilia.In proposito, si vedano: F. BOCCHI, L’autonomia e la repressione: castelli urbani ecittà nel Regno di Sicilia in età federiciana, in Atti delle quinte giornate federiciane(Oria, 10-12 ottobre 1980), s. l., Puglia Grafica Sud, 1983 (Società di StoriaPatria per la Puglia, Convegni, XV), pp. 75-97; il lemma Bando e confini politici,a cura di G. MILANI, in EF, vol. 1, pp. 141-144, che insiste invece particolar-mente sui provvedimenti ai danni delle città settentrionali ribellatisi all’autoritàdell’Imperatore; un quadro necessariamente sintetico, sebbene preciso e indica-tivo delle potenzialità di uno studio monografico è V. D’ALESSANDRO, Ceti diri-genti e forze sociali nel Regno di Sicilia di Federico II, in Medioevo MezzogiornoMediterraneo, vol. I, pp. 267-281, mentre più ricca indagine sulla nobiltà e sullapromozione di singole individualità è il lavoro di E. CUOZZO, La nobiltà dell’Ita-lia meridionale e gli Hohenstaufen, Salerno, Gentile Editrice, 1995.
(150) PISPISA, Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, pp. 211-212.
(151) Esemplari, in proposito, sono le vicende individuali di Maione diBari al tempo dei re normanni Ruggero II e Guglielmo I, e di Pier delle Vignesotto Federico II, ma non meno trascurabili furono le sollevazioni di singolecollettività municipali, che di volta in volta avversarono tanto i sovrani nor-manni, quanto gli Svevi.
gli stessi Angiò ed infine presso gli Aragonesi –, e dei vari Lancia edella nutrita schiera evidenziata dalla Wieruszowski (152), nellaquale fa capolino lo stesso Ruggero.
Sarebbe però parziale, a riguardo, issare l’esclusiva bandiera delfuoriuscitismo filo-svevo di singoli ed eminenti personaggi, poichél’iniziale politica angioina di controllo del territorio non solo punivanell’immediato la fazione filo-sveva al di qua e al di là del fiumeSalso, ma frizionava con tutta una piccola nobiltà locale insediatanel breve regno di Manfredi e che si era localmente avvantaggiataproprio mediante quella rete di rapporti incrociati con i maggio-renti filosvevi, vale a dire i Lancia, gli Agliano, gli Agliano-Sem-plice, i Maletta poc’anzi accennati.
Ancora sul tema del fuoriuscitismo, l’avvicendamento dei Lorianei feudi continentali del Regno è ulteriore indizio a favore del ridi-mensionamento della politica del primo degli Angiò, poi sussuntanella vulgata storiografica di matrice siciliana – estremamente esem-plificatrice – del malgoverno angioino, lasciando intravedere, all’op-posto, una dinamica politica molto più sottile da parte di Carlo, perla quale, ad un primo momento volto ad immettere strategicamen-te nel Regno una burocrazia provenzale a lui fedele, ne segue unsecondo che vuole e persegue invece, lungo una linea legittimista, ilreintegro di quanti erano stati penalizzati dalle confische sveve.Questa politica, infatti, può bene intendersi come una risposta sulterreno delle azioni concrete, intese a governare un Regno cheCarlo voleva pacifico, sebbene a lui sottomesso, soprattutto dopo laseconda sollevazione filo-sveva al seguito di Corradino.
ROSANNA LAMBOGLIA
54 ROSANNA LAMBOGLIA
(152) WIERUSZOWSKI, La corte di Pietro D’Aragona e i precedenti dell’im-presa siciliana, pp. 141-162.


















































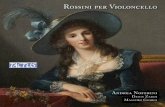




![[con D. Bucca] Per lo studio delle origini della Paracletica: alcuni testimoni antiquiores d’ambito orientale e italiota, in Bisanzio e le periferie dell'Impero. Atti del Convegno](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63209238c5de3ed8a70dc99c/con-d-bucca-per-lo-studio-delle-origini-della-paracletica-alcuni-testimoni-antiquiores.jpg)





