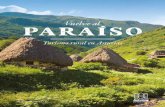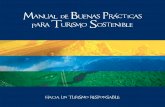Le origini del Turismo a Pontedilegno
Transcript of Le origini del Turismo a Pontedilegno
3
Indice Premessa .............................................................................................. 5 Ponte di Legno alla metà dell’800 ....................................................... 7
La prima accoglienza ......................................................................... 13 L’Alpinismo ....................................................................................... 21
I Rifugi ........................................................................................... 21 Le guide e i portatori ...................................................................... 24
Le acque di S. Apollonia .................................................................... 29 Le prime strutture alberghiere ............................................................ 37
L’albergo Maculotti a Pezzo .......................................................... 37 L’albergo delle Alpi di Panzarini ................................................... 39 L’albergo Tonale ............................................................................ 40 Il Barattieri ..................................................................................... 42 Le Canossiane ................................................................................. 43 Il Grande Albergo ........................................................................... 44 Il boom turistico di Ponte di Legno ................................................ 46
Lo Sci: gli esordi ................................................................................ 51
Il periodo successivo alla prima Guerra mondiale ............................. 57 Nuovi alberghi, trattorie, negozi ..................................................... 57 Il Comitato per l’Amministrazione dell’Azienda Autonoma ......... 58 La “bella vita” ................................................................................. 60
Bibliografia ........................................................................................ 67
5
Premessa Difficile oggi per un giovane di Ponte di Legno immaginare com’era il suo paese 150 anni fa. Una scarsa dimestichezza con il passato porta a pensare che il comune dell'alta valle viva da tempo immemorabile soltanto, o per lo più, di turismo. Nulla di più falso. Il turismo è economia relativamente recente, perché i dalignesi erano, pressoché tutti, nient’altro che pastori. Gente civile, ma abituata a trattare più con le bestie che con gli uomini, e ben lontani da quelle predisposizioni (non sempre genuine) all’accoglienza e all’ospitalità, che sono la materia prima del turismo. La nascita del turismo, così come la conosciamo ora, è il risultato di una serie di fattori sociali ed economici che vengono a maturazione a fine ottocento. E’ solo allora, infatti, che si fanno sentire i primi effetti dell’incipiente rivoluzione industriale, che rende più agiati non solo i vecchi aristocratici, ma anche la nuova borghesia imprenditoriale e commerciale. Da non dimenticare, inoltre, la maggiore facilità a muoversi, indotta dal cambiamento del sistema di trasporti, dovuto principalmente al ramificarsi del sistema ferroviario, che toccherà anche l’alta Valcamonica nel 1909. Dobbiamo pensare anche alla rivalorizzazione delle potenzialità terapeutiche delle acque “ferrugginose” di Sant’Apollonia, in Val delle Messi, che già costituivano motivo di mobilità nell’antica società romana, ma che poi erano state ignorate per lunghi secoli per motivi sociali, culturali e religiosi. E che dire, infine, della “scoperta” della montagna, come luogo adatto
6
per distendersi, curarsi, esplorare, forse anche in contrapposizione alle nascenti fumose periferie delle città industriali. Ma, accanto alla trasformazione della vita cittadina, si fa largo il cambiamento della società anche nella antica “comunità” di pastori. Si comincia ad intravedere la possibilità di un’occupazione remunerata, non solo in natura, ma con un vero e proprio salario. Si comincia a pensare e a constatare che la pastorizia e la pratica della transumanza non sono più (posto che lo siano mai state completamente) accettate nel sistema produttivo della pianura padana. Cominciano in definitiva a crearsi alcuni presupposti economici e sociali (impensabili qualche decennio addietro) di uno sviluppo economico ... diverso.
7
Ponte di Legno alla metà dell’800
Immagine di una cartolina spedita il 9 agosto 1904: la strada del Tonale è ben visibile per la mancanza di vegetazione (l’inaugurazione della strada che conduce in Tonale risale al 1880) L’alta Vallecamonica, e Ponte di Legno in particolare, è sempre stata una terra di confine: a soli dieci chilometri il Passo del Tonale, fin dai tempi antichi, ha costituito il passaggio obbligato per molti viandanti. Ma erano viandanti di passaggio, nessuno si fermava in quello sperduto paesello, il business qui non era ancora arrivato, e non vi era motivo di soggiornare tra quelle vecchie case se non giusto il tempo per passarvi una notte e consumare un magro e povero pasto, prima di
8
affrontare la salita del Tonale, o dopo esservi scesi per andare verso Brescia o Bergamo. Ponte di Legno era molto diversa da come oggi la vediamo.
Cartolina della Tipografia Pandini di Brescia, spedita il 6 agosto 1912
Ma la “diversità” non è data soltanto dal fatto che vi erano molto più spazi verdi, rispetto ad oggi, e quindi molte meno costruzioni; le case stesse erano diverse. Prima del grande incendio che devastò il paese nel 1917, a seguito del bombardamento operato dagli austriaci nel corso della prima guerra mondiale, i tetti delle case non erano in coppi, ma in tavole di legno. Qui sotto vediamo un tipico esempio di casa con tetto in paglia e scandole. E' una delle case di via Carettoni, appena sotto il ricovero. Si noti la parete annerita dal fumo che esce dalla porta della cucina: la casa rurale non aveva infatti i camini. L'immagine è del 1911, e
9
quindi precedente lo scoppio della Grande Guerra. Bellissima l'immagine di Ponte di Legno della fine dell'800 che esce dalla penna di Francesco Orazio Serale, maestro di Ponte di Legno. Egli, sulla rivista che usciva settimanalmente nel periodo estivo negli anni '20, e che aveva titolo, appunto, “Ponte di Legno”, il giorno 25 agosto 1928 scriveva un interessante articolo dal titolo “Allora e oggi”. Il maestro Serale ricorda come era Ponte di Legno ai primi del ‘900, quando egli iniziò a frequentare il paese per ragioni del proprio ufficio. Egli ricorda quanto fosse duro raggiungere Ponte di Legno. Egli arrivò, infatti, “colle ossa peste e tutte intormentite per lo sballottamento subito durante sette ore di viaggio. L’automobile che oggi strepita e trombetta un po’ dovunque svegliando tutti gli echi dei nostri monti, a quei tempi era cosa, non dico molto rara, ma quasi invisibile fra questi buoni alpigiani”. Ricorda ancora che il passeggero che volesse raggiungere Ponte di Legno, doveva scendere dal treno a Breno, ultima stazione della Valcamonica, e salire quindi sulla diligenza. Il viaggio era assai scomodo, perché i passeggeri erano costretti ad un gran “pigia pigia e ai ... non gaietti sobbalzi della stridula diligenza, nonché al ritmico ‘va là’ dell'automedonte il quale rinforzava spesso il grido incitatore con certi sibilii di frusta che ti foravano il cervello”. Giunti a Edolo i viaggiatori si dovevano fermare per la notte. Il mattino successivo si partiva di buon ora per arrivare alla tanto agognata meta solo a mezzogiorno. Il maestro Serale ci racconta che all’alba del ventesimo secolo Ponte di Legno aveva abitazioni costruite con una certa cura, “parecchie potevano anche classificarsi tra le civili. Ma la maggior parte erano
10
tozze, panciute, nimicissime d’ogni simmetria, col tetto ricoperto di scandole, vale a dire di assicelle strettamente commesse tra loro, oppure di gran lastre di pietra chiazzate di musco, le quali proteggevano - coi buoni inquilini - i bei cumuli di fieno o le cataste di legna allogate nei piani superiori: fieno e cataste che, per le aperture praticate nell’immediato sotto tetto, curiosavano piacevolmente sulla via, con quanto vantaggio per l’estetica paesana ognuno può immaginare. Fendimenti e scrostature se ne vedevano un po’ per tutto: qua stillicidio di gronde, quando v’erano gronde, là scalette di legno che s’arrampicavano tremando lungo i muri esterni degli abitati, più su certi poggioli sganasciati essi pure di legno, che eran per sé soli veri trattati dell’equilibrismo perfetto, più oltre nuvolette azzurrine di fumo che, per l’assenza di comignolo, scaturivano giocondamente dagli usci e dalle finestre. Pochissimo dirò delle strade. Fatta eccezione per quella che attraversa la piazza, la quale non è che il proseguimento della via nazionale, e (con un pochino di buon volere) esclusa anche la stradetta che s’arrampica verso la chiesa, le altre eran vicoli dalle curve inverosimili, tutte rialzi e depressioni, sognanti da qualche decennio un indispensabile riattamento. Vi si respirava un’aria non sempre purissima per le esalazioni delle stalle che pullulavano un po’ per tutto; vi correva una penombra grigia ed uniforme per ristrettissimo spazio interposto fra le due ali dei caseggiati. Anche quella che s’intitolava allora pomposamente la piazza del paese, e che ritiene pur oggi a un dipresso, le linee primitive, si riduceva a ben povera cosa: uno spiazzo modestamente selciato, circoscritto da costruzioni vecchie irregolari, di cui le principali erano il palazzotto del Comune, ed un certo casamento lungo, chionzo, tutto giallastro, dall’aspetto quasi conventuale: la
11
locanda, diremo così centrale del paese. Quest’ultimo (si tratta evidentemente dell’albergo Battistazza, bruciato nel settembre 1917, a causa del bombardamento austriaco, e non più ricostruito, n.d.a.) occupava gran parte di quella che fu poi l’area della piazza, dove sorgono attualmente l’edicola dei giornali e la bella fontana dal grazioso motto latino: ‘Tu bibis, ipse gemo’: accostati, o viandante, tu bevi, io ti reco l’acque purissime delle nostre sorgenti”. Abbiamo già detto che i dalignesi erano in maggior parte dediti alla pastorizia. Ai primi di ottobre gli uomini se ne andavano quasi tutti verso la pianura (il cremonese e il lodigiano soprattutto), che raggiungevano in circa dieci giorni. A Ponte di Legno rimanevano i bambini, i vecchi e le donne. I pastori rientravano in paese solo a maggio inoltrato. Ben pochi erano coloro che restavano in paese per svolgere lavori diversi: alcuni erano dediti a lavori del ferro, soprattutto per la fabbricazione di arnesi da lavoro. Altri lavoravano alla follatura dei panni, altri ancora nell'agricoltura, anche se i risultati erano veramente magri. In sostanza a Ponte di Legno regnava la povertà e si viveva con molta fatica.
13
La prima accoglienza E' solo dalla metà dell’800 che si può parlare di nascita del turismo in alta Vallecamonica. E non fu certo grazie all’intraprendenza di qualche spericolato sognatore dalignese, ma per quella nuova passione che aveva contagiato soprattutto inglesi e tedeschi: l’alpinismo. E' pur vero che qualche osteria e qualche bettola esistevano già a Ponte di Legno e a Pezzo, ma non si può certo parlare di “accoglienza turistica” fino alla seconda metà del diciannovesimo secolo. Sappiamo per certo, ad esempio, che Omobono Zuelli, alla fine del ‘700, nella sua casa di Pezzo, proseguendo un’attività ereditata dal padre, gestiva un’osteria, in cui mesceva buon vino, e dava ospitalità ai viandanti, macellava carne e vendeva un po’ di tutto. Il 25 febbraio 1807 il responsabile del Dazio di Edolo autorizzava Zuelli a tenere nella sua casa, sita nell'attuale via Tognali a Pezzo, plurime attività: “Si concede licenza al signor Omobono Zuelli di vendere nella sola di lui casa di abitazione, posta nella terra di Pezzo, vino all’ingrosso ed al minuto dal primo marzo prossimo venturo a tutto dieci novembre 1809. Resta pure libero allo stesso sig. Zuelli anco la macellazione per il solo uso però della di lui osteria e della terra di Pezzo e non altrimenti. Calvo Calvi abboccatore del Dazio consumo del cantone di Edolo”. Non risultano invece alberghi a Pezzo, quanto meno, fino al 1890, quando aprì i battenti l’albergo Maculotti, di cui parleremo.
14
A Ponte di Legno, invece, risulta che a metà '800 qualche primitiva accoglienza turistica fosse già presente. Nel 1853 Agostino Caggioli accenna alla presenza di due alberghi, il Battistazza e il Faustinelli1.
L’albergo - trattoria Battistazza venne distrutto dal bombardamento austriaco del 1917 L’albergo Battistazza si trovava sulla odierna piazza XXVII Settembre, dove oggi è situata una grande libreria. “L’Indicatore”, annuario guida della Valle Camonica, nella edizione del 1907, lo indicava tra gli alberghi di Ponte di Legno. Era allora gestito da Domenico Faustinelli. L’Albergo Battistazza andò del tutto distrutto nel 1917 durante l’incendio provocato dal bombardamento austriaco, e non fu mai più ricostruito. L’albergo Faustinelli, invece, si trovava sulla strada per il Tonale, a tre chilometri dal passo, e nel 1914 era di proprietà del Grand Hotel di 1 da Enciclopedia Bresciana, ed. La Voce del Popolo, 1996, vol. XIII, pag. 294
15
Ponte di Legno.
L’albergo Faustinelli in una cartolina del 1908
Come dicevamo, a metà '800 erano giunti a Ponte di Legno i primi alpinisti inglesi e austriaci, i primi portati soprattutto dalla passione, e attirati qui dalla bellezza delle nostre montagne. Da non dimenticare che la stragrande maggioranza delle cime, fino ad allora, era ancora inviolata. Nel 1873 il grande alpinista inglese Douglas William Freshfield, dopo una prima e fugace visita a Ponte di Legno compiuta nel 1864, passò nuovamente in paese. Molto interessante è quanto egli annota descrivendo le nostre zone.
16
Proveniva da Santa Caterina e transitò dal passo Gavia. Egli lo descrive “un cupo portale delle bellezze di Santa Caterina. La sommità è una selvaggia e desolata piana, triste anche col bel tempo, abbastanza pericolosa nelle tormente invernali”. Quindi l’alpinista arrivò finalmente a Ponte di Legno. Egli lo descrive come “un villaggio meschino (l’autore utilizza il termine inglese ‘shabby’, che significa letteralmente ‘in cattivo stato’,
‘miserevole’) e nel 1864 la sua locanda era in carattere. Da allora, in verità, vi è stato un miglioramento e ora un bell’albergo di paese2 offre un comodo punto di partenza per i viaggiatori che desiderano attraversare il Passo di Pisgana, il più facile fra quelli che conducono alla testata della Val di Genova e Pinzolo”. Freshfield racconta di essersi rifocillato con “un banchetto a base di acqua calda profumata col pepe e seguita da vitello lesso”3. Gli alpinisti austriaci arrivarono a Ponte di Legno soprattutto per ragioni militari. La zona, al confine tra l'Italia e l'Austria, separate soltanto dal Passo del Tonale e dalle montagne circostanti, rivestiva evidentemente una importanza strategica fondamentale. Alcuni ufficiali austriaci furono, quindi, spediti in zona non solo perché appassionati di montagna e provetti scalatori, ma anche e soprattutto perché effettuassero rilievi altimetrici, e perché 2 si tratta con ogni probabilità del citato albergo Battistazza 3 Douglas W. Freshfield, Italians Alps, London 1875, nella traduzione curata dalla S.A.T. di Trento, con il volume Le Alpi Italiane, 1971, pagg. 99-101
Douglas William Freshfield (Londra, 27.4.1845 – Forest Row, 9.2.1934)
17
descrivessero versanti, cime, valli, ecc. Notizie che potevano rivelarsi fondamentali in caso di attacco al territorio italiano o di difesa nel caso contrario. Nella zona dell'Adamello e dell'Ortles Cevedale gli austriaci inviarono un grande alpinista, Julius Payer, la cui fama fece modo che il suo nome venne dato ad una cima delle nostre montagne . Dal 1864 al 1868 il Payer effettuò numerose esplorazioni di carattere alpinistico nei due gruppi montuosi dell'Adamello e della Presanella. In questo periodo egli si trovò costretto a gareggiare con altri celebri alpinisti dell'epoca, e tra questi proprio con il già citato Douglas William Freshfield. D’altra parte, come abbiamo già ricordato, le vette dei due gruppi montuosi erano praticamente tutte inviolate.
Julius Johannes Ludovicus von Payer (Schönau, 2.9.1841, Veldes, 19.8.1912)
18
Il 16 settembre del 1864, assieme a due guide della Val Rendena, Girolamo Botteri e Giovanni Caturani, egli conquistò, per primo, la vetta dell'Adamello (3539 m). Quello che ha più dell’incredibile è che il giorno successivo, Payer cercò, accompagnato dal solo Botteri, di raggiungere anche la vetta della Presanella (3558 m). Egli in effetti giunse sulla cima, in condizioni meteorologiche terribili, ma scoprì di essere stato preceduto da altri alpinisti, tra i quali proprio il suo più acerrimo antagonista, il Freshfield, che avevano scalato la montagna tre settimane prima, il 27 agosto. In una delle sue escursioni nel gruppo dell’Adamello, compiute nel 1867, egli decise di fermarsi a Ponte di Legno, e più precisamente a Pezzo. Payer dichiara di essere stato accolto nell’osteria di Pezzo di ritorno dal ghiacciaio del Dosegù, insieme alla guida di Solda Giovanni Pinggera. Stanchi ed in stato “piuttosto miserevole” i due alpinisti furono rifocillati dall’oste di Pezzo con minestra, tante uova, pane e salame, e molto vino4. Con ogni probabilità l’osteria era di proprietà del sig. Domenico Maculotti, di cui molte testimonianze documentali sono rimaste. Nella propria casa, infatti, il Maculotti aveva un’osteria, nella quale si mesceva vino, si giocava a carte e si riunivano i capifamiglia di Pezzo per “questioni importanti”. Ma l’oste Domenico non mesceva solo vino, faceva anche buona e sostanziosa cucina. Suo figlio Remigio racconta5 di due cacciatori cremonesi che si fermarono a cena all’osteria. Furono accolti da Domenico Maculotti con uno dei più classici «Restino serviti 4 Il passo citato è tratto da Escursioni Alpine di Julius Payer, nella traduzione di Miriam Torneri 5 Mario Berruti, Cronache di Pezzo, ed. Grafo, 1994, vedi l’episodio “La caccia”.
19
signori». Questi non si fecero pregare e ben presto si sedettero a tavola. Remigio prosegue nel racconto: “Vennero portati dei salati per antipasto, minestra col manzo, fritti in abbondanza, con i nostri saporiti vitelli; non mancava il croccante”.
21
L’Alpinismo I Rifugi Nella seconda metà dell’800 furono vari gli alpinisti che salirono fino a Ponte di Legno e in Tonale per effettuare escursioni e ascensioni. Tra il 1854 e il 1864 troviamo “in zona”, oltre ai già citati Julius Pajer e a Douglas William Freshfield, anche il grande Karl Schultz. In tale periodo vennero scalati, per la prima volta, il Gran Zebrù, il San Matteo, il Tresero, il Lago Scuro, l’Adamello e la Presanella.
Il primo rifugio in territorio bresciano: il Salarno
Dopo le prime ascensioni, gli alpinisti stranieri, ed anche italiani, arrivarono sempre più numerosi in alta valle. Si rese così necessaria la costruzione di rifugi d’alta montagna, che potessero accogliere gli alpinisti prima e dopo la scalata. Il CAI di Brescia costruì il suo primo rifugio alla testata della valle
22
Salarno. Qui gli alpinisti potevano fare base per la salita sull’Adamello. Era il mese di agosto 1881 quando l’allora presidente del CAI di Brescia Giovanni Duina stipulava il contratto per la edificazione del rifugio Salarno con l’imprenditore Giovanni Andrea Boldini. Il Boldini si mise subito al lavoro e il 1° agosto 1882 l’edificio era finito, ma fu solo il 25 agosto 1883 che venne ufficialmente inaugurato. Fino ad allora al rifugio non era stato dato un nome, perché era semplicemente conosciuto come “Ricovero Alpino” o “Baita dell’Adamello”. Con l’inaugurazione venne scelto il nome di “Rifugio Salarno”.
Il Rifugio Tonolini, posto a m. 2450 s.l.m., fu edificato il 24 agosto 1891, ma allora aveva la denominazione di "Capanna Baitone al Lago Rotondo". Il rifugio venne ampliato ed anche migliorato nel 1886. Nel successi-vo inverno del 1887 l’edificio venne investito da una valanga. Quel
23
che ne rimaneva venne riportato alla luce solo 18 mesi dopo. Si deci-se di riedificarlo, ed offrì riparo e conforto agli alpinisti ancora per al-tri dieci anni, prima di essere definitivamente abbandonato. Nel 1908, poco distante dai ruderi del vecchio rifugio di Salarno, venne costrui-to un nuovo rifugio, che venne dedicato alla memoria dell'avv. Paolo Prudenzini di Breno (scomparso l’anno precedente). Dopo quello di Salarno furono costruiti altri rifugi: il Baitone al lago Rotondo (1891), il Garibaldi al lago Venerocolo (1894), e via via il Gavia (1899), il Prudenzini (1908), il Brescia (1912), il Carè Alto (1912 a cura della Sat di Trento), la Lobbia Alta (1929).
Il Rifugio Garibaldi in una cartolina del 1907. Il vecchio rifugio rimase attivo fino al 1958, quando venne sommerso dalle acque del lago nato dalla costruzione della nuova diga. Mentre la Capanna Baitone assunse successivamente il nome di Rifugio Tonolini, in memoria di Franco Tonolini, capitano degli alpini, caduto nella guerra ‘15-18 ed insignito della medaglia d’oro, il rifugio Garibaldi conserva il nome che fin dalla sua originaria
24
costruzione gli venne dato. Il rifugio fu dedicato a Garibaldi a perenne ricordo dello scontro avvenuto a Vezza d’ Oglio il 4 luglio1866 tra austriaci e garibaldini, che persero purtroppo la battaglia. Nel 1958 venne sommerso dal lago che si era formato con la costruzione della nuova diga. L’anno successivo venne inaugurato l’attuale edificio, costruito dall’ENEL in sostituzione del vecchio rifugio.
Le guide e i portatori E non furono soltanto gli alpinisti a visitare l’alta Valle: pensiamo ai geologi e ai militari, i quali avevano soprattutto il compito di effettuare i rilievi per scopi non proprio pacifici. Costoro, per ovvi motivi, si rivolsero a coloro che meglio di ogni altro potevano fare da guida, perché conoscevano le montagne, le valli, i passi, i sentieri, ecc. Gli escursionisti iniziarono, pertanto, a chiedere ai pastori di accompagnarli nelle loro gite e ascensioni. All’inizio non deve essere stato semplice: la naturale diffidenza della gente di montagna verso gli “stranieri”, soprattutto se di lingua diversa, non aveva sicuramente facilitato i rapporti tra i pastori e gli alpinisti. Interessante, a tale proposito, è quanto scrive il Freshfield6 a proposito dei nomi che i topografi danno alle montagne, e che ovviamente hanno desunto dagli “interrogatori” a cui hanno
6 Douglas W. Freshfield, Italians Alps, London 1875, cit., pag. 95
25
sottoposto la gente del luogo.
Gli sherpa dell’Adamello, come venivano chiamate allora le guide di Ponte di Legno, in questa bella fotografia dell’inizio del 1900. Si riconoscono Giuseppe Mondini, il primo a destra in piedi, e Giovanni Cresseri, il primo a destra seduto. “I pastori spesso non hanno mai pensato prima a quello che si trova oltre il più alto sentiero delle loro capre. Tante volte, condotti alla esasperazione dagli interrogatori, essi inventano sul momento un nome tratto dalle più appariscenti caratteristiche della vetta....”.
26
Martino Bastanzini
La professione di portatore e di guida è quindi nata in modo, potremmo dire, “naturale”. Non furono certo pochi, infatti, i giovani pastori che, lasciato il gregge, iniziarono a seguire i “forestieri”, prima come semplici portatori e poi come guide alpine. Un esempio tipico è il capostipite delle guide dalignesi, Martino Bastanzini fu Giovan Maria, nato a Ponte di Legno il 22 agosto 1851. Da semplice pastore divenne guida alpina nel 1885. Moltissime furono le sue ascensioni sull’Adamello. Pastore di pecore per molti anni, Giovanni Cresseri fu Fedele, nato il
27
1° maggio 1869 a Zoanno (frazione di Ponte di Legno), divenne portatore ufficiale nel 1894 e guida alpina nel 1899. Delle sue ascensioni molto si è scritto: furono dieci le ascensioni sull’Adamello. Morì il 29 agosto 1921. Ancora, si ricorda Emanuele Sozzi fu Martino, nato a Zoanno nel 1846, di professione pastore, divenne portatore il 2 luglio 1894. Morì nel 1910. Di lui ci è rimasto un simpaticissimo “quadretto”, raccontatoci da Remigio Maculotti nel racconto “La caccia”7. Emanuele Sozzi, infatti aveva guidato due cacciatori di Cremona in una battuta in alta Val delle Messi: la descrizione della battuta di caccia è interessantissima, così come gli inconvenienti che i protagonisti incontrano nella loro “avventura”. Sempre a fine ottocento ricordiamo i pastori Faustino Bastanzini (nato nel 1856, divenuto guida nel 1902) e Bortolo Cresseri, entrambi di Ponte di Legno, Giuseppe Mondini di Martino e Giuseppe Mondini di Matteo, entrambi di Pezzo. Questi ultimi due, semplici pastori, divennero portatori nel 1900 e guide ufficiali nel 1906. Il primo si meritò il titolo di “guida emerita” e compì ben 148 ascensioni sulla vetta dell’Adamello. Il secondo fu un altrettanto ottima guida, ma il suo destino non si compì sulle vette delle sue amate montagne, perché morì il 27 settembre 1918 in prigionia, quasi al termine della guerra !
7 Mario Berruti, Cronache di Pezzo, cit.
28
Giovanni e Bortolo Cresseri
Si ricordano, infine, Antonio Donati di Martino, di Ponte di Legno, nato il 30 agosto 1882, che da pastore divenne portatore nel 1911; Faustino Bastansini fu Giovan Maria, di Ponte di Legno, che divenne guida nel 1902; Enrico Emblemi di Zoanno, da pastore divenne portatore nel 1902. Questi furono i primi, ma ad essi si aggiunsero poi altri giovani, che si distinsero in innumerevoli imprese, soprattutto durante la Grande Guerra Bianca in Adamello.
29
Le acque di S. Apollonia Nel territorio di Ponte di Legno non vi erano soltanto le montagne ad attirare i primi turisti. Come già in altre località montane, anche qui si affermò la “moda delle acque”, che tanto bene facevano a tutti. Nel territorio di Precasaglio, a 1580 metri sul livello del mare, proprio all’inizio della strada che raggiunge il Gavia, vi è la località di S. Apollonia. Qui, come è noto, sgorga una fonte di acque ferruginose, simile a quella di S. Caterina Valfurva e di Pejo.
La struttura in legno fu edificata nel 1939, e sostituì la precedente costruzione, che aveva una forma rotonda Rinviando al libretto “La Fonte e lo Stabilimento di S. Apollonia”,
30
scritto da Mario Berruti e edito grazie alla famiglia Bulferetti a Ponte di Legno nel 20098, per uno studio più approfondito della storia turistica di S. Apollonia, qui ci limiteremo a darne qualche breve cenno. E' del tutto impossibile stabilire la data precisa della prima scoperta e dell'utilizzo della fonte; tuttavia è risaputo che l’uso di essa, quale medicamento, risale a tempi remoti. Il 17 giugno 1784 accadde un evento naturale disastroso, che sconvolse tutta la zona. Sulla data dell’evento vi sono alcuni dubbi: in un manoscritto è riportata una data diversa (agosto 1782), ma con ogni probabilità è errata9, anche se questi dubbi restano, perché l’estensore della storia è il reverendo don Bortolo Veclani, vissuto all’epoca dell’evento, e quindi spettatore diretto del nubifragio. Tale manoscritto, tuttavia, non è di provenienza diretta di don Bortolo Veclani, perché in esso si fa cenno alla prima guerra mondiale, mentre il Veclani è vissuto a cavallo del ‘700 e ‘800. L’estensore del manoscritto, quindi, deve aver copiato un appunto del Veclani, e la data dell’evento potrebbe essere stata riportata non correttamente. Del resto la conferma che il nubifragio è effettivamente avvenuto il 17 giugno 1784 ci é data dal registro parrocchiale, che riporta un episodio accaduto lo stesso giorno a Viso. Comunque sia, il reverendo Veclani scrive: “Storia della frana accaduta nella Valle delle Messi nel 1782, d’agosto. In quel giorno il temporale continuava sempre più fortemente. Poi andò sempre crescendo in modo che sembrava un 8 M. Berruti, La Fonte e lo Stabilimento di S. Apollonia, La Cittadina, 2009 9 Si tratta infatti di una trascrizione di un manoscritto, il cui originale è andato perduto. La trascrizione riporta il titolo “Il lago in val delle Messi”, e sotto il titolo si annota: “pubblichiamo il seguente documento gentilmente fornitoci dalla sig.na Cenini Mea fu Domenico che vogliamo qui ringraziare pubblicamente”. In Archivio Giancarlo Maculotti, Ponte di Legno.
31
finimondo. In modo che scatenò una gran frana in cima al Bosco e portò via tutto il gregge: 276 pecore e qualche capra e due maiali e tre pastori. Uno si salvò per causa del mal di corpo, era infatti un po’ distante della baita. La frana in fondo valle fermò il fiume ed allagò tutto quel piano di S. Apollonia che costò tanta fatica ed onori per asciugare il lago e aprire la comunicazione da parte dei montanari. Ma il gran temporale non cessò nella valle delle Messi e passò oltre sopra Pezzo, in cima al bosco Planta e andò a scaricarsi in cima al Gras Grande, alla testata del Serodine e giù nel pendio fino ai Martinoli. In modo che il rigagnolo detto di Bonùm cambiò letto rovinando tanta campagna e portò via sei ponti: uno di Bonùm, l'altro di mezzo, quello delle Posse, quello delle Goie e quello di Martino Maculotti e quello del fabbro Veclani. Nel transitare lungo la valle portò via quattro mulini con dentro un giovane mugnaio, certo Sossi Giacomino che mai più lo troveranno. Solo qualche piccolo resto degli abiti e una tibia che si crede sia sua. Di quei mulini non si conosce più traccia. Solo quando, dopo la guerra '15-18, han fatto la strada bassa, hanno trovato due macine. Esistono tuttora agli occhi di tutti i passanti. Queste memorie sono state scritte dal Don Bortolo Veclani, pure di Pezzo, uomo serio, economo di Pezzo”. Tale disastro coprì completamente anche la fonte di S. Apollonia, che rimase pertanto non più utilizzata fino al completo prosciugamento del laghetto. Nel 1857 la fonte venne nuovamente alla luce. Anche se sulla data ancora una volta non vi è certezza, alcuni punti fermi nei documenti si trovano. Come ad esempio la diatriba che vide su fronti contrapposti il Comune di Ponte di Legno da una parte, e le famiglie Ferrari (Bernardo, Giacomo e Teresa) e Toloni (Martino, Pietro,
32
Giuseppe e Bartolomeo) di Precasaglio dall’altra, famiglie proprietarie del terreno su cui insiste la Fonte. Il 26 giugno 1861 i contendenti raggiunsero un onorevole accordo che consentì, da una parte l'utilizzo della Fonte, e dall'altra l'inizio dell'avventura turistica della Valle delle Messi. Purtroppo il sogno di creare un “polo turistico” in Valle delle Messi durò ben poco: da un lato le difficoltà fisiche di far sgorgare un'acqua buona, utile all'utilizzo anche come acqua da bere, e dall'altra l'invidia e l'avversione dimostrata dagli abitanti di Ponte di Legno, che vedevano in quella località un ostacolo allo sviluppo turistico del capoluogo, impedirono di fatto a S. Apollonia di divenire una nuova Pejo o una nuova Boario.
Lo stabilimento era formato da ben quattro edifici, compresa la piccola chiesa sulla destra Anche la successiva costruzione di uno Stabilimento, cioè di un albergo, non ebbe miglior fortuna. Tra i gestori dell’Albergo di S. Apollonia ricordiamo Leopoldo Zuelli di Pezzo, suo cognato Domenico Maculotti, anch’egli di Pezzo, e Pietro Panzarini di Ponte di Legno. La gestione dello “stabilimento” fu sempre fallimentare, tanto che
33
Leopoldo Zuelli abbandonò l’impresa per dedicarsi ad una fabbrica di birra a Temù. Anche questa attività, comunque, finì male, tanto che Leopoldo si vide costretto a vendere a sua sorella Prudenza, moglie di Domenico Maculotti, la propria casa avita di Pezzo (Leopoldo era il primogenito, ed aveva ereditato “per diritto” la casa di famiglia).
Leopoldo Zuelli (1847-1905)
Domenico Maculotti, che già ricordavamo gestiva l’osteria nella propria casa di Pezzo, unendo quella casa a quella posta di fianco che, nel frattempo, sua moglie Prudenza aveva acquistato dal fratello Leopoldo, aprì un albergo a Pezzo. Pietro Panzarini, nel 1888, decise di abbandonare l’avventura di S.Apollonia, e ne aprì uno a Ponte di Legno.
34
Domenico Maculotti (1842-1908)
Nel 1894 finì l’esperienza dalignese nella conduzione dello stabilimento di S. Apollonia. La proprietà dell'albergo, infatti, passò a due cremonesi: Antonio Gamba, farmacista, e Ambrogio Mancini, possidente. Alla gestione della struttura fu chiamato un certo Rocco Boccasavia, di professione albergatore, anch'egli di Cremona. La storia alberghiera di S. Apollonia cessò definitivamente prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, e la struttura venne utilizzata stagionalmente soprattutto per colonie montane. Proprio di fronte al vecchio stabilimento, sulle ceneri di un “bar” andato completamente distrutto da un incendio, sorse il “Ristoro Passo Pietra Rossa”: da allora la struttura non è assolutamente cambiata, e ancora oggi possiamo notare come l’edificio sia rimasto assolutamente identico, nonostante siano trascorsi ben 85 anni!
35
L'edificio del Ristoro è ancora uguale, solo la struttura della fonte è cambiata
La edificazione venne compiuta da Martino Faustinelli di Pezzo, il quale non nascose l’intenzione di sfruttare a suo vantaggio la vicinanza con la Fonte; l’antico Stabilimento di fronte, infatti, denunciava già grosse difficoltà, e pertanto il Faustinelli, probabilmente, prefigurava di poter sfruttare a proprio vantaggio sia la notorietà, che comunque la località aveva acquisito nel tempo, sia la Fonte. La costruzione iniziò nel 1932 e venne terminata nel 1933, anno nel quale l’albergo iniziò ufficialmente l’attività.
37
Le prime strutture alberghiere L’albergo Maculotti a Pezzo Domenico Maculotti, quando abbandonò la conduzione dello stabilimento di S. Apollonia, decise di non disperdere la sua esperienza di albergatore. Dell’osteria abbiamo già detto.
L'albergo Maculotti nel 1907: in piedi accostato alla ringhiera e a braccia conserte si nota Remigio Maculotti, figlio del proprietario Domenico
38
Nel 1888 adattò alcune stanze nella propria casa a Pezzo, per poterle destinare ai pochi avventori, che qui facevano sosta prima di raggiungere la località di Case di Viso per le escursioni nella omonima valle.
Successivamente, Domenico acquistò, soprattutto da parenti, alcune proprietà attigue alla casa di abitazione per poter offrire altre stanze. Ma l’acquisto che comportò il vero lancio dell’Albergo, fu l’atto del 24 novembre 1899, con il quale Prudenza Zuelli (consorte di Domenico) acquistò dal fratello Leopoldo (anch'egli ex gestore di S. Apollonia) l’attigua casa Zuelli (l’antica casa del ‘500 che fu prima del Notaio Breda e poi di Omobono Zuelli, e che si trova nell'attuale via Tognali). In tale casa Domenico concentrò la maggior parte delle stanze per gli ospiti. Le due case erano separate da una stretta viuzza scoscesa (oggi, appunto, via Tognali). L’Albergo Maculotti è citato nella Guida Illustrata di Valle Camonica del 1905, edita a cura dell’Associazione pro-valle Camonica di Breno, come esercizio “con 15 stanze da £. 1 a £. 1,50, pensione a prezzi modici, servizio cavalcatura”. Domenico Maculotti si diede molto da fare per pubblicizzare la sua attività, come evidenzia, ad esempio, l’articolo, dal titolo “Stazione climatica”, comparso sul giornale La Provincia di Brescia l’11 giugno 1894. “L’estate scorsa Ponte di Legno (metri 1256) era popolato di una moltitudine straordinaria di forestieri, sfuggiti all’afa della pianura per godere le fresch’aure della montagna........ Vicino vi ha Pezzo, grossa frazione di Ponte di Legno, ove trovasi il rinomato Albergo Maculotti, il cui proprietario è persona simpatica e carissima a tutti
39
coloro che ebbero l’occasione di farne la conoscenza”. “L’Indicatore”, annuario guida della Valle Camonica del 1907, a proposito di Pezzo e della sua locanda, scrive: “E’ un’ottima stazione climatica con un’aria imbalsamata (proprio così, non è un errore di trascrizione!) dalla foltissima foresta di giganteschi larici e pini... Ha un buon albergo e là si può godere tutta la maschia, tranquilla tonificante poesia delle alpi”. Nel 1908 Domenico morì e lasciò la conduzione dell’osteria e dell’albergo ai figli Remigio e Attilio. Non passò un anno e morì anche Remigio. L’albergo restò intestato ad Attilio, il quale tuttavia, laureatosi in Veterinaria, iniziò ad esercitare la professione di veterinario di confine. Furono così le donne di casa a continuare la gestione. Prudenza Zuelli e le figlie Tranquilla e Teresa Maculotti, riuscirono da sole a condurre brillantemente le varie attività, facendosi rispettare e stimare, non soltanto dai compaesani, ma anche dai numerosi forestieri che scendevano al pur modesto Albergo Maculotti. Sono rimasti alcuni registri (che abbracciano il periodo dal 1925 al 1937), che evidenziano la presenza di molti ospiti, anche illustri, all’albergo Maculotti. L’albergo delle Alpi di Panzarini Per quanto riguarda Ponte di Legno si ha notizia che nel 1888 esisteva la Trattoria Panzarini, il cui gestore, Pietro Panzarini, era anche proprietario dell’attiguo “Caffè Albergo delle Alpi”. Nell’episodio “La caccia” (più volte citato) si legge che “questa trattoria è ben diretta e governata, poiché ne rimangono tutti contenti”.
40
Al centro uno dei primi alberghi di Ponte di Legno, il “Caffè Albergo delle Alpi”, il cui titolare, Pietro Panzarini, era anche proprietario dell’attigua omonima Trattoria. Dell’Albergo si ha notizia anche nella Guida Illustrata di Valle Camonica del 1905, che lo cita senza commenti. Dalla Guida d’Italia del TCI del 1914 si apprende che aveva 25 stanze, e ciascuna costava 2 lire, e da 7 a 10 lire se con pensione. A Ponte di Legno vi erano anche altre osterie che offrivano ospitalità: da una nota di Remigio Maculotti (1873-1909), si apprende che il 2 febbraio 1890 certo Rossi Giovan Battista di Zoanno, “dopo le sacre funzioni si tratteneva a Ponte di Legno, bivacchiando un po’ di qua un po’ di là, ma specialmente nell’Osteria Tomasotti”10. L’albergo Tonale Nei primi mesi del 1894 Giovan Maria Brichetti trasformò la propria casa in albergo. In un articolo comparso su “La Provincia di Brescia” l’11 giugno 1894, dal titolo “Stazione climatica”, si legge che
10 in Archivio Isabella e Piera Maculotti, Brescia
41
“l’estate scorsa Ponte di Legno (metri 1256) era popolato di una moltitudine straordinaria di forestieri, sfuggiti all’afa della pianura per godere le fresch’aure della montagna........ Un solo lagno si era innalzato qual è quello della scarsità degli alloggi, poiché oltre ad essere al completo gli alberghi e le osterie, anche le case private rigurgitavano di ospiti. A togliere simili lamentele vi pensò il solerte sig. Brichetti Gio’ Maria il quale, non badando a spese, ha approntato per l’entrante stagione estiva un sontuoso palazzo (tal si può chiamare per Ponte di Legno) arredato in modo da accontentare ogni esigenza sia per le sale, le camere da letto e cucine, e capace di ospitare dieci o dodici famiglie”.
L'Albergo Tonale, quando ancora era costituito da un solo corpo. L'immagine è del 1907. Si noti sulla destra il ricovero Carettoni
Il Brichetti pensava senza dubbio in grande, perché l’8 luglio 1902 iniziò una radicale trasformazione dell'edificio (la propria casa) in cui alloggiava gli ospiti, al termine della quale inaugurò l’Hotel Tonale. Si trovava, come molti ricordano sicuramente, di fronte alla attuale
42
Azienda di soggiorno. La Guida Illustrata di Valle Camonica del 1905, lo indica con “25 stanze da L. 1,50 a 3, pensioni a prezzo da convenirsi, servizio vetture”. Nel 1925, assunta la proprietà e la gestione da parte dei figli Brichetti, l’albergo venne dagli stessi totalmente restaurato, e raddoppiato. Le camere divennero ben 70 e vennero installati acqua corrente, bagni e caloriferi.
L'edificio dell'Hotel Tonale è stato raddoppiato
Il Barattieri Sempre di fine ottocento è l’altro vecchio albergo di Ponte di Legno, il Barattieri, che si trovava nella omonima via, oggi c.so Milano. Era senza dubbio un albergo modesto, perché le guide della Vallecamonica lo citano, ma senza fornirne alcuna caratteristica.
43
Con ogni probabilità serviva anche quale base di partenza per le escursioni in Valle delle Messi. Nella fotografia soprastante si nota, infatti, sul muro del vicolo successivo all'Albergo, la scritta “Recapito per S. Apollonia” e più sotto “Stallo”. Si notano anche le stanghe del carretto con il quale si portavano a S. Apollonia gli ospiti.
Siamo all'inizio di corso Milano, gli edifici, pur modificatisi, sono ancora ben riconoscibili
Le Canossiane
Nel 1902 iniziò la costruzione della casa delle Suore Canossiane, che terminò nel 1905. La casa era in splendida posizione, di fronte al Corno d’Aola, e in località (allora) isolata, lungo la strada alta che conduceva a Villa
44
Dalegno. La casa, veramente grande per quei tempi, veniva utilizzata come orfanotrofio, dedicato a San Giuseppe, per gli orfani del paese e della valle, nonché come soggiorno estivo per le educande11. Naturalmente contribuì a dare notevole importanza alla località.
Siamo nel 1902, la struttura delle Canossiane è già costruita, ma è l'unico edificio della zona
Dobbiamo arrivare al 1910 per vedere finalmente la nascita del primo vero albergo di lusso dell’alta Vallecamonica. Il Grande Albergo
Il 31 luglio venne infatti inaugurato il Grande Albergo.
11 A. Cominoli, Ponte di Legno la sua storia dalle origini ad oggi, Malegno 1979, pag.158.
45
Costruito con i finanziamenti del Banco Mazzola e Perlasca (che diverrà poi la Banca di Valle Camonica), contava ben 125 posti letto, aveva tutti i comfort moderni e conferiva così a Ponte di Legno quel prestigio che ancora gli mancava per divenire una vera e propria stazione turistica a livello nazionale e internazionale. Il Grande Albergo divenne il centro di molte manifestazioni e il polo di attrazione per il turismo del paese.
L’edificio è finito, ma non è ancora in attività: una delle prime immagini del Grande Albergo
Viene così descritto in un inserto pubblicitario: “Grande Albergo Ponte di Legno, nella migliore posizione - splendida vista - a tre minuti sopra il paese lungo la strada del Tonale. Ogni comfort, acqua corrente, Orchestra, Vasta pineta, Tennis, Stazione di arrivo e partenza del servizio Autobus di Grande Turismo Milano-Venezia”12. Sotto l’albergo vi era un bellissimo pendio, totalmente privo di alberi, 12 in Archivio Isabella e Piera Maculotti, Brescia
46
che in inverno si riempiva di neve: qual occasione migliore per provare i nuovissimi sci di legno acquistati nelle prime botteghe artigiane di Ponte di Legno!
Le prime folli discese sotto l'albergo in una cartolina pubblicitaria
Il boom turistico di Ponte di Legno Fu il “momento storico” di Ponte di Legno, che più non si ripeterà, quanto meno in quelle dimensioni. In quegli anni nacque lo Sci Club (di cui diremo), si costruirono nuovi alberghi e si iniziò la costruzione di splendide ville, che ancor oggi si possono ammirare, bellissime come allora, soprattutto lungo la Via dei Villini. Lo sviluppo turistico di Ponte di Legno necessitava di vie di comunicazione più comode e veloci: nel 1909 la ferrovia arrivò a Edolo, venne inaugurata una linea di trasporto di persone permanente, che venne affidata all’Impresa Bottarelli. La strada di collegamento con il Tonale risale al 1880, ma è proprio
47
in quegli anni che la stessa fu sottoposta continuamente a migliorie; da non dimenticare la costruzione della carrozzabile che raggiungeva il passo del Gavia, e che fu portata a termine prima della prima guerra mondiale. Nel 1912 Ponte di Legno raggiunse il culmine della sua popolarità, tanto che il Touring Club Italiano la definì quell’anno la “prima stazione italiana di turismo e sports invernali”.
Villa dell’ing. Baslini
L’industria turistica si arricchì di nuovi alberghi, e nacque così l’Albergo Centrale, sul corso Milano, di proprietà del sig. Luigi Panzarini, ma gestito dal signor Pedrali. Era moderno, dotato di bagni, docce e garage e di una sala da biliardo. Venne poi l’Albergo Vittoria, sul corso Trieste, munito di 60 letti, le camere erano rigorosamente riscaldate, e si annunciava che si parlava francese, tedesco e inglese. E infatti vi soggiornavano soprattutto stranieri: da Berlino la famiglia del sig. Nocooltuisk Neord, da Londra le famiglie Rubart e Nejer, da
48
Innsbruck la famiglia Sarnstein, da Balunen le famiglie Faeger e Kanneman. A tavola “vini scelti da pasto e di lusso”13 . Ancora, l’Albergo Bella Milano, in “posizione centrale, trattamento di famiglia, bagni, docce, auto-rimessa, ecc. ecc”. Lo gestiva il sig. Alessandro Pincetti. Più avanti vennero aperti altri alberghi: “l’Alpino” sulla strada del Tonale.
L’albergo Alpino sulla strada del Tonale
il “Montozzo” a Pezzo
13 dalla rivista “Ponte di Legno”, in Archivio Isabella e Piera Maculotti, Brescia
49
L’albergo Montozzo a Pezzo in inverno
e un po’ più tardi il “Miravalle” nella stessa località
L'albergo Miravalle a Pezzo … quasi isolato
50
il “Sandrini” a Ponte di Legno
Sandrini: una immagine “moderna” (1940)
e il “Ristoro Pietra Rossa” a Santa Apollonia, di cui già si è detto. Il turismo, quindi, non si limitò al capoluogo, ma “invase” anche le frazioni. Qui sotto possiamo ammirare alcune delle strutture turistiche or ora citate. Si trattava, indubbiamente, di alberghi abbastanza modesti, ma lo sviluppo turistico di Ponte di Legno era solo all’inizio.
51
Lo Sci: gli esordi
L’immagine è scattata a Pezzo negli anni ’20, nel prato sotto le scuole
Lo sviluppo turistico non significa, soltanto, la nascita degli alberghi, delle pensioni e delle trattorie, Ponte di Legno era in primo luogo una
52
stazione invernale, e in quegli anni lo sci (anzi lo Ski) iniziava a svilupparsi in tutte le Alpi. Sul primo paio di sci giunto a Ponte di Legno molte voci corrono, ma nessuna è sicura. Sull’argomento rinviamo al completo lavoro “70 anni di sci a Ponte di Legno”, di Remigio Maculotti14. Qui ci limiteremo ad accennare alcune notizie sulla nascita dello sci e dello Sci Club. L’introduzione dei primi sci a Ponte di Legno viene fatta risalire ad una “dimostrazione” che il nobile bresciano Piero Arici, a fine ‘800, fece in paese, tra lo stupore, la curiosità e ... lo scetticismo generale. Altra notizia ci viene riferita dal dr. Gualtiero Laeng, il quale scrisse di aver inforcato un paio di sci in una folle discesa dal Corno d’Aola nel 1906, anche se su questa data l’avv. Remigio Maculotti, nel suo libro “70 anni di sci a Ponte di Legno”, dimostra qualche dubbio, rilevando che all’epoca tutta la zona del Corno d’Aola era militare, e quindi strettamente off limits. Con ogni probabilità i primi sci furono portati a Ponte di Legno dalla Svizzera (Engadina), ad opera di dalignesi là emigrati. Famiglie come i Rossi, i Carettoni, gli Zampatti, i Donati, i Beltracchi e i Lazzarini, già a metà dell’800, erano emigrati in Engadina in cerca di un lavoro. Alcuni di loro, come Luigi Carettoni, figlio di dalignesi, ma cittadino svizzero, si erano già fatti onore in competizioni sportive, dalla discesa con gli sci, al salto dal trampolino. Alcuni falegnami dalignesi, tra i quali ricordiamo soprattutto gli Zampatti e i Veclani, pensarono bene di costruire in proprio gli sci, invece di importarli dalla Norvegia o dalla Svizzera. Tra questi
14 Remigio Maculotti, 70 anni di sci a Ponte di Legno, edito da Comitato Interventi Turistici Ponte di Legno, 1981
53
possiamo ricordare Gioacchino Zampatti, il quale si trovò a lavorare a Chiavenna insieme ai fratelli Persenico, famiglia valtellinese che divenne produttrice di sci molto famosi. Lo Zampatti nel 1909 tornò a Ponte di Legno portando con sé un paio di sci da lui stesso prodotti, e qui si ristabilì aprendo una fabbrica di questi nuovi attrezzi sportivi. Degno di nota è il fatto che sua moglie, Armida Pandini, fu la prima donna dalignese che inforcò un paio di sci.
Proprio in quegli anni alcuni dalignesi iniziarono a partecipare a manifestazioni sportive. Ricordiamo Antonio Leoncelli e Omobono Beltracchi, i quali erano emigrati in Svizzera, dove avevano avuto occasione di provare gli sci, e tornati in patria, per il servizio militare, furono addestrati e fatti partecipare ad alcune gare. E già a gennaio del 1910, partecipando al grande concorso internazionale di sci organizzato dal Club Alpino Francese a Eaux Bonnex (bassi Pirenei), il Leoncelli arrivò secondo nella prova individuale di velocità, e il Beltracchi fu quarto.
Le “furie rosse” della squadra dello Ski Club del 1913
Ormai Ponte di Legno era lanciato, e tutti si rendevano conto che lo sci poteva diventare il “veicolo” per portare la località ad essere un centro di sport invernali. Proprio nel 1910 si inaugurò il Grande
54
Albergo, che per quegli anni rappresentava il lusso più sfrenato, quasi al pari dei grandi alberghi svizzeri: non per nulla venne chiamato a dirigerlo il sig. Petruchic, con esperienza alberghiera appunto in Svizzera.
Il manifesto della Grande Settimana d'Inverno del Touring Club Italiano 1911-12
55
Nell’inverno 1909-1910, ad opera del dott. Giovanni Zuelli, medico condotto, e di suo cugino, il dott. Attilio Maculotti, medico veterinario, si costituì il “Comitato Pro Stagione Invernale”. Il Comitato si mise a lavorare di gran lena, con la passione di professionisti, commercianti e semplici cittadini, e il gran lavoro venne premiato nella stagione 1911-1912, quando il Touring Club Italiano definì Ponte di Legno come la “Prima stazione italiana di turismo e sport invernali”.
Dal Comitato nacque lo Sci Club Ponte di Legno, pienamente operativo a gennaio del 1911. I primi soci furono il tenente Omero Bontempi, che fu nominato Presidente, il medico dott. Giovanni Zuelli (Vice Presidente), il maestro Lino Donati (segretario), Omobono Beltracchi (che per la sua esperienza sciistica fu nominato Direttore Tecnico), Emilio Donati (commerciante), Nino Brichetti (titolare dell’Hotel Tonale), il dott. Nino Milesi (farmacista), Luigi Panzarini (titolare dell’albergo alle Alpi), il dott. Attilio Maculotti
Salto col trampolino sotto il Grande Albergo
56
(veterinario di confine), Andrea Brichetti (commerciante). Il vero lancio della nuova stazione turistica avvenne tra l’8 e il 15 febbraio 1912, quando venne organizzata la Settimana d’Inverno, promossa dal Touring Club Italiano. La manifestazione ebbe grande eco a livello nazionale, e fu citata dai più importanti giornali italiani, tra gli altri il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. Le gare si susseguirono giorno dopo giorno, anche con lusinghieri risultati degli atleti dalignesi, come Antonio Leoncelli, Domenico Sandrini, Battista Donati, Angelo Donati, Martino Donati, Bulferetti e Lazzarini. Ma soprattutto la squadra di Ponte di Legno, composta da Omobono Beltracchi, Domenico Zambotti, Battista Donati e Domenico Sandrini vince la Coppa Martinoni, gara a squadre di marcia con gli sci (trenta chilometri durissimi tra salite e discese). I quattro atleti furono soprannominati le “furie rosse” per la divisa che indossavano: maglione e berretto di un rosso vivo. Questi furono gli esordi, ma ancora per lunghi anni, tranne che per le disgraziate soste forzate delle guerre, Ponte di Legno fu una delle stazioni sciistiche di maggior rilievo nel panorama nazionale, fino ad arrivare ai nuovi fasti odierni.
57
Il periodo successivo alla prima Guerra mondiale Nuovi alberghi, trattorie, negozi Il turismo faceva crescere rapidamente Ponte di Legno e ne modificava radicalmente l'economia. Con l’arrivo dei “forestieri” nascevano nuove attività. Nel 1923 si raccomandavano ai turisti la Trattoria Risorgimento di Bezzi Martino, il Cinema Italia di Massimo Scainelli, la bravura del sig. Vincenzo Marcolini come pittore decoratore, le trattorie delle sigg.re Maria Crapelli vedova Bezzi, e Caterina Panzarini vedova Sandrini, la prestineria di Margherita Scarsi, la ferramenta di Francesco Tomasi e figli, i lavori in legno (intagli, restauri, arredi, serramenti, ecc.) dei fratelli Ferrari. Ancora si consigliava la drogheria e privativa di Antonio Zampatti, il negozio di articoli sportivi di Domenico Donati, il negozio di vini, liquori (tra cui il formidabile Noreas fabbricato a Edolo), oli, formaggi, salumi, saponi, farine, granaglie, ecc. di Giovanni Donati, la premiata calzoleria di Domenico Zambotti, specializzata in scarponi da alta montagna e per skiatori, il Bar Pasticceria Negri, il Caffè Aurora di Ottorino Dripisi, la sartoria civile e militare di Pietro Cominoli, la prestineria dei fratelli Cominoli, il Caffè Cinema di Battista Donati, la salumeria di Attilio Zambotti in piazza Vittorio Emanuele III, la fabbrica di Ski (del tipo norvegese) di Gioacchino Zampatti, la fabbrica di paste alimentari dei fratelli Calcari e il parrucchiere Giacomo Crapelli.
58
Il Comitato per l’Amministrazione dell’Azienda Autonoma Il 27 ottobre 1927 il Governo emise un decreto, col quale, tra l’altro, riconosceva Ponte di Legno come “stazione climatica e di cura di prim’ordine”. Il che fa dire ai dalignesi che la notizia “è stata accolta con entusiasmo sincero, con compiacimento, con gratitudine da quanti conoscono e frequentano Ponte di Legno, poiché si apre per esso una nuova era di prosperità e di sviluppo”15. E’ così che, nella Sala Comunale di Ponte di Legno, il 28 aprile del 1928 si insediava il “Comitato per l’Amministrazione dell’Azienda Autonoma”, nominato dal Prefetto di Brescia. Il Comitato era così composto: cav. uff. Lino Donati, noto benemerito ed infaticabile lavoratore, che ricopriva la carica di Presidente; comm. dott. Franco Guarneri, servizi di comunicazione; cav. ing. Giuseppe Baslini, piano regolatore; cav. dott. Ercole Masera, preparazione di speciali carte topografiche della regione; cav. Luigi Panzarini, redazione del giornale Ponte di Legno; dott. Giovanni Musini, servizio igienico-sanitario (era il medico di Ponte di Legno); sig. Ferruccio Sacchetti, rappresentante della industria alberghiera; sig. Giovita Faustinelli, miglioramento delle frazioni; sig. Battista Donati, rappresentante dei commercianti e degli industriali; sig. Battista Sandrini, servizi di segreteria, coadiuvato dal maestro Odelli (segretario comunale). 15 dalla rivista “Ponte di Legno”, anno I, numero 1, in archivio Maculotti Isabella e Piera, Brescia
59
Il Comitato si diede un programma di innovazioni e miglioramenti: “rendere il soggiorno comodo, miglioramento delle vie, delle strade, dei sentieri, provvedimenti di indole igienico-sanitaria, istituzione di un Ufficio con servizio di informazioni, istituzione di un osservatorio meteorologico, e di un servizio di polizia urbana”. E l’attività, in effetti, inizia subito. I componenti del Comitato si sentono investiti di una grande responsabilità, tanto da far dire ad un giornalista del settimanale “Ponte di Legno”: “Il periodo delle discussioni cede il passo al veloce ritmo dei fatti, per avviare la nostra stazione climatica alle più alte fortune e per levarla a quel posto che degnamente le spetta”16. Tra le iniziative del Comitato vi fu anche la fondazione di un settimanale. Il giorno 14 luglio 1928 uscì il primo numero di “Ponte di Legno”, il cui direttore responsabile era Luigi Panzarini. Il giornale veniva stampato dagli Stabilimenti Editoriali Ditta F. Apollonio & c. di Brescia. Si trattava di quattro pagine dense di informazioni e notizie, con descrizione delle attività principali che si svolgevano in paese, alcuni spassosi commenti sugli ospiti, l’elenco rigoroso dei turisti ospitati in ville e alberghi, l’elenco delle guide alpine e dei portatori, nonché delle possibili gite dal paese. L’immagine che si trae dalla lettura di questo settimanale è sicuramente di una comunità entusiasta, conscia del ruolo di primo piano che occupava nel panorama turistico italiano. Ogni numero si apriva con un lungo articolo che si sforzava di dimostrare come una vacanza a Ponte di Legno fosse estremamente benefica per la salute degli stressati cittadini, che fuggivano dalle città per ritrovare qui luoghi incantevoli, clima salubre e una società gaia e spensierata.
16 dalla rivista “Ponte di Legno”, cit.
60
E sicuramente molti furono i turisti che raccolsero l’invito, se pensiamo che alla data (ad esempio) del 28 luglio 1931 i villeggianti erano 1415, di cui 282 ospitati negli alberghi e 1183 in ville e appartamenti. La “bella vita”
Come si diceva, i giornalisti del settimanale non disdegnavano di “commentare” i costumi e le abitudini dei forestieri, come ad esempio il caso della famiglia con 11 figli, con arzilla suocera di 72 anni al seguito, e una “grassoccia bambinaia che, poveretta, subisce a torto la doppia tortura della malignità della signora, per via che pare sia gelosa (figurarsi sfacciata dopo le prove di una così potente e virile fedeltà datale dal marito) e delle scenate della suocera, per via che queste ultime signore pare abbiano avuto dalla Provvidenza la missione di dar sempre ragione a chi ha torto”. Si annota che in paese vi erano “molte signore, abbondantissime le signorine. Il gentile sesso è largamente e degnamente rappresentato”, anche se si può notare non prima delle undici di mattina, “che prima si dorme”. Spassosa è infatti la descrizione della “giornata tipo” del turista di Ponte di Legno (e molti riconosceranno che non è cambiata molto oggi!). “Si dorme bene in montagna. E poi la montagna è fatta per riposare; e allora riposiamo. Magari ci si sveglia alle otto. Uno sbadiglio ed una soffregatina agli occhi. Atti tradizionali che vogliono dire: grazie, ho dormito bene. Poi comincia il lavoro serio. Come mi
61
vesto? Od anche: Mi vesto o non mi vesto oggi? - Faremo una cosa intermedia. E quale toilette? - E di quale colore? Almeno fosse freddo, si potrebbe sfoggiare quel golf regalatomi dal fidanzato, o quella pelliccia carpita a quell’avaraccio di un marito. Ma con questo caldo. Deciso. Si sfoggia qualche cosa d’altro e di meglio. La grande decisione è fatta. Un nuovo pisolino per riposare la mente stanca da tanto lavoro e finalmente vengono le undici. Si farà poi in tempo a vestirsi in un’ora sola? Non che gli indumenti da mettere siano molti e abbondanti, ma ci sono quelle benedette scarpe che occupano più tempo da sole che tutto il resto dell’abbigliamento insieme. E sì che hanno una sola fibbiettina con gancio automatico, ma insomma è sempre più dell’altro. A mezzogiorno e un quarto tutto è finito. Si fa colazione. Che bell’appetito mette l’aria di montagna. E come si è presi da una dolce sonnolenza dopo aver mangiato. Un altro sonnellino fino alle sei del pomeriggio. Allora si respira e come è bella la montagna vista da una comoda sedia del caffè attraverso l’opalino di una bibita ghiacciata. Dopo il pranzo il grande passeggio. Sciami di bambini che ciangottano, comitive di giovanetti spensierati che cantano, crocchi che si fermano a discutere in piena luce dei lampioni, coppie che non discutono nell’ombra di passaggi solitari. Meravigliosi ed innumerevoli i colori delle toelette. Una tavolozza di pittore non ne può contare di più. Vesti leggere, vaporose, che modellano divinamente il corpo, scialli veneziani che strascicano le lunghe frangie per terra, cappelli di tutti i tipi e colori, scarpettine nere o gialle, o rosse o bianche, di capretto o di vernice o di serpente, dai tacchi alti e dai tacchi bassi, calze di tutti i colori, di
62
filo o di seta, ma sempre estremamente trasparenti, gonne larghe e strette quasi sempre corte, mai troppo lunghe, ombrellini giapponesi, abbondanti nel manico e dall’ala microscopica. La visione è quanto mai leggiadra. Diversi anche i colori della pelle. Dal bianco niveo a bruno accentuato. Varie gradazioni a seconda della quantità di sole presa. Dalla valle greve di umidità un balenio di scariche elettriche annunciano vicinissimo un desiderato temporale. I crocchi si sciolgono, i caffè si spopolano, il corso principale a poco a poco si deserta. Spira un’aria pregna di frescura e umidità. I lampioni delle strade dondolano ritmicamente col soffiar del venticello che va man mano crescendo di intensità. E’ delizioso un temporale di notte, mollemente stesi in un morbido letto. Passa il temporale e con esso un dolce languore subentra a ristorare il corpo e nella mente guizza un ultimo fuggevole pensiero; chissà, forse ad un amico, forse ad un paio di calze chiffone e forse ad un difficile passo del charleston non ancora ballato in quest’anno a Ponte di Legno”.
Era soprattutto al Grande Albergo che si svolgeva una “vita sociale” spensierata. Gli ospiti erano illustri: industriali, ingegneri, avvocati.
63
Il campo da tennis, costruito accanto alla strada per il Tonale
Gli stranieri abbondavano: Pritchard Groendolen da Londra, Alberto Nicot da Parigi, Heurer Waumund da Dresda, Helene Harl Susitzky da Budapest, Gibb D. Travis da New York, Kathrijn Michaela da S.Francisco, Clongh Milton e signora dal Sud Africa. Al Grande Albergo si organizzavano tornei di “tennis”, maschile e femminile, la cui iscrizione costava ben 25 lire, e l’organizzazione precisava che “si useranno palle Slazenger”. Per la cronaca vinse il torneo maschile il sig. Giorgio Gropalli, il cui premio fu costituito da un quadro dono dell’avv. U. Ferrari e da una medaglia d’oro, dono del comm. G. Zanchi. L’albergo Tonale non era comunque da meno. Vi si svolgevano normalmente feste sontuose. Ebbe “notevole nomea la bella festa organizzata dalle signorine dell’albergo sabato 4 agosto 1928 in onore degli ufficiali del 50° e 78° Reggimento di Fanteria. Che tono diverso alle feste, quest’anno! Orchestrina ottima, rinfreschi sceltissimi, clientela impeccabile”.
64
Un disegno-progetto dell'Albergo Tonale, in una cartolina pubblicitaria
Quanti cambiamenti in poco più di venti anni! Dai tuguri ai grandi alberghi, dalle vie strette e tortuose al gaioso passeggio dei turisti. Una trasformazione che non poteva che rivoluzionare non solo il paese e le sue strutture immobiliari, ma anche le abitudini, la vita, il lavoro e l’economia in generale di Ponte di Legno. I campi vennero ben presto venduti ai costruttori, per l’edificazione di alberghi e ville, i giovani iniziarono a lavorare nei cantieri, oppure come camerieri nelle trattorie, nelle locande e negli alberghi. Gli esercizi commerciali fiorivano ed avevano bisogno di commessi, facchini, ecc. Il mestiere che soffrì di più per tali trasformazioni fu senza dubbio la pastorizia.
65
Solo a Pezzo resisteva un gruppo di irriducibili, ma non sarebbe durato a lungo, il destino di questo antico mestiere era ormai segnato.
67
Bibliografia AA.VV., L'alta Valcamonica da Vione a Ponte di Legno, Guide Grafo Brescia, 1992 Berruti Mario, Cronache di Pezzo, Grafo Edizioni Brescia, 1994 Berruti Mario, Una famiglia di pastori di fine ‘700 (in appendice a "Clima e comunità alpine"), Grafo Edizioni Brescia, 1998 Berruti Mario, L’Albergo Maculotti, Bollettino parrocchiale di Pezzo, 1998 Berruti Mario, Santa Apollonia, un sogno termale a Ponte di Legno, Grafo Edizioni Brescia, 2002 Berruti Mario e Maculotti Giancarlo, Pastori di Valcamonica, studi, documenti, testimonianze su un antico lavoro della montagna, Grafo Edizioni, Brescia, 2002 Berruti Mario, La Dismembrazione, Quaderni della Biblioteca di Ponte di Legno, 2008 Berruti Mario, La Fonte e lo Stabilimento di S. Apollonia, Edizione Ristoro Pietra Rossa, 2009 Cominoli Adelio, Ponte di Legno: la sua storia dalle origini ad oggi, tip. Mediavalle, Malegno, 1979 Franceschini Giulio e Apostoli Silvio, Il rifugio Salarno, vicende storiche del primo rifugio del Cai Brescia, a cura del Cai sezione di Brescia, 2004 Freshfield Douglas William, Italians Alps, London 1875, nella tradu-zione curata dalla S.A.T. di Trento, con il volume “Le Alpi Italiane”, 1971 Maculotti Remigio, 70 anni di sci a Ponte di Legno, Comitato Interventi Turistici Ponte di Legno, 1981