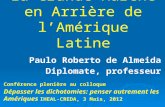Origini neolitiche e latine di ZAPPA
Transcript of Origini neolitiche e latine di ZAPPA
Origini neolitiche e latine di zappadi Mario Alinei
Premessa metodologica, datazione, prime attestazioni ed etimologia correnteCome ho sostenuto in un mio recente libro [Alinei 2009], non è possibile affrontare un problema etimologico seriamente senza una conoscenza approfondita della "cosa"; e non solo dei suoi aspetti esterni e funzionali, ma anche della sua storia o preistoria evolutiva, spesso fondamentale per l'identificazione dell'iconimo che sta all'origine della voce studiata. In questo articolo riprendo ed elaboro il problema dell'etimologia di zappa, già abbozzata in Origini II [Alinei 2000].
In base al principio dell'autodatazione lessicale [Alinei 2009], il nome della zappa è, per definizione, neolitico, se non più antico (v. oltre). Anche in termini tradizionali, tuttavia, lasua antichità è dimostrata dalla sua penetrazione nell'area germanica, documentata dal FEW: stir. zappe, tirol. zappin, St. Gallen zapi, Brienz tsapin, Jaun tsapí, Vallese sappe.
In latino, e nella forma sappa, la voce appare solo tardi. Ma sulle sue prime attestazioni Ernout e Meillet [DELL s.v. sappa] danno informazioni che risultano scorrette, perché citano Isidoro e le Glosse. Ora, sappa non figura affatto in Isidoro (né si comprende da quale fonte i due autori abbiano potuto trarre l'informazione errata) ed è attestato, sì, nelle Glosse germanichedi Kassel dell'VIII secolo (cfr. FEW), ma non in quelle, più antiche, greco-latine (CGL), a cui di solito rinvia l'abbreviazione Gloss. del DELL. Le attestazioni successive a quella delle Glosse di Kassel sono, secondo il MLLM, per sappa: Carte di Reggio Emilia del sec. X [Torelli p. 235] e Ughelli [IV col. 862 (a. 1183)]; per sappare: Chron. Farf. Contin., Muratori, Scr. II, pt. 2 col, 563, Gaddoni-Zaccherini, Chart. Imolense I, no. 302 (a.1177) .
Quanto all'etimologia, i risultati della ricerca tradizionale sul termine – che non esito a definire del tutto inadeguati – sono così riassunti dal DELI:
Prob. da zappo ‘caprone’ (zappus nel 1366, in lat. mediev.: Sella Ven., che traduce erroneamente ‘porco’), di orig. sconosciuta (G. Bertoni in AR III 1919 126 e 379; se non è dal grido di richiamo ciap-ciap, come ha sostenuto G. Rohlfs in ZrPh XLV 1925 665 e XLVIII 1928 436-437, e accettato da J. Hubschmid in RLiR XXVII 1963 402-404), come il lat. capreolu(m) ‘capretto’ passò a indicare una ‘zappa bicornuta’ (più difficile il passaggio inverso, come è detto nel DEI). Altri (Devoto Avv.) pensano, in presenza di sappa nel lat. tardo, ad una vc. mediterranea e spiegano la z- per s- con un'introduzione dal nord. J. Hubschmid
(RLiR XXVII 1963 388-402) l'intruppa in una lunga serie di vc., che apparterrebbero tutte ad un'ant. rad. *tsapp- ‘battere (la terra), zappare’.
A cui si deve aggiungere, per completezza di informazione, cheDEI, VEI e PELI e Corominas [DCECH] adottano la stessa tesi; e chesia von Wartburg [FEW] che Bloch e von Wartburg [DELF] la rigettano («tout à fait improbabile»), mentre von Wartburg ipotizza una forma onomatopeica, basata sul rumore della zappa [FEW s.v.].
Come si vede, comunque, l'unica osservazione concreta che riguardi la zappa come strumento è quella che può essere "cornuta"; ma anche questo lo si è fatto non tanto per un interesse primario ad approfondire la conoscenza della "cosa", quanto perché, una volta adottato il consueto approccio enigmistico dell'etimologia tradizionale, che dà la precedenza assoluta alla ricerca di una semplice somiglianza fra parole lontane – si deve poi procedere a cercarne una qualunque giustificazione. Nessuno sembra essersi interessato alla preistoria evolutiva della "cosa", che risale certamente per lo meno al Neolitico e, come già detto, si rivelerà invece fondamentale per rivelare l'iconimo originale della parola.
Evoluzione preistorica della zappaPoiché dubito che tutti i lettori di questa rivista sappiano che differenza c'è fra una zappa, un badile (o pala) e una vanga, riproduco qui sotto, da quel capolavoro dell'etnografia italiana che è Scheuermeier [1983] (e che tutti gli etimologi dovrebbero avere sotto mano se studiano una parola che ha a che fare con la cultura contadina), la tipologia italiana dei tre tipi di strumento agricolo (fig. 1).
Figura 1: I tre tipi di strumento agricolo da scavo: zappa, badile, vanga (da
Scheuermeier 1983)
Come si vede, la zappa ( a sinistra nella figura) si differenzia dal badile (o pala) (al centro) e dalla vanga (a
destra) per la lama perpendicolare al manico, mentre la vanga si differenzia dal badile per la presenza di una staffa nel manico.
Tutti e tre i tipi, tuttavia, rappresentano l'evoluzione differenziata di un unico strumento preistorico: quello che antropologi, archeologi e storici dell'agricoltura chiamano il ‘bastone da scavo’. Ecco la definizione che ne dà il Dizionario di Preistoria di Leroi-Gouran [1991-1992]:
Strumento agricolo primitivo costituito generalmente da un bastone dritto. Una delle cui estremità è appuntito o a spatola e talvolta appesantita. Questo semplice strumento può servire sia per seminare semi e piantare tuberi, sia per estrarre le parti commestibili sotterranee dei vegetali
La seconda parte della definizione, tuttavia, non mette in luce l'enorme differenza cronologica fra le due possibili funzionidel bastone da scavo: la semina presuppone già l'esistenza dell'agricoltura, e quindi una datazione post- Neolitica, mentre l'estrazione dal terreno di piante spontanee commestibili esistevagià nell'economia di caccia e raccolta, caratteristica del Paleolitico e Mesolitico. Come ha mostrato la ricerca etnografica,infatti, il bastone da scavo era ancora usato dalle donne raccoglitrici delle diverse società di caccia e raccolta storiche (v. fig. 2).
Figura 2: Donna aborigena dei Coorong (Australia) con il suo bastone da scavo (dipinto di GF Angas (1844))
In una variante più evoluta, certamente già associata all'agricoltura (e quindi già databile al Neolitico), al bastone da scavo viene poi applicata una spatola di osso perpendicolare al
bastone (fig. 3), per creare quella che è già una vera e propria zappa.
Figura 3: Bastoni da scavo con lame di osso, degli Indiani americani e canadesi(da cataloghi di Museo)
La nuova etimologia: morfologia e foneticaIl nome zappa che, come abbiamo visto, nelle sue prime attestazioniha la forma sappa, a mio avviso si lascia interpretare come un continuatore alto-italiano del lat. cippus, il cui significato può essere, come è noto, anche 'palo confitto nel terreno' (cfr. Cesare, De bello gallico 7, 73, 4).
Anche cippus è termine antico. Che lo fosse, scrive von Wartburg, “beweisen bret. kef ‘Wurzelstock’, kymr. cyff [...] sowie Ortsnamen: Ceppetum (già attestato nel VII sec.), das wohl nichts anderes als ein Kollektivum zu cippus bedeuten kann”, nonché da ted.Kippe, Kipfe, mned. kep ‘Fussklotz’, abt. kip ‘stipes’, e svizz. ted. Tscheppach [FEW s.v. 694]. Aggiungerei, fra i toponimi, Sappada, chenon deriva da sapa ‘zappa’ e sapar ‘zappare (come vuole il DT s.v.),bensì da ceppata, attestato sia in a. lombardo e a. emiliano nel XII (cfr. DEI, s.v. ceppata), che in catalano, come aggettivo, cepatcepada 'robusto, di forte muscolatura', e perfino nella variante sapat sapada [DCVB s.v.].
Naturalmente, per arrivare a zappa si deve partire da un femminile *cippa, la cui esistenza, tuttavia, è abbondantemente provata: lo mostrano sia l'it. ceppa, che lo sp. e il cat. cepa, tutti con il significato di ‘parte interrata dell'albero da cui sidipartono le radici’ (cfr. DELI e DCVB). La carta dell'ALT riprodotta qui sotto (v. fig. 4), che risponde alla domanda 153 'ceppo', mostra, inoltre, la vastissima diffusione del tipo femminile ceppa in Toscana: secondo, per frequenza (99 loc.), solo rispetto al maschile ceppo (129 loc.).
A nord della Toscana, infine, la carta dell’AIS III 536 ‘ceppo’, oltre a confermare la presenza del tipo femminile, ci fornisce gli altri elementi necessari per elaborare la nuova etimologia: (1) anzitutto, come è noto, in questa area la c- iniziale davanti a vocale palatale subisce il normale passaggio alla sibilante /s/: quindi partiamo da uno stadio alto-italiano intermedio *sĭppa; (2) In secondo luogo, all'interno dell'areale alto-italiano in cui il tipo si presenta al femminile, anche la vocale tonica subisce dei mutamenti, fra cui il più diffuso e rilevante per la nostra tesi è l'abbassamento ad /α/, e quindi il passaggio a *sαp(p)a. Come è anche noto, infatti, l'abbassamento della ē e della ĭ toniche lat. in sillaba chiusa, attraverso /e/ [puntino sotto] neo-italide, ad /α/, è caratteristico di una partedei dialetti piemontesi, lombardi ed emiliani (cfr. Rohlfs GSLDI §57), nonché, come ha dimostrato Zamboni [1990] (al quale si deve la migliore illustrazione del fenomeno) del ladino dolomitico e del vegliotto. La cartina della fig. 6 mostra l'area del tipo femminile *cippa e, al suo interno, quella in cui la vocale tonica si abbassa ad /α/, generando la variante sappa.
Figura 6: l'area settentrionale di f. *cippa nel Nord e, al suo interno, il tiposappa
Come si vede, l'area interessata dal tipo sappa è proprio quella caratterizzata dall'abbassamento della /e/ [puntino sotto],cioè il Piemonte centrale, la Lombardia sud- occidentale e l'Emilia occidentale.
La nuova etimologia: semanticaPer quanto riguarda la semantica, il passaggio da cippus 'palo conficcato nel terreno' a ‘zappa’, alla luce di quanto visto precedentemente, si spiega da solo: è' evidente che fra il 'bastone da scavo' e il 'palo conficcato in terra' non c'è soluzione di continuità. Si può inoltre notare:
(1) lo sviluppo parallelo di lat. pala (e palus), da pango 'conficcare, piantare' (cfr. Varrone «pala … a pangendo» (L.L. 5, 134) e DELL s.v.);
(2) il fatto che in molti dialetti italiani con 'ceppo dell’albero' non si intende 'ciò che resta fuori dell'albero dopo il taglio', ma la sua 'radice', quindi 'ciò che resta conficcato nel terreno': la Legenda della carta 536 dell'AIS documenta questa ambiguità. Non a caso, il ceppo si può chiamare ràdica in un punto delle Marche, radichina in tutta la Sardegna (cfr. AIS 536), e Wurzelstock in tedesco. Ciò che conferma che il principale tratto distintivo del significato di ceppo/ceppa è la sua 'penetrazione' nel terreno;
(3) come mostra la documentazione del FEW s.v. sappa, nei dialetti dell'area franco-provenzale in cui la voce è attestata (v. oltre), essa non designa la 'zappa' (houe), bensì la vanga o il badile' (bêche) o la 'pala' (pelle). Ciò cherende la sappa franco-provenzale – che per la sua posizione periferica è certamente più arcaica di quella della Val Padana – ancora più simile al bastone di scavo paleolitico. Ci si può domandare, semmai, se il significato di cippus/*cippa
'radice conficcata nel terreno', così ampiamente documentato nell'area neo-italide (cfr. fr. cep, cat. cep, sp. e port. cepo e cepa etc.), sia uno sviluppo dal lat. classico cippus 'palo conficcato', come nell'ottica tradizionale si sarebbe obbligati a pensare, o se, nell'ottica continuista, non sia preferibile ipotizzare il passaggio inverso, dal significato arboricolo dialettale – tipico del latino neolitico, e poi scomparso dall'usodel ceto egemone in epoca romana – ai significati attestati in latino, cioè il palo conficcato della palizzata, il cippo sepolcrale e la pietra di confine. La logica dell'evoluzione ci lascia poca scelta.
La lettura in chiave archeologicaResta il problema se sia possibile attribuire l'innovazione lessicale a una specifica cultura archeologica. Problema la cui soluzione sarebbe importante, dato il ruolo centrale di uno strumento come la 'zappa' per le origini dell'agricoltura. Come sempre, lo strumento decisivo per tentare di realizzare questa identificazione è l'individuazione di possibili convergenze significative fra le aree linguistiche rilevanti e quelle di culture preistoriche sincronizzabili con la datazione dell'innovazione, in questo caso neolitica.
Ora, per quanto riguarda l'Italia, la carta dell'AIS 1428 mostra che il tipo zappa è diffuso in tutta la penisola. In Francia, invece, dove il nome della zappa più diffuso è quello chesi è affermato anche nella lingua standard – cioè houe, di origine germanica (cfr. ted. haue) – sappa “ist im Frpr. und in einer darananstossenden Zone beihametet”, e “hat von dort aus sich nur nur wenig in weitere Mundarten gedehnt” (FEW s.v. p. 212). Anche in Iberia, dove la zappa in catalano, castigliano e portoghese si chiama, rispettivamente, aixada, azada, enxada (da lat. *asciata), sapa e zapa hanno una diffusione limitata e sono considerati prestiti dall'italiano (cfr. DCECH). Quindi il focolaio dell'innovazione e della successiva diffusione di zappa non può essere che in alta Italia occidentale, da cui la voce si sarebbe poi diffusa nella contigua area franco-provenzale. Questa conclusione sembra confermare l'etimologia qui illustrata, secondo cui l'innovazioneavrebbe avuto luogo nella Val Padania occidentale, e precisamente nell'area dell'abbassamento di –e- [puntino sotto] implicata neo-italide ad /α/.
Ora, nel quadro neolitico in cui l'etimologia necessariamente si pone, la cultura che più si avvicina a quella del nostro fenomeno fonetico (e conseguentemente di sappa < *cippa) è quella del Neolitico antico (VI e V millennio a.C.) detta del Vho di Piadena (CR)1, la cui area è indicata nella cartina riprodotta qui sotto (fig. 7).
1 L'uso dell'articolo davanti al toponimo Vho, costante nella letteratura, è certamente dovuto ad una sua origine come nome comune. Assente nel DT, ritengo probabile che la sua origine sia da vadum 'guado' (cfr. Padus > Po).
Figura 7: Areale di distribuzione della cultura del Vho e delle altre culture del Neolitico antico in alta Italia (da Seragnoli, modificato)
Come si vede, la sua area comprende il Piemonte sud-occidentale, il Basso Cremonese, parte del Mantovano, il Bresciano, il Pavese e la Val Trebbia (Emilia occidentale) (cfr. Bagolini [1992, 285] e Seragnoli [2007-2008, 174-177]), e corrisponde quindi da vicino all'area fonetica sopra ricordata, e a quella lessicale di sappa da *cippa.
A questo punto, tuttavia, devo ritornare, per modificarla, su una tesi che ho presentato nel secondo volume delle mie Origini [2000, pp. 699-700], a proposito non solo dell' etimologia di zappada cippus, qui discussa, ma anche di quelle, foneticamente e culturalmente analoghe, e quindi sincroniche, di zattera da lat. secta (ligna) [ibid. 864], e di strappare da esxtirpat [ibid. pp. 853-854]. Come possibile causa dell'abbassamento della /e/ [puntino sotto] implicata ad /ε/ e ad /α/ avevo infatti ipotizzato un influsso slavo meridionale (che presenta un fenomeno simile), introdotto dalla cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (VBQ) del IV millennio, nota per le sue forti affinità con il mondo culturale balcanico. Questa ipotesi, tuttavia, si dimostra incompatibile con la cronologia imposta dall'origine di zappa, che nel nostro quadro non può che essere antico-neolitica (VI e V millennio) e non medio-neolitica. Se, quindi, si tratta di influenza slava, questa non sarà stata introdotta dalla cultura dei VBQ, bensì da quella di Starčevo (Serbia), anch'essa del Neolitico antico. E questo è tanto più verosimile in quanto la cultura del Vho, per alcuni suoi aspetti significativi, appare influenzata proprio da Starčevo [Bagolini 1992, 285, 304-305]: le figurine fittili muliebri bicefale, con decorazioni geometriche incise o dipinte, ritrovate al Vho, sono infatti tipiche delle culture di Starčevo edi Körös e, dal Vho, raggiungono anche la cultura di Fiorano e la facies piemontese di Alba [ibid.].
Ma, a rafforzare la nostra tesi, si può ancora aggiungere un'altra osservazione: la cultura del Vho non è soltanto aperta a contatti con l'oriente, ma si mostra anche capace di diffondere elementi della propria cultura in tutta l'area nord-italiana e alpina occidentale. Lo dimostra la recente scoperta, nell'area delVho, di ateliers specializzati nella lavorazione della pietra verde, che veniva prima reperita in Liguria, in Piemonte e nelle Alpi occidentali, e poi lavorata per ottenerne strumenti da taglio e oggetti di ornamenti, notevoli per la loro robustezza e per la loro estetica. Manufatti che appaiono diffusi in tutta l'Italia del nord. Per cui, come sintetizza la Seragnoli, «non si può escludere che proprio la cultura del Vho, per la sua posizione strategica a cerniera tra l’area occidentale e quella orientale, avesse un ruolo determinante nel veicolare tali prodotti» (v. fig.8). E' anche utile notare che l'importante commercio di questi manufatti (che proseguirà anche nei millenni successivi) seguiva direttrici fluviali (zattera!) e raggiungeva anche aree molto lontane.
Figura 8: Mappa dell’area di provenienza (in grigio) e localizzazione di alcuni dei siti ove sono stati rinvenuti manufatti in “pietra verde” (da
Seragnoli)
Inoltre, come appare dalla cartina, una delle principali aree per il reperimento della pietra verde era la Val d'Aosta. Di qui, gli agricoltori-manifatturieri della cultura del Vho poterono facilmente diffondere la voce zappa nel resto dell'area franco-provenzale.
Dall'alta Italia, poi, nei millenni successivi, la voce si sarà diffusa verso sud: con ogni probabilità alla fine del medio Neolitico, quando l'ondata della grande cultura di Chassey-Lagozza, strettamente associata a quella contemporanea di
Cortaillod, tipica dell'area franco-provenzale franco-svizzera, ricopre tutta la penisola. Anche la diffusione del tipo zappa nell'area germanica (v. sopra) rafforza questa ipotesi.
Si potrebbe obiettare che questo quadro contrasta con il fattoche in latino classico la zappa si chiama ligo, -onis, un probabile prestito dal greco (tardo) λίσγος. Perché adottare un prestito greco se la voce zappa era già diffusa in tutta la penisola fino dalla fine del Neolitico medio? La risposta non può che essere sociolinguistica, e mi sembra facile: perché zappa era tipica dellemasse servili rurali, aveva tutte le caratteristiche di una voce dialettale, e i proprietari romani certamente preferirono un termine più elegante.
ConclusioneAnche per chi rifiuta il quadro continuista illustrato in quest'ultima sezione, spero di esser riuscito a dimostrare, ancorauna volta, che senza uno studio preliminare della storia evolutivadella "cosa", che raggiunga, quando necessario, anche la preistoria, non si può fare etimologia seria, soprattutto se si haa che fare con il nome di uno strumento o di un istituto che conosca una lunga evoluzione. Anche nel quadro "romanzo" tradizionale, insomma, mi sembra sia mille volte preferibile adottare il passaggio da lat. cippus 'palo conficcato', a it. zappa,sulla base delle forme pre-metallurgiche del 'bastone da scavo', edel primato agricolo della Val Padana sul Centro-Sud, piuttosto che una somiglianza fra le corna di uno zappo caprone e una zappa adue rebbi. Ed anche per spiegare lo zappo caprone, invece di ricorrere al ciap-ciap e al solito bagaglio di congetture enigmistiche, sarebbe opportuno studiare prima la preistoria e la storia antica dell'allevamento caprino nell'area mediterranea, peridentificare l'eventuale sottotipo, la sua area di diffusione, e le possibili associazioni iconomastiche. Prima o poi, sono certo che qualche studioso vorrà cimentarsi con il problema in modo adeguato.
BIBLIOGRAFIA
AEI = G. Devoto, Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico, Firenze, Le Monnier, 1967.
AIS = K. Jaberg, J. Jud, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, Zofingen, Ringier, 1928-1940, 8 voll.
Alinei [2000] = M. Alinei, Origini delle lingue d’Europa II: Continuità dal Mesolitico all’età del Ferro nelle principali aree etnolinguistiche, Bologna, Il Mulino.
Alinei [2009], M. Alinei, L'origine delle parole, Roma, Aracne.ALT = Atlante Linguistico Toscano in rete, CNRS.Bagolini [1992], Il Neolitico nell'Italia settentrionale, in Alessandro Guidi,
Marcello Piperno (a cura di), Italia preistorica, Roma-Bari, Laterza, pp. 274-305.
DCECH = Corominas, Joan - Pascual, José A., Diccionario crítico etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, Editorial Gredos, Madrid, 1980-1983, 5 voll.
DCVB = A. M. Alcover, F. de B. Moll (1964-1969), Diccionari Català-Valencià-Balear. Inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana, Palma de Mallorca, Editorial Moll, 10 voll.
DEI = C. Battisti, G. Alessio , Dizionario Etimologico Italiano, Firenze, Barbera, 1968.DELF = Oscar Bloch, Walter Von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la
langue française, Paris, Presses Universitaires de France, 1960 .DELI = M. Cortelazzo, P., Zolli, Il nuovo ETIMOLOGICO: DELI - Dizionario
Etimologico della Lingua Italiana, seconda edizione in volume unico a cura di M Cortelazzo e M.A. Cortelazzo, con CD e motore di ricerca a tutto testo, Bologna, Zanichelli, 2002 (prima ediz. in cinque volumi: 1979).
DELL = A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, Paris, Klincksieck, 1959-19604 (prima ediz.:Paris, Klincksieck, 1932).
DT = AAVV., Dizionario di Toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani, Torino, UTET, 1990.
FEW = W. von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes, Basel, Zbinden, 1928 ss.
Leroi-Gourhan, André (a cura di) [1991-1992], Dizionario di preistoria. I.:Culture, vita quotidiana, metodologie; II.: Giacimenti, abitati e necropoli, monumenti, Torino, Einaudi.
MLLM = J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, 2 voll., Leiden, Brill, 1976.
PELI = Migliorini, Bruno - Duro, Aldo, Prontuario etimologico della lingua italiana, Torino, Paravia, 1958.
REW = W. Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, Carl Winters, 1935.
Rohlfs GSLID = G. Rohlfs, Grammatica Storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi, 1966-1969, 3 voll. (ediz. orig.: Historische Grammatik der Italienischen Sprache und ihrer Mundarten, Bern, Francke, 1949-1954, 3 voll.).
Scheuermeier, Paul [1983], Il lavoro dei contadini, Longanesi & C. , Milano, 2 voll.
Seragnoli, Laura [2007-2008], Il Neolitico, Dispense del Corso aa. 2007-2008, Università di Milano, Archeoserver.
VEI = Angelico Prati, Vocabolario etimologico italiano, Roma, Multigrafica.
Zamboni, Alberto [1990], Per una riconsiderazione generale del vocalismo cisalpino: l'abbassamento di /e/ neolatino in posizione, in Scritti in onore di Lucio Croatto, Centro di Studio per le Ricerche di Fonetica del CNR, Padova, pp. 287-296.