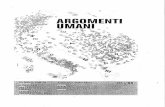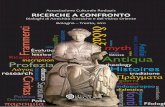L’origine delle origini. Jonathan Z. Smith e la storia naturale del cristianesimo
-
Upload
uni-regensburg -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of L’origine delle origini. Jonathan Z. Smith e la storia naturale del cristianesimo
ASE 32/1(2015) 199-216
Luigi walt
L’origine delle origini. Jonathan Z. Smith e la storia naturale del cristianesimo
199
«Was ist das Allgemeine? Der einzelne Fall. Was ist das Besondere? Millionen Fälle»
(J.W. Goethe, Maximen und Reflexionen, § 558)
«In culture, there is no text, it is all commentary… there is no primordium, it is all history…»
(J.Z. Smith, No Need to Travel to the Indies)
I. Quello dell’oscurità delle origini è un topos antichissimo e pro-teiforme, da sempre connesso alla riflessione dell’uomo sul mondo e sul suo posto nel mondo. Dagli inni dei Veda a Essere e tempo, dalla Teogonia di Esiodo al Finnegans Wake, le variazioni del mito non si contano, e nessuno si è mai azzardato a volerne scrivere la storia: sa-rebbe d’altronde un’impresa impossibile.1
Di fronte all’enigma delle origini, di fronte a quella che Vico, nella Scienza nuova, definì come «deplorata oscurezza delle cagioni e qua-si infinita varietà degli effetti»,2 l’uomo non ha mai cessato di porsi domande, e di elaborare altrettante risposte. Da questo punto di vista, come faceva notare Pierre Hadot, il celebre aforisma di Eraclito physis philei kryptesthai (fr. 1 DK), tanto spesso tradotto come «la natura ama nascondersi», potrebbe essere interpretato più correttamente come
1 Anche se non mancano, com’è ovvio, le antologie espressamente dedicate alle grandi speculazioni cosmogoniche dell’umanità: un esempio recente, destinato al grande pubblico, è offerto per esempio dal volume di M. Bielawski (a cura di), In principio. Racconti sull’origine del mondo, Milano, Garzanti, 2014; ma sarebbe assurdo non ricordare la riedizione di R. Pettazzoni, Miti e leggende, vol. I (1948), col titolo In principio. I miti delle origini, a cura di G. Filoramo, Torino, UTET, 1990. Per una prima definizione e classificazione dei racconti sulle origini, sono ancora preziose le pagine di U. Bianchi, Teogonie e cosmogonie, Roma, Studium, 1960.
2 Cito dalla Scienza nuova secondo l’edizione del 1744: G.B. Vico, La scienza nuova, a cura di P. Rossi, Milano, Rizzoli, 1998, 91.
ASE 32-1 2015.indb 199 29/05/15 09:37
200
«l’ori gine tende a rimanere nascosta».3 Di fatto, nonostante il nostro smarrimento davanti all’inesauribilità del “perché”, continuiamo ad essere affascinati dall’idea di incipit, anche quando l’incipit assume la forma di un caos inconoscibile o incomunicabile: un caos la cui oscu-rità, in qualche caso, può corrispondere soltanto alla nostra sciagurata capacità di usare violenza in nome di esso (come non pensare a quando Heidegger dichiarava, nel cuore di tenebra del Novecento, che «occorre farsi piccoli davanti alla terribilità segreta della presenza di tutto ciò che è inizio»?).
Un conto, tuttavia, è interrogarsi sul problema delle origini del co-smo, della vita, del tempo, e un altro conto è interrogarsi sull’origine, la prima occorrenza o il nucleo generativo di un determinato fenomeno nella storia dell’uomo, di una forma culturale, di un’istituzione, oppure – perché no? – di una singola opera d’arte.4 In questo caso, come si usa ripetere, le ragioni di Vico s’incontrano con quelle di Aristotele: essendo la scienza uno scire per causas, e dato che «provare per cause una cosa è lo stesso che farla»,5 dovremmo ben essere in grado d’indagare, e di legittimamente comprendere, tutto ciò che deriva dall’attività creatrice dell’uomo, ivi compreso quel bizzarro e vastissimo insieme di costrutti culturali che a partire dall’età moderna si è cominciato a rubricare sotto l’ambigua etichetta di “religione”.6
Ciò che mi propongo di offrire in questo intervento non è di cer-to l’ennesima riflessione sul concetto di religione o sulle origini del
3 Si veda in particolare P. Hadot, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura, Torino, Einaudi, 2006, 5-12 (ed. or. Paris, 2004).
4 Per tutti questi esempi, si vedano le suggestive pagine di G. Steiner, Grammatiche della creazione, Milano, Garzanti, 2003 (ed. or. London, 2001).
5 Vico, De antiquissima Italorum sapientia, III (cito dalla traduzione di P. Cristofolini, in: G.B. Vico, Opere filosofiche, I, Firenze, Sansoni, 1971, 63). L’importanza di Vico per la storia della storia delle religioni è un tema sul quale mi riprometto di tornare in futuro; per un primo orientamento, cf. almeno J. Mali, The Rehabilitation of Myth: Vico’s “New Science”, Cambrid-ge, Cambridge University Press, 1992; e J. Chabot, Giambattista Vico, ou la raison du mythe, Aix-en-Provence, Edisud, 2005. Curiosamente, nonostante il suo richiamo vichiano nel titolo, il bellissimo volume di G.G. Stroumsa, A New Science: The Discovery of Religion in the Age of Reason, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2010, non dedica al filosofo partenopeo che una manciata di righe.
6 Per una storia del termine e dei suoi impieghi moderni, mi limito a rimandare ai saggi di U. Bianchi (ed.), The Notion of “Religion” in Comparative Research: Selected Proceedings of the XVI International Association for the History of Religions Congress, Roma, “L’Erma” di Bretschneider, 1994; W. Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion, New York, Macmil-lan, 1963; G. Filoramo, Che cos’è la religione. Temi metodi problemi, Torino, Einaudi, 2004, 75-126; M. Sachot, “Religio / Superstitio. Historique d’une subversion et d’un retournement”, RHR 208/4 (1991) 355-94; J.Z. Smith, “Religion, Religions, Religious”, in: M.C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1998, 269-84 (ora in J.Z. Smith, Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2004, 179-96); B.C. Wilson, “From the Lexical to the Polythetic: A Brief History of the Definition of Religion”, in: T.A. Idinopulos, B.C. Wilson (eds.), What Is Religion? Origins, Definitions, and Explanations, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998, 141-61.
ASE 32-1 2015.indb 200 29/05/15 09:37
201
concetto di religione; ma sarebbe altrettanto insensato, da parte mia, pretendere di svolgere una riflessione sull’argomento che compare nel titolo stesso di questo contributo: vale a dire “l’origine delle origini”, dove per “origini” s’intendono le origini cristiane. Quella che cercherò di sviluppare, più modestamente, è una riflessione di secondo grado, ba-sata sulle domande che un grande studioso contemporaneo di religioni, l’americano Jonathan Z. Smith, ha cercato di porre su questo tema. In-nanzitutto, di che cosa parliamo quando parliamo di “origini cristiane”? Qual è l’oggetto specifico della nostra interrogazione? E attraverso quale apparato concettuale (metafore, categorie analitiche, campi disciplinari, ecc.) possiamo tentare di definirlo? E ancora: quando, come e perché si è sviluppata l’esigenza di un’indagine storica sulle origini del cristia-nesimo? Sulla base di quali fattori si è formato un interesse storico nei confronti delle origini cristiane? E su quali presupposti riposa l’analisi storica delle origini cristiane, a partire dalla definizione stessa del pro-prio oggetto d’indagine?
Tutte queste domande, naturalmente, non sono state poste per la prima volta da Jonathan Z. Smith: ma a Smith va ascritto il merito di averle collegate in unico insieme, facendo di esse l’oggetto di una ri-cognizione analitica che rimette in discussione, in maniera innovativa e radicale, il senso stesso del nostro “fare storia” sulle origini cristiane. Dell’elaborazione teorica di Smith non si è mai discusso adeguatamente in Italia, e se si esclude la presenza di qualche citazione sporadica in opere di autori per lo più di area francofona e tedesca, possiamo dire che la sua stessa ricezione in Europa è tuttora, a conti fatti, ben lontana dall’essere soddisfacente.7 All’Italia, comunque, spetta il privilegio di una prima menzione dello studioso in una pubblicazione di area non anglosassone: il nome di Smith compare infatti all’interno di una lettera che Mircea Eliade inviò a Ioan P. Culianu, e che questi pubblicò, non senza un pizzico di civetteria, come premessa a un profilo bio-biblio-grafico di Eliade, pubblicato presso le edizioni Cittadella nel 1978. In quella lettera, che Culianu stesso si peritò di volgere dal romeno alla
7 Fino alla recente – ed encomiabile – decisione di rendere disponibili al pubblico francofono alcuni saggi scelti dello studioso (cf. J.Z. Smith, Magie de la comparaison. Et autre études d’hi-stoire des religions, éds. D. Barbu, M. Meylan, Genève, Labor et Fides, 2014: volume segnalato in questo stesso numero di ASE), l’unico contributo di Smith a essere apparso in una lingua diversa dall’inglese era “The Domestication of Sacrifice”, all’interno della traduzione francese del volume collettivo Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, ed. R.G. Hamerton-Kelly, Stanford, Stanford University Press, 1987. Vale la pena di notare, tuttavia, come l’editore francese abbia scelto di presentare il volume sotto il solo nome di Girard (cf. R. Girard, Sanglantes origines, Paris, Flammarion, 2011), lasciando intendere il carattere subordinato – e in ogni caso meno “appetibile” – degli altri interventi. Il libro, in tal modo, è stato fatto passare come una sorta di tavola rotonda sulle tesi di Girard, laddove in origine esso raccoglieva i materiali di un colloquio organizzato da B.L. Mack, nell’autunno del 1983, attorno ai temi della violenza, del mito e del rito.
ASE 32-1 2015.indb 201 29/05/15 09:37
202
nostra lingua, il maestro biografato si rivolgeva all’allievo biografante, elogiandolo perché, benché lo sapesse «eliadiano», egli non era «caduto nel peccato di agiografia» (soprassediamo pure sull’innocenza della frase).8 Ma il punto che ci interessa arriva poche righe dopo, quando Eliade si abbandona a una breve digressione autobiografica:
«Se mi si chiede chi è il mio “maestro” o il mio “modello”, io rispondo sempre: R. Pettazzoni. E poi spiego: ho imparato da lui che cosa fare, non come fare (egli è storicista, etc.). Pettazzoni ha tentato per tutta la vita di fare la storia generale delle religioni. Questa è stata la sua grande lezione; perciò in Italia esistono alcuni storici delle religioni, mentre in Francia, in Germania, in Inghilterra, non esiste più nessuno. Della giovane generazione, per il momento, ci sei tu [Culianu] e Bruce Lincoln (Jonathan Smith ha quasi 40 anni…)».9
Sarebbe interessante commentare queste righe nel dettaglio, se non altro perché l’incontro e il rapporto con Eliade furono davvero decisivi (anche se non determinanti) per la formazione scientifica di Smith; ma tutto questo ci porterebbe troppo lontano.10 Passerò quindi, immedia-tamente, all’opera di Smith sulla quale intendo soffermarmi: Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity (1990).
II. Drudgery Divine raccoglie, in forma rielaborata, il ciclo delle “Louis H. Jordan Lectures in Comparative Religion” tenute da Smith presso la Scuola di Studi orientali e africani dell’Università di Londra,
8 Per il testo della lettera, cf. I.P. Culianu, Mircea Eliade, Assisi, Cittadella, 1978, 5-7 (cit. a p. 5). L’originale romeno è riportato in Id., Dialoguri întrerupte. Corespondenţă Mircea Elia-de – Ioan Petru Culianu, Iaşi, Polirom, 2004, 96-98. Sui possibili sottintesi dell’affermazione di Eliade, si vedano le pagine – non sempre equilibrate, ma spesso ricche di informazioni – di M. De Martino, Mircea Eliade esoterico. Ioan Petru Culianu e i “non detti”, Roma, Settimo Sigillo, 2008, 19-23 e 443-66. Come osserva De Martino, è davvero «difficile che Culianu non avesse sospettato qualcosa riguardo alle reali connessioni di Eliade con la Guardia di Ferro già nel 1978, data della redazione della bio-bibliografia» (ivi, 19), eppure nel suo testo egli non dedicò che un fugace accenno alla questione, con parole che tendevano a scagionare il maestro: «È da scartare però ogni legame diretto di Eliade col movimento legionario di C. Codreanu» (Culianu, Mircea Eliade, 34). Sui controversi legami tra Eliade e la Guardia di Ferro, si vedano le osservazioni di N. Spineto, Mircea Eliade storico delle religioni, Brescia, Morcelliana, 2006, 34-35 (con relativa bibliografia).
9 Eliade a Culianu, 3 maggio 1977 (cf. nota precedente; cit. a p. 6 di Culianu, Mircea Eliade). 10 Cf. quanto afferma lo stesso Smith nella sua scanzonata autobiografia intellettuale, “When
the Chips Are Down”, in: Relating Religion…, 1-60, soprattutto 11-17: «Ai tempi dell’università avevo deciso di leggere praticamente tutte le opere citate da Eliade negli straordinari apparati bibliografici del suo Trattato di storia delle religioni, prendendo lezioni private per acquisire la conoscenza di tutte le lingue che mi fossero state necessarie. Queste letture costituirono la mia formazione di base» (p. 13). Tutto ciò non impedì, ad ogni modo, di maturare un graduale distacco nei confronti di Eliade: cf. in particolare Id., “The Wobbling Pivot”, JR 52/2 (1972) 14-149 (ora in Id., Map Is Not Territory, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1993, 88-103 [1a ed. 1978]); e “Acknowledgments: Morphology and History in Mircea Eliade’s Patterns in Comparative Religion (1949-1999)”, I-II, in: Relating Religion…, 61-79 e 80-100.
ASE 32-1 2015.indb 202 29/05/15 09:37
203
nel marzo del 1988. Assieme a To Take Place: Toward Theory in Ri-tual (1987), è forse il contributo più compatto e omogeneo di Smith, e varrebbe la pena di rilevare i numerosi punti di contatto, sul piano metodologico e d’intenti, fra le due opere – ma anche questo è un tema sul quale sarò costretto a sorvolare.
Contributo compatto e omogeneo, si diceva, perché Jonathan Z. Smith è di norma autore rapsodico, che rifugge tanto dalle grandi si-stemazioni monografiche quanto dai lavori di sintesi: unica eccezione, ma solo in senso lato, è la direzione editoriale di The HarperCollins Dictionary of Religion, un’opera per la quale lo studioso ha stilato per-sonalmente più di quattrocento voci.11 La maggior parte dei contributi di Smith si trova pertanto sparsa in riviste, o raccolta in volumi che non presentano un disegno unitario. Complessivamente, abbiamo due raccolte di saggi accomunati da un singolo tema (le citate To Take Place e Drudgery Divine) e quattro collezioni di tipo antologico: Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions (1978), Imagining Reli-gion: From Babylon to Jonestown (1982), Relating Religion: Essays in the Study of Religion (2004) e il recentissimo On Teaching Religion (2013). A questa produzione, per molti versi non ingente ma sempre incisiva e di altissimo livello, bisogna aggiungere ciò che Smith stesso descrive, con piglio wittgensteiniano, come la parte più importante del proprio lavoro: quella dedicata all’insegnamento, e come tale destinata a restare, almeno per il momento, sommersa (Smith ha più volte affermato che il cuore dell’attività accademica non consiste nella pubblicazione di saggi e monografie, ma nella progettazione e stesura di syllabi per i corsi universitari).12
Nel panorama della produzione scientifica di Smith, Drudgery Di-vine occupa dunque un posto del tutto particolare, non soltanto per la robusta coerenza del disegno, ma anche – e direi soprattutto – perché in
11 L’elenco completo si può leggere nella bibliografia parziale riportata in appendice a Re-lating Religion…, 397-400 (nel dizionario le singole voci non sono accreditate). Accanto alla stesura di queste voci, molte delle quali di poche righe e di taglio puramente informativo, sono da attribuire a Smith anche il disegno complessivo del volume, l’introduzione generale, l’elaborazione teorica delle mappe, la scelta dell’ampio corredo iconografico e l’aggiunta dei rimandi interni ai vari lemmi.
12 Nel corso di una recente intervista, è stato chiesto a Smith di parlare dei suoi progetti fu-turi, al che lo studioso ha risposto: «L’anno prossimo potrei andare in pensione. Se ciò accadrà, temo che non concluderò nulla. Non ho mai pubblicato niente che non sia stato prima pensato e testato in un’aula scolastica» (P. Bornet, “Jonathan Z. Smith par lui-même”, intervista realizzata a Chicago nell’aprile 2010, Asdiwal 6 [2011] 23-37; ora in Smith, Magie de la comparaison…, 175-95: 195). Sull’importanza dell’attività didattica per Smith, e sulla concezione smithiana del ruolo degli studi religiosi nell’accademia, si possono leggere ora i vari saggi raccolti in J.Z. Smith, On Teaching Religion, ed. C.I. Lehrich, Oxford University Press, Oxford 2013. Nel corpo delle note di “When the Chips…”, peraltro, si trovano spesso descrizioni o programmi di corsi tenuti da Smith, con diversi accenni a progetti rimasti incompiuti: cf. 37-38, n. 28, 39-41 n. 33, 42-43 n. 38, 43-44 n. 40, 51-52 n. 75.
ASE 32-1 2015.indb 203 29/05/15 09:37
204
quest’opera il metodo dell’autore, la sua peculiare strategia analitica si rivelano nel loro stesso dispiegarsi.13 Questo ci permette di cogliere, qui più che altrove, la sostanza del lavoro comparativo tante volte descritto e auspicato da Smith; potremmo dire anzi che il laboratorio dello studioso non è mai stato così penetrabile allo sguardo di colleghi e allievi.14
La procedura tipica dei saggi di Smith è presto detta. Si parte dal-l’idea di fornire quella che viene definita come una «double archaeo-logy», una doppia archeologia (nel senso foucaultiano del termine), che mira a rileggere un testo o un artefatto culturale prestando attenzione sia al suo contesto generativo che al contesto di chi lo ha interpretato e reso “canonico”, cioè esemplare, per l’elaborazione di categorie analitiche o di particolari teorie nello studio dei fenomeni religiosi. Tra le condizioni che hanno sempre guidato Smith nella scelta dei propri argomenti, c’è quindi il carattere topico di determinati episodi e momenti della storia culturale e religiosa dell’umanità – specialmente nell’ambito del giu-daismo antico, dei sistemi religiosi di età ellenistica e della moderna letteratura etnografica – che hanno acquisito un ruolo fondante nella riflessione sui temi del mito e del rito, e più in generale nei tentativi di costruire una teoria “critica” della religione.
L’analisi si dipana di norma attraverso quattro operazioni distinte, che per Smith rappresentano altrettante fasi del lavoro comparativo: a) descrizione, b) comparazione, c) ri-descrizione e d) rettificazione.15 La prima fase, quella della descrizione, comprende in realtà due ulteriori operazioni: un esame contestuale dell’esempio prescelto e la conse-guente analisi della sua ricezione critica. Entrambe le operazioni sono applicate in seguito anche a un secondo caso, e solo a questo punto è possibile passare alla seconda fase del lavoro, quella della comparazione propriamente detta. Lo scopo della comparazione è la ri-descrizione degli esempi, grazie alla quale ciascuno di essi potrà essere riletto alla luce dell’altro. In questo modo si perviene all’ultima fase del processo,
13 Anche da qui deriva il titolo dell’opera, che allude sottilmente alle metafore alchemiche del poema The Elixir (1633) di George Herbert. A questa poesia, secondo Smith, farebbe allusione anche Thomas Jefferson, nel passaggio delle Notes on Virginia (1781) citato in epigrafe a Drudgery Divine (cf. Smith, “When the Chips…”, 53, n. 80).
14 Oltre allo speciale panel dedicato a Drudgery Divine all’interno di un convegno annuale dell’American Academy of Religion (Kansas City, 1991: materiali raccolti in H.G. Kippenberg, T.E. Lawson [eds.], “Panel on Jonathan Z. Smith’s Drudgery Divine”, Numen 39 [1992] 217-38), le recensioni critiche al volume furono innumerevoli: per un elenco dettagliato, si vedano le “Reading Notes” di K.R. Schaeffer: <http://religion.ua.edu/secure/rel490drudgerynotes.pdf> (url consultato il 31 gennaio 2015).
15 Lo schema deriva da J.Z. Smith, “Epilogue: The ‘End’ of Comparison”, in: K.C. Patton, B.C. Ray (eds.), A Magic Still Dwells: Comparative Religion in the Postmodern Age, Berkeley, University of California Press, 2000, 237-41: 239; ma si vedano anche le osservazioni di metodo in Smith, Imagining Religion…, xi-xiii.
ASE 32-1 2015.indb 204 29/05/15 09:37
205
cioè alla rettificazione delle categorie analitiche che sono scaturite dallo studio di quegli stessi esempi.
Questo schema di base si ritrova, con minime varianti, in moltis-simi contributi di Smith, ed è stato applicato, di volta in volta, per la decostruzione delle elaborazioni teoriche di James G. Frazer,16 di Adolf Jensen e della scuola di Leo Frobenius,17 di Mircea Eliade,18 come pure di autori verso i quali andava tutta la simpatia di Smith, per esempio Lucien Lévy-Bruhl o Claude Lévi-Strauss.19 Ma non è questo che tro-viamo – o non così scopertamente – in Drudgery Divine. In questo caso, a essere oggetto della dissezione anatomica20 di Smith non è un singolo mitologema, e nemmeno una singola categoria analitica, bensì un’intera e sfaccettata topografia di interessi, di pratiche e di discorsi storiografici, facenti capo al problema delle cosiddette origini del cristianesimo. Se in questo contesto parliamo di “topografia”, è in riferimento a quanto scrisse Michel De Certeau sull’operazione storiografica:
«Ogni ricerca storiografica si articola su un luogo di produzione socio-economico, politico e culturale. Essa implica un ambiente di elabora-zione circoscritto da determinazioni specifiche: una professione libe-rale, un posto di osservazione o una cattedra, una categoria di letterati, ecc. È dunque soggetta a condizionamenti, legata a privilegi, radicata in una particolarità. In funzione di questa collocazione si instaurano dei metodi, si precisa una topografia di interessi, si organizzano dossier e domande da porre ai documenti».21
Ora, come sappiamo bene, perché una buona critica possa esercitarsi è necessario che ci siano anzitutto buone domande. Ma questo implica che, per capire il modo in cui ci si è posti storicamente di fronte a un determinato problema, il metodo migliore non sia tanto quello di guar-dare alle risposte che ad esso sono state date nel tempo, quanto quello
16 Il primo amore di Smith, oggetto della sua monumentale (e a tutt’oggi inedita) tesi di dottorato, The Glory, Jest and Riddle: James George Frazer and The Golden Bough (Yale University, 1969): alcuni risultati di questo lavoro sono confluiti nel saggio “When the Bough Breaks”, HR 12/4 (1973) 342-71 (ora in Map Is Not Territory…, 208-39).
17 Soprattutto in uno dei contributi più virtuosistici di J.Z. Smith, “A Pearl of Great Price and a Cargo of Yams: A Study in Situational Incongruity”, HR 16 (1976) 1-19 (ora in Map Is Not Territory…, 90-101 e [“Appendix I”] 121-26).
18 Vd. sopra nota 10, con particolare riferimento a “The Wobbling Pivot”. 19 Cf. J.Z. Smith, “I Am a Parrot (Red)”, HR 11/4 (1972) 391-413 (ora in Map Is Not
Territory…, 265-88). 20 La metafora riprende il ritratto di Smith («the greatest pathologist in the history of re-
ligions») abbozzato da Culianu, nella sua breve recensione a Drudgery Divine: «As in many precedent cases, Smith follows a standard procedure: he carefully selects his victim, and then dissects with artistic finesse and unequaled acumen. The operation is always necessary, and a deconstructor of Smith’s caliber is hard to find» (in JR 72/3 [1992] 476-77). Con diabolica ironia, l’autore aggiunge poi che «pathology is circular: one day, no doubt, Smith himself will end up on the dissection table» (ivi, 476).
21 M. De Certeau, La scrittura della storia, ed. it. a cura di S. Facioni, Milano, Jaca Book, 2006, 64 (ed. or. Paris, 1975).
ASE 32-1 2015.indb 205 29/05/15 09:37
206
di interrogarsi sulla particolare natura delle domande con le quali è stato affrontato. Ed è questo, precisamente, l’obiettivo del lavoro di Smith. L’interesse è eminentemente teoretico, e si rivolge in prima istanza al problema della comparazione, con lo scopo di «ripensare l’impresa comparativa secondo modalità appropriate all’autocomprensione degli studiosi (academy’s self-understanding), ma anche alla loro percezione dei procedimenti e degli scopi di un’indagine disciplinata». Il banco di prova è offerto per l’appunto da un esempio paradigmatico («a classic and privileged example»), quello del confronto tra i primi cristianesimi («early Christianities», si noti il plurale) e le religioni della Tarda Anti-chità, specialmente i cosiddetti culti misterici.22
Di conseguenza, la requisitoria di Smith si articola in cinque capito-li, intitolati rispettivamente On the Origin of Origins (“Sull’origine del-le origini”, 1-35), On Comparison (“Sulla comparazione”, 36-53), On Comparing Words (“Sulla comparazione di parole”, 54-84), On Compa-ring Stories (“Sulla comparazione di storie”, 85-115) e On Comparing Settings (“Sulla comparazione di contesti”, 116-43). Per non trasformare il mio intervento in una recensione fuori tempo massimo, mi limiterò in questa sede a riportare a volo d’aquila i principali argomenti dei primi due capitoli, accennando solo di sfuggita a quanto esposto da Smith nel resto del libro. Concluderò poi con alcune osservazioni sull’importanza complessiva di Drudgery Divine, e su come il progetto smithiano di una doppia archeologia delle origini cristiane potrebbe essere proseguito oggi con profitto.
III. Il primo capitolo del libro si apre con un’istantanea,23 dedicata a quello che Smith descrive come «one of the most touching moments of rapprochement in western history»,24 vale a dire la riconquistata amici-zia, dopo anni di rivalità politica e alcune incomprensioni epistolari, tra due padri fondatori della storia americana: John Adams, secondo presi-dente degli Stati Uniti d’America, e il suo successore Thomas Jefferson.
22 J.Z. Smith, Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, Chicago, The University of Chicago Press, 1990, vi. Per una panoramica sulle più recenti tendenze del dibattito intorno al comparativismo religioso, si vedano i contributi raccolti in: F. Boespflug, F. Dunand (éds.), Le comparatisme en histoire des religions, Paris, Cerf, 1997; M. Burger, C. Calame (éds.), Comparer les comparatismes. Perspectives sur l’his-toire et les sciences des religions, Lausanne, Études de lettres, 2005; R. Gothóni (ed.), How to Do Comparative Religion? Three Ways, Many Goals, Berlin, Walter De Gruyter, 2005; T. Idinopulos, B.C. Wilson, J.C. Hanges (eds.), Comparing Religions: Possibilities and Perils?, Leiden-Boston, Brill, 2006; C. Grottanelli, G. Clemente (a cura di), Comparativa/mente, Firenze, Seid, 2008; C. Calame, B. Lincoln (éds.), Comparer en histoire des religions antiques, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2012; si vedano anche i fascicoli di Annales 58/1 (2003) e Le genre humain 42 (2004).
23 È Smith stesso a definirla così (il termine è snapshot), in: Drudgery Divine…, 33. 24 Ivi, 1.
ASE 32-1 2015.indb 206 29/05/15 09:37
207
L’esame del loro ampio carteggio (158 lettere, di cui 47 incentrate su tematiche religiose) permette innanzitutto a Smith di individuare la loro comune predilezione per le posizioni del deismo inglese, e in particolare per l’opera del filosofo e teologo dissenziente Joseph Priestley. Adams e Jefferson condividono uno stesso progetto di riforma storica del cri-stianesimo, ovvero di riforma del cristianesimo a partire dalla storia: entrambi sono convinti che il sublime messaggio morale del Cristo sia stato corrotto dalle chiese, e che occorra riportarlo alla purezza delle origini, liberando gli scritti degli apostoli e le parole di Gesù dalle incro-stazioni dottrinali dovute al contatto con le «assurdità» del paganesimo orientale e/o greco (Priestley, nei suoi scritti, ondeggiò senza troppi scrupoli tra l’una e l’altra opzione): assurdità che avrebbero condotto, nel loro punto di massima degenerazione, all’«idolatria» e alle «super-stizioni» del cattolicesimo romano. Le posizioni di Jefferson e Adams, osserva Smith, sono chiaramente il riflesso di una ri-narrazione mitolo-gica delle origini cristiane, che affonda le proprie radici nella polemica cinquecentesca tra protestanti e cattolici – laddove i primi proponevano di interpretare le dottrine e le pratiche dei secondi come risultato di una degenerazione ispirata o «dal diavolo» o da «infiltrazioni pagane».25
Due tradizioni polemiche, in proposito, vengono passate al setac-cio da Smith: da una parte quella dei controversisti antitrinitari di età moderna (Socino, Serveto), dall’altra quella dei teorici del cosiddetto «pagano-papismo» (John Corbet, Conyers Middleton).26 Se i primi af-frontano il problema della corruzione del cristianesimo concentrandosi sulla storia delle dottrine, i secondi preferiscono insistere sui riti e sulle pratiche. Mancando però di uno sguardo libero da preoccupazioni con-fessionali, e soprattutto di un metodo comparativo adeguato, entrambe le parti finiscono con l’assimilare superficialmente, secondo Smith, il cattolicesimo al paganesimo, con l’effetto di proiettare sulle religioni della Tarda Antichità i difetti imputati ai papisti contemporanei. Paga-nesimo e Tarda Antichità, in definitiva, diventano «parole in codice» per indicare il cattolicesimo,27 e la feroce disanima di Smith, in particolare ai capitoli terzo e quarto, si preoccupa di rintracciare la sopravvivenza di questo assunto nella successiva storia degli studi cristianistici e neo-testamentari, anche in forma implicita o sotterranea, come una sorta di peccato originale dal quale è impossibile sfuggire.
Smith fa derivare da qui, in maniera significativa, lo sviluppo di differenti strategie retoriche e storiografiche volte a preservare l’unicità
25 Ivi, 13-14. Nel primo caso si può parlare di una causa interna (fu la tesi di Flacio Illirico e dei centuriatori di Magdeburgo), mentre nel secondo di una causa esterna (tesi sostenuta da Calvino, Melantone e Bullinger, fra gli altri).
26 Cf. ivi, 25. 27 Ivi, 43.
ASE 32-1 2015.indb 207 29/05/15 09:37
208
del cristianesimo,28 ciò che renderebbe il cristianesimo irriducibile alle altre religioni e gli permetterebbe al contempo di diventare misura per la definizione stessa del concetto di “religione”. Una prima strategia, che potremmo chiamare de-ellenizzante, tende per esempio a sottolineare la distanza incolmabile tra cristianesimo paolino e culti misterici (per inter-pretare i quali, osserva Smith, gli studiosi non disdegnano l’impiego di categorie concettuali mutuate dalla teologia cattolica dei sacramenti): ad agire, in questo caso, è l’equazione implicita per cui «apostolico» sta a «protestante» come «pagano» sta a «cattolico».29 Una seconda strategia punta invece a recuperare, sempre in maniera funzionale e apologetica, il rapporto genealogico tra cristianesimo e giudaismo, vuoi per confer-mare l’isolamento dei primi cristiani dal quadro globale delle religioni ellenistiche, vuoi per rappresentarne la filiazione diretta dal giudaismo, da intendersi però, alla bisogna, come un antenato da “superare”.
Ciò che sta alla base di tutte queste prospettive, per Smith, è un errore di tipo teoretico, che vanifica il procedimento stesso della com-parazione: si tratta dell’imposizione di una categoria ontologica e dun-que extra-storica, quella di “unicità”, all’analisi di fenomeni storici, per comprendere i quali sarebbe invece necessario ricorrere a nozioni come somiglianza e differenza. Dire che qualcosa è “totalmente unico” o “totalmente altro”, in effetti, equivale a sottrarlo dalla possibilità di essere pensato attraverso il confronto con qualcos’altro: il totalmente altro, come il sacro di Rudolf Otto, è incommensurabile; mentre il total-mente unico è incomparabile, e anzi sarebbe empio volerlo assimilare a qualcos’altro. In ultima analisi, il principio nascosto che informerebbe e minerebbe tutti questi primi tentativi di comparazione tra cristianesimo e religioni della Tarda Antichità sarebbe il seguente: cristianesimo apo-stolico e protestantesimo vengono ascritti al reame dell’«unico», mentre religioni della Tarda Antichità e cattolicesimo a quello del «medesimo», dello «stesso». Come chiarisce Smith, in una delle sue pagine più felici,
«il modello di questa strategia difensiva è antico quanto la storia della comparazione religiosa, e si trova già nella nozione erodotea di “au-toctonia”. Ma questo concetto di generazione spontanea, in Erodoto,
28 Qualcosa di analogo, da un punto di vista comparativo, si può rilevare anche per l’islam: cf. il recente volume di M. Cook, Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective, Princeton, Princeton University Press, 2014, recensito da J. Benthall in un articolo dal titolo eloquente: “What Makes Islam Unique?”, TLS, 10 settembre 2014 (ringrazio Cristiana Facchini per la segnalazione di questo articolo).
29 Da queste righe si potrebbe pensare che quella di Smith sia una mera ricostruzione contro-apologetica, decisamente ingenerosa nei confronti della storia intellettuale del protestantesimo. In realtà le critiche di Smith non risparmiano né il mondo cattolico né la storiografia di impianto illuminista e/o non confessionale: su quest’ultimo versante, basti pensare al caustico trattamento che Drudgery Divine riserva alla questione dei rapporti tra la morte e risurrezione di Gesù e i vari miti delle cosiddette divinità «che muoiono e risorgono» (si vedano in particolare le pp. 89-111 e 125-29).
ASE 32-1 2015.indb 208 29/05/15 09:37
209
si accompagna sempre a un secondo topos, la nozione di “prestito”. Così gli Egiziani, per i loro costumi, non dipendono da nessuno, e “gelosi delle proprie tradizioni, non ne accettano altre” (Hist. II, 79); mentre i Persiani, suscitando lo sdegno di Greci ed Egizi, prendono in prestito da tutti, e “più di tutti gli altri popoli amano accogliere gli usi stranieri” (Hist. I, 135). […] Dai tempi di Erodoto i nomi sono cambiati, ma le relazioni sono rimaste le stesse. Da ciò consegue che il cristianesimo primitivo debba essere considerato autoctono; e se esso presenta una qualche forma di dipendenza, questa possa essere solo da un precedente illustre. In questo modello, Israele recita la parte dell’Egitto di Erodoto, mentre la chiesa cattolica (o nelle trattazioni più recenti, il “sincretismo greco-orientale”) riveste i panni della Persia».30
Per comprendere in quale misura una tale logica continui a esse-re attiva e operante anche oggi, è sufficiente pensare al modello stan-dard con cui gli studiosi di origini cristiane sono soliti rappresentare il problema della cosiddetta «separazione delle vie» tra giudaismo e cristianesimo; basterebbe un rapido confronto tra questo modello e la visione supersessionista ricavabile dagli scritti di Eusebio di Cesarea, per rendersi conto di come i due schemi siano concordi nell’escludere (cioè nel mantenere al di fuori dei propri confini) quelle che vengono genericamente indicate come «varietà del paganesimo».31 Accade così che la comparazione sia resa impossibile: perché invece di fondarsi sull’analogia, cioè sulla somiglianza di forma e struttura tra specie che non condividono un antenato comune (e che perciò non possono ri-vendicare un primato), essa viene ridotta per motivazioni apologetiche all’omologia, cioè a una relazione di tipo genealogico, dove i rapporti possono essere sia diretti (riguardando la discendenza o, sempre per attenersi al lessico delle scienze naturali richiamato da Smith, il pedi-gree) sia indiretti (implicando tutt’al più prestito e contaminazione).32
Anche per questo, osserva ironicamente Smith, «in comparison a magic dwells», nella comparazione c’è qualcosa di magico – dove il riferimento è alle due leggi speciali della magia, secondo la celeberrima formulazione di Frazer: entrambe basate sulla simpatia, l’una agisce per somiglianza, l’altra per contatto o contiguità.
IV. Fin qui, per sommi capi, la pars destruens del libro. Ma quali sono le strade alternative che Smith propone di percorrere, per uscire da questa impasse secolare? Al riguardo, i punti da sottolineare sarebbero
30 Ivi, 45-46. 31 Si vedano le utilissime rappresentazioni grafiche approntate da M. Goodman, “Modeling
the ‘Parting of the Ways’”, in: A.H. Becker, A.Y. Reed (eds.), The Ways That Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003, 119-29.
32 Cf. Smith, Drudgery Divine…, 46-53 (sulla differenza tra omologia e analogia, che risale al biologo Richard Owen, cf. ivi, 47-48, n. 15).
ASE 32-1 2015.indb 209 29/05/15 09:37
210
tanti. Rimandando ad altra sede, per il momento, la trattazione dell’im-portante coppia analitica «locativo vs. utopico», che Smith adopera per ri-descrivere i cristianesimi delle origini (anche nel loro rapporto con i sistemi religiosi della Tarda Antichità), mi limiterò ad accennare soltanto a tre parole-chiave, che dischiudono altrettante indicazioni di metodo. Questo mi permetterà di segnalare alcune piste d’indagine che si potrebbero seguire, fruttuosamente, sulla scia di Drudgery Divine.
1. La prima parola, ovviamente, è comparazione. Nella particola-re ottica di Smith, la comparazione non ha il compito di dirci «come sono le cose» («questo – avverte lo studioso – è il presupposto che soggiace alla nozione di “genealogia”, con la sua ricerca di connes-sioni storiche “reali”»); allo stesso modo dei modelli o delle metafore, essa può invece indicarci «come le cose potrebbero essere pensate, e perciò ri-descritte».33 La comparazione, pertanto, è un affare che ri-guarda essenzialmente lo studioso e il suo modo concreto di porsi di fronte ai fenomeni. Contro chi sostiene che alle scienze storiche man-cherebbe per principio la «possibilità della conferma sperimentale», e si rimarrebbe «sempre dipendenti dalla validità di ipotesi più o meno incontrollabili»,34 è interessante a questo punto rilevare la profonda sintonia che lega il procedimento smithiano di comparazione alla conce-zione classica di metodo sperimentale. Anche in senso negativo: perché l’esperimento, di per sé, non riguarda mai direttamente la natura, ma la natura sotto certe condizioni, stabilite a priori dall’osservatore e rilevate in seguito dai suoi strumenti. L’esperimento, in tal senso, non ci informa su com’è “davvero” il mondo, ma si limita per così dire a provocarne le reazioni, permettendoci di descriverle: da qui il suo valore euristico, e da qui la sua stretta somiglianza con l’impresa comparativa delineata in Drudgery Divine.35
L’approccio naturalistico di Smith – che in giovinezza, non dimenti-chiamolo, compì studi di botanica, serbando viva questa passione anche in seguito – può essere messo a confronto con quello di Goethe, del Goethe scienziato, di cui Smith si è sempre dichiarato attento lettore ed estimatore.36 A giusto titolo si è definita quella di Goethe come una “scienza protestante”, sempre attenta a cogliere l’intima connessione tra
33 Ivi, 52. 34 Così L.L. Cavalli Sforza, Geni, popoli e lingue, Milano, Adelphi, 1996, 12 (ed. or. Paris,
1996). 35 Il paragone tra comparazione e metodo sperimentale si trova già in G. Dumézil, Loki, Paris,
Flammarion, 1986, 68 (1a ed. 1948): il comparativismo è «la forma che riveste naturalmente, nelle scienze umane, il metodo sperimentale».
36 Si veda il confronto ingaggiato da Smith tra la Metamorfosi delle piante di Goethe e il progetto eliadiano di una morfologia delle forme religiose, in “Acknowledgments…”, I. Per farsi un’idea della complessità del discorso goethiano sulla natura, come pure della sua permeabilità a letture metodologicamente e ideologicamente anche molto distanti fra loro, rimando invece ai
ASE 32-1 2015.indb 210 29/05/15 09:37
211
riflessione scientifica e storia della riflessione scientifica, tra filosofia della scienza e storia della scienza. Nelle parole di Goethe, «la storia dell’uomo presenta l’uomo, e nello stesso senso possiamo affermare che la storia della scienza è la scienza stessa».37 Nessuna distinzione di rango, quindi, tra conoscenza scientifica e conoscenza umanistica: ma al contrario apertura totale a un sapere critico, che rimetta in continua discussione le proprie impalcature teoriche. «Le ipotesi – osservava Goethe – sono impalcature che s’innalzano prima dell’edificio e che si tolgono quando l’edificio è compiuto. Sono indispensabili al muratore, solo che questi non deve scambiare l’impalcatura per l’edificio». Nel momento in cui ci troviamo di fronte a un castello di ipotesi, come quel-lo che l’autore del Faust imputava all’approccio matematizzante della scienza newtoniana – e come quello che Smith, da parte sua, denuncia presente nella storiografia sulle origini cristiane –, il primo compito che attende lo studioso è quello di smantellarlo «a partire da comignolo e dal tetto», facendo sì che «il sole finalmente entri a far luce in quel covo di topi e civette».38
Ma sbaglieremmo a pensare che il merito dell’operazione di Smith risieda esclusivamente in questo piglio decostruttivo. Altrettanto impor-tante è il richiamo alla comparazione, di qualunque tipo essa sia, per ripercorrere la storia delle nostre immagini del cristianesimo primitivo. Già un’ampia serie di studi ha potuto evidenziare l’intreccio fra la nasci-ta del comparativismo religioso e gli esordi della moderna scienza delle religioni,39 per un insieme di concause che va dalla scoperta delle (e dal contatto con le) culture extra-europee, evento che portò alla nascita dell’etnografia moderna, fino all’invenzione della stampa a caratteri mobili, legata a doppio filo alle evoluzioni della critica filologica; e dal conflitto di memorie tra cattolici e riformati, coevo al resources-sement degli umanisti, fino al problema delle “antichità gentilesche”, che contribuì allo sviluppo di una sensibilità antiquaria e archeologica. L’apporto di Smith si inserisce a pieno titolo in questo filone di studi,
contributi che compongono il bel volume di G. Giorello, A. Grieco (a cura di), Goethe scienziato, Torino, Einaudi, 1998, dal quale dipendo per molte delle affermazioni che seguono.
37 J.W. Goethe, La teoria dei colori, a cura di R. Troncon, Milano, il Saggiatore, 1983, 9. 38 Id., Massime e riflessioni, trad. it. a cura di S. Giametta, Milano, Rizzoli, 2013, § 1222.
Le frasi di Goethe ricordano una delle proposizioni centrali del Tractatus di Wittgenstein, altro punto di riferimento per Smith: «Le mie proposizioni si illustrano così: colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, se è salito per esse – su esse – oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo che v’è salito)» (L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trad. it. a cura di A.G. Conte, Torino, Einaudi, 1989, § 6.54).
39 La bibliografia è abbondantissima. Oltre al già citato lavoro di Stroumsa, A New Science…, si vedano quantomeno i contributi fondamentali di S. Gruzinski, C. Bernard, Dell’idolatria. Un’archeologia delle scienze religiose, Torino, Einaudi, 1995 (ed. or. Paris, 1988); H.G. Kippenberg, La scoperta della storia delle religioni. Scienza delle religioni e modernità, Brescia, Morcelliana, 2002 (ed. or. München, 1997); e P. Borgeaud, Aux origines de l’histoire des religions, Paris, Seuil, 2004.
ASE 32-1 2015.indb 211 29/05/15 09:37
212
ma con l’indubbio vantaggio di presentare questa storia come una storia presente. Ritroviamo qui il doppio movimento della comparazione: se analogica, aiuta a distinguere la prospettiva delle scienze religiose da quella delle discipline teologiche; se genealogica, permette di capire che la storia delle origini cristiane (così come la storia della storia delle origini cristiane) comincia sempre con una comparazione, fosse anche la più elementare di tutte: quella tra i cristiani di oggi e i cristiani di ieri.
2. Questo ci riporta alla seconda parola-chiave che vorrei sottoli-neare: tassonomia. Il termine rimanda, in primo luogo, all’esigenza di costruire una storia naturale delle religioni, inserendo il cristianesimo all’interno di essa. Da questo punto di vista, mi pare altamente signifi-cativo il tentativo di Smith di opporsi a una lettura “evoluzionista” dei fenomeni religiosi: anche nella sua proposta di distinguere tra quattro tipologie fondamentali di comparazione – etnografica, enciclopedica, morfologica ed evolutiva – la sua preferenza va esplicitamente al terreno della morfologia, seppur mitigata dalle esigenze di uno storicismo ben temperato.40 È qui che si avverte, d’altronde, la genealogia “spiritua-le” dell’autore, che può esser fatta partire, come dicevo più sopra, da Goethe, e che arriva fino a Lévi-Strauss, passando attraverso due snodi d’importanza cruciale: il neokantismo di Cassirer, con la sua filosofia delle forme simboliche, e la sociologia di Durkheim, il cui capolavoro sulle forme elementari della vita religiosa è considerato da Smith come l’opera che più ha avuto influenza su di lui, assieme ai modelli “nega-tivi” rappresentati da Frazer ed Eliade.41
Anni fa, Giovanni Filoramo ebbe a osservare che «la polifonia in-terpretativa dello studio scientifico della religione è stata contraddistinta da un basso continuo articolato su di una serie di presupposti e di con-vinzioni, che sono stati estrapolati dal mondo delle scienze della natura e adattati, in forme e gradi diversi, al mondo dell’interpretazione della religione».42 Ora a me piacerebbe, sulla scia di Smith, rovesciare almeno in parte questa constatazione, o farne percepire tutta la problematicità.43
40 Cf. in particolare J.Z. Smith, “Adde Parvum Parvo Magnus Acervus Erit”, HR 11/1 (1971), 67-90 (ora in Map Is Not Territory…, 240-64). Questa distinzione attende ancora di essere esplorata a fondo.
41 Sull’influenza di Durkheim, cf. Bornet, “Jonathan Z. Smith par lui-même…”, 179; ma si vedano anche le osservazioni in Smith, “The Topography of the Sacred…”, in: Relating Reli-gion…, 103-109; e in “Manna, Mana Everywhere and / ̮/̮ /”, 127-34 (in: N.K. Frankenberry [ed.], Radical Interpretation in Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 188-212; ora in Smith, Relating Religion…, 117-44). Per una valutazione delle altre influenze intellettuali, rimando ancora alle pagine di “When the Chips…”.
42 G. Filoramo, Religione e ragione tra Ottocento e Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1985, 225.
43 È sempre Filoramo, d’altra parte, a riconoscere la chiara «derivazione cristiana» di determinate concezioni scientifiche, come ad esempio l’equiparazione tra sviluppo filogenetico
ASE 32-1 2015.indb 212 29/05/15 09:37
213
Consideriamo per un istante il problema dell’evoluzionismo, sulla cui storia siamo bene informati.44 Sappiamo che il termine “evoluzio-ne” – che oggi tendiamo a identificare semplicisticamente con Darwin, benché nel suo capolavoro sull’Origine delle specie questa parola non compaia mai – allude etimologicamente allo svolgimento del rotolo, a ciò che ne permette la lettura. Il dettaglio non è di poco conto: il pro-cesso evolutivo di una forma vivente – anche se i primi a utilizzare il termine, com’è stato giustamente osservato, non lo intendevano affatto come un processo – è ciò che permette l’osservabilità della stessa forma vivente da parte di un osservatore esterno. In assenza di un osservatore/lettore, la forma/rotolo rimane infatti illeggibile, perché non “evolve”, non si dispiega per quello che è.
Tecnicamente, i primi evoluzionisti furono dei “fissisti”, partiro-no cioè dal presupposto dell’immutabile fissità delle specie: erano i cosiddetti preformisti, che muovendo dalla teoria embriologica della preformazione o preesistenza dei germi si divisero ben presto tra ovisti e animalculisti.45 Entrambe le scuole di pensiero, tuttavia, condividevano l’idea che non si potesse parlare di “generazione”, ma solo di “sviluppo” degli organismi viventi;46 e ciò anche per influsso delle gerarchie cat-toliche, che a quel tempo difendevano l’idea di generazione spontanea (non senza avanzare giustificazioni bibliche, per esempio richiamandosi a un passaggio del libro dei Giudici in cui si parla della nascita di api dalla carcassa di un leone).47
Buona parte della storia dell’embriologia moderna si è giocata attra-verso lo scontro tra i preformisti e quanti parteggiavano per una visione alternativa alla loro, postulando uno sviluppo graduale degli organismi,
e ontogenetico (Filoramo, Religione e ragione…, 29; su questo punto cf. anche S. Pollard, The Idea of Progress: History and Society, New York, Basic Books, 1968, 31 ss.). Una riflessione più articolata, ma sulla stessa lunghezza d’onda di quella che cercherò di svolgere ora, si trova nell’affascinante ricognizione di G. Bocchi, M. Ceruti, Origini di storie, Milano, Feltrinelli, 2009, 141-202 (1a ed. 1993).
44 Si vedano, fra i tanti, i profili storici di G. Barsanti, Una lunga pazienza cieca. Storia dell’evoluzionismo, Torino, Einaudi, 1995; e P.J. Bowler, Evolution: The History of an Idea, Berkeley, University of California Press, 1983; molto utile anche É. Gilson, Biofilosofia: da Aristotele a Darwin e ritorno. Saggio su alcune costanti della biofilosofia, Genova, Marietti, 2003 (ed. or. Paris, 1971).
45 Teoria esposta in maniera compiuta da diversi studiosi seicenteschi, come Giuseppe degli Aromatari, nell’Epistola de generatione plantarum (1625), o Jan Swammerdam, nell’Historia insectorum generalis (1669), e che sembrò trovare conferma nelle verifiche sperimentali di Marcello Malpighi (Dissertatio epistolica de formatione pulluli in ovo, 1672) e nella scoperta degli «animalculi spermatici» da parte di Antoni van Leeuwenhoeck (1677). Per maggiori ragguagli, si veda Barsanti, Una lunga pazienza cieca…, 33-43.
46 Una celebre incisione esprime perfettamente questa idea, e rappresenta un omuncolo, già provvisto di testa torace braccia e gambe, racchiuso all’interno di uno spermatozoo (riproduzione in Barsanti, Una lunga pazienza cieca…, 42).
47 Cf. J. Rostand, Lazzaro Spallanzani e le origini della biologia sperimentale, Torino, Einaudi, 1967, 15-16 (ed. or. Paris, 1951).
ASE 32-1 2015.indb 213 29/05/15 09:37
214
vale a dire l’epigenesi (alla lettera, “generazione dopo”). Una volta costatate le debolezze intrinseche del preformismo (come l’incapacità di spiegare i caratteri ereditari e i fenomeni di ibridazione), la teoria epigenista, di derivazione aristotelica, riuscì progressivamente a im-porsi, soprattutto con la Vénus physique pubblicata in forma anonima da Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1745), considerata da molte storie della scienza come precorritrice della nuova biologia e, in parte, anche dell’odierno evoluzionismo. Ma se accenno ora allo scontro tra preformisti ed epigenisti, non è di certo per ricostruire in poche battute la complessa storia dell’evoluzionismo, quanto piuttosto per porre sul tavolo un’ipotesi di lavoro che varrebbe la pena di sviluppare: quella di rileggere la storia della storia delle origini cristiane alla luce di un conflitto tra diverse storie naturali.
Pensiamo soltanto alle vicende e all’arco temporale che sono al centro di Drudgery Divine. Su un primo versante, quello della teolo-gia, troviamo riflessioni che non possono che dibattersi tra concezioni preformiste: negli ambienti riformati, sono concezioni che assegnano al corpo delle Scritture – e in particolare al Nuovo Testamento – il ruolo di un embrione preformato, che già tutto contiene dei suoi futuri sviluppi; negli ambienti cattolici, sono concezioni che si fondano su una teologia radicale dell’incarnazione, e che associano al corpo di Cristo – realmente presente nel sacramento eucaristico – queste stesse prerogative. Sul versante opposto, quello della storiografia religiosa (che non di rado è una teologia mascherata da storia), non si potranno ab-bracciare, per lento contrasto, che concezioni epigeniste, e in quanto tali schiettamente “evoluzioniste” (basti pensare al culmine rappresentato dall’opera di John Henry Newman sullo sviluppo del dogma cristiano, che tanta importanza avrà nei dibattiti della stagione modernista, e la cui pubblicazione precede di quindici anni l’opus magnum di Darwin).48 In tutti questi casi, le nostre metafore riconducono a scontri di tipo con-fessionale. Ma chi ha influenzato chi? E che cosa si nasconde dietro al nostro parlare, sempre più ossessivo a partire dall’Ottocento, di origini del cristianesimo, di evoluzione e di metamorfosi del cristianesimo, di mutazioni e di ibridazioni, per tacere di tutto quell’inesauribile cam-pionario di metafore legate alla parentela, alla generazione, e da ultimo alla genetica («il DNA del cristianesimo»)?
In questa prospettiva, non è di certo un caso che Smith si opponga implicitamente a qualunque idea di “generazione spontanea” del cristia-
48 L’origine delle specie (titolo completo, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life – “Sull’origine delle specie per mezzo della selezione naturale, o la preservazione delle razze favorite nella lotta per la vita”) apparve nel 1859, mentre il Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana (Essay on the Development of Christian Doctrine) nel 1845.
ASE 32-1 2015.indb 214 29/05/15 09:37
215
nesimo.49 Ma l’immagine che Smith ci offre delle origini cristiane non è neppure quella di un evoluzionismo di tipo spenceriano-darwiniano, con le sue idee centrali di lotta per la vita e di sopravvivenza del più adatto. La sua visione ricorda piuttosto quella di biologi come Karl Ernst von Baer (tra i padri fondatori dell’embriologia comparata), che si oppongono all’idea di uno sviluppo graduale delle specie, dal semplice al complesso,50 e suggeriscono di guardare alle origini come a un vero e proprio fango primordiale, un fango “totipotente”. In questo senso, le origini di una specie non sono mai il punto iniziale di qualcosa: esse sono piuttosto il momento conclusivo di qualcos’altro, secondo una concezione che potrebbe essere affiancata a quella di un altro grande padre delle scienze naturali moderne, lo svedese Carl von Linné (Lin-neo). Nel Systema naturae di Linneo (1735), del resto, a governare non è l’immagine dell’albero, che tanta importanza avrà nelle successive elaborazioni dell’evoluzionismo darwiniano e post-darwiniano, bensì quella della mappa.51 Una mappa che non è il territorio, come Smith ci ricorda, ma che è pur sempre tutto ciò che ci permette di pensarlo, in quanto insieme di rapporti.52
3. La terza e ultima parola-chiave – e con questa concludo il mio fin troppo rapido esame – è ri-descrizione. Ciò che Jonathan Z. Smith ci invita a compiere, lo abbiamo visto, è una continua ri-esplorazione cri-tica dei nostri presupposti teoretici, che ci permetta di calibrare meglio
49 Dopotutto, come ammoniva Raffaele Pettazzoni, è pur sempre vero che «ogni phainomenon è un genomenon» (R. Pettazzoni, La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro, Torino, Einaudi, 1953, 11 [1a ed. Bologna, 1921]).
50 Definirei questa posizione come “evoluzionismo ingenuo”. Essa si ritrova nella maggior parte degli autori che, tra Ottocento e Novecento, cercano di rileggere la storia dei fenomeni religiosi in chiave evoluzionista. Ma sul problema mi ripropongo di tornare in futuro, anche considerando il caso di posizioni apparentemente evoluzionistiche come quella espressa da Durkheim in questo passaggio: «Al concetto di origini, così come a quello di primitivo, attribuiamo un significato del tutto relativo. Con le origini intendiamo non già un cominciamento assoluto, ma lo stato sociale più semplice che sia oggi conosciuto, quello al di là del quale non è possibile risalire» (É. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, ed. it. a cura di M. Rosati, Roma, Meltemi, 2005, 58, n. 3 [ed. or. Paris, 1912]).
51 Come ha spiegato Barsanti, Linneo promosse «una nuova immagine della natura: quella della “rete” o “mappa” (la natura si dispone “come il territorio su una mappa geografica”), conseguente alla scoperta di affinità multiple, differenziate e incrociate…» (Barsanti, Una lunga pazienza cieca…, 74; la citazione tra parentesi è tratta dai Fundamenta Botanica [1736]: cf. Linneo, I fondamenti della botanica, a cura di G. Barsanti, Roma, Theoria, 1985, 42-83). Non è davvero il caso di aprire una parentesi sulle tante analogie che collegano la storia naturale di Linneo agli sviluppi successivi della linguistica comparata, e la linguistica comparata allo strutturalismo. Questo ci riporterebbe, ancora una volta, al nome di Goethe, che già Lévi-Strauss indicava come una delle fonti remote del suo sistema di analisi dei fenomeni culturali (cf. C. Lévi-Strauss, “Appendice al capitolo XV”, in: Antropologia strutturale, Milano, Mondadori, 1992, 358 [ed. or. Paris, 1964]).
52 Si consideri allora come l’idea della mappa informi i tentativi più recenti di rappresentazione della «separazione delle vie» (vd. sopra, nota 31).
ASE 32-1 2015.indb 215 29/05/15 09:37
216
le nostre metafore, così da ottenere «rappresentazioni più perspicue»,53 «descrizioni più dense»,54 oppure, detto in maniera più semplice, nuove “traduzioni” delle forme culturali che ci troviamo a indagare. In questo consiste, credo, la lezione profonda di un testo come Drudgery Divine.
Quello che Smith non smette di rammentarci, in definitiva, è il ca-rattere programmaticamente antiplatonico dell’indagine storica. A diffe-renza del Socrate dell’Eutidemo o dello schiavo del Menone, lo storico non scopre mai nulla ricordando, perché altrimenti saprebbe già cosa trovare.55 Tutte le terre toccate dalle sue esplorazioni sono terre vergini; e quand’anche non fossero considerate come tali, la loro conoscenza rimarrebbe in ogni caso imperfetta, incompiuta, sospesa. Anche lo sto-rico, come ogni uomo di scienza, è destinato a soccombere alla prov-visorietà delle proprie ricerche, e ad essere «servo di un progresso che cancellerà o emenderà il suo lavoro».56 Le sue stesse fatiche, in questo senso, assumono i tratti di un’impresa che non risulta sempre eroica, ma che non dovremmo comunque esitare a definire come “sacrificale”.
Luigi WaltUniversität [email protected]
53 Cf. L. Wittgenstein, Note sul “Ramo d’oro” di Frazer, Milano, Adelphi, 1992, 29 (ed. or. 1967); e la relativa discussione in Smith, “Acknowledgments…”, I, 64.
54 Secondo il programma esposto nel primo capitolo di C. Geertz, Interpretazione di culture, Bologna, il Mulino, 1987 (ed. or. New York, 1973), al quale Smith rimanda spesso in maniera implicita.
55 Mi riferisco al famoso passaggio del Menone: «Non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa né ciò che non sa. Infatti, né potrebbe cercare ciò che sa, perché lo sa già, e intorno a ciò non occorre indagare, né ciò che non sa, perché in tal caso non saprebbe che cosa cercare» (Platone, Men. 80d5).
56 Così G. steiner, La lezione dei maestri. Charles Eliot Norton Lectures 2001-2002, Milano, Garzanti, 2004, 165 (ed. or. Cambridge, Mass., 2003).
ASE 32-1 2015.indb 216 29/05/15 09:37