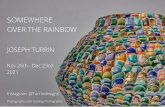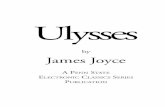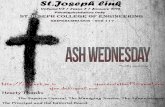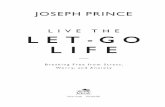L'introduzione al cristianesimo di Joseph Ratzinger
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'introduzione al cristianesimo di Joseph Ratzinger
L’INTRODUZIONE AL CRISTIANESIMO DI JOSEPH RATZINGERNEL PANORAMA DELLE OPERE INTRODUTTIVE
AL MISTERO DEL CRISTIANESIMO
KRZYSZTOF CHARAMSA
1. Introduzione
L’opera giovanile di Joseph Ratzinger che intendeintrodurre al cristianesimo, Einführung in das Christentum1,è forse il suo libro più importante e più letto2. È unlibro a cui lo stesso autore attribuisce unparticolare legame, sia in quanto frutto della suavita teologica in un periodo di tempo difficile econtroverso, come quello dell’insegnamentoall’Università di Tubinga, sia come un’operaprogrammatica di grande successo3. La ricorda nella
1 Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das ApostolischeGlaubensbekenntnis, Kösel-Verlag, München 1968, tr. it. Introduzioneal cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, tr. E. Martinelli, BTC 5,Queriniana, Brescia 1969; nuova tr. G. Francesconi, Introduzioneal cristianesimo. Lezioni sul Simbolo apostolico, Queriniana, Brescia 2005.
2 Cfr R. GIBELLINI, La teologia del XX secolo, BTC 69, Queriniana,Brescia 1992, 20045.
Un’agile “introduzione” ai contenuti dell’Introduzione… sipuò trovare in S. VON KEMPIS, Grundkurs Benedetto. Kleine Einführung indas Denken des Papstes, St. Benno-Verlags, Leipzig 2007, tr. it.Benedetto. Breve introduzione al pensiero del Papa, I Rombi: nuova serie55, Marietti 1820, Genova 2008, pp. 9-68. Si può vedere ancheJ. MURPHY, Christ Our Joy. The Theological Vision of Pope Benedict XVI,Ignatius Press, San Francisco 2008, passim.
3 Si può, a buon diritto, vedere nell’Introduzione uno“specchio” dell’intero pensiero di Joseph Ratzinger, della suafede nel Dio di Gesù Cristo, cioè sull’essenziale del misterodel Cristianesimo. Si potrà vedere nel testo una vera e
sua autobiografia: “…prima ancora di arrivare allatappa seguente del mio cammino personale, devo ancoraricordare che malgrado tutto anche in quellasituazione potei portare avanti il mio lavoro, inmaniera considerevole e feconda. Dato che nel 1967 ilcorso principale di dogmatica veniva tenuto da HansKüng, io fui finalmente libero di realizzare unprogetto che coltivavo silenziosamente ormai da diecipropria “porta d’accesso” al pensiero teologico ratzingeriano:in questo testo vi si ritrovano le sue linee guida, i suoipunti chiave, le sue domande decisive ed i temi forti, poiripresi ed approfonditi nell’arco di tutta la sua vita, finoall’insegnamento da Pontefice. Nel libro si possono scorreremolti temi che vengono proposti in una fase iniziale, per cosìdire “embrionale”, per essere, poi, i perni della speculazioneteologica di Ratzinger, come la questione della verità, ilcarattere personale ed esistenziale della fede, il concettodel Logos, la questione del Dio della fede e Dio dei filosofi,la Persona e l’Opera di Gesù Cristo, la natura della Chiesa,la santità, la speranza e l’amore, la risurrezione, etc. Ciòche è ammirevole, che pur essendo agli inizi del cammino dateologo, non è difficile afferrare in quel volume un pensiero,un’apertura di orizzonti, nonché una lungimiranza dellesoluzioni, che si distinguono per una maturità, fuori dalcomune, e che si attenderebbero piuttosto a seguito di lunghianni della ricerca teologica e non da un professore “alleprime armi”.
È importante notare che lo stesso Santo Padre BenedettoXVI è tornato a questa sua opera, citandola nella Catechesi delmercoledì, dedicata alla figura di Sant’Ambrogio di Milano, il24 ottobre 2007, dove dice: “Così, stando al magistero diAmbrogio e di Agostino, la catechesi è inseparabile dallatestimonianza di vita. Può servire anche per il catechista ciòche ho scritto nella Introduzione al cristianesimo, a proposito delteologo. Chi educa alla fede non può rischiare di apparire unaspecie di clown, che recita una parte «per mestiere». Piuttosto- per usare un’immagine cara a Origene, scrittoreparticolarmente apprezzato da Ambrogio - egli deve essere comeil discepolo amato, che ha poggiato il capo sul cuore delMaestro, e lì ha appreso il modo di pensare, di parlare, diagire. Alla fine di tutto, il vero discepolo è colui che
2
anni. Osai quindi cimentarmi con un corso che sirivolgeva a studenti di tutte le facoltà, con iltitolo “Introduzione al cristianesimo”. Da questelezioni è nato poi un libro, che è stato tradotto in17 lingue, che è stato ristampato più volte, non soloin Germania, e che continua a essere letto. Ero esono pienamente consapevole dei suoi limiti, ma ilfatto che esso abbia aperto una porta a molte personeè per me motivo di soddisfazione e, insieme, digratitudine per Tubinga, nella cui atmosfera hannoavuto origine quelle lezioni”4. A parte il numero
annuncia il Vangelo nel modo più credibile ed efficace” (inL’Osservatore Romano, 25 ottobre 2007, p. 3, cpv. 7).
Mentre, nel suo discorso in occasione del VI Simposioeuropeo dei Docenti universitari sul tema “Allargare gliorizzonti della razionalità. Prospettive per la Filosofia”, il7 giugno 2008, si riferisce nuovamente al volume, dicendo:“Fin dall’inizio del mio pontificato ho ascoltato conattenzione le richieste che mi giungono dagli uomini e dalledonne del nostro tempo e, alla luce di tali attese, ho volutooffrire una proposta di indagine che mi sembra possa suscitareinteresse per il rilancio della filosofia e del suo ruoloinsostituibile all’interno del mondo accademico e culturale.(… in questo percorso comune di ricerca) Vorrei partire da unaprofonda convinzione, che più volte ho espresso: ‘La fedecristiana ha fatto la sua scelta netta: contro gli dei dellareligione per il Dio dei filosofi, vale a dire contro il mitodella sola consuetudine per la verità dell’essere’ (J.Ratzinger, Introduzione al cristianesimo, cap. III). Taleaffermazione, che rispecchia il cammino del cristianesimo findai suoi albori, si rivela pienamente attuale nel contestostorico culturale che stiamo vivendo. Infatti solo a partireda tale premessa, che è storica e teologica ad un tempo, èpossibile venire incontro alle nuove attese della riflessionefilosofica. Il rischio che la religione, anche quellacristiana, sia strumentalizzata come fenomeno surrettizio èmolto concreto anche oggi” (in L’Osservatore Romano, 8 giugno2008, p. 4, cpv. 4).
4 J. RATZINGER, La mia vita. Ricordi 1927-1977, tr. it. G.Reguzzoni, San Paolo, Milano 1997, p. 103; or. ted. Aus meinem
3
delle traduzioni, oggi di gran lunga superato5,facendo diventare di quest’opera un indiscusso bestsellera scala mondiale, è importante cogliere quel posto dirilievo che l’opera ricopre nel suo progettoteologico, di cui offre un vero programma, una“porta” e uno “specchio”... In fondo dopo i trattati:dottorale sull’ecclesiologia di Sant’Agostino6 e diabilitazione sulla teologia della storia in SanBonaventura7, e non contando una piccola operaspeculativa di spessore più personale, quella sulla
leben. Erinnerungen 1927-1977, DVA, Stuttgart 1998.5 Si ricorda il successo straordinario ed immediato
dell’opera pubblicata a München nel primo anno, 1968 in 5edizioni, e seguita nell’anno 1969 nelle ristampe da 6 a 9,nel 1970 (10-11 edizioni), nel 1977 (12 edizione), ecc., pernon contare le Taschenbuchausgaben: 1971, 1972 (2 ed.), 1977 (3ed.), 1980 (4 ed.), o Paperbackausgaben: 1974, 1976 (2 ed.),1977 (3 ed.), 1980 (4 ed.), 1985 (5 ed.), 1998 (6 ed.).L’edizione con la nuova introduzione dell’Autore segna l’anno2000 (Kösel, München, poi come Taschenbuchsonderausgabe inWeltbild Verlag, Augsburg 2005).
Oggi è un bestseller, a scala mondiale, con traduzioni chehanno raggiunto oltre trenta lingue, tra le quali: inglese(London 1969 e nell’edizione americana New York 1970),francese (Paris – Tours 1969), italiano (Brescia 1969),spagnolo (Salamanca 1969), olandese (Tielt – Utrecht 1970),polacco (Kraków 1970), croato (Zagreb 1970), portoghese (SaoPaulo 1970), giapponese (Tokyo 1973), coreano (Seoul 1974),sloveno (Lubljana 1975), ungherese (Wien 1976), ceco (Brno1988), russo (Brussel 1988), lituano (Vilnius 1991), norvegese(Oslo 1993), arabo (Beirut 1993), cinese (Shanghai 2002),rumeno (Iaşi 2004), etc., tenendo presente che le date e iluoghi delle traduzioni elencate si riferiscono solo all’annodella prima edizione e sono aggiornate al 19 aprile 2005,giorno dell’elezione dell’Autore al Soglio Pontificio.
6 Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, München 1954;tr. it. Popolo e casa di Dio in Sant’Agostino, Jaca Book, Milano 1979.
7 Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura, München 1959; tr.it. La teologia della storia di San Bonaventura, Jaca Book, Milano 1978.
4
fraternità cristiana8, nonché alcuni altri scrittiminori, lo studioso si cimentava con questa primagrande opera di speculazione teologica personale, chesi delinea nell’Introduzione. Essa, nata da un ciclo dilezioni, fu però pensata nell’arco di abbastanzalunghi anni di giovinezza teologica, nei qualirifletteva su quanto essenziale nella fede, cioè sulnucleo centrale del mistero cristiano compreso nelCredo. Egli approfondisce, pertanto, il nucleooriginale della fede, concentrandosi sui suoifondamenti e sulle sue radici, come scaturisconodalla sobrietà degli articoli del Simbolo apostolico.
2. L’impegno teologico di un’Introduzione
2.1 Molte opere di simile genere letterarioIl libro, nel suo genere, non è affatto nuovo. In
realtà, l’intento di introdurre al cristianesimo ecogliere così la sua essenza, avanzando una sua sintesi,costituisce una lunga scia nella riflessione dellateologia cattolica e anche protestante. Ora non cisarebbe possibile mettere a confronto tutte le opereanaloghe per genere o simili per lo scopo dellacomposizione, in qualche modo parallele al libro diRatzinger, anche se distinte per i propri contestistorici. Diverse opere di quel genere di Introduzione oEssenza nascono dalla necessità di un’epoca e da unadomanda, che molto prima di Ratzinger (e prima delConcilio Vaticano II) fu afferrata9. Nel nostro primo
8 Die christliche Brüderlichkeit, Kösel-Verlag, München 1960; tr.it. La fraternità cristiana, Roma 1962, ed. agg. GdT 311, tr. C.Danna, Queriniana, Brescia 2005.
9 Si ricorda, ad esempio, lo scritto di un altroprofessore della scuola di Tubinga, Johann Sebastian VON DREY(1777-1853), Vom Geist und Wesen des Katholizismus, risalente allaprima metà dell’800 e pubblicato nel primo numero di da luifondato Theologische Quartalschrift 1 (1819) 3ss., 193ss., 369ss.,
5
sguardo introduttivo vogliamo solo riportare allamemoria alcune opere scelte tra gli approcci diversi,ma sempre accomunati per la stessa ricerca diraggiungere il nucleo/essenza/sintesi della fede erispondere a cosa sia il cristiano. Ricordiamo,pertanto, alcuni esempi prima dell’Introduzione diRatzinger (penso a Karl Adam e Romano Guardini) edopo di essa (penso a Karl Rahner e Leo Scheffczyk).
2.2 Esempi prima dell’Introduzione al cristianesimo diRatzinger (Karl Adam e Romano Guardini)
Innanzitutto, in questa veloce panoramica e, diconseguenza, non esente da frammentarietà, il primoposto lo riserviamo a Karl Adam (1876-1966), con ilsuo volume Wesen des Katholizismus (L’essenza delCattolicesimo)10. Nella stessa Università di Tubinga,quasi mezzo secolo prima di Ratzinger, Adam hacompiuto un’impresa simile di introduzione, col suo“magistrale” – come riconosce Ratzinger – corsointitolato Essenza del Cattolicesimo, tenuto nel semestreinvernale del 1923-1924. Ora, per Ratzinger questastessa impresa “andava tenuta nuovamente allo stessomodo pur nelle condizioni completamente cambiatedella generazione” post-conciliare11.
Un secondo esempio, sulla stessa linea, ci offreil teologo italo-tedesco Romano Guardini (1885-1968)con il suo Das Wesen des Christentums (L’essenza delcristianesimo)12, dell’anno 1938, in cui costata che
559ss. (cfr Lo spirito e l’essenza del Cattolicesimo e altri saggi, intr. M.SECKLER, Lateran University Press, Città del Vaticano 2007).
10 K. ADAM, Wesen des Katholizismus, Haas & Grabherr, Augsburg1924; tr. it. L’essenza del cattolicesimo, tr. M. Bendiscioli,Morcelliana, Brescia 19627.
11 J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Prefazione (1968), p. 8.
12 R. GUARDINI, Das Wesen des Christentums, Werkbund Verlag,Würzburg 1938; tr. it. L’essenza del cristianesimo, tr. M.
6
nella presa di coscienza e di posizione cristiana“assume importanza decisiva la questione dove stiaquello ch’è peculiare del cristianesimo”. Egli sichiede: “che cosa costituisce la qualità particolaresolo ad esso propria, in virtù della quale ilcristianesimo si fonda in se stesso e si distingue daaltre possibilità religiose?”13. Guardini, come glialtri della sua epoca, con Erich Przywara, S.J.(1889-1972)14 per primo, riflette sulle struttureoriginarie (Ur-Strukturen) dell’esperienza della fedecristiana e della Rivelazione. È ben noto come questopensiero guardiniano sia anche approfondito edibattuto dallo stesso Ratzinger15.
Se l’opera di Adam, pur con una dose di enfasi,fu definita l’ultima summa16, il libretto di Guardiniè piuttosto un’opera sintetica, di un’ottantina dipagine, che va letta nella prospettiva più ampiadell’insieme della produzione guardiniana. Tra quelliche precedono l’Introduzione di Ratzinger, questi due –
Baronchelli, Morcelliana, Brescia 1950.13 R. GUARDINI, L’essenza del cristianesimo, p. 7.14 Oltre ai suoi ben noti lavori di filosofia della
religione e di metafisica, cfr E. PRZYWARA, Christliche Existenz, J.Hegner, Leipzig 1934.
15 È paradigmatico che la sua opera Einführung in den Geist derLiturgie (Introduzione allo spirito della liturgia) del 1999, che costituisceuna sorta di proposta di “riforma della Riforma”,sostanzialmente si pone sulla stessa linea del volume diGuardini, Lo spirito della liturgia, pubblicato nel 1918 e guida alloraper il movimento liturgico in Germania: “essa diede il suocontributo perché si celebrasse la liturgia in maniera‘essenziale’ (termine assai caro a Guardini)” (Introduzione allospirito della liturgia, San Paolo, Milano 2001, p. 5).
16 Cfr C. MILITELLO, “La riscoperta della teologia”, in R.FISICHELLA, ed., Storia della teologia 3: da Vitus Pichler a Henri de Lubac,Edizioni Dehoniane, Roma – Bologna 1996, p. 641.
7
a mio sommesso parere – si prestano ad un confrontoprofiquo17.
2.3 Esempi posteriori all’Introduzione (Karl Rahner eLeo Scheffczyk)
Notiamo anche due esempi da un altro contesto,quello posteriore all’opera ratzingeriana.Precisamente otto anni dopo di essa, nel 1976 appareil volume di Karl Rahner (1904-1984), Grundkurs desGlaubens (Corso fondamentale sulla fede)18: atteso prima dellapubblicazione dall’editore Herder con diecimilaprenotazioni. Era la richiesta di molti lettori ecritici dello stesso Rahner ad esigere, dal teologo,un’opera su ciò che potesse rappresentare il nucleodi tutto il suo insegnamento sul cristianesimo. Ilvolume si propone così la ricerca del nucleoessenziale del fenomeno della fede cristiana,introducendo al “concetto” di cristianesimo19.
17 Tra molti altri, si potrebbe aggiungere, a questi duemaestri, il Card. Michael Schmaus (1897-1993), che oltre allasua monumentale Katholische Dogmatik (1953-1965), ben conosciuta,ci ha lasciato un’opera, oggi meno nota, anche dedicata all’Essenza del cristianesimo: cfr M. SCHMAUS, Vom Wesen des Christentums,Augsburg 1947; tr. it. Essenza del cristianesimo, tr. V. Simon,Edizioni Paoline, Alba 1958.
18 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff desChristentums, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 1976; tr. it.Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, tr. C.Danna, Edizioni Paoline, Milano 19905.
19 Come è noto, anche l’opera di Rahner, come quella diRatzinger, è frutto della sua attività di docente (la suastesura fu iniziata nel 1964) e, in particolare, dei due corsidi lezioni sull’introduzione al concetto di cristianesimotenuti a München e a Münster. Al riguardo, va tenuto conto cheil sottotitolo dato non è di poco conto: l’autore introducepiù che al Cristianesimo stesso, ad una sua formulazioneconcettuale. Nella prefazione, Rahner ravvisa il suo lettoreche intende muoversi su un “primo livello di riflessione”,senza “limitarsi a ripetere in maniera puramente catechetica e
8
Cronologicamente siamo molto vicini al libro diRatzinger, ma con il Corso di Rahner ci imbattiamo inun’opera radicalmente diversa20.
Al panorama si può aggiungere un libro, menoconosciuto, di Leo Scheffczyk (1920-2005), KatholischeGlaubenswelt. Wahrheit und Gestalt (Il mondo della fede cattolica.Verità e forma)21, pubblicato nel 1977, un anno dopol’opera di Rahner. In essa l’autore si pone la“domanda sull’essenza e sul senso del cristianesimo
secondo le formulazioni tradizionali ciò che il cristianesimopredica, bensì capire in maniera nuova e ridurre a un“concetto” questo messaggio (…); inserire questo cristianesimo– ferma restando la sua unicità e la sua incomparabilità –negli orizzonti della comprensione di un uomo d’oggi e nelmodo migliore possibile. Nel fare ciò, non dobbiamo agire comese il cristiano non sapesse, già antecedentemente alle nostreconsiderazioni, che cosa è il cristianesimo. Però, nondobbiamo neppure limitarci a ripetere, sulla base di una fedegià definitivamente appagata in se stessa, quanto viene dettoin modo tradizionale in ogni catechismo cristiano”; “Il librosi propone di illustrare e di rendere conto in maniera onestae leale, su “un primo livello di riflessione”, del complessodel cristianesimo” (ivi, pp. 7-9, cfr pp. 17-19).
20 Al riguardo basterebbe richiamare solo alcuneparticolarità diversificanti del Corso che intenderebbe essere“il condensato della teologia” di Rahner. In esso, per primo,si assiste ad un’evidente oblio del confronto diretto con laParola vivente della Sacra Scrittura e non sembra sufficientel’ammissione di questo fatto che Rahner offre in apertura delvolume. Al nucleo della fede cristiana, al Dio di Gesù Cristo,alla Santissima Trinità sono dedicate praticamente pochissimepagine (cfr ivi, pp. 183-188). In definitiva, non rimane altrapossibilità che afferrare l’essenza o il concetto delcristianesimo in una sua “antropologizzazione”, di cui rischionotavano molti critici di Rahner, cominciando da Hans Urs vonBalthasar.
21 L. SCHEFFCZYK, Katholische Glaubenswelt. Wahrheit und Gestalt, PaulPattloch Verlag, Aschaffenburg 1977; tr. it. Il mondo della fedecattolica. Verità e forma, tr. A. Musio, con un’intervista a BenedettoXVI, Vita e Pensiero, Milano 2007.
9
cattolico”, ovvero sull’“elemento cattolico checontiene in sé pretesa della totalità, di ‘ciò che ècomprensivo di tutto’, nei termini della verità edella realtà della salvezza, a prescindere da comequesta esigenza possa essere stata posta in modoprovocatorio nel corso dei tempi”, proponendosi,pertanto, “di comprendere e rappresentare con i mezzilimitati del pensiero umano una totalità istituita daDio”22.
In realtà, gli ultimi esempi riflettono il climadel tempo post-conciliare, in cui si impone in modonuovo la questione di un’introduzione essenziale, chediventa quasi “di moda”, se non di necessitàteologica23. La percepiscono lo svizzero Hans Küng(1928-)24, il Card. Walter Kasper (1933-)25, il
22 Ivi, pp. 3 e 5-6.23 Tale domanda si fa pressante in quanto il Concilio
Vaticano II nel Decreto Optatam totius raccomanda che nellaformazione sacerdotale per orientare gli studi al mistero diCristo, essi siano introdotti da un corso introduttivo, incui, per primo, il mistero della salvezza sia proposto in modoche gli alunni possano percepire il senso degli studiecclesiastici, la loro struttura e il loro fine pastorale, e,per secondo, siano aiutati a fare della fede il fondamento el'anima di tutta la loro vita e vengano sostenutinell’abbracciare la loro vocazione con piena dedizionepersonale e con cuore gioioso (cfr Optatam totius, n. 14). Se laprima prospettiva mantiene l’esigenza di una esposizionedettagliata dei singoli contenuti della fede, la seconda aprepiuttosto all’accoglienza personale del mistero della fedecome tale.
24 H. KÜNG, Christ sein, Piper, München 1974; tr. it. Esserecristiani, Mondadori, Milano 1976; Credo. Das apostolischeGlaubensbekenntnis – Zeitgenossen erklärt, Piper, München 1992 =Einführung in den christlichen Glauben, Piper, München 2006.
25 W. KASPER, Einführung in den Glauben, Matthias-Grünewald,Mainz 1972, 19835; tr. it. Introduzione alla fede, tr. R. Gibellini,GdT 65, Queriniana, Brescia 1973, 2003.
10
protestante Wolfhart Pannenberg (1928-)26, in un certosenso anche il Card. Hans Urs von Balthasar, S.J.(1905-1988)27, per richiamare qui soltanto i più noti.
2.4 Una prima differenza storica di fondoDobbiamo chiederci se possiamo riportare ad un
denominativo comune gli autori appena citati? Checosa unisce questi teologi, oltre al fatto di esseretedeschi o di lingua tedesca? In realtà, si esprimonocon linguaggi diversi, sono di scuole non simili eformano epoche molto differenti tra di esse. Potremmofarli sedere attorno alla stessa tavola ponendodavanti la questione dell’essenza del cristianesimo,tentando un paragone degli stessi con JosephRatzinger, ma non ci vorrà molto per stabilire che ilcerchio che formerebbero, ovvero una linea storica disuccessione è piuttosto un insieme di “fuochi” accesie diversi tra di loro. Sono dei “focolai” che, aproposito dello stesso tema dell’introduzione/essenzadel cristianesimo, seguono percorsi molteplici eoffrono risposte profondamente diversificate. Inquesto senso, non sembra facile proporre un sinteticoparagone tra l’opera giovanile di Ratzinger e gliapprocci degli altri teologi.
2.5 Le Essenze prima del Concilio Vaticano IIPrima di tutto, esiste una fondamentale
differenza generazionale tra la storia delle Essenze
26 W. PANNENEBERG, Glaubensbekenntnis ausgelegt und verantwortet vor denFragen der Gegenwart, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 19905;tr. it. Il Credo e la fede dell’uomo d’oggi, pres. G. Barbaglio,Morcelliana, Brescia 1973.
27 Si potrebbero consultare, al riguardo: H.U. VON BALTHASAR,Katholisch. Aspekte des Mysteriums, Johannes Verlag, Einsiedeln 1975;tr. it. Cattolico. Aspetti del mistero, tr. L. Tosti, Jaca Book, Milano1976, nonché Wer ist ein Christ?, Benziger Verlag, Einsiedeln 1965;tr. it. Chi è il cristiano?, Queriniana, Brescia 1966.
11
prima della II guerra mondiale (e prima del ConcilioVaticano II), e le Introduzioni del post-concilio.Mentre, prima, risposte come quella di Karl Adam o diRomano Guardini, intendono affrontare l’interrogativiposti dal filosofo bavarese Ludwig Andreas Feuerbach(1804-1872) con la sua riduzione antropologica siadell’immagine di Dio sia, conseguentemente, delcristianesimo stesso nel L’essenza del cristianesimo (1841)28,poi, intraprendono la sfida posta dallo storicoprotestante Adolf von Harnack (1851-1930).Quest’ultimo tiene all’Università Humboldt diBerlino, nel semestre invernale 1899-1900, le suefamose sedici lezioni su Das Wesen des Christentums(L’essenza del cristianesimo), seguite da più di 600 studentidi tutte le facoltà e il cui testo viene subitopubblicato nel 190029 (anche quest’impresa quasianaloga a quella di Ratzinger). In quel tempo, comesi sa, egli è già in conflitto con la Comunitàufficiale proprio per la controversia sul Credoapostolico, in quanto riteneva che il Credo sia untesto che, al contempo, contenga troppo e troppo pocoper essere soddisfacente per i candidati alministero, come lo stesso Harnack scriveva, nel 1892,nella sua opera Das Apostolische Glaubensbekenntnis.L’intenzione di Harnack nell’Essenza del cristianesimo eraquella di rispondere alla domanda di fondo, del tuttolegittima, “che cosa è il cristianesimo?”, mal’intento fu portato in porto attraverso i solimezzi, insufficienti e – se in quell’ambito presisingolarmente – lacunosi, delle scienze storiche. A
28 L.A. FEUERBACH, Das Wesen des Christentums, Leipzig 1841,18834; tr. it. L’essenza del cristianesimo, 1949-1959, Feltrinelli,Milano 197111.
29 A. VON HARNACK, Das Wesen des Christentums, Leipzig 1900(zuletzt 2007); tr. it. L’essenza del cristianesimo, tr. A.Bongioanni, Bocca 1903, 19233, rist. Bastogi Editore, Foggia1982; tr. G. Bonola, GdT, Queriniana, Brescia 2003.
12
partire dalla sola storia, in definitiva egli dis-seziona la realtà cristiana e pretende di risolverlacome un grande fatto storico30. In seguito, sarà lavolta del protestante Ernst Troeltsch (1865-1923) ariprendere quei vicoli ciechi, nei quali cercarel’identità del cristianesimo, mediante la solaricerca storica31.
A questa opzione nociva rispondevano gli autoricome Karl Adam, che dichiarava di non opporsiall’applicazione del metodo storico alla religione,ma solo fino al punto che esso si mantenga entro isuoi limiti, cioè fino a che la sua teoria dei tipireligiosi non pretenda di pronunziare giudizidefinitivi sul contenuto essenziale delle formereligiose studiate32. Alle descrizioni puramentestoriche sfugge la coscienza della vitasoprannaturale che circola nella natura più intimadell’essere cattolico, nella essenza propria delcredente33. Ad esse sfugge il tesoro della fede.
30 «Che cosa è il Cristianesimo? Tale questione noi lastudieremo unicamente sotto l’aspetto storico e cercheremo dirisolverla col sussidio della scienza storica e dell’esperienzadella vita, di cui la storia ci è maestra. Ma con ciò, nonintendiamo escludere dalle nostre considerazioni l’apologeticae la filosofia della religione» (L’essenza del cristianesimo,Conferenza I, Il soggetto ed i suoi limiti, Bastogi Editore,Foggia 1982, p. 10, il corsivo nostro). «…Il Cristianesimo èun grande fatto storico…» (ivi, p. 14).
31 E. TROELTSCH, Was heisst “Wesen des Christentums”? (1902), inGesammelte Schriften, vol. 2, Tübingen 1922; tr. it. Cosa significa“Essenza del cristianesimo“?, in E. TROELTSCH, Etica, religione, filosofia dellastoria, ed. G. Cantillo, Guida, Napoli 1974.
32 K. ADAM, L’essenza del cattolicesimo, Introduzione, p. 7.33 Sarà anche Ratzinger a fare i conti con la primitiva
teologia liberale di stampo harnackiano, ma concentrando lacritica in particolare sulla riduzione della fede cristologia(cfr Introduzione al cristianesimo, pp. 152-157). Mentre i problemidello storicismo (verum quia factum) egli affonda in unaprospettiva più ampia dei principali passaggi che il pensiero
13
2.6 Le Introduzioni post-conciliariQuando all’indomani del Concilio Vaticano II,
Joseph Ratzinger compone e pubblica la sua opera, lasituazione è decisamente cambiata. Oltre al fenomenoconfuso del 1968, attorno regna sia l’entusiasmo, siail fermento del tempo post-conciliare con le nuovesfide. La domanda che si propone solo in parte èanaloga a quella precedente, diventando una questionepiù particolareggiata. Ci si chiede se per introdurreal cristianesimo dobbiamo ancora confessare espiegare il Symbolum degli Apostoli con i suoiarticoli, cioè con i contenuti concreti dei misteridella fede – per dirlo con l’espressione cara aMatthias Joseph Scheeben (1835-1888) –, oppurenell’entusiasmo conciliare dovremmo piuttosto ri-formulare questa essenza del cristianesimo edesprimerla nuovamente, componendo nuovi simboli dellafede (come avviene nel Credo del popolo di Dio di Paolo VIdel 30 giugno dello stesso 196834). Ci si interroga
ha subito fino alla concezione moderna della realtà stessa(cfr Introduzione al cristianesimo, pp. 27-37). Il problema dellostoricismo viene affrontato più specificamente sul terreno deisuoi influssi sulla teologia, quando questa viene ridotta allastoria attraverso il ricorso ad un’esegesi storico-criticaesasperata. Non basta però fermarsi alla diagnosi condotta, inquanto lo storicismo si sviluppa in un pensiero tecnico, incui verum est quia faciendum (nell’azione della fattibilità e nelfuturo si descriverebbe l’uomo), che permette il riaccendersisia delle teologie politiche sia della teologia dellaliberazione. In questo ambito, la diagnosi che Ratzingerpresuppone e sintetizza pare più completa di quantoaffrontavano le Essenze succitate.
34 Riguardo al significato dottrinale, valore e contestoteologico-storico della proclamazione di questa Professione difede da parte del Papa Paolo VI si rinvia al contributo di G.FERRARO, “Il Credo del Popolo di Dio di Paolo VI nel 40° anniversariodella solenne proclamazione”, contenuto nel presente volume.
14
sulla possibilità di simboli suscettibili del tempo,dei contesti culturali e degli stessi linguaggi. Cisi chiede se sia possibile tralasciare le anticheformulazioni della fede e per catturare l’essenza eun’introductio a ciò che cristiano, dedicarsi piuttostoal fenomeno trascendente della fede che rimane semprepersonale (come propone di fare Rahner nel Grundkurs).
Dove sta l’essenza o il nocciolo delcristianesimo, a cui i credenti desiderano introdurreogni uomo e donna indipendentemente da tempo e luogodella terra? Bisogna “ri-leggere” e “ri-dire” ilSimbolo della fede35 o, viceversa, trovare un’altraespressione dell’essenza del Cristianesimo. In questaprospettiva va affrontata anche l’opera di JosephRatzinger nel panorama delle varie risposte alriguardo.
3. La fede come fulcro dell’Introduzione…
Per introdurre adeguatamente all’essenza delcristianesimo / cattolicesimo, si deve ripartiredalla fede (non dalla storia)36. Così intitola il suocorso fondamentale Karl Rahner: sulla fede (Glaube).
35 Per un esempio recente al riguardo, nell’ambito italianosi può segnalare il progetto di ricerca intitolato “Ri-dire ilSimbolo di fede oggi”, promosso dalla Società italiana per laricerca teologica (SIRT), di cui i primi sei volumi sonopubblicati nella serie “Biblioteca di ricerche teologiche”delle Edizioni Dehoniane di Roma (2002-).
36 In generale, circa il concetto di fede in J. Ratzinger,si possono vedere: P. BLANCO SARTO, «La transmisión de la fesegún Joseph Ratzinger», in J. PALOS – C. CREMADES, edd.,Perspectivas del pensamiento de Joseph Ratzinger, Diálogos de TeologíaVIII (enero-abril 2006), Asociación Almudí – BibliotecaSacerdotal, Edicep, Valencia 2006, pp. 195-214; R. FISICHELLA,«Verità fede e ragione in J. Ratzinger», in PONTIFICIA ACADEMIATHEOLOGICA, Aspetti del pensiero teologico di Joseph Ratzinger, Path 6 (2007)pp. 27-43.
15
Già molto prima Romano Guardini apre L’essenza delcristianesimo, dicendo: “essere cristiano significa lastessa cosa che essere credente, anzi essere piosemplicemente”37.
Anche il vecchio Adam è convinto che arrivareall’essenza del cattolicesimo e percepire il suomistero necessità di avere una “familiarità” conesso, o per dirlo in termini teologici, richiede laprofessione di fede, come espressione della coscienzacattolica38. Essenziale è, pertanto, analizzareaccuratamente questa coscienza che la Chiesa ha disé. Per Adam, anche se la professione di fede è unatto del soggetto credente, lo è solo nella misura incui si inserisce nella fede oggettiva della comunità(communio fidelium), radicata nel dogma, nella morale enel culto. L’io personale nella prospettiva dellafede non è mai un ente autonomo, solitario edisolato, il che lo sradicherebbe dalla fede dellacomunità. Solo sulla via della professionecomunitaria della fede il cattolicesimo risplendecome è in sé, nella sua essenza, cioè come la grandetesi di affermazione della verità di fede.
Ratzinger, per conto proprio, abbraccia l’intentocosì concepito da chi lo precedeva nella simileavventura: introdurre al cristianesimo significa peril suo volume “aiutare a far comprendere in manieranuova la fede”39.
3.1 La fede cattolica – la fede cristiana
3.1.1 L’essenza del cristianesimo sta nella fede,ma quale fede: la fede cristiana o invece la fedecattolica? Su questo punto una prima differenza cade
37 R. GUARDINI, L’essenza del cristianesimo, p. 7.38 K. ADAM, L’essenza del cattolicesimo, Introduzione, pp. 9-10.39 Introduzione al cristianesimo, Prefazione (1968), p. 8.
16
all’occhio sin dai titoli delle opere degli autoriricordati. L’impostazione di fondo è per gli uni:“introduzione al cristianesimo” e per gli altri: “alcattolicesimo”? Mentre Adam, prima, e Scheffczyk,poi, introducono rigorosamente al cattolicesimo40,Ratzinger, come d’altronde anche Rahner, intitolal’opera con il nome “cristianesimo”.
3.1.2 A tal proposito, proprio Ratzinger,nell’Introduzione, parla dell’ecclesialità concreta,rilevando i tratti di quanto sia universale(cattolico). Egli ritiene che per trovare la rispostasull’essenza del Cristianesimo, è necessario puntaregli occhi sulla configurazione concreta, vale a dire,ecclesiale della fede cristiana41. La fede cristiana èconfigurata ecclesialmente in un modo concretissimo.Il teologo lo esprime in modo discreto, ma ancheincisivo, quando ci racconta brevemente la storia delSymbolum: il testo della nostra professione di fedeconformatosi nel corso del II e III secolo,nell’ambito sacramentale della liturgia battesimale,proviene sicuramente, nella sua origine, dalla cittàdi Roma nella sua qualità di unica “sede apostolica”nella zona occidentale. In Oriente non si eraaffermato un Simbolo unitario perché nessuna dellechiese particolari è mai riuscita ad assumere una
40 Riconoscendo che la comprensione dell’essenza delcattolicesimo è un compito particolarmente impellente, ambeduesi riferiscono a quanto diagnosticava, a suo tempo, lo storicodelle religioni Friedrich HEILER in Das Wesen des Katholizismus. SechsVortrage, gehalten im Herbst 1919 in Schweden (München 1920): “solopochissimi cattolici sanno che cosa sia propriamente ilcattolicesimo, e anche i teologi cattolici spesso non losanno” (ivi, p. 5) o anche in Der Katholizismus, seine Idee und seineErscheinung, Reinhardt, München 1923. Cfr L. SCHEFFCZYK, Il mondodella fede cattolica, pp. 4. 9-10. 35, etc.; K. ADAM, L’essenza delcattolicesimo, pp. 7-17.
41 Introduzione al cristianesimo, p. 49ss.
17
posizione nemmeno lontanamente paragonabile a quellatoccata a Roma in Occidente42. L’unico Symbolum rinviaall’unità di una Chiesa universale (cattolica). Lasua fede è sempre confessione d’unità. Pertanto, comeoggi – prima che tutti i cristiani si trovino sottol’unico Pastore e nell’unico ovile – non si potrebbeparlare di una teologia genericamente cristiana, mabisogna custodire la teologia cattolica (o per i
42 Ivi, p. 51. Al tema della santa Chiesa cattolica,Ratzinger torna in occasione degli ultimi articoli del Credo(pp. 279ss, qui 285-287). Senza lacuna pretesa apologetica,brevemente descrive le note qualificanti la Chiesa. Circa lasua “cattolicità” ammette che “il Simbolo non contiene quindialcuna allusione diretta alla cristallizzazione di quest’unità[tra i vescovi] nella sede episcopale di Roma. Sarebbe peròsenz’altro sbagliato dedurre che un tale spunto orientativodell’unità rappresenti solo uno sviluppo secondario. A Roma,dove il nostro Simbolo ha avuto i natali, questa idea è statasubito sottintesa come ovvia e scontata”. Mentre continua arilevare gli elementi fondanti della sua ecclesiologia circala struttura spirituale della chiesa, che lo hanno formato dateologo e costituiscono fin’ora la visione ecclesiale delPontefice, spiega l’unità cattolica dell’Ecclesia a partire dalsuperamento della sua dimensione organizzativa storica: “unacosa è chiara: la chiesa non va pensata partendo dalla suaorganizzazione, ma è invece l’organizzazione che va concepitapartendo dalla chiesa. Tuttavia, resta al contempo assodatoche, per la chiesa visibile, l’altrettanto visibile unità rappresentaqualcosa di ben più alto della mera ‘organizzazione’. La concreta unitàdella fede comune attestatasi nella Parola, e della comunemensa imbandita da Gesù Cristo, costituisce essenzialmente ilsegno che la chiesa deve inalberare sul mondo. Solo in quanto‘cattolica’, ossia visibilmente una pur nella molteplicità,essa corrisponde ai postulati del Simbolo”. Infine, convintoche gli “elementi fondanti per la costruzione della chiesaappaiono invece il perdono, la conversione, la penitenza, alcomunione eucaristica e in derivazione da questa la pluralitàe l’unità”, con quest’ultime intende: “pluralità costituita dallechiese locali, che però restano chiesa unicamente tramite illoro inserimento nell’organismo dell’unica chiesa”.
18
fratelli separati protestante o ortodossa), cosìancora prima la stessa fede è inscindibilmente legataalla Chiesa, alla sua propriaprofessione/confessione. La fede, anche quando èlegittimamente detta “cristiana”, non si svuota delsuo essere “cattolica”. Il credente cattolico – anchein mezzo a quel grande segno dei tempi, che è laricerca ecumenica dell’unità –, potrà comprendere lapropria fede solo a partire da ciò che vi èuniversale, propriamente cattolico nel cristiano. Lapotrà accogliere e comprendere solo a partire da quelbackground indispensabile per il suo credere che è il“concreto” contesto ecclesiale.
In linea generale, poi, considerando più davicino il Cristianesimo, ci si accorge presto comeesso, preso nel senso assoluto, è essenzialmente eoriginariamente, dall’interno, “cattolico”. È propriol’unità della fede del Credo Apostolico a presupporre,anche quando non tutti riescono a riconoscerlo, unacattolicità (l’universalità) della Chiesa che ne siadietro il Symbolum, del cui esistere essa è ragione egaranzia. Anche se all’infuori di essa non esiste unvuoto ecclesiale della fede, nondimeno permane pursempre un’oggettiva ferita, una carenza, ovvero undefectus subentrato con le divisioni storiche.
Introdurre al Cristianesimo, per il Papasignifica, pertanto, presentare, spiegare edinterpretare il Credo, che è l’“essenza fondamentaledella fede cristiana” e la sua dottrina più cara; untesto dottrinale del cristianesimo, anzi una suapagina centrale. Ma quando tratta il Simbolo di fede,presume in esso la professione di una fedeecclesiale, e cioè, in sostanza, dalla propria fedecattolica, perché con l’“immersione” nel Credo non siappartenga ad una Chiesa genericamente cristiana, maa quella cattolica, nel Simbolo professata. In realtà
19
Ratzinger tiene ben presente questa coscienzaecclesiale, della propria Chiesa, e non un genericoed astratto concetto del cristianesimo. A partire daquella fede della Chiesa riesce ad annunciare ad ogniuomo ciò che è essenziale nel Cristianesimo43.
Alla luce di tale presupposto, la scelta cheviene operata, cioè di introdurre al “cristianesimo”,presenta due particolarità: innanzitutto, potràessere di aiuto per i fratelli separati, in quanto favedere che la nostra sperata unità scaturiscedall’unico Simbolo, che è “romano”, universale-cattolico, che abilità, con la sua impronta storico-salvifica e cristologica, di afferrare il nucleocentrale positivo della storia cristiana; esso “silimita semplicemente ad accettare il fatto che Dio siè fatto uomo per la nostra salvezza, e non tentanemmeno di scavare dietro questa storia”44.
Il secondo scopo di tale scelta è ancora piùdecisivo: bisogna venir incontro alla specificasituazione in cui versa l’uomo d’oggi, quando più chemai il contenuto e il significato della fedecristiana, in generale, è avvolto da un nebulosoalone d’incertezza, fitto e spesso, come mai primad’ora lo è stato nella storia45. Mentre il mondo primadel Concilio poteva essere ancora visto come un mondogeneralmente credente, il tempo post-conciliare
43 In questo senso si riesce forse a superare la notacritica di L. Scheffczyk, pur niente togliendo all’importanzadell’approccio proposto dall’autore, circa i teologicattolici, che introducono al cristianesimo, mostrandol’elemento cattolico anche come cristiano, in realtà nonriescono a formulare lo specifico del cristianesimo (Il mondodella fede cattolica, pp. 26-27). Se questo sia vero riguardo alCorso di Rahner, più difficilmente risulterebbe fondato in unaIntroduzione al Credo, come la concepisce Ratzinger.
44 Introduzione al cristianesimo, p. 51.45 Cfr Introduzione al cristianesimo, Prefazione (1968), p. 8.
20
coincide con una nuova mentalità di un mondo chegeneralmente non crede o ha difficoltà di credere,mai viste prima. Il dibattito di prima, anche contratti apologetici o polemici, spesso di confrontoacceso con interlocutore protestante, come lo eraancora nel tempo di Adam, ora deve essere precedutoda un dibattito preliminare che si sforzi aricuperare la fede stessa: un dibattito impostato trail credente e i non credenti.
Tale grave diagnosi richiede una radicale ripesadell’orizzonte universale della fede delcristianesimo. Il problema di fondo, dunque, più chele possibili controversie tra le confessionicristiane (che richiedono di per sé il clima dellafede), sarebbe la debolezza dell’orizzonte mentaledell’umanità, in cui il fenomeno del credere, con isuoi presupposti antropologici, sarebbe in gravecrisi: l’uomo d’oggi non sente più che la fede siaagevolazione all’autentico vivere umano in questomondo. Bisogna smuovere quella dialettica tra lafede, che il Cristianesimo ha portato nel mondo, etra il senso diffuso di non credenza. In una talesituazione storica bisogna, nella sede diun’introduzione, far calare in mezzo agli uomini lostesso senso di Dio: far introdurre a ciò che è ilcapitale distintivo cristiano, ovvero il dono dellafede e la capacità di credere.
Per sintetizzare la scelta di Ratzinger,possiamo, pertanto, fare nostra la formulaesplicativa del Card. Henri de Lubac, S.J. (1896-1991): quando egli introduceva la famosa raccolta distudi col titolo Catholicisme46, era convinto che essanon fosse un libro sul cattolicesimo o sulla chiesa
46 H. DE LUBAC, Catholicism. Les aspects sociaux du dogme, Editionsdu Cerf, Paris 1938; tr. it. Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma, tr.U. Massi, Edizioni Studium, Roma 1964.
21
cattolica, ma mirasse a “mostrare il carattereuniversale, e più precisamente cattolico delcristianesimo”47, con tutte le implicite esigenze ditipo ecumenico. L’opera di Ratzinger, pur venendo adaffrontare una situazione diffusa di non credenza,proprio nella misura in cui parte dal Credo dellaChiesa, non mancherà di poter essere intesa in questachiave esposta da de Lubac: far mostrare ciò che ècattolico nel cristiano, o la stessa cattolicità originariae connaturale della fede cristiana, dell’essenza delcristianesimo48.
3.1.3 Tornando ad Adam, egli si riferiva alladivergenza (anche storica) tra ciò che è cattolico e,più in generale, cristiano: quest’ultimo, a partiredal cristianesimo primitivo è conservato nellafisionomia essenziale del cattolicesimo, anche se nonin una maniera automatica, ma organicamente49.L’annuncio di Cristo è infatti un messaggio vivente,da un seme cresce fino ad un albero, in un interioresviluppo di forze vitali. Nello sviluppo vannoenucleati i suoi “elementi strutturali”, grazie aiquali il cattolicesimo è una realtà perfettamentespiegabile anche storicamente. Adam sottolinea poifortemente, sin dalle prime pagine della sua Essenza,la completezza del cattolicesimo. In questo senso,cercare la sua essenza non significherà comprendereciò che esso ha di particolare, di specifico, o ciòche lo distingue dalla altre confessioni (come indefinitiva faceva von Harnack), ma intende ricercarela determinazione della sua idea fondamentale e
47 Cattolicismo. Aspetti sociali del dogma, in Opera omnia di Henride Lubac, vol. 7, Jaca Book, Milano 1978, Avvertenza, p. XIX.
48 Tale intento si distingue dall’altra esigenza legittimadi mostrare l’elemento cattolico anche come cristiano (cfr L.SCHEFFCZYK, Il mondo della fede cattolica, pp. 26-27).
49 K. ADAM, L’essenza del cattolicesimo, Introduzione, p. 8.
22
dominante, ovvero “il principio unitario, la formaessenziale che vivifica quella complessa realtà chenoi chiamiamo cattolicesimo”50. Esso è sempremedesimo, in quanto la sua essenza era già fissata daCristo in modo visibile. Perciò, si distingue ancheper la “positività ed affermazione” della propriaessenza, a differenza dalle Comunità acattoliche,sorte non per via di un’affermazione incondizionata,ma sulla base di una scelta soggettiva di negazione edi repulsione51. Tale è positività del ““sì”incondizionato, deciso, comprensivo dato allapienezza della vita in tutti i suoi aspetti e nellesue radicali esigenze, (…) innanzitutto al fondamentopiù radicale del nostro essere, al Dio vivente”52.
In realtà, anche se le prospettive – quella diRatzinger e quella di Adam –sono diverse, lo sono piùa livello dell’approccio storico. Teologicamente, laprospettiva ratzingeriana non sembra lontana dalla“positività” e dalla universalità, rilevate da Adam,che sono proprie della cattolicità della fedecristiana. Ratzinger usa spesso il termine della“positività” (“inalienabile positività dellaconcezione cristiana”), ma lo fa a partire dal nucleodel Symbolum, cioè volgendo lo sguardo al cuore delCristianesimo, verso la Persona di Gesù Cristo. Adamlo fa partire dal deposito e dalla vita della Chiesacattolica, pensando come ha sviluppato armonicamenteed organicamente questo fulcro di partenza.
50 K. ADAM, L’essenza del cattolicesimo, Introduzione, p. 7.51 K. ADAM, L’essenza del cattolicesimo, Introduzione, p. 14-15:
“La storia del cattolicesimo è storia dell’affermazionedecisa, conseguente, comprensiva dall’intera realtà dellarivelazione, della pienezza dello Spirito divino rivelatosi inCristo, secondo tutte le dimensioni del suo sviluppo”.
52 K. ADAM, L’essenza del cattolicesimo, Introduzione, p. 15.
23
3.1.4 Anche il teologo slesiano Leo Scheffczyk53,introduce e riflette decisamente sul Cattolicesimo o,come egli è solito dire, sul “Cristianesimocattolico”54. Il discorso di che cosa viene in primalinea, il “cristiano” o il “cattolico”, per lui vienerisolto e superato. “Cattolico”, infatti, non è unaspetto secondario e posteriore di quanto sia“cristiano”, ma è il nucleo stesso e originario diquanto si possa descrivere per il Cristianesimo esperimentare nella sua forma storica delCristianesimo primitivo.
53 Il Papa Benedetto XVI lo ricorda come colui che “dicevasubito con grande chiarezza e, nello stesso tempo, conpuntuale giustificazione teologica quello che andava e quelloche non andava”, riferendosi ai lavori della Commissionedottrinale della Conferenza Episcopale tedesca dopo ilConcilio, in una situazione che era “estremamente confusa eirrequieta e quando la stessa posizione dottrinale dellaChiesa non era più sempre chiara. Venivano fatte circolaredelle tesi che si premeva fossero diventate improvvisamentepossibili, nonostante non coincidessero, in realtà, con ildogma” (BENEDETTO XVI, «Un ricordo di Leo Scheffczyk», in Ilmondo della fede cattolica. Verità e forma, Vita e Pensiero, Milano 2007,p. XI).
54 In questa chiave va riletta tutta la sua operateologica, che al centro porta la riflessione sull’universodella fede cattolica, come dimostra una prima sinteticaintroduzione ai principali temi della riflessione diScheffczyk, offerta da M. HAUKE, Ganz und gar katholisch. Ein ersterEinblick in das theologische Werk von Leo Cardinal Scheffczyk, Stella MarisVerlag, Buttenwiesen 2003 (cfr recensione di K. CHARAMSA in AlphaOmega 9, n. 1 [2006] 186-188); tr. it. Essere cattolico? Un primosguardo all’opera teologica del Cardinale Leo Scheffczyk, Mane nobiscum 10,Lateran University Press, Città del Vaticano 2007. Hauke favedere come nell’opera di Scheffczyk “l’essere cattolico non èun elemento superfluo che va nascosto dietro aspetti piùimportanti. La cattolicità fa parte dell’essenza delCristianesimo, così come è stata voluta dal Figlio di Dio” (ivi,p. 5).
24
Anche nel volume di Ratzinger, sembra che, in uncerto senso, il problema da dove partire: – cioè dalcristianesimo o dal cattolicesimo – venga risolto,perché tutto è sottomesso alla prevalenza del dato difede. Ovvero, il problema: del rapportocristianesimo-cattolicesimo trova la sua rispostanella misura in cui è risolta la questione delprincipio, dell’inizio stesso del discorso teologico,che è fissato nel dato di fede, nei suoi articolicompresi nel Simbolo Apostolico. Se questo presenta isuoi indubbi risvolti per il dialogo ecumenico eoffre la base per tutto il Cristianesimo, in realtàquesta fede non è mai inter-confessionale, maappartiene alla confessio. La fede da cui prende avviola riflessione teologica è necessariamente cattolicae, a partire da questa sua nota, nasce il suocarattere positivo ed aperto al dialogo ecumenico,nonché anche ad un corretto incontro con le altrereligioni55. Non si tratta perciò di una ricerca difondamento che stia fuori del cattolicesimo o oltredi esso, ma di qualcosa da cui si viene catturatinella stessa professione di fede cattolica, sin dalprimo dialogo con la Chiesa nell’ora del Battesimo.
3.1.5 Mentre ancora Adam precisava che l’essenzadel cattolicesimo è anche l’affermazione piena edenergica di tutto l’uomo56, Ratzinger costata lastessa relazione più direttamente nei confronti dellafede: la fede permette agli uomini di condurre unavita veramente umana, ciò da cui ricevono un vero“io”.
Egli lo fa in una prospettiva allargata, quandoapre il volume con una breve, ma incisiva analisi
55 Cfr J. RATZINGER, Saggio introduttivo alla nuova edizione 2000 –“Introduzione al cristianesimo”, ieri, oggi, domani, p. 15ss.
56 K. ADAM, L’essenza del cattolicesimo, Introduzione, p. 15.
25
della situazione dell’uomo d’oggi in riferimento allafede e ai suoi rapporti con l’incredulità. Ratzingerè convinto che la questione della fede coinvolge ogniuomo, nessuno escluso, sia quando crede, sia quandorifiuta o non conosce ancora la gioia della fede.Egli traccia il sottile spazio esistenziale dellafede e del dubbio: il credente è tentato dal dubbio(“forse non è vero?”), ma anche l’incredulo è tentatodalla fede (“forse è vero?”)57. Ora Ratzinger, da verocredente, nel fare teologia parte non dal dubbio, madalla fede. In altri termini, egli non ammette ildubbio come punto di partenza, ma esclusivamente ildato di fede. La “fede” per lui si distingue dalla“legge” che guida l’Antico Testamento e dalla“religio” dell’osservanza romana, che altrettanto nonrichiede di credere. In tal modo, Ratzinger avvia undiscorso che oggi è di massima attualità: cioè cheproprio la fede distingue il cristianesimo dallecredenze delle altre religioni58. La piccola parola“credo” indica “conversione”, “cambiamento dimentalità”, “svolta dell’essere”59 e così permetteagli uomini di condurre una vita veramente umana, ciòda cui ricevono un vero “io”.
3.2 Fede, accettazione di una dottrina – fede,accoglienza di una persona
La priorità assoluta della fede che riguarda ogniuomo fa vedere un altro aspetto importante: purcustodendo la professione, per così dire, oggettivadella fede nel Simbolo, Ratzinger riesce a rilevarecostantemente il carattere personale (del soggetto
57 Introduzione al cristianesimo, pp. 11-18.58 Introduzione al cristianesimo, p. 19.59 Introduzione al cristianesimo, pp. 21 ss.
26
credente) della fede60, perché dire “io credo in te”segna un incontro personalissimo con Gesù61. Cosìl’Introduzione al cristianesimo ci pone davanti ad unulteriore problema: questa fede, a cui introdurre gliuomini, è l’accettazione di una dottrina (la sacradoctrina di un Simbolo degli articoli di fede) opiuttosto consiste nell’abbracciare ed accogliere unaPersona (Gesù Cristo)?
3.2.1 Al centro Christus totusSe guardiamo alla riflessione teologica di Karl
Adam, non vi sono dubbi che per l’autore dell’Essenzadel cattolicesimo al centro sta la Persona di Cristo Capocon la sua Chiesa in quanto suo Corpo (Christus totus).
Romano Guardini in questo punto è ancora piùesplicito, quando a più riprese afferma nella suaEssenza che Gesù Cristo, il Signore è centrale per ilCristianesimo, esigendo dal credente la radicalitàdella sequela e facendo comprendere il mondo e lastoria essenzialmente solo a partire dalla Persona diCristo. “Non c’è – scrive – una determinazioneastratta di tale essenza. Non c’è alcuna dottrina,alcuna struttura di valori morali, alcunatteggiamento religioso od ordine di vita, che possavenir separato dalla persona di Cristo, e dei qualisi possa dire che siano l’essenza del cristianesimo.Il cristianesimo è Egli stesso; ciò che per mezzo suoperviene agli uomini, e la relazione che per mezzosuo l’uomo può avere con Dio. Un contenuto dottrinaleè cristiano in quanto viene dalla sua bocca.L’esistenza è cristiana in quanto il suo movimento èdeterminato da Lui. In tutto ciò che voglia esserecristiano, Egli deve essere compresente. La persona
60 Introduzione al cristianesimo, pp. 46-47.61 Cfr Lettera Enciclica Deus caritas est sull’amore cristiano,
25 dicembre 2005, n. 1.
27
di Gesù Cristo, nella sua unicità storica e nella suagloria eterna, è di per sé la categoria che determinal’essere, l’agire, e la teoria di ciò che ècristiano”62. Guardini presume, pertanto, anch’egli,la vera distinzione qualitativa tra quelle che sonovarie esperienze religiose, storicamentequalificabili, e la fede.
Dal momento che il nucleo del cristianesimo stanella fede cristo-logica (cristo-centrica), diventaquasi connaturale, ad un teologo, tendere oltre tuttoad un’opera dedicata alla Persona e alla Missione delSalvatore. Non a caso, gli stessi autori delle“Essenze” tendono ad un’opera cristologica, che inquesta prospettiva andrebbe vista come un complementoe la continuazione dell’Introduzione al cristianesimo. DiKarl Adam sono rimaste addirittura tre opere su Gesù:Christus unser Bruder (1926; tr. it. Cristo nostro fratello),Jesus Christus (1933) e Der Christus des Glaubens (1954, tr.it. Il Cristo della fede). Di Guardini viene finora letto ilcapolavoro meditativo Il Signore (Der Herr. Betrachtungen überdie Person und das Leben Jesu Christi del 1937, cioè di un annoprecedente all’Essenza del Cristianesimo)63. In questalinea, si può dire che Ratzinger coltiva la tensioneverso una tale opera cristologia sin dall’Introduzione ei suoi ideali contenuti muovono – per così dire –tutto il suo pensiero, venendo finalmente a compiersinel suo recente capolavoro da Pontefice64. Ogni veraintroduzione alla fede cristiana tende a un profondoincontro con Gesù Cristo ed a livello teologico non
62 R. GUARDINI, L’essenza del cristianesimo, p. 77.63 Si ricordano inoltre in questo approccio globale a
Cristo anche i lavori di minore portata, come La figura di GesùCristo nel Nuovo Testamento (1936) e La realtà umana del Signore. Saggio sullapsicologia di Gesù (1958).
64 J. RATZINGER – BENEDETTO XVI, Jezus von Nazareth. Von der Taufe imJordan bis zur Verklärung, Herder, 2007; tr. it. Gesù di Nazaret, tr. I.Stampa e E. Guerriero, Rizzoli, Milano 2007.
28
potrà mancare di una personale rivisitazione dellafigura del Salvatore.
3.2.2 La dottrina o la Persona da accettareCon questa esperienza dei nostri grandi teologi
non abbiamo ancora affrontato la questione che per imoderni si pone con particolare intensità: la fede èaccettare la dottrina o la Persona?
La fede mai è semplicemente una raccolta didottrine, formule aride e datate da difendere conostinazione: una tale visione del credere sarebbemonca e senza vita. All’apertura della sua primaLettera Enciclica Deus caritas est Benedetto XVI loinsegna con parole divenute programmatiche delpontificato, ma che, nella sua origine, ci riportanodirettamente al volume dell’Introduzione: “All’iniziodell’essere cristiano non c’è una decisione etica ouna grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, conuna Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e conciò la direzione decisiva”65. La fede si configuracome l’accettazione di una Persona, costituente lascelta fondamentale della vita del cristiano66. Essanon consegna un codice di divieti e prescrizioni daosservare, ma apre la via da intraprendere nellalibertà.
Chi, però, pensa che questa fede personalissimanon sia altrettanto un’accoglienza di una dottrina,sbaglierebbe. E proprio con l’opera ratzingerianaalla mano, dobbiamo dire che la fede, che inizianell’incontro con la Persona di Gesù, si configura e
65 Deus caritas est, n. 1: “Ad initium, cum quis christianusfit, nulla est ethica voluntas neque magna quaedam opinio,verumtamen congressio datur cum eventu quodam, cum Persona quaenovum vitae finem imponit eodemque tempore certamprogressionem”.
66 Cfr Introduzione al cristianesimo, p. 21.
29
continua nella comprensione sempre maggiore della suadottrina, di cui linfa vitale rimane sempre Lui.
Innanzitutto, la dignità della fede sta nella suaragionevolezza, e questa esige la comprensione deisuoi contenuti. Essa non è “un cieco buttarsi inbraccio all’irrazionale”, né “un ciecoaffastellamento di paradossi incomprensibili”, ma èuna forma mentis, è propriamente “un accostarsi al‘logos’, alla ‘ratio’, al vero senso della cosa equindi alla stessa Verità”67. L’incontro della fede èper niente generico, ma ogni-comprensivo,totalizzante, cioè coinvolgente la comprensione ancheintellettuale. Da una tale fede, che ha sempre a chefare con la ratio e non umilia né distruggel’intelletto, scaturisce come compito originario eprecipuo la teologia con il suo discorso comprensivo,logico (= razionale, intellettivo-razionale) vertentesu Dio, perché solo dalla fede scaturisce il verocomprendere, ovvero, stare come su un solido appoggioe comprendere il contenuto dato. La razionalità dellafede presuppone la dignità della discorsività di unadottrina, con le proprie formule razionalmenteafferrabili. La dottrina fortifica e consolida lafede-incontro e la protegge dal rischio di degenerarein un puro sentimento o un’emozione passeggera, inuna mera fiducia suffragata da una bigotteriadevozionale e da una ritualità vuota.
Seguendo le orme dell’Introduzione, è ancora unavolta il Simbolo Apostolico a conservare ed assicurareambedue gli aspetti della fede, sia dell’accoglienzadella Persona, sia dell’accettazione di veritàdottrinali. Esso fugge dall’essere una sempliceraccolta di principi dottrinali, perché è un testopermeato all’interno dalla dinamica sacramentaledella vita cristiana con la sua articolazione di
67 Introduzione al cristianesimo, pp. 42. 44.
30
domande e di risposte prima dell’amministrazione delBattesimo e dunque anche dell’Eucaristia: “Credi tu?”“Credo”. È una pagina vivente, immersa nella logicadialogica, che coinvolge direttamente l’atteggiamentointeriore dell’uomo chiamato. Con la sua forma didialogo, contiene dentro di sé l’esigenza dellaprofessione e di confidenza in Colui in cui si crede,fa scaturire la decisione del soggetto, che decide ilsenso dell’esistenza, la forma e la prospetta versol’Altro.
In questa dinamicità del dialogo della fede,sulla scia di Ratzinger, si può ben vedere nella fedeil suo carattere dell’incontro personale, ma ciò nontoglie il suo secondo aspetto interno: nei suoiarticoli si tratta di una cosciente accettazionedella dottrina, che viene offerta dall’Altro, cheesige la risposta positiva ad ogni domanda sullesingole verità di Dio e di Gesù Cristo. Sulla basedel Simbolo, la forma dialogica dell’incontropersonale della fede diventa una relazione che siconfigura per un indispensabile e ricco contenutodottrinale, articolato in singole proposizioni eformulazioni dell’unica Verità.
3.2.3 Persona, una categoria essenziale riscopertaCiononostante, non bisogna nascondere la
specificità del discorso ratzingeriano con larilevanza che dà all’aspetto personale. Una dellesfide che egli si pone è riflettere sulle categoriespeculative che esprimano meglio la fede personalenella Persona di Gesù. La categoria essenziale è qui,ovviamente, la “persona”, su cui l’attuale Papa haofferto un significativo approfondimento diapplicazione teologica68.
68 Nella prospettiva teologica si ritrova la veragrandezza, pur paradossale, della persona: “cambiano
31
Già l’Introduzione al cristianesimo è permeata dal valoredel personale, perché si basa sulla “visionedialogica e personalissima della Bibbia”69 e perché lastessa formula del Credo presuppone ed esige un”‘io’personale in carne ed ossa”70. Il valore “personale” è,pertanto, presente sin dalle prima pagine dell’operadedicate alla fede personale; precisamente sindall’immagine del Dio delle Sacre Scritture fino acompletamente fisionomia le categorie di minimo e massimo, diinfimo ed eccelso. In un mondo che in ultima analisi non èaffatto matematica, bensì amore, il minimo diventa massimo;l’infimo soggetto capace di amare assurge a suprema grandezza;il particolare prevale sull’universale; la persona, ossial’entità unica e irreiterabile, diviene subito l’elementosupremo e definitivo. In una simile visione del mondo, lapersona non è ormai più un mero individuo, un esemplare fattoin serie nato dalla suddivisione dell’idea proiettata sullamateria, bensì precisamente una ‘persona’. Il pensiero grecoha sempre interpretato i molti esseri singoli, anche e persinoi singoli uomini, unicamente come individui, che si formano inseguito alla frantumazione dell’idea ad opera della materia.Il moltiplicato quindi è sempre un fattore secondario:l’elemento genuino sarebbe l’uno, l’universale. Il cristianoinvece vede nell’uomo non un individuo, bensì una persona. E amio modesto parere, in questa evoluzione dall’individuo apersona, affonda le sue radici tutta la tensione provocata dalpassaggio dall’antichità al cristianesimo, dal platonismo allafede (Introduzione al cristianesimo, p. 119).
Al riguardo è interessante notare che, da Pontefice,Benedetto XVI ha già avuto occasione di rilevare il contributodell’approfondimento sulla persona offerto da Giovanni PaoloII, quando nel Discorso ai membri delle Pontificie Accademie selle Scienze edelle Scienze Sociali, 21 novembre 2005, disse: “In un certo qualmodo, il suo [di Giovanni Paolo II] contributo indiscusso alpensiero cristiano può essere compreso quale meditazioneprofonda sulla persona. Ha arricchito e ampliato tale concettonelle sue Encicliche e in altri scritti. Questi testi sono unpatrimonio da accogliere, serbare e assimilare con cura” (cpv.6). Nel pensiero di Joseph Ratzinger, prima, enell’insegnamento di Benedetto XVI, ora, troviamo altrettantoun forte nuovo impulso di approfondimento di quanto sia
32
quelle sul Giudizio finale, ove si dice che “ilgiudice non ci si farà incontro come una personaignota e forestiera, bensì come uno di noi, come uno checonosce ed ha sofferto intimamente la natura umana”71,e pertanto anche la risurrezione sottintende“un’immortalità della persona, dell’unico impastoumano”72, corpo e anima. Il Dio biblico si rivelapersonale sin dal “Colui che è” di Jahwe (Es 3,14) efino al parallelo “Io sono” di Gesù (cfr Gv 17)73.Nella fede biblica, in Dio “l’Essere vien credutopersona e la persona vien creduta Essere, ritenendo pervero che solo il Remoto è il Vicinissimo, che solol’Inaccessibile è l’Accessibile, che solo l’Unico è
personale.69 Introduzione al cristianesimo, p. 294.70 Introduzione al cristianesimo, p. 20.71 Introduzione al cristianesimo, p. 268.72 Introduzione al cristianesimo, p. 288. Nell’immortalità “è
tratto essenziale dell’uomo, ossia la persona, che rimane; ilcondensato di spiritualità corporea e di corporeitàspiritualizzata maturato in quest’esistenza terrena continueràsempre a sopravvivere, sia pure in maniera diversadall’attuale” (ivi, pp. 292-293). Se da una parte, non si vuoleabbandonare il tradizionale concetto dell’anima, anche se sidistacca criticamente dalla sola visione dualista del mondogreco (p. 287ss.; la critica ratzingeriana in cui, per quantoposso vedere, si tratti di un distaccamento dalla visioneplatonica, molto diversa al riguarda da quella aristotelica),dall’altra, si afferma dottrinalmente la risurrezione dellepersone (p. 296). Alla fine dei tempi verrà a crearsi “il‘complesso’ definitivo, ossia il dominio stabile ed indiscussodella persona, nonché l’affermazione incontrastata diquell’unità che sgorga dall’amore” (p. 278, i corsivi nostri).Recentemente, nella sua Lettera Enciclica Spe salvi sullasperanza cristiana, 30 novembre 2007, il Papa affermava:“resta vero che una speranza che non riguardi me in personanon è neppure una vera speranza” (n. 30, circa la salvezzapersonale [delle persone] si vedano, poi, nn.45-46 e seguenti).
73 Introduzione al cristianesimo, pp. 79-84. 88-94.
33
l’Universale, buono per tutti e per cui tuttisussistono”74. Finalmente la stessa formazione dellinguaggio a partire dal concetto stesso dipersonalità divina come relazione75, fa concludere:“il confessare la sussistenza di Dio in quanto personaa mo’ di triplice personalità sfonda le barriere d’unconcetto ingenuo, antropomorfo, di persona. Esso civiene a dire, in chiave cifrata, che la fisionomiapersonale di Dio è infinitamente superiore allastrutturazione personale umana, cosicché il concettodi persona, per quanto rivelatore sia, si presentaperò a sua volta come un semplice e inadeguatissimoparagone”76. Al riguardo conclude: “così veniva in
74 Introduzione al cristianesimo, pp. 96-97. Nella sua LetteraEnciclica Spe salvi sulla speranza cristiana, il Papa insegnavaal riguardo che in definitiva solo “un Dio personale governale stelle, cioè l’universo; non le leggi della materia edell’evoluzione sono l’ultima istanza, ma ragione, volontà,amore – una Persona. E se conosciamo questa Persona e Leiconosce noi, allora veramente l’inesorabile potere deglielementi materiali non è più l’ultima istanza; allora nonsiamo schiavi dell’universo e delle sue leggi, allora siamoliberi”, pertanto, “la vita non è un semplice prodotto delleleggi e della casualità della materia, ma in tutto econtemporaneamente al di sopra di tutto c’è una volontàpersonale, c’è uno Spirito che in Gesù si è rivelato comeAmore” (n. 5).
75 Introduzione al cristianesimo, pp. 138-141. Al riguardoRatzinger rinvia ad un testo che in prospettiva risulta ancheprogrammatico su questo tema: «Zum Personverständnis in derTheologie» (1966), in Dogma und Verkündigung, Wewel, München1973, pp. 205-223; tr. it. «Il significato di persona nellateologia» in Dogma e predicazione, Biblioteca di teologiacontemporanea 19, Queriniana, Brescia 1974, pp. 173-189.
76 Introduzione al cristianesimo, p. 137; proposizione questacirca il concetto di persona in Dio, che rinvia al backgroundagostiniano, e in cui si vede il dialogo che l’Autore compiecon il pensiero personalista moderno: il punto di riferimentoè la persona, in quanto persona umana, un concetto pertantoinadeguato a Dio.
34
fondo ad affermarsi il linguaggio del dogma. Essoesprime la nozione che Dio in quanto sostanza, inquanto “essenza”, è assolutamente Uno. Se noi peròdobbiamo parlare di lui anche tirando in campo lacategoria della Trinità, non può qui trattarsiovviamente d’una moltiplicazione delle sostanze, masi viene invece a dire che, nell’unico e indivisibileIddio, esiste il fenomeno del dialogo, delvicendevole scambio di parole e d’amore. Ciò comportaa sua volta che le “tre persone” sussistenti in Dio,costituiscono la realtà della parola e dell’amorenella loro mutua circuminsessione. Non sono sostanze,personalità intese nel senso moderno, bensì unacorrelazione, la cui pura attualità (“pacchettod’onde”!) non distrugge l’unità dell’Essere supremo,ma ce la spiega”77.
Se tentiamo un paragone con Adam, notiamo chequesti percepiva l’importanza del concetto di“personalità”, ma – come si diceva – era soprattuttoGuardini a porre il termine di persona al centrodella sua esperienza di fede78, perché questa vieneordinata dalla Persona di Gesù, che è anche l’essenzadel cristianesimo. Nell’Introduzione al cristianesimo,Ratzinger riprende questa parola chiave, come è stataconcettualizzata dal discorso guardiniano, ma allostesso tempo va ben oltre la sola visione diGuardini, sistematizzando e armonizzandoteologicamente ciò che in Guardini era un’intuizionee una visione profetica. In questo senso possiamo
77 Introduzione al cristianesimo, pp. 139-140; proposizione che sirifà allo spirito della teologia trinitaria di Riccardo di SanVittore e non ha timore di cogliere i concetti della fisicamoderna (“pacchetto d’onde”!) per avvicinarsi allacomprensione del mistero delle Persone in Dio, ma soprattuttoper renderla leggibile e comprensibile per l’uomo d’oggi.
78 Cfr Welt und Person; tr. it. Mondo e persona. Saggi di antropologiacristiana, Morcelliana, Brescia 2000.
35
parlare della teologia “personalista” di Ratzinger:non tanto in quanto si voglia riferire ad unaparticolare scuola filosofica personalista, ma inquanto è permeata da una priorità e prevalenza delconcetto e del valore della persona. Questo concettochiave, in realtà, non riceverebbe, secondo Ratzingerun senso e una chiarificazione a partire dal pensierofilosofico, ma precisamente si formerebbe neldiscorso teologico. Esso non andrebbeconcettualizzato come la parte della ratio per esserepoi trasportato sul terreno del teologare, mailluminerebbe la stessa ratio a partire dalla suacrescita all’interno del discorso teologico, cioè apartire dalla Rivelazione. Una sistematica delsignificato della persona andrebbe colta in pienosolo all’interno della teologia. Da ciò segue, sindalle pagine dell’Introduzione, la prevalenza delladimensione personale nella teologia ratzingeriana e,in particolare, nella sua visione della fede,costituendo una sua nota di particolare originalità.
3.2.4 Nella Persona di Cristo Gesù – l’accesso alladottrina vera
Torniamo, però, alla nostra questione. Perrisolvere il dilemma tra “Persona” e “dottrina”, comecomponenti essenziali della fede, ci viene in aiutola speculazione ratzingeriana sul nome di Diorivelatosi nel roveto ardente come Io sono colui chesono (Es 3,14), ma nel Vangelo si fa chiaro che lostesso nome di Dio, annunciato ora da Gesù, è Gesùstesso. Il suo nome si è fatto carne e vive in mezzoa noi, come uno di noi. Il nome di Dio è una Persona:Gesù79. L’idea della totalità dell’Essere chesoggiaceva al nome di Dio nell’Antico Testamento è
79 Cfr Introduzione al cristianesimo, pp. 79ss.
36
riversata ora e definitivamente rivelata nellaPersona vivente di Cristo.
A questo punto, aggiunge Ratzinger, anche il nomedel Messia è complesso. Egli predilige, infatti, ladizione paolina che fa precedere il nome di Gesù daquello di Cristo (Cristo Gesù). Il termine “Cristo”indica in realtà più che un nome, un titolo (Messia),ovvero un ministero e una missione. Gesù è ilRedentore inviato, il Messia che salva. Il nome diGesù non bisogna scinderlo in missione (Cristo) e inpersona (Gesù), ma dovrebbero stare sempre insieme,perché secondo la fede in quel Gesù “non è possibilefare una distinzione tra ufficio e persona: taledifferenziazione risulta assolutamente priva difondamento nei suoi confronti. Qui in effetti lapersona è anche l’ufficio, e l’ufficio è pure lapersona, (…) il soggetto è l’opera, e l’opera è ilsoggetto”80. In Lui coincidono Persona e missione. Mac’è di più: questa Persona di Gesù il Cristo è ancheil Logos, la Parola. Giungiamo cosìall’identificazione tra persona, opera e parola. LaPersona sua è l’insegnamento (di una dottrina) conevidente conseguenza. La tematizzazione di unadottrina (Parola d’insegnamento) da accogliere sarebbe,pertanto, la diretta conseguenza di quell’Io divino diGesù, che riconduce sempre all’identità fra Parola ePersona81.
Se nella concezione della fede in Guardini sipoteva avere l’impressione del prevaleredell’incontro con la Persona di Cristo, in Ratzingerè più chiaramente espressa l’unità della fede nellaPersona con ciò che le è necessariamente comprensivo,per la fisionomia stessa della Persona da accogliere,
80 Introduzione al cristianesimo, p. 158.81 Cfr Introduzione al cristianesimo, p. 160-162.
37
e che nella fede esige l’accettazione della suaverità, della dottrina sua.
La fede come accoglienza della Persona non potràmai ridursi ad una sorta di opzione fondamentale afavore della Persona di Gesù, ma dovrà sempre basarsisull’accettazione di quell’insegnamento divino (cfr Mt28,19-20), che il Verbo Incarnato “in sé riassume” ea cui egli introduce, come il vero Esegeta delleSacre Scritture.
Viceversa, la fede che accetta l’insieme delladottrina non potrà mancare di alimentarsicontinuamente dell’amicizia personale con il Verboeterno. Con la linfa amorosa dell’amicizia con laPersona del Signore l’accettazione della dottrina nonrischierà di essere solo un formale accettazione dielementi aridi e teoretici, distaccati dalla vita.L’incontro con il Signore precede ogni dottrina,morale e culto, ma esso si esprime poi nella totalitàdella conoscenza (dottrina), dell’agire (morale) edel pregare Dio (culto). La prima prospettiva sullafede non esiste senza quell’altra; la seconda rinviacontinuamente alla prima, affinché Cristo, nella suaPersona, Opera e Parola, sia tutto in tutti.
3.3 Auditus fidei – intellectus fidei
Abbiamo finora visto che tra “persona” e“dottrina” non esiste una contraddizione e l’una nonesclude, ma esige l’altra, perché nella fede in cuisi incontra la Persona, si comprende anche la Parola.Arriviamo però ad un ulteriore problema. Questa fedesi distingue principalmente come un auditus o unintellectus, ovvero cosa dovrebbe prevalere nell’essenzadel cristianesimo?
La risposta dell’Introduzione al cristianesimo è anche aquesto riguardo conciliante. Quella via che in Cristo
38
Gesù si è dischiusa per l’umanità, l’uomo nonpotrebbe offrirsela da solo, inventare da sé stesso,ma tutto gli viene donato gratuitamente. Per questonel quadro delle “strutture essenziali” delcristianesimo, Ratzinger acclude per ultimo, quasi acoronamento, il fatto che il Cristianesimo afferma ilprimato del ricevere sul dare, del dono sulleprestazioni82. Se un tale dono presume l’atteggiamento
82 Introduzione al cristianesimo, Excursus: Strutture delcristianesimo, pp. 195-218, qui 214-216. Oltre quellarichiamata le altre “strutture essenziali” sono: (1.) ilCristianesimo fa appello al singolo ma aprendolo al tutto:l’esistenza cristiana è un’esistenza aperta; (2.) l’esistenzacristiana denota essenzialmente il passaggio dall’essere perse stessi all’essere per gli altri: è il principio del pro cheè espressione di amore; (3.) per il Cristianesimo Dio è iltotalmente Altro, è il Massimo, ma si manifesta nel Minimo(nella croce di Cristo), sub contrario come si esprime Lutero,rimanendo così misteriosamente sconosciuto; è la leggedell’incognito; (4.) il Minimo rimanda al Massimo dellasovrabbondanza: Cristo è l’infinita prodigalità esovrabbondanza di Dio; (5.) la Rivelazione cristiana ècaratterizzata dall’essere definitiva, ma essa apre al futurodel Regno. Tutti e sei i principi fondamentali sono poiriconducibili ad un unico principio come “il principio amore”.Se la fede è uno star-saldi e un porsi-in-relazione con latotalità, in-conoscibile, della realtà, allora nella fedecomprendiamo che l’amore ci precede e rende possibileun’esistenza aperta, che, nella speranza, cerca il tutto. Sigiunge così, per Ratzinger, alle linee fondamentali,essenziali del Cristianesimo.
Ratzinger riprende così la ricerca di quelle ur-Strukturendel cristianesimo, avanzata con Gaurdini o Przywara. Va peròtenuto ben conto che per Ratzinger una tale sintesi delprofondo significato di “essere cristiani”, ovvero della“decisione della fede” si caratterizza innanzitutto per ilfatto che le “strutture” proposte sono aperte adapprofondimenti e indagini ulteriori. La conoscenza della fedenon viene qui racchiusa in una pretesa esauriente, mapiuttosto si apre in vista di un continuo progredire della suacomprensione. Infatti, lo scopo di partenza di questo sguardo
39
dell’auditus continuo, esso, per non rimanere a suavolta effimero ed esteriore, ha bisogno di unpersonale intellectus, che rinforza la forma mentisricevuta. Essa ricerca l’“intelligibile in credendo”;può essere designata in sostanza come penetrazioneintellettuale della fede.
“La teologia come scienza della fede – insegneràpiù tardi la Fides et ratio – si organizza alla luce di unduplice principio metodologico: l’auditus fidei el’intellectus fidei. Con il primo, essa entra in possessodei contenuti della Rivelazione così come sono statiesplicitati progressivamente nella Sacra Tradizione,nella Sacra Scrittura e nel Magistero vivo dellaChiesa (cfr Dei Verbum, n. 10). Con il secondo, lateologia vuole rispondere alle esigenze proprie delpensiero mediante la riflessione speculativa”83.
d’insieme è quello di iniziare, aprire, intavolare il dialogocon gli uomini increduli del tempo d’oggi.
83 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Fides et ratio circa irapporti tra fede e ragione, 14 settembre 1998, n. 65a. IlDocumento continua al riguardo: “Per quanto concerne lapreparazione ad un corretto auditus fidei, la filosofia reca allateologia il suo peculiare contributo nel momento in cuiconsidera la struttura della conoscenza e della comunicazionepersonale e, in particolare, le varie forme e funzioni dellinguaggio. Ugualmente importante è l’apporto della filosofiaper una più coerente comprensione della Tradizione ecclesiale,dei pronunciamenti del Magistero e delle sentenze dei grandimaestri della teologia: questi infatti si esprimono spesso inconcetti e forme di pensiero mutuati da una determinatatradizione filosofica. In questo caso, è richiesto al teologonon solo di esporre concetti e termini con i quali la Chiesariflette ed elabora il suo insegnamento, ma anche di conoscerea fondo i sistemi filosofici che hanno eventualmente influitosia sulle nozioni che sulla terminologia, per giungere ainterpretazioni corrette e coerenti. Per quanto riguardal’intellectus fidei, si deve considerare, anzitutto, che la Veritàdivina, «a noi proposta nelle Sacre Scritture, interpretaterettamente dalla dottrina della Chiesa» (San Tommaso d’Aquino,
40
Se la fede esige strutturalmente sia l’auditus chel’intellectus, possiamo dire anche che, nell’introduzionea tale fede, si esige di essere istruiti sia suicontenuti della fede, cioè circa la cosiddetta fidesquae creditur, sia su che cosa sia lo stesso atto difede, cioè la natura propria del credere (lacosiddetta fides qua creditur, che in passato veniva inqualche modo esclusivizzata da parte dellaSumma Theologiae, II-II, 5, 3 ad 2), gode di una propriaintelligibilità così logicamente coerente da proporsi come unautentico sapere. L’intellectus fidei esplicita questa verità, nonsolo cogliendo le strutture logiche e concettuali delleproposizioni nelle quali si articola l’insegnamento dellaChiesa, ma anche, e primariamente, nel far emergere ilsignificato di salvezza che tali proposizioni contengono peril singolo e per l’umanità. E dall’insieme di questeproposizioni che il credente arriva a conoscere la storiadella salvezza, la quale culmina nella persona di Gesù Cristoe nel suo mistero pasquale. A questo mistero egli partecipacon il suo assenso di fede” (nn. 65b-66a).
Si tratta ancora oggi di una problematica di particolareimportanza per la teologia. In una recente Istruzione pastorale iVescovi spagnoli dicono in merito: “La conoscenza della fedeha il suo punto di partenza nella testimonianza personale di Dioche si rivela. La fede ci giunge attraverso l’udito, mediantel’ascolto della parola di Dio (cfr Rm 14-17). Ora, la stessafede che accoglie la verità rivelata (auditus fidei) suscita ildesiderio di progredire nella sua intelligenza (intellectus fidei).La fede, in effetti, cerca l’intelligenza. La verità rivelata,pur trascendendo la ragione umana, è in armonia con essa. Laragione, essendo orientata alla verità, con la luce della fedeè in grado di penetrare il significato della rivelazione.Contro l’opinione di alcune correnti filosofiche molto diffusetra noi, dobbiamo riconoscere la capacità che possiede laragione umana di raggiungere la verità, come pure la suacapacità metafisica di conoscere Dio a partire dal creato. Inun mondo che spesso ha perso la speranza di poter cercare etrovare la verità, il messaggio di Cristo ricorda lepossibilità a disposizione della ragione umana. In tempi digrave crisi per la ragione, la fede viene in suo aiuto e si fasuo avvocato” (CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción Pastoral
41
riflessione protestante). Per quanto riguarda la fidesquae creditur, è necessaria l’introduzione ad un possessoretto e integrale della dottrina (attraverso la SacraScrittura, la Tradizione e il Magistero), all’internodella quale bisogna imparare a scrutare l’eternodisegno divino, ed intendere così ogni realtà edevento nel quadro dell’economia salvifica. Rispettoalla fides qua creditur, per una fede viva ed operantenella carità, bisogna acquisire una comprensionestabile della presenza attuale e trasformante dellaPersona del Cristo risorto nella sua Chiesa, in mododa aprirsi ad essa con fiducia e lasciarsicoinvolgere senza riserve.
Queste due classiche dimensioni riescono aripercorrere sia l’atto dell’accoglienza dellaPersona creduta (fides qua creditur) sia l’accettazione diuna dottrina insegnata (fides quae creditur). Riescono afissare l’atto dell’ascolto (fides qua) e la suacomprensione (fides quae); sono l’auditus e l’intellectus.Ciò che è il grande merito di fondo dell’Introduzione alcristianesimo di Ratzinger è proprio questa visioneconciliante dei due aspetti, sempre alla scuola delprincipio cattolico “et – et”. Ratzinger può essereritenuto maestro di come cogliere nell’essenza dellafede la sua oggettività (dottrinale) e la sanasoggettività (personale), preservandola al contempodagli estremi del dogmatismo, da una parte, e delsoggettivismo relativista, dall’altra. Qui si fasentire ancora la positività della fede cattolica, apartire da cui si comprende tutto il cristianesimo.
3.4 Ragionamento su u n a verità di fede – elaborazionedi un sistema di t u t t a la fede
Teología y Secularización en España. A los cuarenta años de la clausura del ConcilioVaticano II, 30 marzo 2006, n. 15).
42
La quarta questione che si pone alla luce dellaIntroduzione è la seguente: come intelligere questa federicca e complessa di contenuti dottrinali e insiemesemplice e immediata quale è l’incontro di unaPersona vera. Di per sé, l’intellectus fidei, nella propriadiscorsività, esige di ragionare su una verità difede, poi su un’altra e così affrontare inparticolare ogni articolo della fede.
Specifico della logica prevalente in un’Introduzioneal cristianesimo è il fatto che essa pone, con forza,un’altra sfida, quella cioè della elaborazione di unsistema di tutta intera la fede nella suaessenzialità, nelle sue ragioni più profonde; il chepresumerebbe cha la fede possa essere racchiusa in untale sistema. In ogni caso, una tale sinteticaelaborazione non è facile, ma il suo impegno sipresenta come l’esigenza della priorità del principiopersonale della fede in Gesù, che coinvolge tutta lapersona ed ordina tutta la vita a Lui. La rispettivafede non è un insieme di frammenti artificiosamenteraccolti, ma un tutt’uno, in quanto proviene da unaPersona e nella Rivelazione della Persona di Cristosi riassume. La fede esigerebbe, pertanto, ancheun’espressione della sua interezza.
Come far coincidere le due esigenze,dell’interezza della fede e della particolarità deisuoi articoli? Von Balthasar direbbe che il tutto stanel frammento. Mentre, nell’Introduzione, come abbiamodetto, la coincidentia del “tutto” della fede e deisingoli frammenti si ha nel Credo: esso permette dientrare nel dialogo con il Dio personale ed è lacustodia dell’insieme degli elementi fondanti dellafede articolata. Non è, però, una raccolta fatta atavolino, come nota Ratzinger. Non è frutto di unconsenso deliberato da un Papa o concordato daiVescovi, per essere poi ripetuto automaticamente e
43
protetto ciecamente. È un testo da vivere in unincontro, di cui caratteristici sono l’amore e lafiducia, compresi i sentimenti, ma è anche un testoche è la base per ciò che è appunto “la cosa piùpropria” della fede, cioè la comprensione, senza dicui la fede sarebbe priva della sua dignità.
Solo a partire dalla professione di fede nel Credosi riescono a coniugare le due esigenze di unragionamento teologico sulle verità di fede, una peruna, e di una elaborazione del sistema (sintesi) ditutta la fede. Et-et… Solo questo testo riesce ariassumere il Cristianesimo, cioè a introdurre allasua essenza, non perdendo di vista la Persona delSalvatore nella sua interezza e nella singolarità disuoi ricchi aspetti, coniugando le esigenze di unarisposta personale della fede soggettiva ecomprendendola all’interno della fede della Chiesa,senza cui non c’è un vero incontro di fede, conCristo e in Cristo.
4. Il compendio della fede
4.1 Con l’Introduzione al cristianesimo di Ratzingertocchiamo, oltre a particolari aspetti storici di unepoca, anche l’universale necessità dei cristiani diogni tempo, a cominciare dai grandi maestri, diintrodurre alla propria fede.
San Tommaso d’Aquino, a suo tempo, lo fece con ilCompendium theologiae, dedicato al frate Reginaldo edestinato non agli studenti di teologia, ai quali erapredisposta la Summa theologiae (“ad eruditionemincipientium”), ma alle persone che si occupano dellefaccende quotidiane della vita e che non hanno tempoper una riflessione approfondita: “summa propteroccupatos”. In realtà, nel Compedium, venivanospiegati gli articoli del Credo degli Apostoli,
44
perché questo offre la forma più breve possibiledella sostanza della dottrina necessaria allasalvezza. Tommaso era convinto che, dietro laformulazione dei pochi e brevi articoli di fede, stala volontà dello stesso Verbo Eterno del Padre, cheprima di una tale sintetizzazione della fede, si èfatto Egli stesso piccolo, assumendo la nostrapiccolezza senza deporre la propria maestà84. Eglistesso si è abbassato nell’Incarnazione, offrendosicome la Parola “abbreviata” (cfr Rm 9,28 Vg; 1Tess1,2-3).
Nonostante il Compendio tomista seguisse ilcontenuto degli articoli85, esso fu ordinato secondola sequenza delle virtù teologali, della fede,speranza e carità (cfr 1Cor 13,13)86. Ora, se il primomomento rinvia alla fede nel suo oggetto degliarticoli, la cui conoscenza è necessaria per lasalvezza, il secondo riguarda più da vicino l’aspettopersonale: fede-speranza-carità sono la perfezione ditutta la vita da raggiungere attraverso laprofessione del Credo. Così, anche per Tommaso,introdurre al Cristianesimo comporta la spiegazione
84 Compendium theologiae, prologo, cap. 1.85 Riguardo ad essi, disponiamo anche di un distinto
opuscolo dell’Aquinate, Expositio in Symbolum.86 La struttura di un’introduzione tomista è, pertanto,
analoga a quella di Sant’Agostino offerta nel suo Enchiridion adLaurentium de fide, spe et caritate. Il Dottore d’Ippone apre ildiscorso sull’essenza della fede in un’ottica cristocentrica,rispondendo alla domanda di Lorenzo, a cui dedica l’opera: “Ècertamente questo quel che domandi, chiedendo che cosa sidebba mettere al primo posto e che cosa all’ultimo: l’inizioappartiene alla fede, il compimento è nella visione. E questaè anche la sintesi completamente definita. È Cristo, poi, ilfondamento certo ed esclusivo della fede cattolica: Infattinessuno può porre un fondamento diverso – dice l’Apostolo – da quello chegià vi si trova, che è Gesú Cristo (1Cor 3,11)” (ivi, n. 1.5). Cfr anche Defide et simbolo liber unus (PL 40), etc.
45
dei singoli contenuti della doctrina sacra, ma non senzacostituire un compendio di tutta la vita, che deveessere il culto gradito a Dio: la professione di fedeè l’esistenza del cristiano. I due momenti, quellodella fede oggettiva e quello della fede personale,sono inscindibilmente uniti e coinvolti.
4.2 L’Introduzione al cristianesimo di Joseph Ratzinger,salvo restando la differenza di partenza, quella cioèdi porsi più nella prospettiva agostiniana chetomista, presenta il grande pregio, simile a quelloappena descritto dall’Aquinate, che sta ancheall’origine di un indiscusso successo di quest’opera.In essa si è riusciti a cogliere le due esigenze: ilmomento del prezioso tesoro dottrinale da comprenderee quello dell’accoglienza personale, ambedue propridella stessa natura della fede, ovvero l’unità tra lafides quae creditur e la fides qua creditur, tra l’auditus etintellectus fidei, tra la Persona Jesu Christi e la sacra docrinafidei, tra le fede-incontro e la fede-conoscenza.Tutto, infatti, cerca “un’ultima ‘complessità’”,un’ultima stretta connessione87…
Questo aspetto “conciliante”, proprio dellospirito cattolico e della teologia cattolica, inparticolare, si traduce nella capacità ratzingerianadi andare oltre la conflittualità delle tesi estremee delle proposizioni esagerate, cercando sempre unavia teologica di mezzo, una soluzione evangelica, cherifiuti ogni pericoloso eccesso. È questa lacaratteristica distintiva dell’opera di Ratzingernello spettro panoramico di altri approcci, pur senzatogliere nulla ai meriti propri di altri autoriricordati. Esiste un’originalità propria di Ratzingere questa è indubbiamente una delle ragioni delsuccesso indiscusso della sua Introduzione al cristianesimo.
87 Cfr Introduzione al cristianesimo, p. 297, cfr p. 278.
46
L’Introduzione al cristianesimo, con la sua forza e ilsuo ordine speculativo, non mancando di sana aperturaecumenica e illustrando, a partire dagli articoli delSymbolum, le più profonde ragioni del credere, puòessere detto un compendio della fede. Ratzinger si eraproposto di aiutare a far comprendere in manieranuova la fede, presentandola come agevolazioneall’autentico vivere umano nel nostro mondo odierno,spiegandola ed interpretandola, senza per altro –riferendosi alla storiella di Giovannino felice ebeato che il mucchio d’oro ha cambiato in una cote –degradarne la consistenza ad un vacuo chiacchiericcioche stenta faticosamente a mascherare un totale vuotospirituale”88. Se Ratzinger non è stato mai unapologeta, ma si è ritenuto sempre un teologospeculativo, ha mostrato che, proprio nella forzadella corretta speculazione, sta il vero fulcro anchedell’apologetica della fede in Cristo Gesù e nellasua Chiesa.
È un’introduzione all’avventura del credere, che unavolta imboccate le vie della comprensione, nonfinisce mai di conoscere/vedere meglio, maturare esvilupparsi organicamente: il che riguarda tanto ognisemplice credente che viene introdotto alla fede,quanto il più raffinato teologo che deve rinnovarecontinuamente la sua coscienza dell’essenza dellafede cristiana.
88 Introduzione al cristianesimo, Prefazione (1968), p. 8.
47
[«L’Introduzione al cristianesimo di Joseph Ratzinger nel panoramadelle opere introduttive al mistero del Cristianesimo», in K.CHARAMSA – N. CAPIZZI, edd., La voce della fede cristiana. Introduzione alCristianesimo di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, 40 anni dopo, Edizioni ART,Roma 2009, pp. 27-58]
48