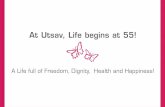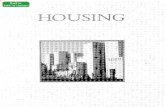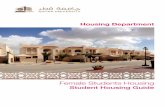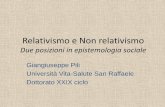"Spessore e housing sociale"
Transcript of "Spessore e housing sociale"
Sara
Mar
ini, F
eder
ico D
e M
atte
is (
ed.)
N
ello
sp
esso
re
hort
usb
ooks_
06
Nel mese di luglio 2012, la rivista (h)ortus ha ospitato un numero "monogra-fico" dedicato ad una rete di ricerca formatasi nell’ultimo anno tra un gruppo di giovani studiosi provenienti da vari atenei italiani. I saggi elaborati per l’occasione sono stati raccolti e formano il corpus di questo volume. Il tema centrale che questa rete ha formulato per l’inizio della sua attività è quello dello “Spessore della città”: indagine che, attraverso un tentativo di dialogo interdisciplinare, cerca di superare l’idea ormai consolidata e largamente condivisa di “densificazione” come strumento di riqualificazione degli spazi della città. Il concetto di “spessore”, che in ciascun saggio viene diversa-mente declinato per generare un glossario trasversale e condiviso, vuole ricapitolare, al di là dei semplici aspetti quantitativi, anche la coerenza strutturale e funzionale che un efficace spazio urbano, a tutte le diverse scale, deve possedere.
A cura di Sara Marini e Federico De Matteis | Contributi di Alberto Bertagna Daniela Besana | Fulvio Cortese | Federico De Matteis | Francesco Gastaldi | Alfonso Giancotti | Massimiliano Giberti | Carmela Mariano Sara Marini | Annalisa Metta | Luca Reale | Chiara Rizzi | Massimo Rossetti
In copertina: Serie Mibloom, Milano | Fotografia di Sissi Cesira Roselli, 2011
hortusbooks collana diretta da federico de matteis e alfonso giancotti
hortusbooks è un progetto editoriale che nasce dall’esperienza di hortus - rivista di architettura. raccogliere saggi e riflessioni di giovani studiosi dell’architettura, siano essi sul contemporaneo, sulla storia, la critica e la teoria, sul progetto o sugli innumerevoli altri temi che caratterizzano l’arte del costruire è la missione che vogliamo perseguire, per una condivisione seria e ragionata dei problemi che a noi tutti, oggi, stanno profondamente a cuore.
Nello spessoreTraiettorie e stanze dentro la città
A cura di Sara Marini e Federico De Matteis
Prefazione di Alfonso Giancotti
hortusbooks
Edizioni Nuova Cultura
hortusbooks_06
hortusbooks www.vg-hortus.it
Nello spessoreTraiettorie e stanze dentro la città
a cura di Sara Marini e Federico De Matteisprefazione di Alfonso Giancotti
hortus
Edizioni Nuova Cultura
hortusbooksCollana diretta da Federico De Matteis e Alfonso Giancotti
www.vg-hortus.it
© 2012 Nuova Cultura, RomaISBN 978-88-6134-866-0
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in alcuna forma senza esplicita autorizzazione degli autori.
Hortusbooks è un progetto editoriale che nasce dall’esperienza di (h)ortus- rivista di architettura. raccogliere saggi e riflessioni di giovani studiosi dell’architettura, siano essisul contemporaneo, sulla storia, la critica e la teoria, sul progetto o sugli innu-merevoli altri temi che caratterizzano l’arte del costruire è la missione chevogliamo perseguire, per una condivisione seria e ragionata dei problemiche a noi tutti, oggi, stanno profondamente a cuore.
Metodi e criteri di valutazione
La collana Hortusbooks propone saggi di alto livello scientifico nel campodell’architettura. I testi pubblicati, che potranno essere anche in lingua stra-niera per facilitarne la diffusione in campo internazionale, vengono valutatidal Comitato scientifico, che ne considera la validità scientifica sulla base deiseguenti criteri: originalità del lavoro e significatività del tema proposto nel-l’ambito della composizione architettonica e urbana; rilevanza scientifica nelpanorama nazionale e internazionale; attenzione alla letteratura sull’argo-mento e apparato critico; rigore metodologico; proprietà di linguaggio e flui-dità del testo; uniformità dei criteri redazionali.
Collana diretta da Federico De Matteis e Alfonso Giancotti
TraiettoriePercorsi Alfonso Giancotti
Inventari Sara Marini
Traguardi Federico De Matteis
I Stanza. Vaghezza e governoSpessore e vaghezza Alberto Bertagna
Spessore e governo Fulvio Cortese
II Stanza. Del centroSpessore nella metropoli territoriale Carmela Mariano
Spessore e centralità urbane Francesco Gastaldi
III Stanza. Sottosuoli e valoriSpessore della città alta zero Annalisa Metta
Spessore dei luoghi rifiutati Chiara Rizzi
IV Stanza. Dell’abitareSpessore e housing sociale Luca Reale
Spessore e abitare pubblico Federico De Matteis
V Stanza. Frequenze e spaziSpessori e frequenze in architettura Sara Marini
Spazi altri Alfonso Giancotti
Spessore doppio della città Massimiliano Giberti
VI Stanza. Della costruzioneSpessore reversibile Daniela Besana
Declinazioni di spessore in tecnologia Massimo Rossetti
11
19
25
35
47
63
73
85
97
109
117
127
137
155
173
187
Nello spessoreTraiettorie e stanze dentro la città
Indice
IV Stanza. Dell’abitare
IV Stanza. Dell’abitareIV Stanza.
Dell’abitareIV Stanza. Dell’abitareIV Stanza.
Dell’abitare
SPESSORE E HOUSING SOCIALELuca Reale
109
Ridefinire e incrementare lo spessore della città, scenario comune di questo itinera-rio di ricerca nazionale, vuol dire abbandonare l’idea espansiva della città contem-poranea e tornare a quella che storicamente ha costituito la pratica urbana, in parti-colare in Europa, del costruire nel costruito, densificando o sostituendo manufatti oquartieri, riciclando parti o materiali, trasformando dunque e non ampliando la strut-tura urbana esistente. Questo processo ha il primo merito di segnare una netta discontinuità con la recen-te crescita urbana, contenendo il consumo di suolo, fenomeno che negli ultimidecenni ha investito gran parte del territorio nazionale (1). Il territorio attorno e den-tro le principali città e lungo le maggiori infrastrutture viarie del paese è stato talmen-te eroso da diventare, drammaticamente e in pochi anni, una risorsa che scarseg-gia, un bene “ecologico” per così dire, da tutelare o da utilizzare comunque con par-simonia. La nuova densificazione della città produce invece un aumento d’intensità
110
d’uso del suolo urbano, e si lega profondamente, come vedremo, alle nuove forme dell’abitaree alla domanda di un’architettura che si concretizza solo se effettivamente “necessaria”, sulpiano del programma, dell’economicità, dell’innovazione, della qualità spaziale e urbana. Nel dibattito contemporaneo questo processo prende forma principalmente in tre maniere:attraverso la densificazione dell’edilizia residenziale pubblica, con completamenti e innesti nellacittà compatta – ed è il campo di cui si occupa questo breve scritto – e infine con il riciclo dimanufatti industriali o infrastrutture dismesse.
Ridefinire lo spessore della città attraverso l’housing
Perché allora l’housing sociale e perché nella città compatta. Per decenni si è creduto di doverintervenire nel tessuto della città consolidata esclusivamente, o prevalentemente, attraversol’edificio specialistico, il museo, la biblioteca, le attività commerciali o ricettive. Gran parte deicentri storici sono andati così trasformandosi con logiche per lo più dettate dalla nuova voca-zione turistica del centro città. È il rovescio della medaglia dell’enorme espansione della cittàdiffusa: parallelamente all’abbandono dei centri storici (2) la città negli ultimi trent'anni ha dila-tato i propri confini con agglomerati, prevalentemente residenziali, a densità piuttosto basse,consumando dunque grandi porzioni di territorio. Questi nuovi insediamenti hanno paradossal-mente gli stessi difetti dei quartieri sorti in Italia nel periodo glorioso dell’edilizia popolare (lastagione dell’INA-Casa e le prime 167): la monofunzionalità e l’isolamento, senza averne tutta-via le stesse qualità architettoniche e urbane. Le condizioni abitative nell’ultimo decennio sono peraltro profondamente mutate; se un tempoc’erano gli alloggi sul libero mercato, l’ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) per i senza redditoe l’edilizia sovvenzionata per le classi deboli, oggi gli enti pubblici non hanno più finanziamen-ti, né aree a disposizione. D’altra parte la fascia debole della popolazione si è notevolmenteallargata, solo a Roma la domanda di edilizia popolare ammonta oggi a 30.000 domande. Ma
111
la più ampia emergenza abitativa in Italia (e in Europa con numeri simili) si concentra in quellafascia di popolazione, in continuo aumento, che non ha mezzi sufficienti per accedere aglialloggi sul mercato – né per l’affitto né per l’acquisto – e non è abbastanza indigente per acce-dere di diritto alle graduatorie di assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica. È in risposta atale domanda che, soprattutto in Europa, sono stati fatti investimenti e sperimentazioni attraver-so l’elaborazione di proposte per l’edilizia sostenibile a basso costo basate su economicità equalità degli interventi, valore urbano dell’architettura e capacità del progetto di riappropriazio-ne e valorizzazione degli spazi pubblici. Rigenerare la città compatta attraverso la residenzasociale vuol dire anche opporsi ai fenomeni di gentrification e terziarizzazione dei centri stori-ci, o perlomeno inserire brani di mix sociale e funzionale all’interno di quartieri che sempre piùvanno configurandosi come aree omogenee per classi abbienti. In molti esempi recenti il tema dell’abitazione sociale nella città compatta diventa dunque stru-mento cruciale per rivitalizzare il centro urbano sul piano del mix sociale (oltreché funzionale)attraverso l’introduzione di abitazioni realmente necessarie e non legate ad operazioni esclusi-vamente speculative. È il caso dei 26 alloggi per impiegati delle Poste di Philippe Gazeau in ruede l’Ourcq a Parigi. L’edificio, che arretra il fronte dal filo strada per risolvere l’attacco tra nuovoe contesto, colma la lacuna di un isolato storico stretto e lungo conservando un alto grado dipermeabilità tra interno del lotto e strada e tra i vuoti esistenti interni all’isolato attraverso lascomposizione in tre elementi del pur piccolo fabbricato. La scala esterna diventa un luogo disocializzazione tra gli inquilini, i pianerottoli si trasformano in terrazze sulla città.Un altro esempio in cui il marciapiede della strada “si dilata” a creare uno spazio pubblico linea-re è presente nel recente progetto per 41 alloggi di social housing a Práter street, Budapest(2006-2007). I progettisti (PLANT– Atelier Peter Kis) decidono di separare l’intervento in duecorpi, uno a "C" che reintegra una corte incompleta, l’altro lineare in adiacenza ad una testatacieca. Le due strutture sono collegate ai livelli superiori da passerelle che mettono in comuni-
112
cazione i vani scala che distribuiscono gli alloggi. Nella distanza tra i due corpi edificati lo spa-zio urbano filtra all’interno dell’isolato con una strada pedonale che riporta ad un uso semipub-blico lo spazio del giardino interno al lotto.Un terzo esempio ci mostra come anche il risarcimento integrale di un isolato incompleto puògarantire qualità architettonica e spaziale ad un intervento di housing. Siamo nel quartiere ber-linese di Prenzlauerberg dove lo studio Zanderroth Architekten ha realizzato il progetto BIGyardin Zelterstrasse tra il 2007 e il 2010. La ricucitura dell’isolato non fraziona la superficie in 4 lottisecondo la parcellizzazione originale, ma unifica lo spazio aperto in un unico grande giardinoche diventa affaccio e spazio di relazione per le tre diverse tipologie di alloggi che ne costitui-scono i limiti: 23 townhouses, più basse, sul fronte urbano, 10 gardenhouses con affaccio tuttointerno con sovrapposte 12 penthouses che recuperano lo spazio aperto delle coperture e lavista sul quartiere e sulla città.Un altro esempio in cui l’intervento di housing sociale diventa occasione per riqualificare lospazio interno di un isolato è il progetto di Frédéric Schlachet per 13 alloggi sociali e attivitàcommerciali nel 14° arrondissement di Parigi (2004 – 2010). L’architetto considera fondamen-tali per la qualità architettonica e urbana di un intervento abitativo i luoghi di transizione tra spa-zio pubblico e spazio domestico. Il suolo urbano e lo spazio semiprivato delle residenze entra-no in relazione così come nel progetto di ricucitura di una manzana a Barcellona dove lo stu-dio Coll-Leclerc Arquitectos propone di sdoppiare il corpo di fabbrica del blocco di Cerdà cre-ando una strada interna che distribuisce gli alloggi a ballatoio per giovani sul fronte urbano euna scuola elementare con dei campi sportivi sul lato interno del blocco.
L’housing sociale nella città compatta. Un’occasione per Roma
L’housing sociale potrebbe rappresentare uno strumento essenziale di rinascita anche per lecittà italiane e in particolare per i centri storici. Attraverso la trasformazione e il riutilizzo di aree
113
già urbanizzate (anziché edificare su spazi liberi) si afferma la necessità di valorizzare i vuotiche ancora caratterizzano la città consolidata, da anni sottoposti ad una generalizzata satura-zione, o lasciati in stato di abbandono e degrado. A Roma il Nuovo Piano Regolatore Generaledel 2008 individua aree da trasformare e valorizzare con interventi basati su mixitè e forte pre-senza di residenziale (ambiti di valorizzazione); c’è poi il patrimonio edilizio delle ex-rimesseATAC, i forti e le caserme militari per gran parte inutilizzati o trasferibili, le aree industrialidismesse da riciclare. Anche queste strutture potrebbero essere in parte dedicate al social hou-
sing. Il riuso di archeologia industriale per destinazioni residenziali è per la verità molto com-plesso e quindi non molto comune, ma alcuni progetti europei in questo senso sono statiimmaginati, come la ristrutturazione dei magazzini De Wande dello studio Big HouseArchitecture (1997) a Deventer in Olanda, altri realizzati come il TechnoPark di Zurigo (comple-tato nel 2003). Nel primo caso tra i manufatti industriali sono innestati dei corpi lineari che con-tengono servizi e collegamenti verticali (“travi luminose”) e che consentono alla luce di illumi-nare gli spazi al piano terreno dei capannoni dedicati ad attività pubbliche. Alle coperture delleex-fabbriche vengono sovrapposte le abitazioni che disegnano il nuovo skyline del quartiere.Nel progetto svizzero il distretto industriale di Zurigo viene riqualificato attraverso la trasforma-zione dei grandi capannoni in strutture commerciali, uffici, spazi dedicati alla cultura e al tempolibero. Le residenze sono in sottili corpi di fabbrica a sviluppo lineare che avvolgono i padiglio-ni creando gli accessi alla quota urbana e tre livelli di uffici mono affaccio. Al di sopra dei qualisi posizionano altri tre livelli di abitazioni che, guadagnata la quota delle coperture dei fabbrica-ti industriali, recuperano un doppio affaccio sulla corte e sulla strada. L’ispessimento del corpodi fabbrica dei padiglioni restituisce anche una scala urbana alle strade interne al quartiere.Perché i risultati sono ancora insoddisfacenti in Italia (qualcosa si è fatto a Milano) e del tuttoinesistenti a Roma? Il Piano di edilizia abitativa del 2008 (3) prevede lo stanziamento nell’edi-lizia privata sociale (social housing) di oltre 2 miliardi di euro da parte dello Stato attraverso
114
CDPI Sgr con il Fondo Investimenti per l’Abitare, «con la finalità di incrementare sul territorioitaliano l’offerta di alloggi sociali per la locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi con-venzionati, a supporto ed integrazione delle politiche di settore dello Stato e degli enti locali»(4). Questi soldi, che vanno a coprire il 40% dei costi degli interventi, dovrebbero attrarre il pri-vato su operazioni di social housing. Quindi ci sono le risorse, ci sono alcune procedure, c’èuna domanda forte e in grande crescita – come abbiamo già detto – al contrario della doman-da di residenze “ordinarie”, in forte stallo. La domanda di social housing, potremmo dire, èinversamente proporzionale alla prosperità del momento economico. Forse quel che manca èil coraggio di sperimentare da parte di imprese e amministrazioni, un’inerzia pregiudiziale dovu-ta anche al fatto che il termine "sociale" – per tradizione associato all’intervento pubblico – silega ora all’iniziativa privata. Certamente manca una legge nazionale (5) e si registra ancorauna volta una profonda inadeguatezza dell’urbanistica la cui normativa è ancora impostata sul-l’espansione come regola più che sul riciclo della città esistente. Dal punto di vista più specificatamente architettonico il progetto della residenza sociale nellacittà compatta, inteso come completamento, innesto (infill), densificazione o totale sostituzio-ne, apre questioni linguistiche e morfologiche di grande interesse. Il rapporto con la storiabasato su «l’allusività di tipo figurativo piuttosto che su repliche» (6) è oggi l’orientamentodominante nel panorama europeo. Ed è in fondo l’approccio italiano (penso a Gardella, Albini,Scarpa) che dal dopoguerra in poi ha costellato di esempi eccellenti i nostri centri storici. Altema del continuum urbano, tipico dell’abitazione, l’intervento sul costruito aggiunge anche unproblema di coerenza linguistica oltrechè tipologico - formale. Alcuni straordinari esempi roma-ni (Moretti a viale Buozzi, Ridolfi a via Paisiello, Passarelli a via Campania) ci ricordano poi cheil progetto della residenza, anche come metafora della stratificazione, ci permette di leggere lospessore della città attraverso la semplice ma raffinata operazione del “costruire sopra”.
115
Note
(1) Il consumo di suolo in Italia è aumentato del 500% dal 1950 a oggi, la popolazione – nello stesso arco
temporale – del 22%; sono circa 4 milioni le abitazioni realizzate solamente negli ultimi 15 anni in Italia.
Fonte: Rapporto Ambiente Italia 2011.
(2) «Le undici più grandi città italiane hanno perduto circa 700.000 abitanti nel decennio compreso tra i
censimenti 1991 e 2001. Gran parte dello spopolamento proviene dai nuclei storici di quelle città. A
Venezia restano poco più di 60.000 abitanti: con i ritmi attuali non ci sarà alcun residente nel 2030. Nel
centro storico di Roma vivono meno di 100.000 abitanti; erano 370.000 nel 1951», in BERDINI P., La città
in vendita. Centri storici e mercato senza regole, Roma, Donzelli, 2008, p. 3.
(3) Precisamente l’art.11 del Decreto legge n. 112 del 2008 convertito nella Legge n. 133 del 2008. In
seguito il Decreto interministeriale del 23 marzo 2010 sul sistema dei fondi immobiliari ha istituito il Fondo
Investimenti per l’Abitare (FIA), gestito da CDPI Sgr.
(4) www.cdpisgr.it
(5) Il recente annuncio del ministro delle Infrastrutture Corrado Passera di andare avanti col piano città in
sostituzione del piano casa su proposta dell’ANCE, menziona anche gli oltre 2 miliardi di fondi per l'hou-
sing sociale «che aspettano di essere spesi», e che andrebbero infatti impegnati entro il 2015.
(6) Si pensi ad esempio al disegno dei prospetti e all’uso raffinato dei materiali che fa David Chipperfield
in un recente progetto per una galleria privata a Berlino, cfr: COSTANZO M., Due opere di David
Chipperfield a Berlino, in "Hortus", 2009, 27.