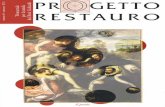La fiesta del poblado el Cedral como alternativa de turismo cultural.
FINANZA ALTERNATIVA E INNOVAZIONE SOCIALE: PROLEGOMENI AD UNA TEORIA DELL’«IMPACT INVESTING»
Transcript of FINANZA ALTERNATIVA E INNOVAZIONE SOCIALE: PROLEGOMENI AD UNA TEORIA DELL’«IMPACT INVESTING»
L’associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e lacollaborazione scientifica fra gli studiosi del diritto civile.
A tal fine l’associazione favorisce lo svolgimento di attivitàdi interesse giuridico generale anche con indagini di politicalegislativa, partecipa a iniziative e progetti di istituzioni ita-liane, estere e sovranazionali, collabora con soggetti pubblicie privati, redige pareri ed esprime opinioni su questioni giu-ridiche internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, or-ganizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di in-contri culturali, promuove la costituzione di commissioni distudi, conferisce premi e borse di studio, cura pubblicazionianche di raccolte di leggi d’interesse nazionale ed interna-zionale e realizza ogni altra attività reputata utile per il per-seguimento dello scopo*.
* Art. 2 dello Statuto della «Società Italiana degli Studiosi delDiritto Civile» (in forma abbreviata S.I.S.DI.C.), Atto Notar Gio-vanni Cesàro del 7 aprile 2005, Rep. n. 3619/serie 1. Registrato aNapoli il 21 aprile 2005.
Edizioni Scientifiche Italiane
BENESSERE E REGOLEDEI RAPPORTI CIVILILO SVILUPPO OLTRE LA CRISI
Atti del 9° Convegno Nazionalein ricordo di Giovanni Gabrielli
8-9-10 maggio 2014Royal Continental Hotel - Napoli
AttiSocietà Italiana degli Studiosi del Diritto Civile
Comitato scientifico:Pietro Perlingieri, Donato Carusi, Alessandro Ciatti, Raffaele Di Raimo,Pasquale Femia, Marialuisa Gambini, Stefania Giova, Attilio Gorassini,Michele Graziadei, Daniela Memmo, Vincenzo Ricciuto, Chiara TenellaSillani, Raffaele Tommasini, Mario Zana.
Comitato dei garanti:Francesco Benatti, Cesare Massimo Bianca, Antonino Cataudella, NicolòLipari, Rodolfo Sacco.
Coordinamento e cura:Manolita Francesca
Comitato editoriale:Marcello D’Ambrosio (Università degli Studi di Salerno); Alessia Fache-chi (Seconda Università degli Studi di Napoli); Andrea Lepore (SecondaUniversità degli Studi di Napoli); Anna Malomo (Università degli Studidi Salerno); Roberta Marino (Università degli Studi di Napoli «FedericoII»); Emanuela Migliaccio (Università degli Studi del Sannio); Maria Por-celli (Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale); FrancescoQuarta (Università degli Studi di Bologna); Carla Solinas (Università de-gli Studi di Roma «Tor Vergata»).
Società Italiana degli Studiosi del Diritto CivileBenessere e regole dei rapporti civiliLo sviluppo oltre la crisiAtti del 9° Convegno Nazionalein ricordo di Giovanni GabrielliCollana: Atti SISDiC, 9Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2015pp. 524; 24 cmISBN 978-88-495-2972-2
© 2015 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.80121 Napoli, via Chiatamone 7
Internet: www.edizioniesi.itE-mail: [email protected]
I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo(compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di cia-scun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall’art.68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra siae, aie,sns e cna, confartigianato, casa, claai, confcommercio, confesercenti il 18 dicem-bre 2000.
SOMMARIO
BENESSERE E REGOLE DEI RAPPORTI CIVILILO SVILUPPO OLTRE LA CRISI
Parte IBenessere della persona e benessere economico
G. Calabresi, Introduzione 7S. Rodotà, Crescita e benessere 15M. Musella, Produzione e valore non patrimoniale: beni am-
bientali e culturali. Brevi riflessioni di un economista 23G. Azzoni, Dignità umana, dipendenza reciproca, felicità co-
mune 31M. Grondona, Welfare e libertà: una prospettiva individuali-
sta 51B. Pozzo, Le nuove regole dello sviluppo: dal diritto pubblico
al diritto privato 71U. Mattei, Civiltà e benessere: Stato, Stato minimo, colletti-
vità organizzate 103
Parte IIAttività economica e habitat naturalePresiede: M. Nuzzo
F. Marinelli, Titolarità dei beni e soggettività giuridica: col-lettività locali e interessi diffusi 113
L. Francario, Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili esostenibilità 123
M. Monteduro e S. Tommasi, Paradigmi giuridici di realiz-zazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenzaindisponibile e ad appartenenza necessaria 161
U. Salanitro, Impatto ambientale dell’impresa e teorie eco-nomiche della responsabilità 203
Sommario
A. Nervi, Proprietà pubblica vs proprietà privata: il caso dellereti infrastrutturali 219
M. Pennasilico, Contratto e promozione dell’uso responsabiledelle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi 249
M.R. Maugeri, Il contratto di rendimento energetico e i suoi«elementi minimi» 275
Parte III Sviluppo e habitat civile
C. Imbriani, Introduzione: Il metabolismo urbano tra sviluppoe habitat civile 287
A.R. Germani e P. Morone, Urban Requalification betweenTechnological Innovation and Sustainable Development 291
G. Recinto, Habitat urbano, tecnologia e qualità del serviziouniversale 303
M. Maggiolo, Micro violazioni e risarcimento ultracompensa-tivo 313
C. Mignone, Finanza alternativa e innovazione sociale: prole-gomeni ad una teoria dell’«impact investing» 343
S. Pagliantini, Il debito da eccezione a regola 377F. Padovini, Indebitamento e sovraindebitamento 415G. Carapezza Figlia, Contratto, dignità della persona e am-
biente civile. Riflessioni sul divieto di discriminazione neirapporti contrattuali 423
Ricordo di Giovanni GabrielliM. Nuzzo 461F. Padovini 465
Parte IV Crescita, benessere e rapporti civili
N. Lipari, Introduzione 471M. Libertini, Persona, ambiente e sviluppo: ripensare la teo-
ria dei beni 479M. Bussani, Le persone e la crisi: il ruolo della responsabilità
civile 493
Conclusioni:P. Perlingieri, Produzione, beni e benessere 509
522
Carlo Mignone
FINANZA ALTERNATIVA E INNOVAZIONE SOCIALE: PROLEGOMENI AD UNA TEORIA
DELL’«IMPACT INVESTING»
Sommario: 1. Destinazione profittevole vs. destinazione solidaristica: l’an-tagonismo delle forme di valorizzazione del capitale all’origine del deficit diimpatto sociale dello sviluppo capitalistico. Il divario tra competitività e in-novazione all’interno dell’industria dell’investimento nei mercati finanziari. –2. For profit vs. non profit: la perfetta incomunicabilità tra i modelli del libroI e quelli del libro V. Rilievo meramente esterno della meritevolezza dei finisociali perseguiti dall’ente: assenza di lucro soggettivo quale presupposto perl’applicazione di un regime di favore basato sulla leva fiscale. – 3. Una fi-nanza privata per il Terzo settore? Gli esperimenti di prima generazione: inparticolare, i titoli di solidarietà destinati al finanziamento delle ONLUS (art.29, d.lg. n. 460 del 1997). – 4. Dal finanziamento al «soggetto» (non-profit)ad un’autonoma categoria di attività finanziarie con funzione di investimentonel progetto sociale: social impact bond, fondi d’investimento EuSEF e socialcrowd-funding. – 5. Interesse al risultato finanziario, interesse agli impatti so-ciali positivi misurabili e loro incidenza sulla disciplina applicabile al rapportodi investimento. In particolare: la questione del finanziamento di un’impresasociale come un problema di struttura finanziaria e le necessarie misure dicorrettezza e trasparenza contrattuale sulle quali si fonda la fiducia dell’im-pact investor. – 6. Segue. Conflitti di interesse e giudizio di meritevolezza sul-l’operazione: compatibilità del SIB con il divieto per P.A. di negoziazione instrumenti di finanza derivata. – 7. Due previsioni sull’immediato futuro: at-tenuazione del vincolo di non distribuzione degli utili ed elaborazione di mo-delli di fiscalità ad impatto sociale. Conclusioni: assoluta imprescindibilità,nella transizione dal non profit al low profit, del profilo funzionale descrit-tivo degli interessi (anche non patrimoniali) deducibili nel rapporto di inve-stimento. – 8. Postilla. Il Disegno di legge delega C. 2617 del 22 agosto 2014per la riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale: il contesto e le lineegenerali dell’intervento. - 8.1. La nuova disciplina dell’impresa sociale: remu-nerazione del capitale e valutazione ex post dell’impatto sociale dell’attività. -8.2. Profili fiscali: storico superamento della nozione di attività non com-merciale ai fini fiscali (art. 2195 c.c.). Verso l’articolazione di un assetto im-
Parte III / Sviluppo e habitat civile
positivo differenziato in ragione dell’impatto generato nello svolgimento diqualunque forma di attività economica.
1. Il deficit di impatto reale e sociale del capitale finanziario sta alcuore dell’odierna crisi. Se guardiamo alla dinamica investimento-ri-sultato, la scena congiura tutta nel restituire un’immagine delle formedi valorizzazione del capitale «in bianco e nero». Alternativamente, ilcapitale può essere: o allocato allo scopo di ottimizzare il rapporto ri-schio-rendimento, senza che rilevi alcun interesse specifico all’impattosociale dell’attività finanziata; oppure il capitale può essere allocato inragione del valore sociale della produzione, ma in questo caso senzaalcuna pretesa ad un ritorno finanziario.
Una volta ridotto il profitto alla mera valorizzazione nei mercatifinanziari del capitale investito, questo si è come scrollato di dosso lasua funzione storica1. Quella di un processo di «distruzione creatrice»2
che ambisce ad innovare la realtà preesistente. Un modello di vita, ol-tre che di attività, che in tanto esiste in quanto è capace di rivoluzio-nare continuamente gli strumenti e i rapporti di produzione certo, maanche di «scuotere» in modo incessante tutto l’insieme dei rapporti so-ciali3.
Quando il capitale rompe i legami con le vecchie forme di controlloetico dell’azione e delle risorse, e definisce cosí un’autonoma forma di
344
1 Ciò che contraddistingue intimamente il modello di sviluppo capitalistico è l’i-dea liberista secondo cui l’impresa innovatrice si giustifica «di per sé, come apporta-trice di benessere economico», senza che abbia alcun «tributo ulteriore da pagare allasocietà» all’infuori del rispetto delle leggi civili. I valori fondanti dell’attività d’impresadivengono soltanto l’efficienza e il rispetto della legge, «nessun altro fine può essereimposto surrettiziamente all’impresa». Idea questa che si inserisce perfettamente nelquadro ideologico del liberalismo come teoria della «divisione dei poteri e dei ruolisociali»: M. Libertini, Impresa e finalità sociali, in Riv. soc., 2009, p. 6. Cfr. M. Wal-zer, Il liberalismo come arte della separazione (1984), trad. it. in Bibl. libertà, 1986,p. 1 ss.
2 «Capitalist reality is first and last a process of change»: J.A. Shumpeter, Capi-talism, Socialism and Democracy (1942), London, 1976; trad it. in Id., Il capitalismopuò sopravvivere? La distruzione creatrice e il futuro dell’economia globale, Milano,2010.
3 «La borghesia non può esistere senza rivoluzionare di continuo gli strumenti diproduzione, quindi i rapporti di produzione, quindi tutto l’insieme dei rapporti so-ciali. Prima condizione di esistenza di tutte le classi industriali precedenti era invecel’immutata conservazione dell’antico modo di produzione. Il continuo rivoluziona-mento della produzione, l’incessante scuotimento di tutte le condizioni sociali, l’in-certezza e il movimento eterni contraddistinguono l’epoca borghese da tutte le altre»:K. Marx e F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei (1848), trad. it. Il ma-nifesto del partito comunista, Roma, 1973, p. 34.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
controllo normativo dell’agire «economico»4, quest’ultimo si fonda sullamoneta5. Non sul mezzo in sé, ovviamente, ma sull’istituzione mone-taria: sulla natura di capitale del denaro6 e, indirettamente, sulla sua at-titudine a rappresentare l’unica forma di ricchezza astratta7. Quale stru-mento tecnico di semplificazione delle transazioni, la moneta rappre-senta un mezzo di scambio, un ausilio alla soddisfazione dei bisogni.In quanto mezzo «neutrale rispetto ai valori»8, ovvero indifferente neiconfronti dello scopo sotteso al suo impiego, la moneta consente purel’astrazione delle possibilità di scambio disponibili nella società ed illoro accumulo come «capitale» senza alcun riferimento ai bisogni9.
La crisi del modello di sviluppo capitalistico, dove l’impresa inno-vatrice si giustificava di per sé quale motore del benessere economico,segna per la prima volta uno iato tra la natura di ricchezza astrattadella moneta e la sua attitudine a generare nuova ricchezza10. L’inte-
345
4 La generalizzazione del valore monetario sprigiona la mobilità dei ruoli sociali,liberando, in un colpo, il possesso dei beni dal legame a monte con il rango socialee le prerogative politiche dal possesso dei beni. La proprietà privata si atteggia comeun diritto sulla cosa indipendente dai ruoli, nel senso che le strutture chiave (le cosee le attività) dell’agire «economico» cessano di essere, formalmente, un attributo diceto e vengono ridefinite esclusivamente in virtú della loro scarsità: cfr. M. Barcel-lona, Diritto sistema e senso. Lineamenti di una teoria, Torino, 1996, p. 369 s. e N.Luhmann, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Ber-lin, 1999, trad. it. di S. Magnolo, I diritti fondamentali come istituzione, Bari, 2002, pp. 173, 176.
5 Sulla moneta quale disciplina di un potere economico di acquisto, della sua im-putazione e disponibilità M. Semeraro, Pagamento e forme di circolazione della mo-neta, Napoli, 2008, spec. p. 205 ss.
6 La dottrina piú risalente individua nell’obbligazione pecuniaria una obbligazionedi dare cose generiche, con conseguente equiparazione della moneta agli altri beni: G.Scaduto, I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario, Milano, 1924, p. 68 ss.; T.Ascarelli, Obbligazioni pecuniarie, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 167 ss. Pure in queste costruzioni, osserva M. Semeraro, Gli inte-ressi monetari. Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema, Napoli, 2013, p. 22 innota 39, il riconoscimento dell’attitudine della moneta a produrre nuova ricchezza «se-gna tuttavia il passaggio dal concetto di moneta come bene al concetto di monetacome capitale; passaggio che sarebbe determinato dalla vocazione della medesima mo-neta alla circolazione in quanto strumento di pagamento, nonché dalla sua funzionedi accumulo della ricchezza».
7 M. Semeraro, o.c., spec. pp. 11, 22 in nota 39, 136, 140.8 N. Luhmann, Grundrechte als Institution, cit., p. 175.9 In questo modo, costituendosi in quanto specifico «linguaggio» dell’economia,
il denaro rende possibile la costituzione di grandi organizzazioni produttive, affrancai bisogni umani dal fattore temporale e pone le scienze naturali moderne al serviziodella produzione di beni: N. Luhmann, o.c., p. 175 s.
10 Cattura il ruolo svolto dal denaro in economia, che da esclusivo strumento di
Parte III / Sviluppo e habitat civile
resse alla valorizzazione del capitale nei mercati finanziari, infatti, hasclerotizzato il conflitto tra ricchezza assente11 e assenza di ricchezza12:finanziaria la prima; reale ma anche personale e culturale la seconda13.
Pensiamo alla negoziazione in strumenti finanziari derivati14, ma an-che alla deriva da sovra-affidamento sulle forme di trading automa-tico, ai fondi ETF, ai fondi a gestione passiva e agli altri prodotti adindice quotati. L’avversione al rischio ed i limiti strutturali dell’indu-stria dell’investimento nei mercati finanziari ci hanno assuefatti all’ideache i mercati vivono di vita propria, sommando operazioni in modoquasi cibernetico. Il mercato finanziario drena risorse da centri di in-teresse che agiscono senza «guardare dentro la scatola», operano con-tinui aggiustamenti prescindendo dall’oggetto sociale dell’attività fi-
346
scambio diviene ad un certo punto strumento di produzione di nuova ricchezza, M.Semeraro, o.u.c., spec. p. 11: «[i]n origine ci fu la funzione di scambio accanto aquella di tesaurizzazione; punto di partenza e non certo di arrivo del lungo percorsoche conduce sino alle forme di ricchezza attuali. Essa continuò a caratterizzare parti-colarmente il danaro fino alle soglie del XIX secolo; quando cioè, con le prime istanzecapitalistiche, forte si affermò la consapevolezza della sua idoneità a rappresentare ilprincipale strumento di investimento».
11 Sulla funzione di finanziamento – esplicativa del rapporto tra ricchezza presentee ricchezza assente – come caratteristica dei rapporti con funzione finanziaria, nonpuò mancare il riferimento a P. Spada, Introduzione al diritto dei titoli di credito, To-rino, 1994, p. 9 ss.
12 Emblematico dell’intervenuto capovolgimento di rapporto tra economia reale edeconomia finanziaria il confronto con uno scritto piú recente: M. Cossu e P. Spada,Dalla ricchezza assente alla ricchezza inesistente. Divagazioni del giurista sul mercatofinanziario, in Banca borsa tit. cred., 2010, p. 401 ss. ove l’affermazione secondo cui:«i derivati, almeno nella variante “differenziale” su titoli e indici, sono tecniche chepossono bensí propiziare, forse razionalizzare, il mercato della ricchezza assente mache iniettano, comunque, nel mercato finanziario una dose di ricchezza inesistente».Sul rapporto tra mercato finanziario e sistemi di circolazione nonché sulla finanzia-rizzazione dell’economia realizzata attraverso operazioni caratterizzate dalla presenzadel denaro come prestazione esclusiva (iniziale e finale) del rapporto: P. Ferro-Luzzi,Lezioni di diritto bancario, I, Torino, 2004, 122; Id., Il tempo nel diritto degli affari,in Banca borsa tit. cred., 2000, p. 407 ss. e R. Di Raimo, Fisiologia e patologie dellafinanza derivata. Qualificazione giuridica e profili di sistema, in F. Cortese e F. Sar-tori (a cura di), Finanza derivata, mercati e investitori, Pisa, 2010, p. 36 ss.
13 A.K. Sen, Mercati e libertà di scelta e Denaro e valore: etica ed economia dellafinanza, entrambi in Id., La ricchezza della ragione. Denaro, valori, identità, trad. it.,Bologna, 2001, pp. 31 ss. e 53 ss.
14 Non vale addurre, «con abilità dialettica», che se le scommesse sono ammesse,nel nostro ordinamento, allora vanno ammesse anche le negoziazioni dei derivati. Ciòche è investito in derivati è sempre e comunque risparmio, «il risparmio di un paeseo di una collettività incanalato attraverso strumenti finanziari che difettano di merite-volezza, di ragionevolezza e di intrinseca adeguatezza»: P. Perlingieri, Crisi dei mer-cati finanziari e crisi delle imprese, in Riv. dir. impr., 2011, 2, p. 246 s.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
nanziata e non manifestano, nel complesso, una chiara propensione ascegliere nel merito progetti innovativi, sistematicamente discriminatia favore di investimenti a basso impatto e tuttavia piú competitivi.
Nel mondo in bianco e nero, le vere «avventure» tagliate fuori dalmercato del capitale finanziario sono principalmente i progetti inno-vativi, in quanto caratterizzati dal divario iniziale tra valore sociale del-l’attività e flussi finanziari. Programmi di riabilitazione di ex detenutie tossicodipendenti. Offerta di cure accessibili a favore di categoriesvantaggiate. Reinserimento dei lavoratori esclusi dal tessuto produt-tivo. Mentre l’impatto sociale in caso di successo del progetto è con-siderevole – come considerevole è pure il rischio di insuccesso – il co-sto iniziale del finanziamento può superare facilmente i guadagni at-tesi.
2. La disciplina del finanziamento coglie l’essenza dell’organizza-zione dell’impresa anche sul versante della natura dei «soggetti», me-glio della disciplina delle modalità tecniche di organizzazione dei po-teri dispositivi e di imputazione in funzione dell’esercizio dell’attività15.
Lo specchio fedele dell’antagonismo tra forme di valorizzazione delcapitale diviene qui perfetta immedesimazione tra idealità dello scopoe assenza di lucro soggettivo16. Questa immedesimazione17 ha costi-tuito per lungo tempo l’assioma fondamentale rispetto alla disciplina,
347
15 L’impostazione seguita è espressa compiutamente in R. Di Raimo, Impresa, pro-fitto e categorie dello spirito, in Riv. dir. impr., 2011, 3, p. 603 ss.
16 Sulla distinzione tra lucro soggettivo e oggettivo e sul modo in cui essa è stataampiamente utilizzata dalla dottrina v. le riflessioni significative di R. Costi, Fonda-zione e impresa, in Riv. dir. civ., 1968, I, 1, p. 1 ss. e G. Marasà, Le “società” senzascopo di lucro, Milano, 1984, spec. pp. 76 ss., 165 ss. Sulla lucratività in senso pro-prio, intesa quale specifica destinazione dei risultati dell’attività alla sfera individualedell’«imprenditore», v. l’importante analisi di D. Preite, La destinazione dei risultatinei contratti associativi, Milano, 1988, spec. 322 ss.
17 «Domandarsi infatti quale sia il confine tra lucro e idealità guardando esclusi-vamente alla ripartibilità dell’eventuale avanzo patrimoniale vale in fin dei conti a esclu-dere – in una prospettiva strettamente patrimonialistica – il rilievo della incidenza nonpatrimoniale dello scopo ideale; vale a escludere il rilievo normativo del principio fon-damentale espresso dall’art. 2 cost.»: R. Di Raimo, Date a Cesare (soltanto) quel cheè di Cesare. Il valore affermativo dello scopo ideale e i tre volti della solidarietà co-stituzionale, in Rass. dir. civ., 2014, 4, p. 1087; cfr. Id., Le associazioni non ricono-sciute, cit., p. 119 ss. In merito al disegno del costituente relativo al sistema di libertàcollettive ed alla scelta di fissarne l’epicentro nell’art. 2 cost.: P. Perlingieri e R. DiRaimo, Sub artt. 18, 19 e 21, in P. Perlingieri, Commento alla Costituzione italiana,2a ed., Napoli, 1997, p. 98 ss.; nonché, con riferimento all’unitarietà del valore espressonell’art. 2 cost., v. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondoil sistema italo-comunitario delle fonti, 3a ed., Napoli, 2006, p. 433 ss.
Parte III / Sviluppo e habitat civile
con rilievo essenzialmente esterno, della destinazione del patrimonio edella relativa attività economica, traducendosi nella perfetta incomuni-cabilità tra i modelli del libro I e quelli del libro V18.
Nonostante i mutamenti intervenuti nel contesto socio-economicoche faceva da sfondo all’attività esercitata dagli enti del libro I19, la di-stanza tra enti lucrativi ed enti con finalità ideale è aumentata coltempo, anziché diminuire. Con riguardo alle società, infatti, si è rea-lizzata una progressiva «emancipazione dall’idea del “soggetto giuri-dico” come persona»20, laddove, con riguardo all’esercizio dell’impresada parte degli enti, «curiosamente è successo il contrario»21 rafforzan-dosi l’idea dell’ente come persona, come tale caratterizzata da «capa-cità» e «separata chirurgicamente dall’attività che esercita»22.
348
18 Enti lucrativi quindi, da una parte, ed enti con finalità ideale dall’altra. La ca-tegoria dello scopo di lucro risulta costruita a partire da una visione pan-patrimonia-listica della produzione di beni e servizi mai tradotta in scelta ordinamentale. Il su-peramento della concezione patrimonialistica del diritto civile si trova condensata, nellasua duplice veste di istanza culturale e di indirizzo ermeneutico imposto dalla Costi-tuzione, nelle pagine sempre attualissime di P. Perlingieri, Depatrimonializzazionee diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, p. 1 ss. e C. Donisi, Verso la “depatrimonia-lizzazione” del diritto privato, in Rass. dir. civ., 1980, p. 644 ss. Questa visione sem-bra destinata ad essere ulteriormente smentita dalla progressiva transizione verso formedi investimento collettivo che implementano nel surplus la misurazione delle ricadutesociali dell’attività. Se ciò è vero rispetto alla disciplina, con rilievo essenzialmenteesterno, della destinazione del patrimonio e della relativa attività economica, non vatrascurato poi che la denunciata immedesimazione tra idealità ed assenza di lucro sog-gettivo finisce per oscurare completamente il fondamento funzionale della disciplina,con rilievo essenzialmente interno, dell’attività nella quale sia rilevante l’interesse idealepartecipativo piuttosto che l’interesse ad un risultato da intendersi come «saldo» fi-nale dell’attività: sul punto v. F. Di Sabato, La nozione di impresa nell’ambito delleorganizzazioni non profit, in Riv. dir. impr., 2002, 51 ss.; M. D’Ambrosio, Parteci-pazione e attività. Contributo allo studio delle associazioni, Napoli, 2012, pp. 11 ss.,41 ss.
19 Le regole del libro I del codice sono state concepite dal legislatore del 1942 inragione di attività profondamente diverse da quelle esercitate oggi dagli enti non pro-fit: in questo senso v. R. Di Raimo, Le associazioni non riconosciute. Funzione, disci-plina, attività, Napoli, 1996, pp. 131 ss., 143 ss. e 253 ss.; Id., «Soggetto» e attivitàd’impresa nella disciplina degli enti del libro I del codice civile, in R. Raimo, M. Fran-cesca e A.C. Nazzaro (a cura di), Percorsi di diritto civile. Studi 2009/2011, Napoli,2011, p. 11 ss.
20 R. Di Raimo, o.u.c., p. 12 s.21 R. Di Raimo, o.l.u.c.22 R. Di Raimo, o.l.u.c. I modelli del libro I e quelli del libro V faticano a co-
municare in quanto costruiti sulla base di schemi diversi: «non è detto che una co-struzione sia giusta e l’altra sia sbagliata», piuttosto si tratta di individuare «un po-stulato unitario per riuscire a realizzare la comunicazione tra i due sistemi».
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
Lo stesso decreto sull’impresa sociale23, seppure ha fornito spuntiimportanti sul piano teorico-sistematico, ha soprattutto perso l’oppor-tunità di fare chiarezza intorno alla natura degli strumenti di finan-ziamento interno ed esterno ed all’individuazione degli interessi chene giustificano l’erogazione.
Il risultato oggi è sotto gli occhi di tutti: un quadro frastagliato,difficile da governare, fatto di una messe di discipline speciali moltedelle quali dettate con prevalente finalità di agevolazione sul piano fi-scale. Al suo interno la meritevolezza dei fini sociali perseguiti dal-l’ente incide sempre dall’esterno sulla disciplina applicabile al rapportodi finanziamento, senza alterarne la funzione avuto riguardo all’inte-resse del finanziatore. La qualificazione, in altre parole, si arresta allastruttura del potere di esercizio della situazione giuridica del finanzia-tore: finanziamento a titolo di capitale (equity) e finanziamento a ti-tolo di debito (debt)24. Il primo sempre escluso, il secondo ammessoentro precisi limiti di remuneratività oltre i quali si ricade nella distri-buzione indiretta (art. 3, comma 2, d.lg., 24 marzo 2006, n. 155). Strut-tura del potere del finanziatore e non lucratività compongono il pre-supposto necessario, ancorché non sufficiente, per l’applicazione di unregime «esterno» – collegato alle specifiche aree di intervento indivi-duate dalla legge – imperniato, in ultima analisi, sulla fiscalità di fa-vore e sul credito agevolato pubblico25.
3. Nel XIX secolo la leva tributaria è stata la grande protagonistadel finanziamento della gratuità dei servizi pubblici. Nella fase suc-cessiva essa ha trovato rinnovata conferma nelle politiche di incentivoall’«intervento sussidiario dei privati nel campo della tutela dei diritti
349
23 Un’ampia panoramica di temi e problemi in M.V. De Giorgi (a cura di), Lanuova disciplina dell’impresa sociale. Commentario al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155,in Nuove legg. civ. comm., 2007, p. 418 ss.
24 In merito alle distinzioni, tanto consolidate quanto discusse, tra «capitale di ri-schio» e «capitale di debito» e tra finanziamento al soggetto e finanziamento all’atti-vità cfr., tra molti, G.F. Campobasso, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, To-rino, 2002, p. 7; G.B. Portale, I «beni» iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tuteladei creditori nella società per azioni, in Riv. soc., 1969, p. 267.
25 È questo un modo di guardare al Terzo settore dell’economia che la miglioredottrina considerava di retroguardia, sotto il profilo concettuale, già al tempo in cuiil legislatore mise mani alla materia: R. Di Raimo, Postulati logici e soggettività deglienti che esercitano l’impresa, in Atti S.I.S.Di.C., Il diritto civile oggi. Compiti scienti-fici e didattici del civilista, Napoli, 2006, p. 330 ss. e Id., L’impresa non lucrativa, Attidel seminario di Benevento del 25 settembre 2007. Introduzione, in Riv. dir. impr.,2007, 3, p. 437 ss.
Parte III / Sviluppo e habitat civile
sociali in coppia con il limite dell’assenza dello scopo lucrativo»26: iltutto nel tentativo di riprodurre l’intervento pubblico di welfare. Nel-l’attuale congiuntura siamo ad un punto di svolta, c’è bisogno di in-dividuare un «nuovo punto di partenza»27. Posto che l’intervento sus-sidiario dei privati trova fondamento in leve egoistiche, il problema èscegliere tra queste «le piú efficaci a garantire una stabilità dell’offertadi solidarietà, senza soluzioni etiche preconcette»28.
Gli esperimenti volti ad istituire una sorta di finanza privata per ilTerzo settore dell’economia29 non sono mancati, a dire il vero, nean-che nel nostro sistema. Tuttavia questi esperimenti, sporadici e disor-ganici, sono rimasti imbrigliati entro il vecchio modello del finanzia-mento al «soggetto non-profit» basato in gran parte sulla leva fiscale.
I titoli di solidarietà destinati al finanziamento delle ONLUS (art.29 d.lg., 4 dicembre 1997, n. 460) rappresentano l’esemplare piú avan-zato – volendo usare un’espressione impropria – di finanza alternativadi vecchia generazione. Emittenti sono le banche e gli intermediari au-torizzati30, che possono dedurre dal reddito d’impresa il differenziale
350
26 M. Francesca, La rilevanza dei fatti di sentimento nel diritto privato: associa-zionismo, terzo settore e tutela dei diritti sociali, in R. Raimo, M. Francesca e A.C.Nazzaro (a cura di), Percorsi di diritto civile, cit., p. 55.
27 M. Francesca, o.l.c.28 M. Francesca, o.l.c.29 Sul passaggio dalla prestazione solidaristica alla solidarietà organizzata, cioè al-
l’organizzazione di attività solidaristiche orientate verso l’esterno e gestite in formad’impresa nella prospettiva del c.d. Terzo settore dell’economia v. A. Fusaro, L’asso-ciazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche, Padova, 1991, p.109 ss.; A. Zoppini, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, 1995, pp. 13ss., 184 ss.; R. Di Raimo, Le associazioni non riconosciute, cit., pp. 191 ss., 274 ss., alquale ultimo si rimanda per gli opportuni riferimenti al dibattito, che permane moltosignificativo, nella dottrina anglosassone e statunitense degli ultimi due decenni delloscorso secolo. «Molto cambia, però» – scrive M. Francesca, o.c., pp. 43 s. e 45 –«quando la medesima assistenza è oggetto di attività organizzata in funzione di unasolidarietà riconosciuta e promossa sul piano generale». Quando la solidarietà è og-getto di un rapporto con rilievo meramente interno, il fine solidaristico riconosciutoall’atto nel suo complesso può attraversare l’interesse egoistico patrimoniale di unadelle parti contrattuali, «senza con ciò subirne ridimensionamento alcuno». Quandola medesima assistenza è oggetto di attività organizzata «in funzione di una solida-rietà riconosciuta e promossa sul piano generale», «la solidarietà come valore giuri-dico razionale dell’ordinamento» raggiunge i luoghi di promozione del suddetto va-lore attraverso la «costruzione di discipline premiali ad hoc, tese a favorirne la strut-turazione sul piano macroeconomico».
30 A fronte di erogazioni effettuate da «risparmiatori “sotto-remunerati”» e «pre-via assunzione da parte dell’intermediario di un vincolo di destinazione a favore diorganizzazioni di utilità sociale»: un fugace tentativo di inquadramento in C. RabittiBedogni, Patrimoni dedicati, in Riv. not., 2002, 5, p. 1125.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
tra il tasso praticato all’emissione e il tasso di riferimento stabilito dallalegge. Il meccanismo, nella sostanza, è semplice e perverso: piú bassoè il tasso di remunerazione per l’investitore, tanto piú alto sarà il van-taggio fiscale in capo agli emittenti. E – la speranza è questa – tantopiú basso sarà il costo del credito per le ONLUS beneficiarie.
Prima di tutto: perché l’investitore dovrebbe «accontentarsi» di untasso notevolmente inferiore a quello di mercato? L’investitore rinun-cia al profitto in ragione della gratificazione che gli deriva dal fatto disostenere genericamente un’attività gestita in forma solidaristica.
Seconda osservazione. L’interesse alla destinazione del finanziamentoqui è generico, non specifico. Le modalità con le quali il finanziatoreha riversato sul Terzo settore i benefici fiscali ricevuti sono oggetto divigilanza amministrativa. Al sottoscrittore, invece, non è attribuito al-cun potere di selezionare l’oggetto sociale da finanziare, e neppure lesingole ONLUS beneficiarie.
Per finire l’aspetto piú importante. La struttura del titolo è quelladello strumento di debito: la sua retributività non dipende in via di-retta dall’andamento dell’attività finanziata. Il sottoscrittore ci guada-gna, molto poco presumo, ma a prescindere dal fatto che la ONLUSriesca effettivamente a produrre un risultato sociale positivo, misura-bile ex post secondo parametri oggettivi.
Insomma, ci troviamo ancóra al cospetto di una mera variante, ocombinazione strutturale, del vecchio doppio canale articolato nelle do-nazioni private e nelle agevolazioni fiscali. Un modello alquanto in-gessato, che ha esercitato un fattore di rallentamento intrinseco sul-l’innovazione sociale31 vuoi ostacolando di fatto un’adeguata pianifica-zione dell’attività, vuoi deresponsabilizzando il Terzo settore rispettoall’effettivo raggiungimento degli obiettivi istituzionali32.
351
31 L’espressione innovazione sociale indica lo sviluppo di idee che mirano alla ri-soluzione di problematiche sociali, economiche ed ambientali tramite l’utilizzo di so-luzioni «alternative»: R. Randazzo, Finanza ed innovazione sociale: un nuovo glos-sario, in Enti non profit, 2012, 1, p. 47. Nella prospettiva dei nuovi modelli econo-mici, basati sulla capacità degli strumenti privati di investimento di intercettare flussifinanziari alternativi alla spesa pubblica da destinare ai servizi di pubblica utilità, cfr.S. Goldsmith, The Power of Social Innovation: How Civic Entrepreneurs IgniteCommunity Networks for Good, San Francisco, 2010.
32 Per le imprese sociali il costo e i vincoli finanziari collegati all’indebitamentobancario sono piú alti rispetto alle imprese tradizionali, e ciò soprattutto a causa dellaminore diversificazione dei canali di finanziamento. Sul rovescio, il sistema basato pre-valentemente sui grant e sulle agevolazioni pubbliche non consente di attuare previ-sioni a medio-lungo termine dei flussi di cassa, impedendo un’adeguata pianificazionedell’attività, oltre a deresponsabilizzare l’ente rispetto ai princípi di sana gestione e al
Parte III / Sviluppo e habitat civile
Fatto sta che il vecchio modello adesso è in debito di ossigeno,mentre la contrazione della spesa pubblica ha ferito gravemente l’or-ganizzazione dei servizi di utilità sociale basata sulla leva fiscale. Nonè un caso che l’Unione europea, a partire dal Single Market Act I, ab-bia espressamente individuato una delle dodici leve per uscire dallacrisi nelle politiche di sostegno al social entrepreneurship, e segnata-mente in un quadro normativo che garantisca lo sviluppo dei fondi diinvestimento solidali. E neppure è un caso che buona parte dei tenta-tivi di elaborare autonomamente una via d’uscita dalla crisi della fi-nanza pubblica – messi in atto tanto dal settore pubblico quanto daquello privato – facciano leva su operazioni finanziarie opportuna-mente strutturate per diversificare le fonti di finanziamento attraversofenomeni di investimento collettivo c.dd. ad impatto sociale33, moltidei quali sono in attesa di opportuna regolazione per ciò che concernei profili relativi alla gestione e alla responsabilità.
4. Ci troviamo perciò sull’onda di una nuova transizione. Quellache porta dal finanziamento al «soggetto» (non-profit), articolato sucombinazioni di liberalità privata ed incentivazione fiscale, ad un’au-tonoma categoria di attività finanziarie con funzione di investimentonel progetto sociale.
Praticamente alla vigilia della crisi questo passaggio è stato prepa-rato dall’introduzione nel TUF e nel Regolamento Intermediari Con-sob della disciplina sulla promozione dei prodotti e servizi qualificaticome «etici» o «socialmente responsabili» (art. 117 ter TUF, artt. 89-90 reg. Consob, 29 ottobre 2007, n. 16190). Gli obblighi di informa-zione e rendicontazione previsti coprono gli obiettivi sociali e i criteridi selezione degli strumenti finanziari in relazione ad essi, nonché laquota dei proventi destinata ad iniziative di carattere sociale.
Nel frattempo il Mondo è cambiato assai velocemente. E le tappedi questa transizione si fanno sempre piú serrate: social impact bond34,
352
raggiungimento degli obbiettivi sociali prefissati. Al riguardo: G. Bosi, Modelli di au-toregolazione dell’impresa sociale, in Giur. comm., 2012, p. 145 ss.
33 A. Bugg Levine e J. Emerson, Impact Investing, San Francisco, 2011; A. Bugg-Levine, B. Kogut e N. Kulatikala, A New Approach to Funding Social Enterpri-ses, in 78 Harvard Bus. Rev., 2012, p. 3 ss.
34 R. Randazzo, Social Impact Bond: un nuovo strumento per la finanza sociale,in Enti non profit, 2011, 7, p. 38 ss.; A. Bugg-Levine, B. Kogut e N. Kulatikala,A New Approach to Funding Social Enterprises, cit., p. 5. Sullo studio dei profili dipublic policy è incentrata invece l’attività, non solamente scientifica, del Social ImpactBond Technical Assistance Lab della Harvard Kennedy School of Government. Il SIBLab di Harvard, cofinanziato dalla Rockfeller Foundation, rappresenta il piú avanzato
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
fondi d’investimento ad impatto sociale (EuSEF) e social crowd-fun-ding. I nuovi modelli economici preludono chiaramente all’abbandonodella qualificazione pan-patrimonialistica delle forme di finanziamentodell’attività d’impresa in favore di strumenti di investimento collettivostrutturati in ragione di un rendimento «misto», composto dall’abbi-namento funzionale di benefici sociali e profitti finanziari35.
Il nodo da sciogliere è sempre il medesimo: colmare il divario traelevato potenziale innovativo dell’attività e bassa competitività espressadal rapporto rischio-rendimento36. Il beneficio sociale, come detto, èconsiderevole, mentre il rischio di perdere l’intero capitale non è con-trobilanciato da un ritorno sufficiente a rendere l’investimento appeti-bile sul mercato della ricchezza assente.
Questo il problema. Quelle che differiscono sono le tecniche di ap-proccio.
Nella disciplina della raccolta di capitale di rischio tramite portaleon-line da parte di start-up innovative37, incluse quelle c.dd. a voca-
353
esperimento di pianificazione di investimenti nel settore dei servizi sociali, condottomediante offerta alle autorità governative U.S. di assistenza gratuita per la realizza-zione di operazioni finanziarie del tipo pay for success. Per lo stato di avanzamentodel progetto di ricerca ed i principali risultati applicativi v. J. Liebman e A. Sellman,Social Impact Bonds. A Guide for State and Local Governments, Harvard KennedySchool Social Impact Bond Technical Assis tance Lab, 2013, in hks-siblab.org.; H. Aze-mati, M. Belinsky, R. Gillette, J. Liebman, A. Sellman e A. Wyse, Social ImpactBonds: Lessons Learned So Far, in Comm. Development Invest. Rev., 2013, 9, p. 21 ss.
35 Di un vero e proprio «business dei rendimenti misti» discorrono A. Bugg-Le-vine, B. Kogut e N. Kulatikala, o.c., p. 3 s.
36 Gli strumenti finanziari, in questo settore, debbono essere strutturati al fine ditrasformare in valore il divario inevitabile tra rendimento finanziario e benefici socialidell’attività («il valore sociale di offrire ai meno abbienti cure sanitarie accessibili ènotevole, mentre il costo del finanziamento privato può facilmente superare i guada-gni attesi»). Il nodo da superare è dunque quello che riguarda la capacità delle im-prese sociali di offrire introiti sufficienti ad indurre i risparmiatori ad effettuare inve-stimenti adeguati «non soltanto per la copertura delle spese, ma anche per lo sviluppoulteriore delle attività istituzionali»: A. Bugg-Levine, B. Kogut e N. Kulatikala,A New Approach to Funding Social Enterprises, cit., p. 4.
37 La disciplina delle start-up innovative è stata introdotta nel nostro ordinamentocon il d.lg., 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Sviluppo bis). L’iniziativa si collocanell’àmbito della strategia per la crescita «Europa 2020», come risposta alla racco-mandazione della Commissione U.E. di attuare politiche di lotta alla disoccupazionegiovanile e di facilitazione all’accesso al credito per le imprese che investono nell’in-novazione. La start-up configura un nuovo modello societario caratterizzato dalla fortepropensione a sviluppare prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente miglioratirispetto allo stato dell’arte nel settore interessato, ciò che si riflette principalmente nelleregole relative alla composizione della compagine sociale (art. 25, comma 2, lett. a),nel divieto temporaneo di dividere utili tra i soci (lett. e) e nell’oggetto sociale esclu-
Parte III / Sviluppo e habitat civile
zione sociale38, il divario è accorciato attraverso una polverizzazionedel rischio, finalizzata a raccogliere il capitale dagli investitori non pro-fessionali, solitamente meno avvezzi ad assumere il rischio di default.
In sintesi: la start-up che intende raccogliere capitali di rischio at-traverso un portale predispone, in conformità all’allegato 3 del Rego-lamento Consob, 26 giugno 2013, n. 18592, una sorta di prospettoinformativo estremamente semplificato, recante le informazioni relativealla singola offerta che il gestore del portale prescelto pubblica sul sito(art. 16 reg. Consob n. 18592/2013). Il documento contiene una de-scrizione dell’emittente, del progetto industriale (con indicazione delsettore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione so-ciale) e del relativo business plan; una descrizione degli organi socialie del curriculum vitae degli amministratori, nonché degli strumenti fi-nanziari oggetto dell’offerta. I crowd-funders che «entrano» nel por-tale, prima di accedere alle sezioni in cui è possibile aderire alle sin-gole offerte, prendono visione delle informazioni di investor educatione di quelle relative all’investimento in start-up innovative, rispondonoad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratte-ristiche essenziali e dei principali rischi connessi a questa tipologia diinvestimento e dichiarano di essere in grado di sostenere economica-mente l’intera perdita del capitale investito (art. 15 reg. Consob n.
354
sivo o prevalente dato dallo sviluppo, dalla produzione ovvero dalla commercializza-zione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (lett. f). Inoltre lastart-up deve possedere almeno uno degli ulteriori requisiti che esprimono la pro-pensione all’innovazione previsti dall’art. 25, comma 2, lett. h, ovvero: i) le spese inricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 20% del maggior valore fra co-sto e valore totale della produzione della start-up innovativa; ii) devono essere im-piegati soggetti che abbiano conseguito un dottorato di ricerca, ovvero siano in pro-cinto di conseguirlo, ovvero negli ultimi tre anni abbiano effettuato, dopo aver con-seguito una laurea specialistica, un periodo di ricerca presso istituti di ricerca, pub-blici o privati, situati in Italia o all’estero; iii) deve essere titolare ovvero licenziatariadi almeno una privativa industriale, relativa ad un’invenzione industriale, biotecnolo-gica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale di-rettamente afferenti l’oggetto sociale e l’attività d’impresa.
38 Quella prevista dell’art. 25, comma 4, d.lg. n. 179 del 2012 è un’ulteriore tipo-logia di start-up che possiede tutti i requisiti elencati nella nota precedente, ma operain via esclusiva «nei settori indicati all’articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24marzo 2006 n. 155». Ammettendo, implicitamente, che obbiettivi di interesse collet-tivo possano essere perseguiti anche tramite veicoli societari, a vocazione sociale (cfr.R. Randazzo, G. Taffari e P. Pellini, Le start-up innovative a vocazione sociale,cit., p. 6), l’intervento rappresenta un significativo passo verso il superamento della ri-gida dicotomia for profit/non profit ed un’apertura verso modelli che guardano agliimpatti economico-sociali generati dall’attività anziché alla natura giuridica del «sog-getto» che la esercita.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
18592/2013). Una volta inoltrati, gli ordini di sottoscrizione e acqui-sto di strumenti finanziari sono trattati e registrati dal gestore del por-tale, quindi da questo trasmessi alle banche e/o alle imprese di inve-stimento incaricate di curarne il perfezionamento (art. 17) e presso lequali è costituita una provvista in un conto indisponibile acceso perciascuna offerta ed intestato all’emittente. Periodicamente il gestore for-nisce le informazioni sullo stato delle adesioni, l’ammontare sottoscrittoed il numero di aderenti. Al momento del perfezionamento dell’of-ferta la provvista viene trasferita all’emittente ed i titoli sottoscritti sonoattribuiti all’investitore. Nel caso in cui l’offerta non si perfezioni ifondi relativi alla provvista necessaria al perfezionamento degli ordinidi adesione tornano nella piena disponibilità degli investitori (art. 25,comma 3, reg. Consob n. 18592/2013).
La filosofia dell’equity-based crowdfunding è semplice, ma non per-versa: un progetto, un piccolo investimento, molti investitori39. Tutta-via, per le ragioni che si diranno a breve, né l’attività di gestione delportale, né le modalità tecniche dell’offerta di capitale per progetti so-ciali rientrano nel fenomeno dell’impact investing propriamente inteso.
In via incidentale, vale la pena di sottolineare fin da subito la pre-senza di alcune forzature rimarchevoli nello schema disciplinare delRegolamento. È una forzatura l’assoggettamento del gestore di portale– che non è un fornitore di servizi di investimento – ad obblighi ditrasparenza, informazione e, addirittura, di protezione degli investitori(artt. 13-17 reg. Consob n. 18592/2013) chiaramente sovrabbondanti
355
39 Il finanziamento collettivo è attuato mediante raccolta di investimenti indivi-duali, per lo piú di modesta entità, provenienti dai c.dd. crowdfunders, i quali pos-sono avere interesse a cooperare alla realizzazione del progetto per spirito impren-ditoriale, semplice apprezzamento o attitudine solidaristica. Secondo il comune av-viso la prevalente partecipazione di investitori non professionali ed il mezzo impie-gato per la raccolta, vale a dire il ricorso al web mediante piattaforme in cui si ve-rifica, con modalità agili ed a costi contenuti, l’incontro tra la domanda e l’offertadi capitale, valgono a differenziare il fenomeno dai canali tradizionali, dal venturecapital e dai cosiddetti business angels. In argomento v. A. Bollettinari, Il crowd-funding: la raccolta del capitale tramite piattaforme on-line nella prassi e nella re-cente legislazione, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2013, 2, p. 12 ss.; P. Alvisi,Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico, in Riv. dir. banc., 2014, 3, p. 1ss.; I. Capelli, Brevissime considerazioni sull’equity based crowdfunding, in Riv.dir. banc., 2014, 3, p. 1 ss.; G. Gagliardi e A. Tonella, Crowdfunding: una nuovafrontiera per la raccolta di capitali, in Amm. e finanza, 2013, 11, p. 51 ss.; G. Nun-ziante, Il «Crowdfunding», in dirittocancario.it., agosto 2013, p. 1 ss.; M. Pinto,L’equity based crowdfunding in Italia al di fuori delle fattispecie regolate dal “De-creto Crescita”, in Le Società, 2013, p. 818 ss.; E. Girino, Le regole del crowdfun-ding, in Amm. e finanza, 2014, 1, p. 81.
Parte III / Sviluppo e habitat civile
rispetto alla sua stessa vocazione operativa40. Ed una forzatura lo è an-cor di piú la scelta, operata a monte dal legislatore (art. 100 ter TUF),di subordinare il perfezionamento dell’offerta all’avvenuta sottoscri-zione di una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari of-ferti da parte di investitori professionali o di fondazioni bancarie (art.24, comma 2, reg. Consob n. 18592/2013). La previsione di una so-glia minima di partecipazione si direbbe volta a garantire che le soleiniziative considerate «meritevoli» da parte degli investitori professio-nali possano costituire oggetto di raccolta di capitale di rischio nelleforme disciplinate dal Regolamento41. Che questo meccanismo rap-presenti, nelle intenzioni del legislatore, una sorta di «certificazione»della bontà del progetto ad opera di soggetti muniti della necessariaesperienza nella valutazione delle idee imprenditoriali è quantomenocontrovertibile42, tanto piú se si pone mente al fatto che nulla impe-disce al soggetto sponsor di dismettere la partecipazione acquistata unavolta avvenuto il consolidamento dell’offerta. Certo è, invece, che neifatti la soglia di sbarramento contenuta nella disciplina applicabile alleofferte si tradurrà facilmente in una barriera alla diffusione del crowd-funding43 ed in uno snaturamento della sua funzione socio-economica,che dovrebbe avere di mira l’emancipazione delle start-up innovativedalle pesanti limitazioni imposte dal sistema bancario e finanziario tra-dizionale44.
Nei fondi europei per l’imprenditoria sociale, recentemente disci-plinati dal reg. UE, 17 aprile 2013, n. 346, assistiamo invece ad unadiversificazione del rischio. Diversificazione che, rispetto agli organi-smi di investimento collettivo tradizionali, è stabilita anche in ragionedel valore sociale dell’attività finanziata.
Le regole di composizione del portafoglio dicono che il gestore di
356
40 E. Girino, o.c., p. 81.41 Per tutti v. I. Capelli, Brevissime considerazioni, cit., p. 4 s., secondo cui la
norma pone uno strumento di tutela indiretta degli investitori non qualificati, ritenuti«per definizione» non in grado di effettuare valutazioni sui progetti presentati sul por-tale.
42 Dubbi sono manifestati da parte di G. Nunziante, Il «Crowdfunding», p. 5. 43 In un periodo di credit crunch le istituzioni bancarie, già restie alla concessione
di credito ordinario, assai difficilmente saranno disponibili ad investire in progetti abassa marginalità: in questi termini E. Girino, Le regole del crowdfunding, cit., p. 91.
44 Di «colpo fatale» inferto alla raccolta di capitale di rischio tramite portali, primache il fenomeno abbia avuto il tempo di affermarsi nel nostro Paese, parla G. Nun-ziante, Il “Crowdfunding”, cit., p. 9, secondo il quale le banche e le imprese di in-vestimento – «specie di questi tempi» – non sono affatto i soggetti in grado di valu-tare questo genere di iniziative, «spesso “visionarie” e con una forte componente dirischio di insuccesso».
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale che intende raccoglierecapitali utilizzando la denominazione «EuSEF»45 ha l’obbligo di inve-stire almeno il 70% del capitale sottoscritto nelle «imprese di por-tafoglio ammissibili» (c.dd. imprese target). Ossia in «imprese sociali»46
che, oltre a non essere ammesse alla negoziazione su un mercato re-golamentato, si prefiggono come obiettivo «primario» il raggiungi-mento di «impatti sociali positivi misurabili»47 e utilizzano «priorita-riamente» gli utili per raggiungere l’obiettivo sociale conformemente
357
45 All’interno del regime AIFMD i Regolamenti nn. 345 e 346 del 2013 ritaglianouna disciplina speciale, armonizzata a livello comunitario, sui gestori di talune speci-fiche tipologie di OICR alternativi, identificati in ragione degli specifici limiti di in-vestimento e delle modalità gestionali ammissibili. In particolare, i menzionati regola-menti concernono i gestori dei fondi europei di venture capital («EUVECA») e deifondi europei per l’imprenditoria sociale («EUSEF»), prevedendo un regime agevo-lato al fine di favorire gli investimenti transfrontalieri in PMI europee di nuova co-stituzione, ovvero impegnate in attività a sfondo sociale. Tali provvedimenti norma-tivi si applicano ai gestori alternativi «sotto-soglia» che intendono fruire, a séguito diapposita registrazione presso lo Stato membro «home», del passaporto comunitario edella denominazione EUVECA ed EUSEF laddove rispettino determinate condizioni,tra cui figurano gli specifici limiti di investimento e di composizione del patrimoniodegli OICR gestiti. La registrazione è subordinata al soddisfacimento di requisiti ono-rabilità e professionalità di coloro che svolgeranno l’attività di gestione e alla predi-sposizione di idonee misure atte a garantire il rispetto delle disposizioni riguardanti irequisiti organizzativi, i fondi propri, le procedure di valorizzazione degli asset, il ri-spetto delle regole di condotta e l’identificazione e gestione dei conflitti di interesse.Il gestore deve inoltre informare l’autorità di origine in merito ai fondi che intendecommercializzare e/o stabilire sotto la denominazione EUVECA ed EUSEF, specifi-candone tra l’altro, le strategie d’investimento.
46 Tali sono le imprese che forniscono servizi o merci a persone vulnerabili, emar-ginate, svantaggiate o escluse, come l’accesso ad alloggi abitativi, l’assistenza sanitaria,l’assistenza per persone anziane o disabili, l’assistenza ai bambini, l’accesso al lavoroe alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate parimenti so-ciali le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi che «in-corpora il loro obbiettivo sociale», ancorché la loro attività esuli dall’àmbito della for-nitura di merci o servizi intrinsecamente sociali: ad esempio, l’integrazione sociale eprofessionale per mezzo dell’accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate,in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionaliche determinano l’esclusione o l’emarginazione; oppure la tutela dell’ambiente, la lottaall’inquinamento, il riciclaggio e le energie rinnovabili (cfr. considerando 13 e 14 reg.UE n. 346/2013). Infine sono sociali le imprese che forniscono sostegno finanziarioesclusivamente alle imprese che rientrano in queste categorie (art. 3, comma 1, lett. d,punto ii).
47 A titolo esemplificativo, tra gli impatti sociali positivi rientrano la fornitura diservizi agli immigrati che sono altrimenti esclusi, o il reinserimento di gruppi emar-ginati nel mercato del lavoro, garantendo occupazione, formazione o altro sostegno(cfr. considerando 13 reg. UE n. 346/2013).
Parte III / Sviluppo e habitat civile
all’atto costitutivo, allo statuto o ai regolamenti interni che governanol’esercizio dell’attività (art. 3, comma 1, lett. b, d reg. 346 del 2013).La necessaria flessibilità nel portafoglio d’investimenti del fondo è as-sicurata dal restante 30% dell’ammontare complessivo dei conferimentidi capitale e del capitale sottoscritto non richiamato, potendo questoessere investito per l’acquisizione di attività che non siano investimentiammissibili, quindi per finalità anche speculative e di copertura (art. 5,comma 1, reg. 346 del 2013).
È appena il caso di sottolineare che, diversamente dalle nostre re-gole di settore che proibiscono alle organizzazioni non-profit di di-stribuire direttamente o indirettamente gli utili (art. 10, lett. d, d.lg. 4dicembre 1997, n. 469; art. 3 d.lg., 24 marzo 2006, n. 155), nell’im-pianto normativo comunitario gli attori dell’economia sociale che agi-scono erogando beni e servizi per il mercato devono utilizzare gli utili«principalmente» a fini sociali. La disciplina europea ammette cioè ladistribuzione ad azionisti e soci da parte delle imprese (sociali) di por-tafoglio ammissibili, a condizione che i regolamenti o l’atto costitutivodell’ente predeterminino le «circostanze eccezionali» in cui i profittipossono essere distribuiti al fine di garantire che la distribuzione diutili non pregiudichi l’obbiettivo primario (art. 3, comma 1, lett. d,punto iii).
Giungiamo infine al social impact bond, il prototipo dell’investi-mento «impact first». Nel social impact bond l’impatto sociale dell’at-tività finanziata ridefinisce dall’interno la dinamica investimento-risul-tato, con particolare riferimento al profilo funzionale descrittivo del-l’interesse posto al centro della situazione giuridica del finanziatore.Nella sua struttura piú consolidata48, il SIB costituisce un nuovo stru-mento finanziario mediante il quale investitori privati forniscono aduna organizzazione non-profit il capitale di upfront necessario per ilperseguimento di determinati obbiettivi sociali (misurabili) di naturapreventiva. Contestualmente, la P.A. interessata al programma si im-pegna a remunerare gli investitori con una parte dei risparmi generatiper le casse pubbliche in caso di conseguimento degli obbiettivi so-ciali.
Il ricorso ai contratti finanziari del tipo pay for success consente iltrasferimento del rischio di fallimento di un progetto sociale dal set-
358
48 Riguardo la «flessibilità» dell’operazione economica sotto il profilo strutturale,essa è stata piú volte sottolineata: v. S. Baliga, Shaping the Success of Social ImpactBonds in the United States: Lessons Learned from the Privatization of U.S. Prisons,in 63 Duke L.J., 2013, p. 441 e R. Leventhal, Using Social Impact Bonds to FinanceSocial Services, in 9 New York Univ. J. Law & Bus., 2013, p. 511 ss.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
tore pubblico a quello privato: in caso di mancato raggiungimento deibenchmark sociali pattuiti, gli investitori perdono l’intero capitale ameno che intervenga nell’operazione un fondo «filantropico» di ga-ranzia. Nel 2012, Goldman Sachs ha lanciato con il Comune di NewYork City il primo SIB negli Stati Uniti per favorire la riduzione dellarecidiva tra i giovani detenuti della prigione di Rikers Island49. L’inve-stimento iniziale, pari a circa 10 milioni di dollari, frutterà fino ad unmassimo del 20% se la recidiva diminuirà oltre il 10% nei 4 anni divita del SIB. Il ritorno è garantito dal Comune di New York City colcorrispondente risparmio di spesa generato dalla diminuzione della po-polazione carceraria di Rikers Island50. L’iniziativa, inutile dire, ha por-tato molta pubblicità positiva. Ma Goldman Sachs ha dichiarato pub-blicamente di considerare la partecipazione al SIB di Rikers Islandcome un vero e proprio «investimento». Abbiamo in questo caso untrasferimento del rischio di fallimento del progetto dal soggetto pub-blico al privato. L’impatto sociale positivo viene misurato attraversoopportune metriche, quindi valutato in termini di risparmio di spesapubblica. Il ritorno finanziario è suddiviso in scaglioni, parametrati alraggiungimento dei benchmark sociali che saranno certificati da un or-ganismo di valutazione terzo e indipendente.
5. Proviamo ora a tirare le somme. Il primo fenomeno tra quellirassegnati non ambisce a rappresentare un’autonoma categoria di atti-vità finanziaria. Se parliamo di modalità della raccolta di capitale, par-liamo di un modo di costituzione del rapporto. Parlare di un agire al-
359
49 Una compiuta descrizione dei «Rikers bonds» in P.G. Dagher Jr., Social Im-pact Bonds and the Private Benefit Doctrine: Will Participation Jeopardize a Non-profit Tax-exempt Status?, in 81 Fordham L. Rev., 2013, p. 3482 s. e A. Damel, Se-cond Thoughts on Social Impact Bonds, in 9 New York Univ. J. Law & Bus., 2013,pp. 504 s., 506.
50 Di là dalla pubblicità positiva derivante dall’iniziativa – pure sottolineata da molticommentatori – Goldman Sachs ha dichiarato pubblicamente di considerare la pro-pria partecipazione al SIB di Rikers Island come un vero e proprio investimento. Ipiú ottimisti – i.e. gli operatori del nuovo settore, le organizzazioni che offrono ser-vizi di intermediazione in strumenti finanziari ad impatto sociale (su tutte Social Fi-nance Ltd. e Inc.) – stimano che il mercato dei SIB costituisca potenzialmente «unarisorsa multimilionaria di capitali di crescita per il settore sociale»: Social Finance, ANew Tool for Scaling Impact: How Social Impact Bonds Can Mobilize Private Capi-tal To Advance Social Good (2012), in www.socialfinanceus.com. Fatto sta che le espe-rienze di realizzazione si vanno estendendo a macchia d’olio fuori dall’area UE (U.K.,Irlanda, India, Colombia, Israele, Australia, Canada): per i relativi resoconti v. H. Aze-mati, M. Belinsky, R. Gillette, J. Liebman, A. Sellman e A. Wyse, Social ImpactBonds, cit., p. 24 ss.
Parte III / Sviluppo e habitat civile
ternativo, invece, significa ben altro, significa che l’impatto sociale nonsoltanto è misurabile, ma è «dentro» il prodotto finanziario: incidesulla disciplina applicabile al rapporto di investimento. Nella disciplinadella raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, semmai, ilvalore sociale dell’attività finanziata (la start up innovativa) è la ragioneche giustifica, a monte, un regolamentazione speciale della raccolta, fi-nalizzata a frazionare il capitale riducendo il rischio e le spese dell’in-vestimento.
Nel secondo e nel terzo fenomeno l’impatto sociale ridefinisce dal-l’interno la dinamica investimento-risultato. Nei fondi EuSEF e nei so-cial impact bond non muta la struttura del potere del finanziatore, mal’interesse. Questo cade sempre sul risultato finanziario, ma anche, condifferenti accenti, sul raggiungimento di impatti sociali positivi misu-rabili.
E pur tuttavia, anche rispetto a strumenti cosí strutturati, in tantoha senso cominciare a parlare di una autonoma asset class51, di un agirealternativo rispetto alla secca dicotomia tra destinazione profittevole edestinazione solidaristica52, in quanto siano soddisfatte alcune condi-zioni minime. Da queste condizioni, in ultima analisi, dipende la stessafiducia degli investitori che perseguono anche fini sociali, e non soloun ritorno in termini finanziari, nel mercato dell’investimento socialeche sta emergendo nell’àmbito dell’Unione europea.
Prima condizione: è necessario tracciare «a clear demarcation line»53
tra strumenti riconducibili al mercato europeo degli investimenti so-ciali ed altri strumenti di investimento alternativi che perseguono dif-ferenti strategie di investimento. Questa la funzione assolta, per in-tenderci, dalle norme uniformi sulle imprese di portafoglio in cui pos-sono investire i fondi che si avvalgono della designazione «EuSEF» e
360
51 M. Falkowski e P. Wis;niewski, Impact Investment as New Investment Class,in 1 Rev. Bus. & Econ., 2013, p. 78 ss.
52 L’abbandono della costruzione a soggetto permette di guardare anche agli entidel Libro I «nella prospettiva delle situazioni giuridiche anziché del soggetto»: R. DiRaimo, «Soggetto» e attività d’impresa, cit., p. 14 s., inquadrando la personalità giu-ridica come una delle possibili tecniche di individuazione e regolamentazione della de-stinazione impressa ad un patrimonio. Sul punto v. R. Orestano, Diritti soggettivi ediritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale, in Jus, 1960, p. 150 ss.; P.Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1975, pp. 127 ss., 213 ss.; P. Spada, Per-sona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico di-battito, in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 848 ss. e R. Di Raimo, Considerazioni sull’art.2645 ter cod. civ.: destinazione di patrimoni e categorie dell’iniziativa privata, in Rass.dir. civ., 2007, p. 945 ss.
53 Considerando n. 13, reg. UE n. 346/2013.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
sugli strumenti di investimento utilizzabili. Dentro il mercato degli in-vestimenti sociali, inoltre, servono regole che favoriscano la classifica-zione delle attività in titoli «impact first» oppure titoli «financial first»54
secondo la maggiore incidenza dell’obbiettivo sociale o finanziario nellaremuneratività del titolo, nelle regole di gestione e nella strategia di in-vestimento. Gli investitori financial first cercano di bilanciare i rendi-menti finanziari con gli effetti socio-ambientali, e ricercano strumentiche offrono rendimenti adeguati a coprire il costo opportunità del ca-pitale, producendo al contempo alcuni benefici sociali o ambientali. Alcontrario, gli investitori impact first cercano di coniugare un’alta per-centuale di effetti sociali o ambientali (obbiettivo primario) con unagamma di rendimenti che vanno dalla semplice protezione del capitalea prestabilite soglie di redditività (inferiori a quelle che il mercato as-segna ad investimenti ad alto rischio)55.
Dopodiché la vera svolta sta nell’aver intuito che si può affrontarela questione del finanziamento di un’impresa sociale come un pro-blema di struttura finanziaria56. Segnatamente, nelle operazioni a «strut-tura stratificata» – c.dd. layered structures, o «Yin-Yang investments»57
– i due tipi di investitori si associano amalgamando il capitale: nel sensoche gli investitori impact first accettano un rapporto rischio-rendimentoinferiore a quello di mercato, consentendo agli altri segmenti dell’o-perazione d’investimento di diventare maggiormente «attraenti» per glioperatori financial first. Questi ultimi possono infatti ottenere rendi-menti a tassi di mercato, laddove i primi possono sfruttare il loro ca-pitale in modo da produrre un impatto piú elevato di quanto non sa-rebbe se ad investire fosse una sola mano58.
Ovvio che la classificazione dei titoli di cui si sta parlando non ri-flette puramente una composizione omogenea dei gruppi sul mercatodal lato della domanda; sul piano regolativo, essa presuppone al con-
361
54 Secondo la tassonomia adottata da J. Freireich e K. Fulton, Investing for So-cial & Environmental Impact. A design for Catalyzing An Emerging Industry, 2009,in www.monitorinstitute.com.
55 Cfr. M. Falkowski e P. Wis;niewski, Impact Investment as New InvestmentClass, cit., p. 80.
56 L’impresa deve poter diversificare «l’offerta di rischi e rendimenti a seconda deltipo di investitore, invece di offrire un rendimento misto che tiene conto di tutti gliinvestitori, ma che ne soddisfa assai pochi»: A. Bugg-Levine, B. Kogut e N. Ku-latikala, A New Approach to Funding Social Enterprises, cit., p. 4.
57 Alcuni casi-studio sono analizzati nel report di Bridges Ventures, Investing forImpact: Case Studies across Asset Classes (2010), in www.parthenon.com.
58 M. Falkowski e P. Wis;niewski, Impact Investment as New Investment Class,cit., p. 80.
Parte III / Sviluppo e habitat civile
trario una disciplina specifica della correttezza e trasparenza contrat-tuale. Regole come quelle previste dal regolamento EuSEF, che im-pongono al gestore di possedere una conoscenza e una comprensioneadeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe (art. 7,lett. e reg. 346 del 2013), di applicare un livello elevato di diligenzanel controllo continuo degli investimenti e dell’impatto sociale posi-tivo delle imprese target (art. 7, lett. d) e soprattutto di informare gliinvestitori, prima della decisione di investimento ed in modo chiaro ecomprensibile, sugli elementi che costituiscono il social core dell’ope-razione finanziaria (art. 14, comma 1). Le informazioni da fornire com-prendono inoltre la descrizione della strategia e degli obiettivi di in-vestimento del fondo, la tipologia e gli obiettivi delle imprese targetin cui il fondo intende investire, l’impatto positivo previsto dalla po-litica di investimento (corredato da proiezioni ragionevoli in merito atali risultati e da informazioni sui precedenti risultati nel settore), non-ché le metodologie utilizzate per misurare gli effetti sociali delle atti-vità finanziate59.
Ovvio pure che l’impact investor, come l’investitore tradizionale,deve poter operare un raffronto tra i diversi titoli60. Gli operatori cheperseguono risultati o impatti sociali, in luogo della semplice massi-mizzazione del profitto, di norma valutano e raffrontano informazionisulla misura in cui le attività sociali riescono a conseguire i risultati ogli impatti promessi. Poiché vi è un’ampia gamma di tipologie di im-patti sociali che un ente può perseguire, sono state sviluppate diversemetodologie per identificarli e quantificarli. Ad esempio, un’impresasociale che si prefigge lo scopo di aiutare gli «esodati», ovvero le per-sone svantaggiate a causa di qualifiche insufficienti o di problemi so-ciali o professionali che ne determinano l’esclusione o l’emarginazione,può indicare il numero delle persone che sono state reinserite nelmondo del lavoro attraverso il programma di aiuto. Oppure, un’im-presa sociale che persegue l’obiettivo di reintegrare gli ex detenuti odi disassuefare i tossicodipendenti può valutare i propri risultati ri-spettivamente in termini di andamento del tasso di recidività o in base
362
59 Tali informazioni devono essere aggiornate e, se opportuno, sottoposte a rie-same. È espressamente previsto l’obbligo di predisporre una relazione annuale sullagestione e una revisione contabile da diffondere presso gli investitori e da trasmetterealle Autorità nazionali competenti.
60 E questo, per essere efficiente, necessita di indicatori classificati per tipologia diattività sociale nonché di sottoinsiemi ripartiti per percentuale financial/impact: M.Falkowski e P. Wiúniewski, o.c., p. 85.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
al numero di utenti in carico presso i Ser.t. presenti all’interno del di-stretto amministrativo in cui l’organizzazione opera.
Sebbene le informazioni sugli impatti sociali siano piuttosto im-portanti per gli investitori, è assai difficile operare un raffronto tra at-tività sociali diverse, sia in ragione delle differenze in termini di risul-tati e impatti sociali perseguiti, sia in ragione della varietà degli attualiapprocci. Per rafforzare la fiducia degli investitori servono pertantospecifici criteri di valutazione delle attività e di rendicontazione: en-trambi sono stati delegati all’Autorità Europea per i Mercati Finan-ziari. Ed al fine di promuovere il massimo grado possibile di coerenzae comparabilità di tali informazioni nel lungo periodo servono anchemetriche comuni di misurazione degli impatti sociali positivi per ilmercato europeo, attualmente allo studio del sotto-gruppo di espertidella Commissione Europea in materia di Social Business.
6. Seconda condizione: la gestione dei conflitti di interesse. In capoai gestori dei fondi EuSEF sono previsti specifici obblighi di identifi-cazione e gestione delle situazioni di conflitto d’interessi (art. 9, reg.346 del 2013). Il gestore del fondo deve condurre gli affari in mododa favorire gli investitori, l’integrità del mercato ma anche l’«impattosociale positivo delle imprese in cui investe» (art. 7, lett. c). Cosa ac-cade se il gestore procaccia un ritorno finanziario soddisfacente, nelpieno rispetto della quota 70/30, ma vi riesce solo tradendo la strate-gia etica di investimento del fondo: ad esempio, dando spazio nellaquota «libera» a titoli che finanziano l’industria degli armamenti, op-pure che comportano lo scarico illegale di rifiuti pericolosi? Se, comecredo, il gestore che tradisce la strategia etica del fondo commette unabuso, allora la rilevanza nella fattispecie prevista dall’art. 1394 c.c. del-l’interesse diverso dall’obbiettiva utilità finanziaria61, eventualmente ditipo anche non patrimoniale62, non è piú intuizione da restare confi-
363
61 Per una critica serrata del criterio della utilità obbiettiva, che non può essereelevato a regola-cardine dell’abuso ma è destinato al piú ad assolvere un ruolo resi-duale nell’area della rappresentanza volontaria, v. C. Donisi, Il contratto con se stesso,Napoli, 2002, pp. 172 ss., 175: «ad esso sembra consentito ricorrere soltanto nelle ipo-tesi in cui, ad esempio, per la genericità del mandato o per il difetto di istruzioni ov-vero per la scarsa precipuità delle stesse […] ci si trovi nell’impossibilità di ricostruireil concreto e specifico interesse del dominus. Solo in questo caso, e per offrire all’e-secutore del iussum una non equivoca regola di condotta, sembra ragionevole vinco-lare la sua attività al conseguimento di un risultato “oggettivamente” utile per il man-dante, disancorato cioè dalla concreta articolazione dell’interesse del medesimo».
62 Al quesito della rilevanza dell’interesse anche non patrimoniale del dominus nelladisciplina dell’abuso dedica talune succinte notazioni C. Donisi, o.u.c., p. 175 s. L’a.
Parte III / Sviluppo e habitat civile
nata al caso di scuola63. Al contrario, ben presto si tratterà di indivi-duare i limiti dell’abuso rispetto all’impatto sociale, e poi di selezio-nare i rimedi adeguati tenuto conto della funzione complessiva del-l’investimento.
Terza ed ultima condizione: bisogna essere sicuri che l’impact in-vestment non contribuisca a generare nuovi rischi sistemici. Penso ailimiti entro i quali un fondo EuSEF può investire in quote di un al-tro fondo ed al divieto di applicare metodi d’investimento che au-mentano l’esposizione oltre il livello del capitale sottoscritto, attraversol’assunzione di prestiti oppure assumendo posizioni in strumenti de-rivati. E penso soprattutto al timore – già comincia a serpeggiare – cheil social impact bond possa essere incompatibile tout court col nostroordinamento, stante il divieto per la P.A. di negoziare in strumenti de-rivati reso permanente dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 572,lett. b, l., 27 dicembre 2013, n. 147)64.
Questi i primi malintesi, le traveggole provocate dagli storici foto-grammi a colori del «Mago di Oz»65. Sappiamo innanzitutto che nonè la tipologia del contratto a porsi in contrasto insanabile con l’eser-cizio della funzione pubblica66, ma piuttosto il suo contenuto, espres-
364
si pronuncia in favore dell’ampliamento dei margini del concetto tenuto conto delfatto che l’art. 1174 c.c. – «di cui va sottolineata l’ampiezza del campo operativo edunque l’attitudine a “condizionare” le altre disposizioni che comunque si riallaccianoall’interesse del creditore» – consente, anzi impone di estendere il concetto di inte-resse oltre l’àmbito dell’economicamente valutabile, di modo da coinvolgere la sfera«ideale» del dominus.
63 C. Donisi, o.u.c., p. 177 in nota 298: «[c]osí, non parrebbe incongruo attribuirerilievo giuridico all’interesse del dominus, non cristallizzato in un esplicito divieto almandatario, ma comunque identificabile, a non consentire, ad esempio, la vendita dellacasa avita ad un soggetto che abbia recato offesa al suo ascendente) o alla memoriadello stesso».
64 In termini dubitativi D. Dal Maso, D. Zanoni e M. Boccia, I social impactbond. La finanza al servizio dell’innovazione sociale?, Quaderni dell’Osservatorio dellaFondazione CARIPLO n. 11 del 2013, pp. 8, 39 s. Sul tema dei derivati degli entipubblici v. R. Di Raimo, Dopo la crisi, come prima e piú di prima (Il derivato fi-nanziario come oggetto e come operazione economica), in D. Maffeis (a cura di), Swaptra banche e clienti. Le condotte e i contratti, in Quad. di Banca borsa tit. cred., nuovaserie, 2013, pp. 61 ss., 69 ss.
65 K. Westway, Beyond Black and White: The New Paradigm of Social Enter-prise, in 9 New York Univ. J. Law & Bus., 2013, p. 441: «il colore ha cambiato persempre ciò che immaginavamo potesse essere un film. Anche per il diritto è giuntoil momento di passare attraverso il proprio “Mago di Oz”, il che significa andare ol-tre la rigida dicotomia for-profit/non-profit».
66 R. Di Raimo, Dopo la crisi, come prima e piú di prima, cit., p. 83 Il problemaincrocia la piú ampia tematica relativa al fondamento e alla specifica conformazione
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
sivo in concreto dell’interesse perseguito a mezzo del regolamento con-trattuale67. Tanto detto, il derivato vietato ex art. 1, comma 572, l. n.147 del 2013 è uno strumento costruito per definizione su elementiestrinseci68, che sfuggono al controllo di entrambe le parti69: la sua re-tributività è governata cioè da scelte di tipo esclusivamente probabili-stico. Laddove il rischio generato dal social impact bond, al contrario,incide di norma su un equilibrio contrattuale per il resto controllabilee razionale, basato sulle conseguenze di un’attività reale70 consideratadall’ordinamento particolarmente meritevole71.
In parole semplici, si cade in una doppia confusione. Si confondela «scommessa»72 sul rischio «se la nave tornerà dal viaggio nelle In-
365
della c.d. autonomia privata della P.A. In merito al problema della stabilità dei negoziche si rivelano in concreto non funzionali alla realizzazione del pubblico interesse v.R. Di Raimo, Contratto e gestione indiretta di servizi pubblici. Profili dell’«autono-mia negoziale» della pubblica amministrazione, Napoli, 2000, p. 11 ss.; Id., Il “dirittoprivato” delle funzioni pubbliche: note sui piú recenti sviluppi di una tendenza, in R.Favale e B. Marucci, Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo, I, Napoli,2003, pp. 683 ss., 696 ss.
67 Soltanto l’interesse «effettivamente perseguito», «per come esso risulta dalla in-terpretazione della complessiva operazione economica», è in grado di esprimere la me-ritevolezza del contratto e consente di ricollegarne le sorti (la validità o la nullità) al-l’ordine pubblico costituzionale: R. Di Raimo, Dopo la crisi, come prima e piú diprima, cit., p. 70.
68 R. Di Raimo, o.u.c., p. 46.69 In virtú di queste sue caratteristiche fortemente aleatorie, la negoziazione in de-
rivati determina l’accollo di oneri non prevedibili che pregiudicano le risorse finan-ziarie pubbliche utilizzabili per finalità collettive: v. Corte cost., 28 marzo 2012, n. 70,in Giur. cost., 2012, 2, p. 919 ss. con riferimento alla mancata previsione di coperturafinanziaria di oneri imprevisti derivanti da contratti derivati stipulati dalla RegioneCampania.
70 In merito ai significati che assume il rischio nella qualificazione degli strumentidi finanza derivata v. P. Ferro-Luzzi, Attività e prodotti finanziari, in Riv. dir. civ.,2010, p. 133 ss. e M. Semeraro, Copertura e speculazione, funzioni e disfunzioni del-l’interest rate swap, in Riv. dir. bancario, 2013, 10, p. 5 s.
71 Sulla portata del giudizio di meritevolezza, che permette di cogliere il «signifi-cato costituzionale» dell’«iniziativa concreta» v. per tutti P. Perlingieri, Il diritto ci-vile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti, Na-poli, 2006, pp. 334 ss., 336: la meritevolezza non riguarda l’atto di autonomia valu-tato isolatamente, ma «nell’àmbito dell’attività» svolta dal soggetto verificando, tra l’al-tro, l’«adeguatezza dell’atto e degli strumenti adoperati per raggiungere il risultato».
72 Qualsiasi attività a sfondo economico, d’altronde, porta con sé un rischio, amaggior ragione se tale sfondo è specificamente finanziario; ma non ogni attività checomporta un rischio è per ciò stesso preclusa alla P.A. Al riguardo v. R. Di Raimo,Dopo la crisi, come prima e piú di prima, cit., p. 83: «anche la conclusione di un con-tratto di mutuo è in questa prospettiva rischiosa. Meglio, è rischiosa la scelta tra tassofisso e tasso variabile. È una pura scommessa poiché non vi è prevedibilità razionale
Parte III / Sviluppo e habitat civile
die», all’origine del finanziamento dell’attività d’impresa, con la purascommessa – nessuna prevedibilità razionale, nessun modo di condi-zionare l’evento – all’origine del deficit di impatto sociale del capitalefinanziario. Ma ancor di piú non si distingue tra un qualsiasi sotto-stante e un cambiamento sociale meritevole agli occhi dell’ordinamento:una concreta modalità di realizzazione dei valori costituzionali che co-lora la funzione dell’operazione di investimento.
7. Tutto ciò ci avvicina a due possibili serie conclusioni, che sonoanche due previsioni su un futuro che si annuncia abbastanza pros-simo.
Quella che si delinea all’orizzonte è una prospettiva aperta anzi-tempo dai diversi progetti di riforma del Terzo settore dell’economiache si sono succeduti nell’ultimo ventennio. Una prospettiva cui sol-tanto ora, nell’emergenza, si guarda con entusiasmo come ad una pos-sibile via d’uscita dalla crisi o, quantomeno, come la migliore rispostaal problema del finanziamento delle attività di utilità sociale. Si trattadavvero del «nuovo punto di partenza»73, dell’«anello di congiun-zione»74 tra (quello che resta) dell’economia del capitalismo occiden-tale e società civile? Oppure stiamo soltanto osservando l’ultima tra-sformazione interna del capitale, da sbandierare come un «nobile di-versivo»75 utile per distogliere l’attenzione dal vero problema: quellodel deterioramento dell’apparato pubblico, della sua incapacità di isti-tuzionalizzare, «a qualunque livello politicamente possibile, un governopartecipato dei beni comuni»76?
366
o modo di condizionare l’evento. Si tratta tuttavia di un rischio che incide soltantomarginalmente su un equilibrio contrattuale per il resto controllabile e razionale. Nes-suno dubita che le pubbliche amministrazioni, nei limiti consentiti dalle leggi di sta-bilità, possano stipulare contratti di credito».
73 Proprio l’interesse lucrativo, principale «leva egoistica», può essere «motore su-biettivo ed oggettivato di stabilizzazione dell’attività ed ampliare la modulazione diun’offerta, fino ad ora, non sempre coerente con la domanda»: M. Francesca, La ri-levanza dei fatti di sentimento nel diritto privato, cit., p. 55.
74 R. Di Raimo, Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare, cit., p. 1093.75 Diversivo «ideologico», come quello di cui discorre M. Libertini, Impresa e
finalità sociali, cit., p. 29 ss. rispetto alle proposte di una riforma radicale del dirittodell’impresa capitalistica incentrata sugli strumenti di CSR (bilancio sociale, bilancioambientale, partecipazione degli stakeholders ecc.) e sul rafforzamento degli incentiviper le imprese che attuano programmi di responsabilità sociale.
76 U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2012, spec. pp. 100 ss., 105 s.:«[s]i ripete ossessivamente che le privatizzazioni in Italia si sono “dovute fare” a causadella cancrena partitocratica che ha attaccato ogni istituzione pubblica, corrompendolain modo definitivo. […] Proporre di considerare un’entità (acqua, università, patri-
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
È chiaramente troppo presto per rispondere a questo interrogativo.Intanto qualche considerazione si può spendere sul mondo in biancoe nero, ossia sul Canto del cigno di quella visione.
Fino all’avvento della crisi, la visione d’insieme è stata quella dellasussidiarietà finanziata con le donazioni private e, soprattutto, con laleva fiscale. La meritevolezza dei fini sociali ha inciso sempre dall’e-sterno sulla disciplina del finanziamento. La qualificazione si arrestavaalla struttura del potere di esercizio della situazione giuridica del fi-nanziatore: finanziamento a titolo di capitale e finanziamento a titolodi debito77. Il primo sempre escluso, poiché – si dice – con esso il fi-nanziatore partecipa del rischio d’impresa, il secondo ammesso entroprecisi limiti che rendono la relativa remunerazione un costo (del de-naro preso a prestito) anziché una forma indiretta di lucro78.
Adesso il quadro normativo sta cambiando. Le imprese target deifondi EuSEF possono distribuire utili, purché la distribuzione non pre-giudichi l’obiettivo primario, vale a dire l’impatto sociale. Anche perla start-up il vincolo di distribuzione è solo temporaneo, ed è stabi-lito per ragioni schiette di consolidamento patrimoniale79. La transi-
367
monio culturale, rendita fondiaria, lavoro, informazione…) come “bene comune” alfine del suo governo politico ideologico ha certamente lo spirito di una radicale “in-versione di rotta” rispetto al trend apparentemente inarrestabile delle privatizzazioni,ma non significa affatto che la prospettiva sia limitata ad un ritorno di tutto il poterenelle mani di un settore pubblico burocratico, autoritario e colluso. Al contrario, lastrada da intraprendere è quella dell’istituzionalizzazione, a qualunque livello politi-camente possibile, di un governo partecipato dei beni comuni, capace di restituirli inuna prima fase alle “comunità di utenti e lavoratori” (art. 43 Cost.) e poi definitiva-mente alle moltitudini che ne hanno necessità».
77 «Ma quanto di questo precede e quanto invece è conseguente alla qualificazionedel rapporto come obbligazione?»: pone l’interrogativo R. Di Raimo, Impresa, pro-fitto e categorie dello spirito, cit., p. 608 s. al quale si rinvia per una critica a questoschema di pensiero.
78 Il social impact bond, stante la sua natura di strumento di «quasi equity»,esporrebbe l’ente non-profit (service provider) al rischio di violare il divieto di di-stribuzione degli utili con conseguente perdita della qualifica di accesso al regimedi agevolazioni pubbliche: D. Dal Maso, D. Zanoni e M. Boccia, o.c., pp. 8, 51s. Il nodo è già venuto al pettine nel diritto statunitense. Un’analisi prognostica sullacompatibilità dell’operazione finanziaria in parola con il divieto di distribuzione de-gli utili è effettuata, con pregevole sforzo ricostruttivo ma con incerti risultati, daP.G. Dagher Jr., Social Impact Bonds and the Private Benefit Doctrine, cit., spec.p. 3486 ss.
79 Il vincolo di non distribuzione degli utili, al pari degli altri vincoli imposti aifini dell’applicazione della normativa in materia di start-up innovative, deve perma-nere per un periodo di 48 mesi dalla data di costituzione; nel caso di start-up costi-tuite prima dell’entrata in vigore della legge, il vincolo di non distribuzione degli utili
Parte III / Sviluppo e habitat civile
zione dalla logica del non-profit a quella del low-profit80 porta con séottime opportunità, ciò è innegabile, ma introduce anche un nuovotipo di anomalia in grado di alterare i singoli rapporti ed il sistema nelsuo complesso. In essa si celano nuovi rischi di abuso: rischi sistemicidi conflitto di interesse a danno degli investitori e di frustrazione dellefinalità ideali dell’ente finanziato.
Le grandi opportunità, invece, si coglieranno a condizione di met-tere da parte la concezione riduzionistica dell’iniziativa economica edel profitto81, per cominciare a guardare con gli occhi dell’ordina-mento82 al profilo funzionale descrittivo degli interessi – anche nonpatrimoniali – deducibili nel rapporto di investimento. In caso con-trario, se e quando verrà rimosso il divieto di divisione degli utili dalladisciplina dell’impresa sociale, magari insieme con la progressiva tran-sizione verso modelli di fiscalità basati sul rating sociale delle im-
368
permane per il periodo di applicazione della normativa determinato ex art. 25, comma3, d.lg. n. 179 del 2012.
80 «[I]nsomma, non è un problema di esclusione del carattere lucrativo dell’atti-vità, ma il suo contrario»: M. Francesca, La rilevanza dei fatti di sentimento, cit.,p. 55.
81 «[L]a volontà fondativa dell’Unione è la volontà che sceglie e persegue questiscopi e perciò rifiuta e esclude altri scopi»: cosí N. Irti, Il metodo, in C. Castro-novo e S. Mazzamuto (a cura di), I. Fonti, Persone, Famiglia, Milano, 2007, p. 57.Ma contro la caparbia tendenza ad inseguire la fondazione di un «diritto privato eu-ropeo» di stampo tecnocratico e mercantilistico – un sistema separato di regole rettodal primato dell’interpretazione letterale («l’imposizione esegetica china sulla sequenzadelle norme», ivi p. 60) ed in assoluto preminente sul diritto interno – si leggano lepagine di P. Perlingieri, Il “diritto privato europeo” tra riduzionismo economico edignità della persona, in Eur. dir. priv., 2010, p. 345 ss., spec. p. 359: «la persona nonpuò essere ridotta al ruolo di consumatore e di produttore […]. La societas non siesaurisce in questa logica»; l’atto di autonomia non è meritevole «in sé», quale eser-cizio di libertà economica, ma il giudizio di meritevolezza «deve ispirarsi ai valorifondamentali dell’ordinamento» quali sono espressi dalle fonti nazionali, da quelle co-munitarie ed internazionali (p. 357). Sulla necessità di abbandonare il postulato dua-lista della rigida separazione tra fonti comunitarie e fonti nazionali, in favore dellaprevalenza del modello della «reciproca integrazione», v. anche P. Perlingieri, Lealecollaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema ordi-namentale, Napoli, 2008, spec. p. 60 ss.
82 «Apparirà forse banale, ma “guardare la realtà con occhi giuridici” è tutto ciò,niente di piú o di meno, che deve fare il giurista: non può determinare a priori qualisiano le esperienze che appartengono alla propria ricerca – e in tal senso non gli èconsentito volgere le spalle alla realtà per costruire un oggetto “puro”, ideale, assolu-tamente formale […] deve tuttavia rielaborare tali esperienze […] entro un complessodi princípi diretti da ideali regolativi permeabili, quanto meno, alla ragionevolezza. Gliocchi giuridici sono gli unici che possa avere»: P. Femia, Interessi e conflitti culturalinell’autonomia privata e nella responsabilità civile, Napoli, 1996, p. 228 nota 412.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
prese83, allora tutto quello che rimarrà da osservare non sarà certo ilmito ancestrale del denaro come concetto puro. E neppure il Mago diOz. Ma soltanto una notte hegeliana in cui tutte le vacche sono nere.
8. Il 22 agosto 2014, pressoché all’indomani della relazione tenutaal Convegno, veniva presentato alla Camera il Disegno di legge C.2617 contenente la delega al Governo per la riforma del Terzo settore,dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Ledirettrici fondamentali dell’intervento normativo si innestano nitida-mente nella transizione, ricostruita ed anticipata in quella sede, dallalogica del non-profit alla dimensione del «low profit»; ciò sia per quantoriguarda la possibile coesistenza della remunerazione dell’investimentoprivato con la fiscalità di vantaggio sia, e soprattutto, in punto di di-versificazione delle forme di accesso alle risorse finanziare da parte deisoggetti che perseguono, come obiettivo primario, il raggiungimentodi obiettivi sociali in luogo della semplice massimizzazione del pro-fitto.
Inutile rammentare che quella del Terzo settore è una riforma piúvolte annunciata nell’ultimo ventennio, a cominciare dai tentativi in-trapresi dal lavoro della Commissione Rescigno (1998), e proseguitipoi con la Commissione Vietti (2005) e con la Commissione Pinza(2006). E pur tuttavia i menzionati tentativi non sono andati oltre –nella migliore delle ipotesi – alla proposizione di disegni di legge diiniziativa parlamentare e governativa mai confluiti in norme vigenti.
Forse questa è la volta buona. Finora la pervicace tendenza a de-scrivere il quadro d’insieme intorno alla centralità dello Stato-eroga-tore ha condizionato buona parte delle tecniche di approccio ai pro-blemi dell’economia sociale, costringendole di fatto entro mere variantidel finanziamento pubblico ed entro le strettoie concettuali di una fun-zione meramente suppletiva rimessa al finanziamento privato delle ci-vil enterprises. Un’immagine secolare, questa del rapporto tra Stato ecomunità «intermedie» nei termini di contenitore a contenuto, di cuitutt’oggi si fatica a tenere insieme i pezzi, stanti il processo di inte-grazione europeo, le politiche di contrazione della spesa pubblica e la
369
83 Ne descrive i princípi di funzionamento A. Mazzullo, Impresa sociale 3.0, inCooperative e enti non profit, 2013, 10, p. 34 ss., auspicando l’approdo ad un sistemache riconosca all’impresa sociale, in luogo di una serie di agevolazioni, la «giusta com-pensazione» tra quanto dovuto a titolo d’imposta e quanto risparmiato grazie al suoimpatto sociale, un sistema che consenta cioè di «collegare un determinato beneficiofiscale in funzione del rating sociale periodicamente certificato e soggetto ad ispe-zioni».
Parte III / Sviluppo e habitat civile
perdita da parte dello Stato del ruolo di principale dispensatore di coe-sione e sicurezza sociali.
Oggi è mutato il contesto economico, sociale e normativo. Al cen-tro di esso campeggiano il bisogno di perequazione e la pressante ri-cerca di una Gemeinschaft europea, di un nuovo collante in grado dicementare, ai piú differenti livelli, il nostro progetto di vita comunita-ria. La valorizzazione del privato sociale assume cosí un ruolo cen-trale nel quadro dell’azione comune per il rafforzamento della solida-rietà, nonché per l’inclusione sociale, economica e politica da attuarsiattraverso la promozione di «dinamiche interculturali positive in Eu-ropa» e la prevenzione delle connesse «forme di separazioni, discri-minazioni e diseguaglianze»84. Tutto ciò ovviamente accresce il rilievodel social entrepreneurship e la meritevolezza, sul piano giuridico, de-gli interessi e dei valori che per suo tramite possono trovare realizza-zione.
In questo contesto le strutture partecipative finalizzate all’«auto-produzione» nel settore dei servizi di utilità sociale sono chiamate adassolvere un’essenziale funzione inclusiva e perequativa, anche alla lucedel divario tra le aree economicamente piú ricche d’Europa e le Re-gioni che maggiormente risentono degli effetti della crisi, come puretra le aree piú ricche del Paese e quelle del Mezzogiorno d’Italia. Que-sta funzione però sembra avere ormai oltrepassato la mera giustifica-zione del coinvolgimento del privato sociale all’interno degli interstiziaperti tra lo Stato-erogatore ed il «mercato», nella misura in cui il pri-vato sociale è chiamato piuttosto a contribuire paritariamente al repe-rimento delle risorse necessarie per sostenere la crescita e l’innova-zione.
Queste le ragioni e le tecniche che dovrebbero animare l’ennesimotentativo di riforma della materia e che, a ben vedere, emergono findall’enunciazione delle finalità e delle linee generali dell’intervento nor-mativo. Per Terzo settore il legislatore intende il complesso degli enticostituiti «con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lu-cro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, anche me-diante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità socialeconseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del prin-cipio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispet-tivi statuti o atti costitutivi»85. La finalità generale presa di mira dallariforma, in attuazione del principio di sussidiarietà, è quella di soste-
370
84 Comunicazione della Commissione, 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020: Unastrategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».
85 Testo aggiornato alla seduta della Commissione XII del 10 febbraio 2015.
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
nere la «libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire ilbene comune», coniugando «la partecipazione, l’inclusione e il pienosviluppo della persona» con l’obiettivo di valorizzare «il potenziale dicrescita e occupazione» del settore (art. 1).
In conformità ai princípi e criteri direttivi previsti, il Governo è de-legato ad adottare decreti legislativi con cui provvedere alla revisionedella disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in mate-ria di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatosenza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non ri-conosciute; al riordino e alla revisione organica della disciplina specialee delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore,compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la re-dazione di un apposito codice del Terzo settore; alla revisione delladisciplina in materia di impresa sociale, nonché alla revisione della di-sciplina in tema di servizio civile nazionale (art. 1, comma 2).
L’articolo 2 contiene i princípi e criteri direttivi generali86 alla stre-gua dei quali stabilire le forme organizzative, amministrative e le fun-zioni degli enti del Terzo settore, definiti come enti privati con fina-lità ideali e senza scopo di lucro che «promuovono e realizzano atti-vità d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di so-lidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni e servizi di uti-lità sociale».
La gran parte delle organizzazioni che si prefiggono il raggiungi-mento di finalità sociali sopravvive grazie al credito bancario, quandodisponibile, alla generosità dei sussidi statali ed al novero, per sua na-tura occasionale, delle liberalità provenienti dai privati. Pertanto, ditutti i profili, quello relativo alla diversificazione delle fonti di finan-ziamento assume un ruolo centrale, atteso che l’attuale carenza di op-portunità finanziarie costituisce una delle principali limitazioni che glienti del Terzo settore si trovano a dover fronteggiare.
371
86 Tra i quali: «a) riconoscere e garantire il libero esercizio del diritto di associa-zione e il valore delle formazioni sociali strumento per l’attuazione dei princípi dipartecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, di cui agli articoli 2, 3, 18 e 118della Costituzione; b) favorire e riconoscere l’iniziativa economica privata senza finidi lucro, finalizzata a produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale e di inte-resse generale; c) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale caratteriz-zanti gli enti del terzo settore per identificare normative promozionali; d) assicurare,nel rispetto delle norme vigenti, la piú ampia autonomia statutaria per consentire ilpieno conseguimento delle finalità dell’ente e la tutela degli interessi coinvolti; e) sem-plificare la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare ilregime di responsabilità limitata delle persone giuridiche nel rispetto di alcuni princípi– quali la certezza nei rapporti con i terzi e la tutela dei creditori».
Parte III / Sviluppo e habitat civile
Tra i princípi e criteri enunciati, il Disegno di legge prevede (perl’impresa sociale) «forme di remunerazione del capitale sociale e di ri-partizione degli utili» nel rispetto di condizioni e limiti prefissati, inderoga alla previsione del divieto di distribuzione anche in forma in-diretta degli utili (art. 2, lett. g), insieme all’introduzione di una disci-plina delle «modalità di verifica dell’attività svolta e delle finalità per-seguite» (art. 2, lett. l). Nel caso di esercizio di attività di impresa daparte dell’ente, inoltre, dovranno essere definiti criteri e vincoli per as-sicurare la «strumentalità dell’impresa rispetto agli scopi istituzionali»,anche mediante l’introduzione di un regime di contabilità separata perdistinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale (art. 2,lett. h). Nella medesima prospettiva si prevede una disciplina specificadegli obblighi di controllo interno e di informazione nei confronti de-gli associati e dei terzi, obblighi che dovranno essere differenziati inragione della «dimensione economica dell’attività» e dell’«impiego dirisorse pubbliche» (art. 2, lett. i).
Non manca la previsione di correttivi strutturali finalizzati a rea-lizzare la semplificazione burocratica ed a riorganizzare, semplifican-dolo, il sistema di registrazione di tutti gli enti e degli atti di gestionemediante un registro unico del Terzo settore (art. 2, lett. n). Nell’ot-tica del superamento del modello di Welfare omologante, sono altresíprevisti
– strumenti atti a valorizzare il ruolo degli enti «nella fase di pro-grammazione a livello territoriale, relativa anche al sistema dei servizisocio-assistenziale e alla tutela del patrimonio ambientale e culturale,individuando criteri per l’affidamento agli enti dei servizi di interessegenerale» (art. 2, lett. o);
– strumenti per favorire i «processi aggregativi» degli enti del Terzosettore (art. 2, lett. p);
– da ultimo, il coordinamento delle azioni di promozione e vigi-lanza delle attività degli enti, che dovrà essere assicurato, in raccordocon i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei mini-stri, «anche mediante l’istituzione di un’apposita struttura di missione»(art. 2, lett. q).
8.1 Ovviamente gli interventi di maggior rilievo ai nostri fini sonoquelli che toccano la disciplina dell’impresa sociale (art. 4). In parti-colare:
– la definizione normativa dell’impresa sociale nei termini di un’im-presa «privata a finalità d’interesse generale», avente come «proprioobiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misura-bili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi
372
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il con-seguimento di obiettivi sociali, anche attraverso l’adozione di modellidi gestione responsabili e idonei ad assicurare il piú ampio coinvolgi-mento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati allesue attività» (art. 4, lett. a);
– la revisione dell’attuale disciplina dell’attribuzione facoltativa dellaqualifica di impresa sociale e la sua attribuzione di diritto alle coope-rative sociali ed ai loro consorzi (art. 4, lett. b);
– l’ampliamento dei settori di attività «di utilità sociale» nei qualil’impresa sociale può operare nonché, entro certi limiti di compatibi-lità, la possibilità di svolgere «attività commerciali diverse da quelle diutilità sociale» (art. 4, lett. c);
– la possibile remunerazione del capitale e la rimozione del divietodi distribuire gli utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati (art.4, lett. d);
– la possibilità per le imprese private e per le amministrazioni pub-bliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delleimprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo(art. 4, lett. f).
8.2. È chiaro infine che l’aspetto fiscale rappresenta ancóra un ele-mento imprescindibile di qualsiasi prospettiva di riforma del Terzo set-tore, laddove ogni ipotesi di regime agevolativo da estendere alle im-prese sociali si è trovato finora a fare i conti con un problema di so-stenibilità in termini di finanza pubblica.
L’articolo 6 del menzionato Disegno di legge detta i princípi e icriteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato al fine diintrodurre misure agevolative e di sostegno economico in favore de-gli enti del Terzo settore, procedendo al riordino e all’armonizzazionedella relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità divantaggio.
Il cuore della riforma consiste, da principio, nella scelta coraggiosadi elaborare finalmente una definizione autonoma di ente del Terzosettore per i fini fiscali: ciò significa rottura del collegamento – stori-camente accreditato – con la nozione di attività non commerciale ri-cavabile a contrario dall’art. 2195 c.c. e ripensamento generale dell’as-setto impositivo in ragione delle «finalità di interesse generale perse-guite» nello svolgimento di qualunque forma di attività economica (art.6, lett. a).
Il superamento della distinzione tra attività commerciale e attivitànon commerciale imprime una svolta che potenzialmente investe l’ar-chitettura complessiva del sistema della tassazione della ricchezza im-
373
Parte III / Sviluppo e habitat civile
putabile alle attività economiche e la sua stessa filosofia di fondo. Nelsistema attuale, infatti, sono la tipologia di attività – produzione dibeni o servizi, intermediazione nella circolazione dei beni, trasporto,attività bancaria e assicurativa o altre attività ausiliarie – e l’organizza-zione in forma d’impresa, a dettare la qualificazione soggettiva del-l’ente per i fini fiscali. Tutto all’opposto nel modello di fiscalità basatosull’impatto sociale, dove è piuttosto l’utilità sociale, meglio la valo-rizzazione degli interessi costituzionalmente rilevanti concretamentesoddisfatti dalla ricchezza prodotta o raccolta nello svolgimento di qua-lunque forma di attività economica, che «colora» l’attività e la quali-fica anche in punto di agevolazioni impositive.
Le potenzialità del disegno traspaiono chiaramente nelle successivedisposizioni finalizzate al riordino delle vigenti agevolazioni fiscali, ovesi apre all’introduzione di strumenti tarati in ragione delle specifichelimitazioni alla ripartizione degli utili e «dell’impatto sociale delle atti-vità svolte dall’ente» (art. 6, lett. a). Di qui il verosimile delinearsi diun sistema che potrebbe ammettere un’articolazione di regimi impo-sitivi differenziati, con la possibilità di modulare le aliquote in ragionedel rating sociale dell’attività e/o della quota di utili volta per voltasottratti alla distribuzione ovvero ad altre forme di destinazione «egoi-stica». In questo modo, l’impresa sociale che si avvale del lavoro diex-detenuti assicura un impatto sociale – l’abbattimento del tasso direcidiva – che si traduce in un risparmio per l’Amministrazione peni-tenziaria oggettivo e quantificabile (poniamo pari a 100). Se la stessaimpresa produce beni che le rendono un reddito pari a 100, al nettodei costi e in particolare degli stipendi che ammontano a 200, e suquel reddito l’impresa dovrebbe pagare imposte per 30, è possibile chein virtú del buon livello di rating sociale certificato questa riesca adusufruire di un credito d’imposta pari a 20. Risultato: lo Stato incassa10 e risparmia 80 (100-20); l’impresa guadagna 90 (100-10); i diversilavoratori guadagnano complessivamente 200 che vengono utilizzatiper comprare beni di consumo e su cui pagheranno le imposte da la-voro dipendente87.
Non è tanto il Terzo settore a necessitare di agevolazioni dallo Stato,quanto piuttosto quest’ultimo ad essere «agevolato» dal primo: anchesotto il profilo fiscale, dunque, il disegno di legge sembra ispirato alcapovolgimento nella logica finora imperante in materia di rapporti tra
374
87 Traggo l’esempio da A. Mazzullo, Impresa sociale 3.0, cit., p. 39: sul pianomacroeconomico, il modello dà come risultato «una collettività piú sicura; un aumentodel tasso di occupazione; un aumento del PIL; un aumento delle entrate erariali (di-rette ed indirette); un risparmio della spesa pubblica».
Carlo Mignone / Finanza alternativa e innovazione sociale
reddito derivante dall’esercizio di attività economiche e perseguimentodi finalità generali da parte dei privati, ponendosi nella prospettiva cheporta gradualmente verso modelli di fiscalità nei quali l’agevolazioneè fissata in proporzione al risultato sociale, periodicamente certificato,raggiunto dall’attività (sia essa di tipo commerciale o non commer-ciale).
Per concludere il Disegno di legge prevede, per le imprese sociali,misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale e la rac-colta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quantoprevisto per le start-up innovative (art. 6, lett. f, n. 1 e 2), nonché l’in-troduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà«e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietàsociale» (art. 6, lett. g).
375