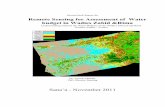Simone di maestro Filippo da Càscina OP († 1420 ca.): "Li secte psalmi penitentiali in rima"....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Simone di maestro Filippo da Càscina OP († 1420 ca.): "Li secte psalmi penitentiali in rima"....
Simone di maestro Filippo da Càscina OP († 1420 ca.)
Simon de Cascina, dominicain, † vers 1420
«Dictionnaire de spiritualité» 14 (1989) coll.871-73.
■ di' "Càscina" (Valdarno inferiore, prov. Pisa), accento sulla prima sillaba, non "Cascìna"! ■
Mio "originale redazionale" è il testo italiano (composizione Pistoia 1986; minori ritocchi inseriti in ed. web, aprile 2002); "originale edito" quello francese. A tua scelta. Oppure lèggitili tutti e due!Traduzione (su mio primitivo testo italiano, 1986) a cura della redazione del «Dictionnaire».Riadatto e unifico le sezioni d'informazioni bibliografiche. Simone Simon1 Vita 1 Vie2 Colloquio spirituale 2 Colloquio spirituale3 Opere 3 Œuvres
in latino | in volgare pisano
4 Bibliografia 4 Bibliographie
1. Vita
Figlio di maestro Filippo, originario di Càscina nel Valdarno inferiore (prov. Pisa), frate del convento domenicano Santa Caterina di Pisa, attivo fin dal decennio 1370, muore in Pisa poco dopo il 1418, ultima data conosciuta. Priore del convento pisano, più volte definitore nei capitoli provinciali e generali, lettore in Perugia, Siena, Firenze, Pisa;maestro in sacra teologia già nel1381, reggente in Santa Maria Novella di Firenze e in San Michele di Pisa, per otto anni vicario dell’arcivescovo pisano. Impegnato nella riforma conventuale del secondo Trecento,all’intensa vita accademica unisce una viva sensibilità per il rinnovamento spirituale all’insegna dell’intimità e dellavita devota, sostenute da una solida informazione teologica.
Membre du couvent dominicain de Santa Caterina de Pise (en activité à partir de la fin des années 70 du 14e siècle), c'est là que Simon mourut peu après 1418, demière date cannue.
Il avait été prieur de ce même couvent, plusieurs fois définiteur aux chapitres provinciaux et généraux, lecteur à Pérouse, Sienne, Florence, Pise; maître en théologie déjà en1381, il fut régent à Santa MariaNovella de Florence et à San Michele de Pise (pendant huit ansvicaire de l'archevêque de Pise).Engagé dans la réforme conventuelle de la deuxième moitié du 14e siècle, Simon unit à une intense activité académiqueun vif intérêt pour le renouveau spirituel marqué par une intériorité et une vie dévote soutenues par une solide information théologique.
2. Colloquio spirituale Frutto precipuo della
divulgazione della dottrina spirituale è il Colloquio spirituale: composizione 1391-92 circa (non “1381”, spiacevole lapsus nella stampa in luogo di “1391”); in Pisa, visto che il celebrante è detto arcivescovo (Firenze è sedearcivescovile solo dal 1419); in volgare pisano. S’innesta su una consolidata tradizione del convento domenicano di Pisa all’attività di diffusione del sapere clericale presso i laici tramite numerosi volgarizzamenti.Se il modello della vita perfettaè, per antica tradizione, di
L'expression principale de ladoctrine spirituelle de Simon estle Colloquio spirituale (1391 environ[pas 1381 de l'éd.]), écrit en dialecte pisan et qui s'insère dans une solide tradition du couvent dominicain de Pise: diffuser le savoir clérical auprès de laìcs au moyen de nombreuses vulgarisations. Tandisque le modèle de la vie parfaite est, selon la tradition, de stylemonastico-conventuel, les destinataires du Colloquio spiritualesemblent être des laics, surtout des femmes, qui fréquentaient le confessionnal et la chaire des
stampo monastico-conventuale, i destinatari del Colloquio spirituale sembrano essere i laici, specie le donne frequentatrici del confessionale e del pulpito dei Mendicanti, presumibilmente l’area dell’Ordine della Penitenza. L’itenerario della vita perfetta è percorso, nel Colloquio, sulla traccia del commento alla messa; ne fa da scorta il De sacro altaris mysterio d’Innocenzo III († 1216). Ma l’intenzionale discrezione del testo divulgativo e la reticenza del corredo documentario non dissimulano del tutto la ricca tradizione teologica, da quella patristica a quella scolastica, non escluso Tommaso d’Aquino, chealimenta la dottrina spirituale ela pratica delle virtù cristiane.
Mendiants, peut-être de l'Ordre de la Pénitence. L'itinéraire de la vie parfaite présenté dans le Colloquio suit le commentaire de la messe à la manière du De sacro altaris mysterio d'Innocent III. La discrétion intentionnelle du texte laisse transparaître la riche tradition théologique (depuis la patristique jusqu'à lascolastique, sans exclure Thomas d'Aquin) qui alimente la doctrinespirituelle et la pratique de la vertu chrétienne.
La struttura è dialogica. Quattroi personaggi: Simone, Caterina, il fraticello e la monachetta. Seal “dottore” Simone è riservato, dietro domande di Caterina, d’introdurre il commento alle parti della messa, d’illustrarne la liturgia e d’enuclearne il contenuto teologico in immediata estensione al nutrimento spirituale, il fraticello allargale istanze della vita spirituale alle ricchezze psicologiche dell’anima semplice e fervorosa col ricorso all’ardore del sentimento e alle ragioni della «fantazia»; una lussureggiante simbologia del linguaggio immaginifico fabbrica forme e spazi per la costruzione del castello della vita interiore.
Le texte se présente sous la forme d'un dialogue entre quatre personnages: le docteur Simone, Caterina, le fraticello et la monachetta. S'il est réservé au premier, à la demande de Caterina, d'introduire le commentaire des différentes parties de la messe, d'en expliquer la liturgie, d'en extraire le contenu théologique puis la nourriture spirituelle, le fraticello prolonge les exigencesde la doctrine spirituelle vers les richesses de l'expérience psychologique offertes à l'âme simple et fervente dans l'ardeur des sentiments et de l'imagination. La luxuriante symbolique du langage utilise l'image de la construction du
«Infiammi e accendi, fraticello,con tuoe fantazie li spiriti: onde piacciati di provare le ’nteriole potente, sforsale testé un poco, fabricando qualch’edificio presioso» (c. 6 § 7; ed. P. Dalla Riva, Firenze 1982) [Infiamma e accendi i nostri animi, fraticello, con letue invenzioni; metti a prova lenostre interiori facoltà, forzale ora un poco fabbricando qualch’edificio prezioso]
Il trapasso all’effusione mistica e alla libertà della preghiera è affidato alla monachetta:«Che ti tiene, monachetta, che si stringhi li spiriti? Lassali scire fuora e non contenere più le tuoe spirituale voglie impettuose» (c. 7 § 52) [Perchétrattieni, monachetta, i tuoi interiori sentimenti? Da' via libera e più non contenere l’impeto del tuoi spirituali desideri]
Al che la monachetta:«Ardore sottile corre per le morolle, muovemi sete instinguibile, voglia dizuzata m’assaglie! Sì come il cervio vaa la fonte, così va l’anima mia a te, Signore (…), anchelante e focosa di grande desiderio» (c. 7 § 53) [Sottile ardore mi scorre per le midolla, inestinguibile sete mi agita, inconsueta voglia mi assale! Come il cervo va alla fonte, così va l’anima mia a te, Signore (…), anelante e ardente
château de la vie intérieure: «Enflamme et brûle nos esprits, o fraticello. avec tes images; mets à l'épreuve nos facultés intérieures, force-les un peu en fabriquant quelque édifice précieux» (ch. 6, n. 7). L'effusion mystique et la
libre expression de la prière sont confiées à la monachetta:
«Pourquoi, monachetta. retiens-tu tes sentiments intérieurs? Donne libre courset ne contiens plus l'impétuosité de tes désirs spirituels» (ch. 7, n. 52). A quoi la monachetta répond: «Une ardeur subtile me parcourt la moelle, une soif inextinguible me pousse, une envie insolite m'assaille! Comme le cerf va à la source,ainsi mon âme vers toi, Seigneur..., haletante et ardente à cause de son grand désir» (ch. 7, n. 53). Le jeu entrelacé des
personnages alimente et tempère les differentes exigences de l'âme dévote, scande les temps etles passages du parcours spirituel.
per gran desiderio].Il gioco intrecciato dei
personaggi alimenta e tempera le differenti esigenze dell’anima devota, scandisce tempi e trapassi del percorso spirituale.
Le profonditrasformazioni dellasocieta comunale delsecondo Trecento, losmarrimento ecclesiale seguìto alla decandenza degli ordini religiosi prima e al grande scisma (1378) poi, consigliano a Simone di sottrarsi alle dimensioni storiche delle fede per coltivare il calore dell’intimità e precorrere le consolazioni celesti. La chiesa, guidata dallo Spirito santo, proclama - si dice - la dottrina apostolica con opere e parole, edeleva a Dio l’incenso di soavissime virtù (c. 19 § 14). Com’è possibile - chiede meravigliata Caterina - se già datredici anni la chiesa soffre profondissime divisioni a motivo dello scisma? In verità la chiesamilitante - risponde il “dottore”Simone - è esposta ad ogni sorta di tempeste, ma è a quella trionfante («alla triunfante di sopra») che convengono in modo speciale le mirabili qualità della chiesa (c. 19 § 15-16). La preghiera della monachetta, la quale è «atterrata da orribile paura e minacci spaventevuli» (c.19 § 36), seconda con sorprendente sintonia l’inclinazione dell’itinerario
Les transformations profondesde la société communale de la deuxième moitié du 14e siècle, les désarrois dans l'Église qui suivent la décadence des ordres religieux et le grand schisme, amènent Simon de Càscina à se replier dans la chaleur et l'intimité de la vie dévote et à y chercher les consolations célestes. L'Église, guidée par l'Esprit Saint, dit-on, proclame la doctrine apostolique en paroles et en actions et élève à Dieu l'encens de la vertu (ch. 19, n. 14). Comment cela est-il possible, demande Caterina émerveillée, si l'Église, depuis 13 ans, souffre de profondes divisions à cause du schisme? En vérité, répond le «dottore» Simone, l'Église militante est exposée à toutes sortes de tempêtes; ce n'est pas elIe, maisl'Église triomphante qui en réalise les merveilleuses qualités (ch. 19, n. 15-16). La prière de la monachetta, accabléede peur par de grands perils (ch.19, n. 36), exprime avec une surprenante syntonie l'itinérairespirituel: «Seigneur, enlève-moi complètement au monde et à moi-méme» (ch. 19, n. 38). Si le Colloquio présente une pratique dela vie dévote exubérante dans
spirituale: «Signore mio, togliemi al tutto del mondo e da me stessa»» (c. 19 § 38) [toglimi completamente dal mondo e da me stessa]. La prassi della vita devota, comunque, anche quando esuberante nei sentimenti e capricciosa nel linguaggio, è saldamente ancorata al dato di fede e sorretta dalla parola di Dio («spesso raguardare e studiare con attento animo in nelle sante Scritture»: c. 11 § 4).
l'expression des sentiments et capricieuse dans le langage, celIe-ci est solidement ancrée dans le donné de la foi et soutenue par la parole de Dieu («Spesso raguardare e studiare con attento animo in nelIe sante Scritture», ch. Il, n. 4).
Colloquio spirituale, éd. F. DalIa Riva, FIorence, 1982 (ms, FIorence, Riccardiana, cod. 1346,f. 1r-78r).
3. Opere a) in latino:Continuazione della cronaca
conventuale di Santa Caterina di Pisa: Pisa, Biblioteca Cateriniana 78, ff. 39r-40v (non "ff. 30r-40v", come scritto in edizione a stampa, col. 872) (ed.Bonaini, Chronica antiqua.; ed. web Panella). Simone inizia a scrivere nell'anno 1411, redige gli articoli biografici del primodecennio del Quattrocento.
Sermones et collationes statuum diversorum, actuum scolasticorum, dierumsolemnpium et festorum: BAV, Barb. lat. 710 (xv in), ff. 234.
b) in volgare pisano:Colloquio spirituale: Firenze,
Bibl. Riccardiana 1346: ed. a curadi F. Dalla Riva, Firenze (Olschki) 1982. Ed. B. Carderi (Teramo 2006)
Salmi penitentiali in terza rima: BNF, Pal. 74 (xv in), ff. 121r-131v: «Qui incominciano li secte psalmi penitentiali reghati in rima dal venerabile padre maestro
On doit encore à Simon la continuation de la Chronica du couvent de Santa Caterina de Pise(Séminaire de Pise, ms 78, f. 30r-40v; éd. Bonaini, citée infra,p. 582-93); l'auteur commence à écrire en 1411 (style pisan) et rédige les articles biographiquesde la première décennie du 15e siècle.
On garde aussi de lui des Sermones et collationes statuum diversorum, actuum scolasticorum, dierum solemnium et festorum (Vatican, Barber. lat. 710) en latin, et des Salmi penitentiali in terza rima (Florence, Bibl. Naz.,Pal. lat. 74, f. 121r-131v) en pisan.
Symone da Cascina dell'ordine de'frati Predicatori. Psalmo primo...».
4. Bibliografia
Études: F. Bonaini, Chronica antiqua...; Excerpta Annalium .... - R. Barsotti, I manoscritti... . - A. Levasti, Mistici del Duecento e del Trecento, Milan, 1935, p. 949-75. - A. Kappeli, La raccolta di discorsi e di atti scolastici di Simone da Cascina O.P. († ca. 1420), AFP 12 (1942) 185-246;SOPMÆ, t. 3, p. 344. - F. Dalla Riva, Introd. à son éd. du Colloquiospirituale, Florence(), 1982, p. 1-26. - C. Delcorno, Presentazione, ibid., p. v-x. - E. Panella, La Cronaca di Santa Caterina di Pisa usa lo stilepisano?, dans «Memorie Domenicane» t. 16, 1985, 325-34.
finis
Simone di maestro Filippo da Càscina OP († 1420 ca.)
Li secte psalmi penitentiali in rima
Bibl. Nazionale di Firenze, Pal. 74 (xv in), ff. 121r-131v
Premessa c San Giusto a Pinti (Firenze)
a I salmi penitenziali d Ricaduta linguistica
b Il codice BNF, Pal. 74 e Volgarizzamento in terza rima dalla Vulgata
Li secte psalmi penitentiali in rima
1 Psalmo primo [Ps. 6] 5 Psalmo quinto [Ps. 101]2 Psalmo secondo [Ps. 31] 6 Psalmo sesto [Ps. 129]3 Psalmo terço [Ps. 37] 7 Psalmo septimo [Ps. 142]
4 Psalmo quarto [Ps. 50] Questo libro è de' poveriJhesuati...
Premessa
a) I sette salmi penitenziali:(1°) Ps. 6, Domine ne in furore tuo arguas me(2°) Ps. 31 (32), Beati quorum remissae sunt iniquitates(3°) Ps. 37 (38), Domine ne in furore tuo arguas me(4°) Ps. 50 (51), Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam(5°) Ps. 101 (102), Domine exaudi orationem meam(6°) Ps. 129 (130), De profundis clamavi ad te Domine(7°) Ps. 142 (143), Domine exaudi orationem meamTesto iuxta LXX emendatus.
Selezione salmica d'antichissima tradizione. Raccolgono smarrimento, peccato, pentimento, perdono, speranza. Pressoché assente l'ossessivo filone dei "nemici". Integrano la celebrazione dell'ufficio divino, scandiscono la pietà delle confraternite laiche e la preghiera domestica. Rapida e vastissimima la circolazione in volgare. E in musica. Difficile imbattersi in statuti di confraternite che non stabiliscano la recita (spesso memorizzata) dei sette salmi penitenziali. La cosa si prolunga nella produzione del libro. Un esempio per tutti:
Item sea do altri libri de carte de cavrèo in tuto consonante e simele uno a l'altro, in caduno di quali sea scripti hi septe psalmi penitenciali cum le letanie e oratione competente... (G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite religiose di Padova nel Medio Evo, Padova 1974, 129).
b) Eccone un esemplare in toscano occidentale, opera diSimone di maestro Filippo da Càscina († 1420 ca.), frate domenicano del convento pisano, maestro in teologia, che non disdegnava pastorale divulgativa. In versificazione rimata, che asseconda diletto e memorizzazione. Inediti, Lisecte psalmi penitentiali, e senza confinata datazione. Unico manoscrito conosciuto il fiorentino Palatino 74, ff. 121r-131v (cf. SOPMÆ III, 344 n° 3593, che rimette il ms al secolo "XIV"; IV, 277).
Firenze, Bibl. Nazionale, Palatino 74 (xiv-xv sec.), membr., mm 175 x 120, ff. 157, solida coperta moderna. Originale omogeneo in gotica libraria rotunda in ff. 1-132, chiuso da sottoscrizione del copista fra Giordano nonché da nota di possesso in f. 131v. Accede successivamente il blocco ff. 133-157, d'altra mano, supporto membranaceo mediocre e annerito. Contenuto: Li notabili detti di sancto Gregorio de' Morali tracti a nostra doctrina del libbro sopra Job, ff. 1-119v, in libri 19, suddivisi in capitoli; i nostri salmi ff. 121r-131v; Vita della venerabile Eufraxia, ff. 133r-157v (scritta da altra mano). Tutto a unasola colonna. Rubriche in rosso. Primo approccio al codicefu solo su riproduzione microfilmica, Roma apr. 1994; in genn. 2007 ho rivisto le cose sull'originale.
«Qui incominciano li secte psalmi penitentiali, reghatiin rima dal venerabile padre maestro Symone da Cascina dell'ordine de' frati Predicatori…» (f. 121r). Salmo settimo termina a f. 131v, con colophon del copista Giordano: «Qui scripsit scribat senper cum Domino vivat. |Vivat in celis Iordanis nomine felix»; che si era sottoscritto anche a fine dei Morali, f. 119v: «Finito
libro isto sit laus et gloria Christo | Vivat in celis frater Iordanis nomine felix. | Manus scriptoris salvetur omnibus horis». L'unica mano di fra Giordano verga il blocco ff. 1r-131v (bianche la carte 120 a 132), in goticalibraria rotunda (Italia mediana), tardiva, databile fine Tre - primo Quattrocento.
Nota di possesso a fine dei salmi penitentiali. Scrittada altra mano, quattrocentesca, non di molto posteriore altesto che la precede. Per quanto possibile stimare. Perchéi tre righi sono stati erasi a fondo, illeggibili a occhionudo, e illeggibili anche con lampada Wood; solo un precedente sviluppo su carta (1994) restiuisce qualche visibilità all'inchiostro, e permette di ridar nome agli originali possessori del codice:
«Questo libro è de' poveri Jhesuati ha-bitanti a Sancto Giusto a le Mura fuoride la porta a Pinti in Firençe» (f. 131v).
c) San Giusto alle Mura, fuori Porta a Pinti di Firenze, porta detta anche Fiesolana (VILLANI X, 256/35-40), popolo San Pier Maggiore.
Nasce monastero femminile a metà Duecento, San Giusto alle Mura; regola di sant'Agostino. Il vescovo fiorentinoconcede indulgenze a favore di «abatissa seu priorissa et sorores monasterii Sancti Iusti de Muris prope Florentiam» (ASF, Dipl. Riformagioni 1.IV.1302). 21.IV.1415 «monialibus et capitulo et conventui et monasterio Sancti Iusti delle Mura extra portam Pinti propre Florentiam» (ORLANDI, S. Antonino, Studi I, 7, 30).
Originariamente dunque monastero femminile. Ma nel 1438 passato ai Gesuati (non scivolare ai Gesuiti!), sodalità laicale fondata dal senese Giovanni di Piero Colombini († 1367), canonicamente approvata nel 1426-28. Operai del Duomo, 31.XII.1466: «alloghorono a' frati, capitolo e convento di Sancto G<i>usto, detti Ingesuati, fuori della porta a Pinti di Firenze, sei finestre di
vetro» (GUASTI, La cupola 107). Convento distrutto nel 1530(DAVIDSOHN, Storia di Firenze VII,85); al riordinamento delleporte e fortificazioni cittadine ad opera di Cosimo I, l'area di Porta a Pinti (attuale area di Piazzale Donatello) fu drasticamente ristrutturata, i Gesuati trasferiti a Porta Romana, popolarmente detti "convento della Calza" (C.C. CALZOLAI, in AA. VV., La Chiesa Fiorentina, Firenze 1970, 125). Ordine dei Gesuati soppresso nel 1668.
■ G. DUFNER, Die Geschichte der Jesuaten…, AFP 36 (1966) 432-33, 433 n. 22 per il nostro ms. R. GUARNIERI, Gesuate/Gesuati, «Dizionario degli istituti di perfezione» 4 (1977) 1114-30. A. BENVENUTI PAPI, "In castro poenitentiae", Roma 1990, 578-79, 609-10, 686a, 689a. DAVIDSOHN, Storia di Firenze VIII, 222a.Poche essenziali notizie, le precedenti, per definire
il valore della nota di possesso del nostro codice. Proprietà, questo, della comunità laica dei Gesuati fiorentini; tipica comunità religiosa che di tali testi faceva uso quotidiano. La transizione di San Giusto nel 1438 ai discepoli del Colombini non data di suo la produzione del manoscritto, né asserisce il termine post quem di appartenenza. Ma la prossimità paleografica della nota di possesso con la scrittura dei ff. 1r-131v, insieme alla qualifica "frate" del copista Giordano, fannonon irragionevolmente pensare che i Gesuati avessero soprinteso anche alla confezione del codice.
d) Psalmi penitentiali in rima ff. 121r-131v, volgarizzamento di fra Simone di maestro Filippo da Càscina OP († 1420 ca.). Ricaduta linguistica: la trascrizione fiorentina non ha azzerato del tutto le caratteristiche grafico-fonetiche dell'originale pisano. Vedi quanto scritto altrove (Preghiera e protesta. La prima lettera di Riccoldo, «Archivum Fratrum Praedicatorum» 59 (1989) 17-88, §3: Il volgarizzamento in toscano occidentale, pp. 38-48), e confronta
con talune caratteristiche del volgarizzamento in versi dei nostri salmi penitenziali. Ad esempio, le frequenti sincopi della vocale protonica: srei (= sarei), droti (= daròtti), formrò (= formerò) ecc. E leggi soprattutto, dello stesso Simone, il Colloquio spirituale.
Psalmi penitentiali in rima utilizzati a lungo. Perché talune note marginali, o di correzione o di ulteriore ripulitura fiorentina, sono molto tardive, sei-settecentesche. Interventi non d'interesse filologico, ma di aggiornamento del sussidio alla preghiera salmica. Esempio: il marginale dirizzai ripulisce il pisano - e autentico - dirissai del testo, f.131r, Ps. 142,8.
e) Simone traduce dalla bibbia vulgata, testo dei salmi iuxta LXX emendatus, ossia revisione latina fatta da san Girolamo (anni 386-89) della traduzione dal greco deiSettanta; accolta dal cosiddetto psalterium gallicanum, testopassato alla liturgia dal tempo d’Alcuino († 804). Non dunque iuxta Hebraicum, traduzione ebraico-latina del medesimo Girolamo (392), che pure circolava tra i medievali dotti della schola.
Ho detto "traduce". Di fatto Simone elabora volgarizzamento versificato: endecasillabi in terza rima o a rime incatenate, schema ABA BCB CDC DED ecc. E si prende maggior libertà anche rispetto alle tecniche del volgarizzamento a lui ben note, visto che versificazione e rima sollecitano propri spazi linguistici. Atto divulgativo che guarda più al destinatario e all'uso del testo che alla sacralità del modello.
Aggiungo il numero dei versetti per facilitare il raffronto con l'originale dei salmi. Del primo salmo penitenziale do a fronte anche il modello latino iuxta LXX.
Emilio Panella OPmarzo 2006, gennaio 2007
Simone da Càscina OP
Li secte psalmi penitentiali in rima
Firenze, Bibl. Nazionale, Palatino 74 (xv in)
|121r| Qui incominciano li secte psalmi penitentiali, reghati inrima dal venerabile padre maestro Symone da Cascina dell'ordine de' frati Predicatori.
Psalmo primo [= Ps. 6]Signor nel furor tuo non mi riprehendere né in tua ira corregge l'errore perché disfacto srei per molto offendere.3Misericordia m'abbi, o gram Signore, ché infermo sono e conturbate ò l'ossa prego mi sani per tuo gran valore4e l'anima [= l'alma?] mia molto turbata possa guida e diriçça co·ll'eterna luce infine a tanto che digiù sia smossa.5Voltati ad me, Signore, e sii mio duce e toglie da' peccati l'alma mia salvo per tua misericordia mi conduce6però che nella morte né è né fia chi di te s'aricordi, e innello inferno quale a te confessrasi in pena ria?|121v| 7Affaticato m'ò con pianto
Domine ne in furore tuo arguas meneque in ira tua corripias memiserere mei Domine quoniam infirmus sum sana me Domine quoniam conturbata sunt ossa meaet anima mea turbata est valdesed tu Domine usquequo?Convertere Domineet eripe animam meamsalvum me fac propter misericordiam tuamquoniam non est in morte qui memor sit tuiin inferno autem quis confitebitur tibi?Laboravi in gemitu meo
interno laverò ogni nocte lo mio lecto le lagrime bagneranno ove io mi sterno.8Turbato è dal furor del tuo aspecto l'occhio che è mio e sentomi invecchiato tra miei nemici che mi dam sospecto.9Partitevi da me, voi che 'l peccato con iniqua malitia adoperate, ch'a le miee voce Iddio perdono à dato10le miee preghiere con pianto meschiate àe exaudito Iddio, e l'oratione con gran benignità àe acceptate.11Vergógninsi e conturbin co·rragione tucti i nimici miei fortemente, voltinsi ad te con presta divotione.Mostrin tanta vergogna che la mente(?) gitti rossore fuora nelle gote acciò che da te acquistin ricche dote.
lavabo per singulas noctes lectum meum in lacrimis meis stratum meum rigabo.Turbatus est a furoreoculus meus, inveteraviinter omnes inimicos meos.Discedite a me omnes qui operamini iniquitatemquoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei,exaudivit Dominus deprecationem meam,Dominus orationem meam suscepit.Erubescant et conturbenturvehementer omnes inimici mei,convertanturet erubescant valde velociter.
Al Padre al Figliuolo al Paraclito flamen|122r| sia gloria come nel principio eraet è testé e senpre serà in terrain secula de' seculi dite amen.
Psalmo secondo [= Ps. 31]
Beati son coloro cui iniquitate son perdonate e coperti i peccati perch'ànno a Dio le membra humiliate.2Beato è l'uhomo a cui non inputati da Dio son vitii né à innel cuor dolo ma monstra fuor simil concepti nati.3Perché tacetti, tucte l'ossa àn duolo invecchiate nel male e io congrido senpre excusava quel che piango solo.
4Ma la tua man sì gravata è ch'io strido perché la spina di consciensa spessa e nella tenpesta converso rido.5Lo mio delicto l'anima già fessa a·tte appaleço et le ingiustitie non nascose da te ma le confessa.Dixi: Confesserò a Dio le mie nequitie |122v| accusando me solo, e tu più tosto perdon donasti alle crudel malitie.6Per questa venia nel tempo disposto accepto e opportuno, e ogna sancto ad te pregha ch'accepti lor proposta;niente men chi à vitioso amanto et nel diluvio di molte acque morte nuota, non preximranno [= non approximabunt] a·llui alquanto.7Tu mio refugio in tribulatione forte che intorno vanno, e se' mia allegreçça, rimuove me da cirumstante corte.8Dici: Droti [= tibi dabo] intellecto con certeçça insegroti [= instruam te] la via per quale andrai formrò in te la pupilla mia stessa.9Non vogliate superbi oggi né crai esser chavallo o mulo in cui intellecto non è né fu né giamai lo vedrai.Ma tu, Signor, guida in lor l'affecto con morsi e freno lor maxelle tiene |123r| chi da te si dilunghan per effecto.10Molti flagelli il peccator sostiene ma quale spera in Dio è circumdato da sua misericordia che 'l mantiene.11Godere in Dio esciti del peccato dentro e di fuora allegreçça monstrate perché giustitia inmente v'à fermatovoi che nel cuor dirictura portate di ciò che manda Iddio vi gloriate.Al Padre al Figliuolo allo Spirito sanctosia gloria laude honor e reverentiasì come nel principio eterno eraet è testé e senpre serà in terra
loda di tre persone in una essentiain secula de' seculi con cantodelli angeli che dicen sancto sancto. - Amen.
Psalmo terço [= Ps. 37]
Signor nel furor tuo e in tua ira non riprehender miei errori né me corregge |123v| ma senpre la tua gratia in me inspira3perché delle saecte tuoe le gregge a me intrate sono, e confirmasti sopra me la tua man che equità regge.4Nulla sanità in carne mia trovasti col volto d'ira tua né pace all'ossa presenti li peccati che schacciasti5per le miee iniquitate è stata smossa la testa alçata, e come charco grave mi son gravate ché venneno a scossa.6Puççulente e corrocte son le prave cicatrice rimase de' peccati per mia stoltitia che è maggior che trave.7Misero facto sono e inchimati in fine al fine son li membri tucti e sempre il dì ne vanno contristati8perché li lonbi miei di bene asciutti d'ilusion son pieni e dan tempesta e sanità non ò ma amari lucti.|124r| 9Aflicto sono e humile è la testa sì che ruggir mi fa per contritione el pianto dentro quasi mi fa festa.10Signor dinanti a te è mia intentione lo desiderio già non t'è nascosto né come strido per gram devotione.11Lo cuor m'è conturbato e à deposto la mia forteçça che m'à abandonato el lume de' miei occhi fuggì tosto.12Li amici mie e i proximi da·llato contra me s'accostonno per offendere
e stetten fermi perch'era accusatoma li compagni che doveano intendere si partitten da lungha, e li adversari 13facevam força per mia vita spegnereet vanità diceam li contrarii che cerchavan far male a me innocente pensando inganno senpre in lor parlari.14Ma io sì come muto era tacente |124v| non aprendo mia bocca e non udiva sì come fusse un sordo non udente15e fatto son come ch'io non sentiva né à in bocca sua reprehensione chiudento tucti i sensi nullo apriva.16Signor, in ogni mia ostentione ò posta la sperança in te, mio Iddio, tu exaudrai le miee oratione17però ch'io dixi "I miei nimici, o pio, non si rallegrim sopra me alquanto", e smossi i piedi miei fenno acto rio.18So<n> a' flagelli apparecchiato tanto che ciò che vien sosterrò con dolceçça e dolor senpre in presentia e con pianto.19Io confessai la iniquità mia stessa e per lo mio peccato che ò commesso pensrò acciò che in te trovi allegreçça.20Ma li nimici miei forse ànno messo, vivi e valenti e son moltiplicati |125r| chi a torto odionno me che son già fesso.21Culor che renden mal per bem donati sparlavam di me perché seguìa la bontà e vertù da ciel mandati.22Signor mio Iddio, innella sancta via che è tua, non mi voler abbandonare prego non ti partir dall'alma mia.23Attende in mio aiuto ad perdonare tu che se' senpre la salute vera dà presto aiuto innanti che sia sera.Gloria sia al Padre in trinitateet al Figliuol che è somma sapientia
et allo Spirito sancto caritatecome era nel principio in una essentiaet è testé e senpre in veritatein secula de' seculi in sententiagloria laude honor e(t) excelletia. - Amen.
Psalmo quarto [= Ps. 50]
3Misericordia a me fa, gra(m) Signore, sicondo la miseriordia tua ch'è grande |125v| co·la qual tu sol<l>evi il peccatorele molte miserationi tuoe spande acciecba e rade la mia iniquitade co·lle tuoe mane tanto venerande.4Anco me lava perché son bructate le mie potentie da nequitia ria e dal peccato monda miee pedate5perché la iniquità mia vo che sia nel mio cognoscimento el mio peccato presente contra a me par senpre stia.6A te solo, Signor, io ò peccato el mal dinanti a·tte fei, che se' giusto et vinci ognun quando se' accusato.7Ecco di iniquità coperto ò il busto perché mia madre in esse e inne' peccati mi concepecte per lo primo gusto.8Con pia verità son mesculati li acti che monstri, e di tua sapientia li occulti e incerti m'ài manifestati.|126r|9Sopra di me sparge acqua di clementia cum ysopo pietoso e sarò mondo, lava e fa quasi nieve mia essentia.10Strò in udir te gaudioso e iocondo e le miee ossa ch'eran superbite si rallegranno in humiltà ch'abbondo.11Volta la faccia tua dalle ferite de' miei peccati e strugge le nequitie che in fin alle morelle [= midolle] eran già ite.
12Cuor mondo crea in me di tue [tucte cod.] divitie rinuova dentro spirito diricto acciò che scacci tucte miee malitie.13Non mi gittar da te per mio delicto el tuo Spirito sancto che mi tiene da me non toglier ch'io sarei aflicto.14Letitia salvera [= salutaris] rende alle vene et con principal spirto me conferma tenendo tucto il corpo colle rene.15Insegnrò a' malvagi e all'alma inferma |126v|le vie che tu c'insegni, e li spietati ad te si conventran con pace ferma.16Libera me, Signor, di que' peccati che son da carne e sangue, e goderae la lingua mia di don iusti mandati.17Signor, le labbra miee m'aperae la tua man sancta, e la bocca mia poi la laude tua e gloria annuntierae;18perché se sacrificio aver da noi volsuto avessi, donato l'arei, ma li holocausti d'animal non vuoi.19Accepto sacrificio a Dio farei con spirto tribulato e cuoir contrito se humiliato per pena il vedrei.20Amor benigno, fa perché perito non sia ·l tuo nome in Syon monte sancto e tua Ierusalem n'abbia il suo sito.21Quine acceptrai sacrifici con canto holocausti con altre oblatione, |127r| vitelli sopra l'altar tuo dram pianti.Quivi exaudrai le sancte oratione le qual vi si faran con divotione.Gloria al Padre e gloria al suo Natogloria a Spirito sancto ch'è clementecome in principio era in ogna menteet è testé e senpre fi' chiamatoin secula de' seculi beato. - Amen.
Psalmo quinto [= Ps. 101]2L'oration mia, Signore, me exaudisce el grido ch'è pietoso ad te pervengna e con salute di me m'ammonisce.3La faccia senpre inver la tua mantegna in dì qualunque io sia tribulato li orecchi inchina pei quai mi sostengnaquandumque io chiamo te sii mio advocato, presto m'exaudi perché non smarriti veggia i miei sensi e sia anichilato.4Li miei dì come fumo [furno cod.] son fuggiti et l'ossa miee come arse le vedea |127v| aride diventar e i dì finiti.5Son come fien percosso, e 'l cuor parea secco perché mangiare il mio pan solo di meritar già mai non lo dovea.6Dalla voce d'interno pianto e duolo l'osso con carne s'è inunto non sano tanto ch'io strido più ch'io non suolo.7Simile facto sono al pellicano che è solo, e come nicticora canto lo qual ne' casalin fa verso strano.8Vegghiai, e·lle miee voce pien di pianto son come pàssar solitario in tecto lo qual con voce sua dilecta tanto.9Tucto dì villanie con gran sospecto diceam li miei nimici, e i laudatori iuravan contra me in mio dispecto10perché maggiavan cenner in fervori come se fusse pane e lo ber mio con pianto mesculava e con dolori,|128r| 11dal volto dirà che suol esser pio et dalla indegnation tua mi nascondo ché mi levasti e desti colpo rio.12Li dì vixuti come ombra in profondo son iti, e io quasi il fien ch'è tagliato d'aridità con secco grande abbondo.13Ma tu, Signor, in eterno fermato se' e srai senpre, e fi' il memoriale
da tucte generation laudato.14Con pietà ti levrai al tuo iocale monte Syon che è sì derelicto che è tempo di misericordia avale,15però ch'a' servi tuoi è nel cuor scripto amor di Syon, e suoe pietre sancte mostran pietà a·lluogho ch'è devicto.16Lo nome tuo le gente tucte quante temranno, ei tucti re che sono in terra lodram tua gloria in eterno stante17ch'edificrà Syon, se 'l ver non erra, |128v| Signore Iddio, e srà veduto in gloria con maestà la quale fi' sença guerra.18Guatò nell'oration pia e notoria delli humili, e·lli lor preghi divoti non dispregiò ma donò lor victoria.19Scrivasi questo perché l'idioti ricòrdinsi nel tempo che è futuro; et chi verrà, Iddio laudrà [landra cod.] con voti;20perché dall'alto excelso sancto e puro luogho guardò e da' cieli beati considerò il terren cotanto obscuro21per udir pianti delli incatenati et sciolger [= solveret] dei figliuoli i gram legami di culor che da morte fun spegnati22perché in Syon lo nome di Dio chiami ciascuno, e in Ierusalem che è santa la laude sua e gloria vi si brami23in convenir populi in una pianta e i re che insieme servano al Signore, |129r| li farà uno e dirà "Qui si canta"24Yerusalem rispuose i(n) salvatore che di vertù è via, e disse a Dio: Nuntia il breve tenpo, o creatore,25nel meço de' miei dì maggior mi è pio non rivocar me perché li anni tuoi finno in generation tucte, e non io.26Inel principio tu, Signor, che puoi terra fondasti e opra di tuoe mane son li cie<l>i sancti innequa' star tu vuoi.
27Perano essi come cose vane ma tu ste senpre, e quasi vestimento ciascuno invecchierà in viçe extraneet come copertoi drai mutamento 28et mutrassi ogna cosa, ma tu strai senpre, e delli anni tuoi neun fi' spento. 29Li figliuol de' tuoi servi ch'arai abitran teco, el seme lor superno in secula dirissar lo farai|129v| acciò che teco che se' in eternoviva, te conlaudando in sempiterno.Al Padre al Figliuolo allo Spirito sanctosia gloria come nel principio eraet è testé e senpre serà in terrain secula de' seculi con canto. - Amen.
Psalmo sesto [= Ps. 129]Iddio, nel profondo ad te gridai che se' lo scampo della vita mia 2exaude l'oratione e i preghi omai.Intendan tuoi orecchi e aprin via alla mia voce che pregha humilmente, non mi lassar in questa pena ria.3Se observrai le iniquità nocente, Signor, chi sosterrà pena condegna qual meritrebbe dipartir dolente?4Ma perché in te clementia e perdon regna e per la legge tua che de leggieri da te sostenni ciò che vuoi che venghna|130r| fidò<s>si l'alma in parole vertieri di lui lo qual sostenne, e la sperança 5solo in Dio puose e tucti i suoi pensieri.6Dal dì che nasce l'uomo e sua stança fine all'ultima nocte Israel sancto speri in Iddio che li drà possança7che di misericordia in lui è tanto che n'à parte ciascuno, e copiosa
redenption si ve' socto 'l suo amanto.8Et esso com potentia gloriosa ricompera d'Israel tucti quanti da ogna iniquità sua vitiosa,et noi tucti cavrà de' nostri piantimenandoci quin u' son dolci canti.Gloria al Padre e al Figliuol si cantisempre in eterno sença mai restareet a Spirito lor sancto de' sanctiin secula de' seculi gridareloda con amen per ben confermare.
|130v| Psalmo septimo [= Ps. 142]
Exaude Iddio l'oration devota co' tuoi orecchi li preghi miei tanti con verità e giustitia tua nota,2et non intrare in giudicio coi fanti perché nel tuo conspecto nul vivente iustificar si potrebbe co' sancti.3Lo mio nimico à si miee forçe spente perseguitando l'alma ch'è mia vita humiliò in terra che è presenteallogòmi in obscuro come a chi è escita 4l'alma, e sta in me lo spirto trangosciato el cuor turbato mi dà gran ferita.5De' dì antichi mi son ricordato et di tucte tuoe opre io pensava et penserò di ciò ch'ài tu creato.6Le man miee iuncte inverso te ledava(?) et l'anima più arida trovai che terra, la quale acqua non bagnava.|131r| 7Presto m'exaudi, Signor, perché sai lo mio biçogno, e vedimi manchare lo spirto mio s'aiuto non drai; la faccia tua da me non rivoltare perché simil sarei coi descendenti nel lago quando si vanno annegare.
8La tua misericordia fa' non stenti ma fa' ch'io loda tosto da mactina perch'esser mia sperança in me lo senti;manifesta la via con tua doctrina per la qual vada sì ch'io non offendi perch'a te dirissai l'alma tapina.9Toglie me da' nimici, ché comprehendi ch'a te io fuggio che se' mio Iddio. 10Insegna che in voler tuo tempo espendi(?)in terra ricta lo spirito pio mi guiderà, e per tuo nome sancto in equità drai vita e buon disio,et di tribulation l'anima tanto |131v| 12cavrai che tucti gl'inimici miei con pietà schaccerai e drai lor pianto,disperderai li tribulanti rei che molèstanmi l'alma per uccidere perché tuo servo senpre esser vorreiperò contrito e tribulato striderequi voglio acciò che in ciel vi possa ridere.Gloria sia al Padre del superno regnoet al Figliuol co·llo Spirito sanctosì come senpre si cantò tal cantocosì in eterno sia come io insegnoin secula de' seculi honor degno. - Amen.
Qui scripsit scribat senper cum Domino vivat.Vivat in celis Iordanis nomine felix.
[Dopo spazio bianco di circa una riga, in fondo e a fine carta 131v, altra mano quattrocentesca (post 1438), scrive nota di possesso del codice; nota molto sbiadita, forse erasa; tratti grafici affini alla precedente scrittura del copista Giordano, ma non identici; confronta Q e G maiuscole nella medesima carta, d, r:]
Questo libro è de' poveri Jhesuati ha-bitanti a Sancto Giusto a le Mura fuoride la porta a Pinti in(?) Firençe.
finis!
Simone di maestro Filippo da Càscina OP
Pisa 1390-1391 ca.: sermone di licenza e vesperieper il magistero in teologia
di Federico di Frezzo ("Frezzi") da Foligno OP
■ Bibl. Apostolica Vaticana, Barb. lat. 710 (xv in ), ff.106vb-108vb ■
■ Dedicato alla signora prof.ssa Elena Laureti, folignate, autrice di Il Quadriregio di Federico Frezzi da Foligno. Un viaggio nei Quattro Regni, Foligno 2007, pp. 592.Di sua iniziativa ha provveduto (febbraio 2007) riproduzione,e sviluppo su carta, di questi folii del codice Barb. lat. 710. Grazie.La medesima dott.ssa Laureti mi ha poi fatto dottorale precetto perché trascrivessi traducessi e pubblicassi il testo nel web. E a più riprese ha pungolato la mia scolasticapigrizia!
Compito eseguito nel corso del 2009. La traduzione, anzi il volgarizzamento!, portato a termine a fine 2009.
■ 2017. Da Pisa la dott.ssa Marina Soriani loda i miei compiti scolastici, ma mi prescrive talune correzioni. Da lettera 06 febbraio 2017: «(…). Nel
mio piccolo credo di aver risolto un dubbio di un passo delle Vesperie: unde Beda in libro De natura rerum: ... nubibusque formatur dum radius solis immissus concave nubi REPULSUS acie radii in solem restringitur instar cere ... Mi sembra che il concettosia chiaro: il raggio solare, respinto, si restringe ... Poco dopo: IN CAPITE nubis, que rara est; è preferibile risolvere: IN EA PARTE nubis que rara est... , in diretta correlazione con in parte densa, in parte densiori, in parte densissima etc. Peril resto siamo in totale accordo». Trasferitomi (ott. 2015) a San Domenico di Fiesole senza la mia personale biblioteca, non sono in grado di ricontrollarre il testo sulle riproduzoni del codice originale. Precedenza alle correzioni proposte dalla dott.ssa Soriani. E grazie!
Premessa1 Il latino di Simone2 licentia e vesperies: che cosa significano e che sono?
3testimonianza notarile: licenza in teologia, e connesse celebrazioni, a fra Andrea di ser Colo Geppi da Pisa OP (1409-10)
4 bibliografia di base
Sermo licentie quam dedi magistro Federico
Vesperie quas feci pro magistro Federico
Premessa
1. Anzitutto il latino di Simone e la mia traduzione italiana. A parte la tonalità ironica di tali atti accademici riversata nel lessico, confesso qualche perplessità nel definire, qua e là, l'articolazione sintattica del periodo, e delle singole proposizioni entro il periodo. Palese, la sua originaria oralità. Mentre peculiarità paleografiche o di compendio, proprie della scrittura (qui autografa) di Simone, possono essereattendibilmente sciolte sulla pista di ricorsi ed affinità; non senza qualche residua incertezza.
■ Cf. Cronica di Santa Caterina in Pisa. Copisti autori modelli, «Memorie domenicane» 27 (1996) 266-272.BAV, Barb. lat. 710 (xv in), mm 315 x 234, ff. 234, raccolta omiletico-scolastica di Simone, codice in granparte autografo.http://www.e-theca.net/emiliopanella/pisa/9600.htmhttp://archivio.smn.it/emiliopanella/pisa/9600.htm
2. I due sermoni (rigorosa composizione redazionale del sermo novus) ben illustrano i passi accademici della licentia ubique docendi (qualcosa come la nostra laurea!), suo sinonimo magistero. Almeno in Pisa di fine Trecento. Licenza di valenza universale (intendi "Europa cristiana"), e dunque concessa in radice da autorità universale (papato= auctoritas apostolica, poi anche impero).Vero e unico grado accademico, la licentia, che dava il titolo di magister ovvero il magistero; mentre il baccellierato era solo di nomina del maestro, con funzione d'insegnamento introduttivo e subordinato alle attività magistrali (lectio, disputatio, praedicatio). Tieni
conto dei molteplici trapassi della medesima licentia: pubbliche solennità in due sedute accademiche. In siffatto contesto lessicale, solemnis o solemnitas significavano primariamente pubblico, atto di diritto pubblico.
Il magister aulandus indìce, 8/15 giorni in anticipo, lequestioni da disputare:
Seduta I, vesperies (così dette perché tenute di sera o pomeriggio; seduta seròtina): a) expectativa magistrorum, vi sono attivamente impegnati i baccellieri sotto la presidenza del maestro; b) vesperies propriamente detta (2a
quaestio), disputata tra il vesperiandus o aulandus e due maestri aulati.
Seduta II, aulica: a) disputa nella quale è impegnato il baccelliere formato, cui muovono obiezione sia l’aulandus che gli aulati (3a quaestio); segue disputa tra i maestri (4a quaestio); b) resumpta: compito esclusivo del magister novus seu aulandus, che riassume tutta la disputa precedentee ne dà la terminatio (soluzione magistrale).
Il tutto termina con la traditio degliinsignia magistralia o insignia doctoratus (berretto, bacio, anello, magistralis infula o benda bianca a mo' di corona, o sertum= corona floreale, libro aperto ecc.) epubblico banchetto... a spese del neomaestro! "Io fui conventato" - fa dire Boccaccio a maestro Simone
(Decameron VIII.9.87): = "fui addottorato!" <── nota qui il birretum rotundum sul capo di Tommaso d'Aquino: non elemento dell'abito domenicano, ma distintivo del solo fratre che ha conseguito la licenza o magistero; talvolta usurpato da chi maestro non era, e pertanto punito dalle autorità dell'ordine. MOPH VIII, 229/32 (1434); VIII, 243/32 (1439).
■ Pisa 1.VI.1409, il candidato baccelliere viene examinatus e approbatus; 2.VI.1409 viene licentiatus, ovvero riceve la licenza magisteriale, premesso il giuramento;
3.VI.1409 vesperiatus; 4.VI.1409 riceve le insignia doctoratus: M. SORIANI INNOCENTI, Per la storia dell’Università di Pisa: ricerche e documenti, «Bollettino storico pisano» 63 (1994) 214-217: importante documento per seguire i molteplici passaggi accademici e le pubbliche celebrazioni per il magistero, almeno nell'area pisana.
3. ASF, Notar. antecos. 8066, ff. 260v-261r (Pisa, chiesa cattedrale, 26.I.1410), rubrica marginale Privilegium magistratus magistri Andree Geppi. Importante atto notarile che attesta legale procedura nel conseguimento della licentia; testimonianza complementare alle celebrazioni accademiche raccolte da Simone da Cascina. Fra Andrea del fu ser Colo Geppi da Pisa OP, il giorno giovedì 5.XII.1409 era stato licenziato in sacra teologiada messer Iacopo Arrigoni de Balardis da Lodi OP (vescovodi Lodi 1407-18, † 1435: SOPMÆ II, 298) per autorità del papa d'obbedienza pisana Pietro Filargis dell'isola di Creta (= Alessandro V, 7.VII.1409 - 3.V.1410); successivamente, domenica di Settuagesima 19.I.1410, vesperiato da maestro Simone del fu maestro Filippo da Cascina OP; e ora, domenica di Sessagesima 26.I.1410, nella cattedrale pisana il medesimo maestro Simone gli rilascia il privilegium magistratus, o insignia doctoratus, sempre per autorità apostolica.
Privilegium magistratus magistri Andree Geppi
Pubblico attestato del magistero di Andrea Geppi
originale latino volgarizzamento (2009) di EP
|260v| «In nomine Domini, amen. Universis et singulis,presentes literas seu publicum instrumentum inspecturis, pateat evidenter qualiter reverendus vir sacre theologie magister, magister
Nel nome del Signore, amen.A tutti e singoli che
leggeranno questa lettera, ovveropubblico attestato, sia evidente quanto segue:
Il reverendo maestro in teologia, maestro Simone del fu maestro Filippo da Càscina dell'ordine dei frati Predicatori
Simon olim magistri Filippi de Cascina ordinis fratrum Predicatorum, habens de infrascriptis omnibus et singulis specialem et generalem comissionem et auctoritatem, sibi iniunctamet datam a reverendo in Christo patre et domino, domino Iacobo, Dei et apostolice sedis gratia episcopo laudensi necnon magistro apostolici palatii,ex auctoritate sibi iniunctaa sanctissimo in Christo patre et domino nostro Alexandro divina providentiapapa quinto, ut de commissione et auctoritate dicti magistri Simonis constat per cartam rogatam et publicatam a ser Filippo filio Francisci olim Lippi de Pistorio, publico imperiali auctoritate notario atque iudice ordinario, sub anno dominicenativitatis millesimo quadringentesimo nono, indictione tertia, tempore eiusdem sanctissimi domini nostri pape, die quinta mensis decembris [= 5.XII.1409] secundum cursum et consuetudinem notariorum civitatis Pistorii,
(= domenicani), aveva ricevuto specifica e generale delega ed autorità circa tutti gli atti legali qui di seguito annotati, dal reverendo in Cristo messer Iacopo, per grazia di Dio e dellasede apostolica vescovo di Lodi, nonché maestro del palazzo apostolico, per autorità conferitagli dal signore nostro Alessandro V papa per divina provvidenza. Siffatta delega ed autorità concessa a detto maestroSimone, è testificata da diploma rogato e reso pubblico da ser Filippo di Francesco del fu Lippoda Pistoia, notaio pubblico e giudice ordinario per autorità imperiale, nell'anno dalla natività di nostro Signore 1409, indizione terza, essendo papa il medesimo summenzionto signore nostro santissimo, giorno 5 dicembre, secondo stile cronologico in uso presso il notariato della città pistoiese.
die dominica que fuit dies Nella domenica che ricorreva
nonadecima presentis mensis ianuarii [= 19.I.1410], Pisis in ecclesia Sancte Caterine fratrum ordinis Predicatorum predictorum, venerabilem virum fratrem Andream olim ser Coli Geppi de Pisis eiusdem ordinis Predicatorum, licentiatum insacra theologia a prefato domino episcopo laudensi auctoritate apostolica, ut constat per cartam rogatam et publicatam a prefato ser Filippo notario de Pistorio supra nominato, dictis anno et indictione, die quinta dicti mensis decembris [= 5.XII.1409], vesperiavit solempniter sibique vesperias dedit cum omnibus solempnitatibus debitis et consuetis, assistente magistrorum, doctorum, bacchalariorum et nobilium civium multitudine copiosa.
il 19 gennaio <1410>, nella chiesa pisana Santa Caterina dei frati dell'ordine dei Predicatori, il maestro Simone daCàscina celebrò e concesse pubblicamente le vesperie al venerabile fra Andrea del fu ser Colo Geppi da Pisa, del medesimo ordine dei Predicatori, celebrando tutte le solennità debite e consuete, e alla presenza di gran numero di maestri, dottori, baccellieri e nobili cittadini.
Il medesimo fra Andrea aveva precedentemente ricevuto la licenza ovvero il grado accademico di magistero in sacra teologia, dal suddetto signor vescovo di Lodi per autorità apostolica, come risulta dal diploma rogato e reso pubblico dal predetto notaio ser Filippo da Pistoia, anno e indizione suddetti, giorno 5 del mese di dicembre <1409>.
Deinde quia dignum et congruum est ut qui in scientia theologie laboravitin sua iuventute intentis vigiliis, multis sudoribus, assiduo studio, sollicitis repetitionibus, exercitio utili, disputationibus crebris, doctrinis catholicis, inquisitivis controvertiis, ardentibus
Inoltre, c'è chi ha molto faticato nella scienza teologica fin dalla propria giovinezza: veglie intense, sforzi plurimi, studio assiduo, ripetizioni rapide, esercizi proficui, dispute serrate, elaborazioni teologiche, dibattiti investigativi, prediche infiammate. Bene, è cosa degna edopportuna che costui venga incoronato del titolo della medesima teologia. E pertanto il
predicationibus, mereatur ipsius theologie titulo laureari, die dominico, que fuit dies vigesima sexta presentis mensis ianuarii, in cathedrali ecclesia pisana idem magister Simon ex auctoritate predicta eidem fratri Andree posuit et dedit insigna doctoratus,cum quibuslibet sollempnitatibus in similibus actibus solitis exerceri [sibique dedit et concessit tenore presentium plenariam licentiam et facultatem ubique locorum publice legendi disputandi terminandi et diffiniendi ineadem scientia brano barrato] velut sacre theologie magistro |261r| egregio, assistente magistrorum, doctorum, bacchalariorum, prelatorum, clericorum et nobilium civium multitudiniecopiosa, ut supra. In quorumomnium testimonium, presentes literas seu publicum instrumentum fieri fecit per me Franciscum notarium suprascriptum [= Franciscum olim ser Pieri deGhessano].
giorno di domenica, ovvero il 26 del presente mese di gennaio <1410>, nella chiesa cattedrale di Pisa il medesimo maestro Simone, sempre per autorità apostolica, impose e dètte allo stesso fra Andrea le insegne di dottorato, con talune pubbliche celebrazioni consuete in tali atti, [e gli concesse inoltre, a tenore della presente lettera, piena licenza e facoltà - valide in ogniddove e pubblicamente - ditenere lezione, di indire disputae di concludere la distuta con defintiva sentenza in materia della medesima scienza teologica brano barrato] come compete ad illustre maestro di sacra teologia; il tutto alla presenza d'una grande moltitudine di maestri, dottori, baccellieri, prelati, chierici e nobili cittadini, come sopra. A testimonianza di tutto ciò, (maestro Simone) ordinò che questa lettera ufficiale, ovvero pubblico attestato, fosse da me redatta, Francesco del fu Piero da Ghezzano, notaio.
Datum et actum Pisis, in suprascripta ecclesia cathedrali pisana,
Atto rogato in Pisa, nella suddetta chiesa cattedrale, presenti il venerabile signor
presentibus venerabili viro domino Iohanne Macthei de Vico, canonico pisano, presbitero Andrea olim item Andree et presbitero Iacobo olim ser Tomasi de Malaventre predicte ecclesiepisane cappellanis, Leopardoolim item ser Leopardi cive et mercatore pisano de cappella Sancte Eufrax(ie) et ser Guillelmo notario olim ser Iacobi domini Chelli de cappella Sancti Laurentii de Rivolta, et pluribus aliis testibus ad hec vocatis et rogatis, dominice incarnationis anno millesimo quadringentesimo decimo, indictione tertia, die vigesimo sexto ianuarii,secundum cursum pisanum [= 26.I.1410], pontificatus eiusdem domini nostri pape Alexandri anno primo».
Giovanni di Matteo da Vico, canonico pisano, prete Andrea delfu Andrea, e prete Iacopo del fu ser Tommaso da Malventre, entrambi cappellani della predetta chiesa pisana, Leopardo del fu ser Leopardo cittadino e mercante pisano della cappella Santa Eufrasia, e ser Guglielmo notaio, figlio del fu ser Iacopo di messer Chello della cappella San Lorenzo di Rivolta, e molti altri testimoni appositamente convocati e richiesti, nell'anno dall'incarnazione del Signore 1410, indizione terza, giorno 26 di gennaio, secondo stile cronologico pisano, anno primo del pontificato del medesimo signore nostro papa Alessandro.
ASF, Notar. antecos. 8066, ff. 260v-261r: Pisa, chiesa cattedrale, 26.I.1410.
Archivio di Stato di Firenze, Notarile antecosimiano 8066, ff. 260v-261r.
4. Bibliografia di base. - T. KÄPPELI, La raccolta di discorsi e di atti scolastici di Simone da Cascina O.P. († ca. 1420), AFP 12 (1942) 185-246, in particolare pp. 202 n. 42 (provincialato di Frederico da datare 1402-04), 216, 220, 226n.
SOPMÆ I, 403-05; IV, 89. Corretta antroponimia: "F(r)ederico (figlio) di F(r)ederico (ovvero Frezzo) da Foligno" = Federico di Frezzo da Foligno († 1416).Pisa, autunno 1388, «Sermo licentie quam dedi magistroVenture de Mevania et magistro Bartholomeo Tebaldi ordinis Predicatorum in pisana ecclesia katedrali» (BAV, Barb. lat. 710, ff. 103va-104rb).C. PIANA, La facoltà teologica dell’università di Firenze..., Grottaferrata 1977, 41, 496-98.O. WEIJERS, Terminologie des universités au XIIIe siècle, Roma (Ed. dell’Ateneo) 1987; in particolare III-C, Les examens et le grades, pp. 385-424.MAIERÙ, Formazione culturale e tecniche d’insegnamento nelle scuole degli Ordini mendicanti, AA.VV., Studio e studia: le scuoledegli Ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo, Spoleto 2002, 5-31.ELENA LAURETI, Il Quadriregio di Federico da Foligno. Un viaggio nei Quattro Regni, Foligno (Associaz. Orfini Numeister) 2007, pp. 592.
Simone di maestro Filippo da Càscina OPSermo licentie quam dedi magistro Federico
(Pisa 1390-1391 ca.)BAV, Barb. lat. 710, ff. 106vb-107va
originale latino volgarizzamento (2009) di EP
|106vb...| SERMO LICENTIE quam dedi magistro Federico, qui fuit provincialis romanuset episcopus fulginas.
Sermone di licenza o dottorato che conferii a maestro Federico, a suo tempo provinciale (1402-1404) della provincia romana (deifrati domenicani) nonché vescovo di Foligno (1403-1416).
Perscruptata [sic] fidelitersacra pagina ut iuxta nomen
Ho passato in rassegna tutta labibbia per trovare un versetto
nostri examinati thema proponerem, nullibi nomen suum reperiens fessusque queritando inveni verbum habens tres sillabas de quatuor sillabis nominis eiuset tertiam partem quarte, ut proferendo omnibus innotescet. Et enim repertum verbum federis, quod est <prop>inquissimum huic vocabulo Federicus. Presupponendo igitur fore sincopam auferentem de medio,iuxta hoc nomen federis thema summo [sic] et est tale:
Hoc signum federis quod dointer me et vos, scribitur <Gen.9>.
tematico basato sul nome del nostro candidato, ma nulla ho trovato. Ormai stanco, gli occhi mi son caduti su una parola a tresillabe, contro le quattro del suo nome, e con la sola terza parte della quarta sillaba, come risulterà dalla pronuncia. La parola trovata è federis (federazione, patto), molto prossima a Federicus (Federico). Prendiamo dunque federis come esitodi sincope, ovvero parola contratta per la caduta d'una sillaba interna, e adottiamola a tema del sermone:
Questo è il segno della federazione (ovvero alleanza), che io pongo tra me e voi, Genesi 9,12.
Mei domini, nunc non torpeat desidia animus sed attentus et pervigil restringat spiritus proprios,ac alis subtilitatis et intelligentie per vias syderum evolet ad superna palatia, ubi cernet sacratissimam nostram theologiam tenentem serta plena violis, rosis et floribus, ac offerentem accipientibus eius insigna, et dicentem Hoc signum federis quod do inter me et vos. Ut enim hic inferius magistri theologie dant corpori magistrandi in signum doctoratus corporale birretum
Signori miei, la nostra mente non ceda alla poltroneria, ma benconcentrata e vigile raccolga i propri spiriti. Con le ali dell'acutezza e dell'intelligenzacorra le strade stellari e voli fino alla reggia celeste. Qui vedrà la nostra santissima teologia; ella reca in mano una corona di viole rose fiori, e consegna ai candidati le proprie insegne, dicendo Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi.E come i maestri in teologia daranno poi al magistrando il berretto fisico e il bacio a simbolo del dottorato, così ora questa regina supernobile dona pressoché l'impronta dell'animo, ovvero la corona delle virtù |107ra| e il suo rigogliosissimo
et osculum, sic hec regina prenobilis largitur animo quasi karacterem, virtuosam coronam et floridam eam |107ra| perfectissime exornationem.
ornato.
Hanc nunc adeamus ut intersimus eius leto festo etcelebri, videamusque dum porriget huic presenti licentiando odoriferum suum sertum. Ibi aderunt qui didicerunt lacteam doctrinam gramatice, colores mellite recthorice ac qui versutias loyce imbiberunt. Ibi assistent ambulantes per scientiarum quadruvium. Ibi medici, philosophy, theologi aliique dilectores scientie, ducti cordis iubilo, melodia melliflua, ob reverentiam nostri licentiandi, efficientfestam diem.
Andiamole incontro, partecipiamo alla sua festa esultante e solenne; guardiamola mentre porge al dottorando la suaprofumata corona floreale. Saranno presenti, lì, gli alunni che hanno imparato la dottrina latticina della grammatica, i colori della retorica zuccherosa,e che hanno ciucciato le malizie della logica. Lì, saranno presenti tutti i pellegrini del quadrivio delle scienze (aritmetica, geometria, musica, astronomia). Lì i medici, i filosofi, i teologi, e tutti gli altri amanti del sapere, sospintida tripudio corale e da saporosa melodia, per onorare il nostro licenziando faranno gran festa.
Ergo cito passu pertranseamus syderum spatia ut participes simus tante letitie, tamque excellenti consortio coniungamur. Verum,quia secundum Apostolum, «nonsumus sufficienties ex nobis quasi ex nobis sed sufficientia nostra ex Deo est», inploremus divinum auxilium, Matrem gratie adeuntes pro gratia, proferentes verbum angelicum voce pia, dicentes sub
Affrettiamoci dunque attraversogli spazi siderali a partecipare a tanta letizia, e uniamoci a così nobile congrega. E poiché a detta dell'apostolo Paolo, «noi non siamo capaci di qualcosa in forza di noi stessi, ma la nostracapacità viene da Dio» (II Corinzi 3,5), imploriamo l'aiuto divino, rivolgiamoci alla Madre della grazia per ottenere grazia, e recitiamo con tono pio le parole dell'angelo, quasi in silenzio: Ave Maria eccetera.
silentio Ave Maria[1].Hoc signum federis quod do inter
me et vos, scribitur ut supra.Amantissimi patres,
anhelans huius nostri licentiandi et nostre theologie, in qua licentiari debet, laudes dignas depropere, pro introductione propositi thematis accipio verbum quod scribitur primi Paralipom(enon), xxij capitulo:«Introducatur archa federis[2]
D<omin>i et vasa Domino consecrata in domum que edificatur nomini Domini».
Questo è il segno della federazione (ovvero alleanza), che io pongo tra me e voi, Genesi 9,12.
Padri carissimi, desidero far degne lodi del nostro candidato alla licenza e della nostra teologia. E a introduzione del versetto tematico or ora proposto, prendo quanto scritto in I Cronache 22,19: «Introducete l'arca dell'alleanza del Signore,e i vasi consacrati al Signore, nel tempio che sarà eretto al nome del Signore».
Ubi, si mentis aciem figerelibeat, triplex conclusio innotescit:et conservatio archanorum supernalis deitatis, quia dicitur «Introducatur archa federis Domini»; est enim, ut dicit primum verbum thematis Hoc signum federis, scilicet cum Deo;annotatio instrumentorum internalis puritatis[3], nam dicitur «et vasa Domino consecrata»; ideo dicebat secundum verbum thematis quod do, idest recipientia idquod do;acceptatio magistrorum eternalis veritatis, quia dicitur «in domum que edificatur nomini Domini»,
Dal che, se è lecita una scaramuccia mentale, ne possiamo trarre tre conseguenze:- preservazione dei misteri dellasuperna divinità, laddove si dice«Introducete l'arca dell'alleanzadel Signore»; infatti, come dettonella prima parte del versetto tematico, Questo è il segno dell'alleanza con Dio; - annotazione degli strumenti della interiore purezza: «i vasi consacrati al Signore»; cui risponde il secondo elemento del versetto tematico che io pongo, ossia vasi che accolgono quel cheio vi ripongo;- accettazione dei maestri della verità eterna, laddove dice «nel tempio che sarà eretto al nome del Signore»: intendi, come vuoleil terzo elemento del versetto tematico, tra me e voi, dove voi staper maestri di teologia.
idest - ut dicit tertium verbum thematis - inter me et vos, scilicet theologie magistros.
Dico primo quod ponitur conservatio archanorum supernalis deitatis, quia dicitur «Introducatur archa federis Domini». Est enim, utdicit primum verbum thematis,Hoc signum federis scilicet cum Deo et cum magistris. Equidem, mei venerandi domini, introducatur archa federis Domini, idest sacra scientia introducatur in animam Federigi; nam hoc est signum federis cum Deo. Vel introducatur archa federis, idest scientia Federigi ducatur ad medium, quod erit signum federis cum magistris.
Dunque, prima conseguenza "preservazione dei misteri della superna divinità", in rapporto a «Introducete l'arca dell'alleanzadel Signore» (I Cronache 22,19). Questo segno dell'alleanza infatti, come risulta dalla prima parte del versetto tematico, è alleanzatra Dio e i maestri. S'introduca dunque, miei rispettabili signori, l'arca dell'alleanza delSignore, ossia s'introduca la sacra scienza nell'animo di Federico, e questo è il segno della federazione (o alleanza) con Dio. Oppure: s'introduca l'arca della federazione, come dire la scienza di Federico vengaqui al centro, segno della federazione con i maestri.
(→ Libeat... )
[1] Con l'invito alla preghiera, termina il pròtema del sermone medievale, cui segue ripresa e sviluppo del versetto tematico, quiHoc signum federis quod do inter me et vos.[2] La ripresa del tema viene introdotta da un'altra citazione biblica, che secondo le norme del sermo novus, porta almeno un lessema già presente nel versetto tematico, qui federis; e chiude proponendo la partizione del tema, qui tripartita. Segue il vero corpo del sermone, col commento e sviluppo delle singole partizioni. Il sermo licentie, dunque, si articola secondo il perfetto modello del sermone medievale.[3] internalis puritatis: non internalis parvitatis, come legge M. SORIANI INNOCENTI, La prédication à Pise: le cas du frère dominicain Simone de Cascina
(1345-1420 env.), AA. VV., De l'homélie au sermon. Histoire de la prédication médiévale, Louvain-la-Neuve 1993, 277.
Sermo licentie quam dedi magistro FedericoBAV, Barb. lat. 710, ff. 106vb-107va
originale latino volgarizzamento (2009) di EPLibeat, mei domini,
speculari subtiliter ut valeamus scientiam huius nostri licentiandi aliqualiter perlustrari.
Erat etatis tenerrime, cum insudare cepit in liberalibusstudiis, ut prepararet animumad suam theologiam dulcissimam. Fuit instructus diligentissime in congrua compositione sermonis. Astutulus factus et audax in veri discretione a falso, allectus eficacissime in exornatione sermonis qua veritas suadetur, plenissime vidit numerorum proportiones,mensuras geometricas, melodias mellifluas ac variosmotus corporum supernorum.
Concediamoci il piacere, miei signori, di una minuziosa indagine e proviamo a esplorare il sapere del nostro candidato alla licenza.
Era appena un ragazzotto quandosi dedicò allo studio delle arti liberali, e così preparò il suo cuore alla dolcissima teologia. Imparò con diligenza la corretta costruzione della parlata (grammatica). Divenuto più astutoe ardito nel distinguere il vero dal falso (logica), fu sedotto dal lustro del linguaggio ornato che rende appetibile la verità (retorica), apprese pienamente leproporzioni dei numeri (aritmetica), le geometriche misure (geometria), le saporite melodie (musica), gli svariati moti dei corpi celesti (astronomia).
Post hec, ad theologiam se transtulit, discurrens famosas civitates in studiis;ubi sic profecit laudabiliterut digne assignaretur per suum ordinem primo Florentie[1], secundo Bononie
Successivamente è passato alla teologia, e ha peregrinato per molte città celebri per le scuole. Con molto profitto. Cosicché ha avuto l'onore d'esserassegnato dalle autorità del suo ordine (domenicano) prima a Firenze, poi a Bologna, al
ad legendum Sententias pro magisterio obtinendo.
lettorato sentenziario, ovvero a tener lezione sul testo delle Sentenze (di Pietro Lombardo, † 1160) in ordine al conseguimento del magistero.
«Introducatur igitur archa federis», idest ducatur ad medium archa scientie Federigi. Est namque eius scientia vera et solida, non palliata sermonibus, non ficta sophismatibus, non tecta errorum nebulis obfuscatis. Est |107rb| eius scientia ornata moribus, plena virtutibus. Sit ergo hoc signum federis cum magistris; nam propter suam scientiam, quam venerandi magistri experti sunt in suo examine, que sic per istam provinciam diffusa est ut in aperto omnibus pateat, confederabitur hodie in licentia collegio magistrorum.
«Introducete l'arca della federazione» (I Cronache 22,19), ovvero sia esposta in pubblico l'arca della scienza di Federico.È una scienza autentica e solida,quella di Federico, non mascherata da parole, non inficiata da sofismi, non oscurata dalle nebbie degli errori. La sua |107rb| scienza è adorna di buona condotta, ripienadi virtù. Ecco dunque il segno della federazione con i maestri: a motivo infatti della sua scienza, riscontrata nell'esame da esperti maestri, ben diffusa in questa nostra regione e a tutti ben nota, il nostro Federico oggi sarà confederato, ovvero aggregato al collegio dei maestri.
Attamen, venerabilis licentiande, atte<n>de et intellige: magisterium non fore honorem sed honus. Ob quod, primam curam habe ut humilitate superes invidiam. Sit tui magisterii officium subvenire pauperibus, visitare languentes, provocare hospitio, lenire blanditiis, gaudere cum gaudentibus, flere cun flentibus. Cecorum sis
Quanto a te, spettabile licenziando, fa' bene attenzione:il magistero non è un onore, è unonere! Tuo primo impegno sarà contenere la presunzione con l'umiltà. Compito del tuo magistero sarà aiutare gl'indigenti, visitare i malati, soccorrere con ospitalità, consolare con dolcezza, gioire con chi gioisce, piangere con chipiange. Sii bastone dei ciechi, cibo degli affamati, speranza deidisperati, consolazione degli
baculus, esurientium cibus, spes miserorum, solamen egre lugentium. Ita emineas in virtutibus singulis quasi ceteras non habens. Sis intermagistros et coequales primusin opere, extremus in ordine,sis creber in orationibus, vigilans in predicationibus, in lectione assiduus, in disputationibus promptus, in sermonibus avidus, in consiliis verus, speculum in exemplis.
addolorati. Risplendi tanto nellesingole virtù, quasi che ti mancassero le altre. Tra maestri e colleghi sii il primo nell'agire, l'ultimo nella scala gerarchica. Fedele nella preghiera, avveduto nella predicazione, assiduo nelle lezioni, accorto nelle dispute, bramoso nei sermoni, sincero nei consigli, specchio nel comportamente esemplare.
Sermo tuus et confabulatio sit semper de scripturis san<c>tis et de tua sacratissima theologia, quam in sponsam es hodie accepturus. Hec namque tua sponsa nec per ostentationem fingit, sensum verbis aperit,vera ut sunt diligit, falsa vitat, bona gratis exhibet, mala libentius tollerare facit quam faciat ullam iniurie ultionem, querit pro veritate contumeliam, lucrum reportat. Audi quid per Ugonem de Sancto Victore de se ipsa loquitur ipsamet: Egoerrantes revoco, egrotantes reficio, labentes erigo, laborantes conforto, honestatem diligo, sanctitatem amo, oscura clarifico, sapientiam infundo. Et pleni esse
Oggetto delle tue parole e delle tue conversazioni siano sempre le sacre scritture e la tua sacratissima teologia, che ora stai per prendere in sposa. Tale tua sposa non inganna per esibizione d'immagine, svela con parole il senso della vita, predilige la verità delle cose, evita la falsità, offre gratuitamente il bene; capace di far sopportare più volentieri il male anziché vendicarsi delle ingiurie, accettare offese per amor della verità, restituire i guadagni. Ascolta quel che ella dice di se stessa, con le parole di Ugo da San Vittore († 1141): «Io correggo gli erranti, ristoroi malati, rialzo i caduti, conforto gli affaticati, prediligo l'onestà, amo la santità, illumino le tenebre, infondo saggezza». In lei, tu esaminato, troverai diletto come nella somma dei tesori.
scientia non possunt qui me puritatis per altitudinem nonagnoscunt. In hac, examinate,delecteris quasi in omnibus divitiis.
Alii, ut dicit Ambrosius super Beati immaculati [Ps. 118,1], in auro, alii in argento, alii in vestibus, alii in possessionibus vinetis? se<??>tibus, alii inoperibus picture marmorum; indiversis denique singuli delectationes habent. Spiritualis in via testimoniorum celestium delectatur. Ob quod delecteris, noviter <licentiande?>, in ista scientia, ungas oleo lectionis tue ratis lacertos.Sit tibi tota die ac nocte exercitii usus in quadam celestium scripturarum palestra. Artus animi tui salubris spiritualium ferculorum esca consumet ut, cum adversarius adsistere ceperit et te pulvere sue temptationis asperserit, stesintrepidus.
Sant'Ambrogio nel commento a Beati gli uomini di integra condotta (Salmo 119,1): «C'è chi trova piacere nell'oro, chi nell'argento, chi nell'abbigliamento, chi nei possedimenti vari, chi nelle pitture marmoree; e ciascuno trova piacere nelle cose più diverse. L'uomo spirituale di questo mondo trova diletto nelle promesse celesti». Gioisci dunque, o nuovo licenziando, di questa scienza, e ungi con l'oliodel tuo insegnamento i muscoli della zattera. Giorno e notte fa'esercizio in una qualche palestradelle sacre scritture. Le giunture del tuo animo robusto sialimentino del cibo di piatti spirituali: quando il nemico tenterà d'accostarsi e ti soffierà addosso la polvere dellatentazione, resta impavido!
Dicit enim Ambrosius, ubi supra: Exerceamur indefesso meditationis usu; exerceamurante certamen ut simus certamini semper parati. Et cum frequentior adversarii ictus ingruerit, nunc inopia,
Dice ancora Ambrogio: Applichiamoci senza stancarci alla meditazione; applichiamoci prima della battaglia per esser pronti al combattimento. Il nostro avversario ci assale costantemente con i suoi fendenti: penuria, rapina,
nunc rapina, nunc orbitate, nunc corporis egritudine, nunc merore animi, nunc terrore mortis et acerbitate penarum, dicat unusquisque nostrum qui potuerit sustinere ac perpeti: «nisi quia lex tua meditatio mea est tunc forsitan perissem inhumilitate mea».
perdita dei cari, malattia, depressione, paura della morte, durezza delle pene. Chiunque di noi è riuscito a sopravvivere, ammetta: «se la tua legge non fosse la mia meditazione, sarei perito nella mia miseria» (Salmo 119,92).
Recte ideo ponebatur primo "conservatio archanorum supernalis deitatis"; nam hanc supernalem scientiam, que est archanorum Dei, debesmeditatione assidua conservare. Sed ponebatur secundo "annotatio instrumentorum internalis puritatis"; nam dicitur in Paralipom(enon) «et vasa Dominoconsecrata». Ideo dicebat secundum verbum thematis quod do, idest recipientia id quod do.
Giusto dunque porre come primo elemento della divisione la "preservazione dei misteri della superna divinità". Tale superna scienza dei misteri di Dio, tu devi coltivarla nella continua meditazione. Secondo elemento della divisione la "annotazione degli strumenti della interiore purezza"; si dice infatti «e i vasi consacrati al Signore», I Cronache 22,19. Pertanto la seconda parte del versetto tematico diceva che io pongo, ovvero vasi disposti a ricevere ciò che io dono.
Plane, mei domini, libeat perscruptari [sic] huius nostri licentiandi potentias anime, que sunt vasa Domino consecrata, dum sacratissimamteologiam contine<n>t, ac laboratores in ea quam plurimum insudant.
Perscruptemur primo potentias anime vegetabilis, que sunt attractiva, retentiva, disgestiva et expulsiva; quas intuebimur
Indagaghiamo allora, signori miei, le facoltà dell'anima del nostro licenziando, che sono vasiconsacrati al Signore, visto che contengono la sacratissima teologia, e i cui cultori faticano non poco.
Esaminiamo prima le facoltà dell'anima vegetativa: la attrattiva, la ritentiva, la digestiva, la espulsiva. Sebbene non adeguate alla sacratissima teologia del nostro licenziando, constateremo tuttavia che esse sgobbano nel fare molti lavori:
etsi non(?) fore capaces teologie sacratissime nostri licentiandi, tamen insudasse multimode, tum propter amministrationem necessariam factam corpori animam retinenti tum quia |107va| persuaserunt nostrum licentiandum theologiam attrahere, retinere, disgerere, falsa et frivola expellendo.
perché gesticono bisogni necessari ad un corpo che ospita un'anima; e perché |107va| hanno sollecitato il nostro licenziandoad attrarre la teologia, a ritenerla, a digerirla, e ad espellere frottole e quisquilie.
Perscruptemur in interiores et exteriores vires sensibilis anime, ac reperiemur fantasiam, sensum comunem, ymaginationem et extimationem in hac scientia laborasse magnis sudoribus, ita ut nuncupari eius vasa iam valeant. Nec minus fatigati sunt exteriores sensus, interioribus potentiis famulando.
Perscruptemur vires eius rationabilis anime, que sunt proprie vasa Domino consecrata, dum divinam teologiam intra se pretiosissime reconderunt. Eius namque voluntas pre aliis scientiis electione libera hanc elegit. Intellecuts discurrendo invenit eius conclusiones verissimas; quas memoria, ut debito loco et tempore effundat quibuslibet, in se
Guardiamo ai sensi interiori edesteriori dell'anima sensitiva. Vedremo che la fantasia, il sensocomune, l'immaginativa e l'estimativa hanno sofferto moltisudori in questa scienza, tanto che meritano d'esser chiamati vasi della teologia. E altrettando hanno faticato i sensi esteriori, prestando aiuto a quelli interiori.
Guardiamo alle facoltà dell'anima razionale del nostro licenziando; veri vasi consacratial Signore, perché hanno preziosamente custodito dentro disé la divina teologia. Con liberascelta la sua volontà ha anteposto la teologia a tutte le altre scienze. L'intelletto ha indagato ed è pervenuto a solidissime conclusioni; la memoria poi le serba in se stessa, per diffonderle a tempo eluogo opportuno.
glausit[2].Hec vasa igitur recipiant
id quod do, ut dicebat verbum propositum. Dabo enim licentiam istis potentiis ut quidquid quesierint invenerint vel voluerint sibiplacibile sit ratum firmum solidum autenticum approbatum.
Et hoc quia ponit tertio "acceptatio magistrorum eternalis veritatis", quia dicitur «in domum que edificatur nomini Domini», idest ut dicit tertium verbumthematis inter me et vos, scilicet theologie magistros.
Questi vasi dunque accolgano quel che io do, come voleva il versetto posto a tema del sermone. Darò licenza alle predette facoltà: che tutto quanto abbiano cercato, trovato, o quanto desiderato a loro gradimento, sia valido confermatostabile autentico approvato.
Ragione di ciò è il terzo elemento della divisione, la "accettazione dei maestri della verità eterna", perché si dice «nel tempio che sarà eretto al nome del Signore» (I Cronache 22,19); ovvero, come vuole il terzo elemento del versetto tematico, tra me e voi, ossia maestri di teologia.
Plane, mei amatissimi domini, magistri eternalis veritatis idest sacratissime theologie, hunc nostrum licentiandum acceptaverunt, voluntque ut introducam ipsum«in domum que edificatur nomini Domini», idest infra eorum collegium quod est quasi domus que edificatur inlaudem et gloriam nominis creatoris. Scribitur enim Gen. xxviij «Non est hic aliud nisi domus Dei et portaceli».
È chiaro, miei carissimi signori, che i maestri dell'eterna teologia, o sacratissima teologia, hanno acccolto questo nostro candidato alla licenza; e desiderano che iolo introduca «nel tempio che saràeretto al nome del Signore»; ovvero nel loro collegio, che è quasi il tempio costruito a lode e gloria del Creatore. È scritto infatti in Genesi 28,17: «Propiro questa è la casa di Dio, questa èla porta del cielo».
In hanc domum introducam hodie nostrum examinatum dando sibi licentiam, faciamque eum talis domus dominum et proprium
E in questa casa intendo indrodurre oggi il nostro esaminato concedendogli la licenza. Di tale casa lo farò signore e legittimo proprietario.
Prima della licenza però, o
possessorem.Attamen, noviter
licentiande, antequam dem licentiam, iurabitur: «Primo»etcetera. Et sequntur sex iuramenta posita superius in prima licentia[3].
Ad laudem igitur etgloriam, prout ibidemcontinetur.
nuovo licenziando, si farà il dovuto giuramento: «Primo, sarò fedele» eccetera eccetera. Seguono i sei capi di giuramento riportati sopra in occasione della prima licenza.
A lode e gloria, eccetera, comenel medesimo luogo.
[ Pisa 1390-1391 ca. ] [ Firenze 2009 !]
[1] Capitolo generale 1378, MOPH IV, 449/18-24: «Studium generale in Romana provincia, quod consuevit esse in Florencia, quia ibidem propter guerras non potuit congregari, ponimus in conventu pisano eiusdem provincie quousque provideatur de loco tranquillo; et facimus lectorem principalem fr. Iohannem Dominici Eugubinum; ad legendum Sentencias ibidem fr. Benedictum Franciscum; magistrum studencium fr. Iohannem de Cachina [= de Cascina?]; ad legendum ibidem bibliam fr. Fridericum de Fulgino». Qui Federico è baccelliere biblico, ruolo anteriore a quello sentenziario.[2] glausit = clausit; sonorizzazione non estranea al sistema fonetico dell'area. Nota ancora: Federigus (si alterna con Federicus ), ecc.[3] Nel medesimo codice, ff. 101r-102r. Formula del giuramento in M. SORIANI INNOCENTI, La prédication à Pise: le cas du frère dominicain Simone de Cascina (1345-1420 env.), AA. VV., De l'homélie au sermon..., Louvain-la-Neuve 1993, p. 271: fedeltà alla chiesa romana (I), difesa della fede cristiana (II), esaltare la città di Pisa (III), onore e venerazione del grado magisteriale (IV), nulla dire o fare contro Pisa e il suo governo (V), non spendere per il festeggiamento più di quanto stabilito dal diritto (VI). ID., Per la storia dell'Università di Pisa: ricerche e documenti, «Bollettino storico pisano» 63 (1994) 207-17, giuramento in pp. 216-17.
Finis!
-------------------------------------------------------
Simone di maestro Filippo da Càscina OP
Vesperie quas feci pro magistro Federico(Pisa 1390-1391 ca.)
BAV, Barb. lat. 710, ff. 107va-108vb
originale latino volgarizzamento (2009) di EP
|107va...| VESPERIE quas fecipro magistro Federico fuerunt michi ablate, ideo postea fecihunc sermonem et obmisi derisiva[1].
Avevo fatto il sermone in occasione delle vesperie (seduta seròtina) di maestro Federico, mami è stato sottratto; ho riscritto allora il sermone seguente e ne ho saltata la sezione derisoria.
Hoc signum federis quod do interme et vos.
Hic insistam principaliterin duobus:
- primo in derisivis verisystoriis ut humilietur; quoddemonstrabit totum themapropositum, dicens Hoc signumfederis quod do inter me et vos;
- secundo in instructivis claris victoriis ut dignificetur, quia Hoc signum federis quod do inter me et vos.
Questo è il segno della federazione (ovvero alleanza), che io pongo tra me e voi (Genesi 9,12).
Insisterò principalmente su due punti:
- primo, veri fatti irrisorii per umiliarlo, come mostra l'intero versetto tematico Questo è il segno della alleanza che io pongo tra me e voi;
- secondo, illustri vittorie istruttive per esaltarlo, poché Questo è il segno della alleanza che io pongo tra me e voi.
Dimisso primo principali, dico secundo quod insistam ininstructivis claris victoriisut dignificetur. Quia premia statuuntur hiis semper quibuscertamina dura proponuntur; ac pro magnitudine certaminis, premii ponitur magnitudo. Hinc est quod noster vesperiatus, studii sudores portavit ylariter, pericula despexit, sitim et famem sustinuit, ut post labores ad magisterii premiumperveniret. Dicitque magistris, a quibus sperat inbrevi accipere premium, Hoc signum federis quod do inter me et vos.
Ometto il primo punto. Punto secondo: illustri vittorie istruttive per esaltarlo. I premivengono deliberati per coloro cheaffrontano dure battaglie; e più grande è la battaglia, più grandeè il premio. Ora il nostro vesperiato ha sopportato con buonumore le fatiche dello studio, ha sprezzato i pericoli, ha sopportato sete e fame; il tuttto per raggiungere, dopo tante prove, il premio del magistero. E ai maestri, dai quali spera di ricevere presto ilpremio, dice: Questo è il segno della federazione che io pongo tra me e voi.
Ubi tria ponuntur:et primo demo<n>strationis
grata pulcritudo, quia Hoc signum federis;
secundo condonationis vera gratitudo, quia quod do
tertio colligationis firma sanctitudo, quia inter me et vos.
Dove vengono proposte tre distinzioni principali:
prima distinzione, gradevole splendore della manifestazione, Questo è il segno della alleanza;
seconda, autentica gratitudineper la donazione, laddove dice che io pongo;
terza, solida santità di ricongiungimento, laddove dice tra me e voi.
Dico primo quod ponitur demonstrationis grata pulcritudo, quia Hoc signum federis. Equidem noster vesperiatus demonstrat gratampulcritudinem archus celestis, dicens Hoc signum federis. Quid per archum celestem, idest yridem,
Prima distinzione, gradevole splendore della manifestazione: Questo è il segno della alleanza. Il nostro vesperiato indica la simpatica bellezza dell'arcobaleno celeste quando dice Questo è il segno della alleanza. Che cos'è l'arcobaleno celeste, ovvero l'iride, se non la sapienza rivelata? - come vuole Beda (673-753). La stessa iride
designatur nisi - ut dicit Beda - sapientia inspirata? Ipsa enim dicit: «Girum celi circuivi sola».
asserisce: «Il giro del cielo da sola ho percorso» (Ecclesiastico, o Siràcide, 24,8).
Audite quid legimus, Ecc. 43: «Vide archum et benedic qui fecit illum; valde enim |107vb| spetiosus est in splendore suo, giravit celum in circuitu glorie sue». Significat enim yris quadricolor: Christi divinitatem, humanitatem, penalitatem, formositatem. Nam in yride est:
- color ethereus limpidiusclarescens
- color ceruleus remissiuslucescens
- color coccineus intensiusrubescens
- color gramineus placidiusvirescens.
Sentite sentite cosa leggiamo in Ecclesiastico (o Siràcide) 43,11-12:«Osserva l'arcobaleno e benedici colui che l'ha fatto; |107vb| è bellissimo nel suo splendore, avvolge il cielo con un cerchio di gloria». I quattro colori dell'iride stanno per: divinità di Cristo, sua umanità, penalità,formosità. Vi è infatti nell'iride:
- colore etereo, o celeste, che s'illumina limpidissimo
- colore ceruleo, o azzurro, decrescente per luminosità
- colore scarlatto, più intenso del rosso
- colore graminaceo, moderatamente verdastro.
Unde Beda in libro De natura rerum: Archus in aere yrisquein corpore nubis quadricolor redditur ex sole adverso, nubibusque formatur dum radius solis immissus concavenubi(?) reple<??> acie radii in solem restringitur instar cere, ymaginem anuli reddentis; qui de celo ethereum, de aere ceruleum, de aqua gramineum, de terra coccineum trahit colorem. Namin capite nubis, que rara est, solares radii ethereum
Beda nella sua opera Sulla naturadell'universo: L'arcobaleno in cieloe l'iride nel corpo della nuvola sono resi quadricolore per contrasto col sole, ed sono formati dalle nubi quando il raggio solare immesso in una nubeconcava <?? ?? ?? ??> si restringe come fosse cera, a forma d'anello <??>; e dal cielo prende il colore etereo, dall'atmosfera quello azzurro, dall'acqua quello verdastro, dalla terra quello scarlatto. Infatti in capo alla nuvola, che è rarefatta, i raggi solari generano un colore celeste ovvero
idest yacintinum colorem faciunt, in parte dempsa ceruleum idest lividum, in parte densiori gramineum idest viridem, in parte densissima coccineum idest plusquam rubeum; vel in purpureum vel croceum obscurum colorem vergentem faciunt.
color giacinto (azzurro-violaceo), nella parte densa un colore ceruleo smorto, nella parte più densa un colore graminaceo verde, nella parte densissima un colore scarlatto, oltre il rosso; oppure fanno evolvere in colore purpureo o zafferano il colore scuro(?).
Sic radii inspirantes sapientiam scripturarum feruntur in nubem idest in capacitatem intelligentie et in corda sanctorum et doctorum. Et ideo ibi apparetrespectu Verbi incarnati:
- in nube lucida color ethereus preconium divinitatis
- in nube rorida color ceruleus vestigium humanitatis
- in nube solida color coccineus ludibrium penalitatis
- in nube limpida color gramineus presagium felicitatis.
I raggi dunque che destano la sapienza delle sacre scritture vengono orientati verso la nube ovvero verso l'abilità dell'intelligenza e verso il cuore dei santi e dei dottori. E là, in rapporto al Verbo incarnato, emerge:
- nella nube luminosa, il color celeste presagio della divinità
- nella nube rugiadosa, il colore azzurro impronta dell'umanità
- nella nube solida, il colorescarlatto scherno del castigo
- nella nube limpida, il colorgraminaceo presagio della felicità.
In nube lucida: «Nubes lucida obumbravit eos et vox de nube dicens "Hic est filius meus dilectus"». In nube rorida, hoc est que septenario donorum rorata est, 3 Reg. 18: «In septima autem vice: Ecce nubecula parva quasi vestigium hominis
Nella nube luminosa: «Una nuvola luminosa li avvolse con lasua ombra, ed ecco una voce che diceva: "Questi è il Figlio mio prediletto"» (Luca 9,35; Matteo 17,5). Nella nube rugiadosa, ossiache è stata irrorata col dono settenario, I Re 18,44: «La settima volta riferì: Ecco, una nuvoletta, come impronta di uomo,
ascendebat». In nube solida: nonne in ludibrium penalitatis veste coccinea vestitus est Dei filius, et antea pannis infantie obvolutus? Ecce quid ait Pater, Iob 38: «Posui nubem vestimentum eius, pannis infantie ipsum obvolvens». Innube limpida: nonne presagiumfelicitatis eterne fuit ascensionis triunphus? «Ponisnubem ascensum tuum», Ps. 103.
sale dal mare». Nella nube solida: a ludibrio del castigo non fu forse vestìto il figlio diDio con una veste scarlatta, e precedentemente avvolto in fasce infantili? Ecco quel che disse ilPadre, Giobbe 38,9: «Lo circondavo di nubi per veste, e lo avvolgevo in panni infantili».Nella nube limpida: il trionfo dell'ascensione non fu forse presagio della felicità eterna? «Tu fai delle nubi il tuo carro»,Salmo 104,3.
Unde beatus Ambrosius, sermone 64, tractans illud Actuum 1 «Nubes suscepit eum ab oculis eorum», ait: Videamus que ista nubes sit, quam splendida quam preclara,que lucem mundi Christum suscipere meretur, que radiosPatris in seipsa inflexit. Neque enim poterat obscura esse ac tetra vel tenebrosa, quia scriptum est «Et tenebrelucem non comprehenderunt». Tenebre enim lucem gestare non possunt. «Vide yridem et benedic qui facit illum, valde spetiosus est in splendore», non in tenebra eius.
Sant'Ambrogio, sermone 64, in commento ad Atti degli Apostoli 1,9 «Una nube lo sottrasse al loro sguardo», dice: Vediamo quale sia siffatta nube, quanto splendente, quanto luminosa: è degna d'accogliere la luce del mondo, il Cristo, che riflette i raggi del Padre. Non poteva essere oscura o tenebrosa, perchéè scritto: «E le tenebre non hanno accolto la luce» (Giovanni 1,5). Le tenebre infatti non sonoin grado di portar luce. «Osserval'arcobaleno e benedici colui chel'ha fatto, è bellissimo nel suo splendore» (Ecclesiastico, o Siràcide 43,11-12), non nelle sue tenebre.
Illa est enim nubes que ascendentem suscepit Christum, que et testimonium Christo etiam in monte perhibuit. De qua
La nube che accolse il Cristo ascendente in cielo è la medesimache sul monte rese testimonianza al Cristo. Dice l'evangelista: «Ed ecco, da una nuvola fu udita una voce che diceva: Questi è il
evangelista: «Vox de nube audita est dicens: Hic est filius meus dilectus, ipsum audite». Hec est sanctarum series scripturarum que omnesretro patres misterio obumbravit, dicente Apostolo:«Patres nostri omnes sub nubefuerunt». Ergo hoc signum federis, scilicet yris iste pulcerimus, scriptura Dei quatuor coloribus obiciebaturoculis nostri vesperiati. Quicolores erant causati celitusin nube, idest mente doctorum, et divinitus inspirati.
Figlio mio prediletto, ascoltatelo» (Matteo 17,5). Ecco il corpo delle sacre scritture che custodì gli antichi padri nelmistero della propria ombra; a detta dell'apostolo Paolo: «I nostri padri furono tutti sotto la nuvola» (I Corinzi 10,1). E pertanto questo segno dell'alleanza, ossia questo bellissimo arcobaleno della scrittura di Dio, è proposto tramite quattro colori allo sguardo del nostro vesperiato. Colori generati nel cielo delle nubi, ovvero nella mente dei dottori, e divinamente ispirati.
Ipsa enim scriptura:- vel est theorica et
speculativa, ecce color ethereus
- vel est phisica et figurativa, ecce color ceruleus
- vel est politica et informativa, ecce color coccineus
- vel est ystorica et enarrativa, ecce color gramineus.
La sacra scrittura:- o è teorica e speculativa,
ed ecco il color celeste- o è fisica e simbolica, ed
ecco il color azzurro- o è politica e informativa,
ed ecco il colore scarlatto - o è storica e narrativa, ed
ecco il color graminaceo.
Et isti colores facti sunt in nube, idest mente sanctorum doctorum radio inspirationis divine. Nam «Spiritu sancto inspirati loquti sunt sancti Dei homines», ut dicit Petrus apostolus. Hinc Ambrosius,
Tali colori si son formati nella nube, ossia nella mente deisanti dottori per il raggio delladivina ispirazione. Infatti «mossi da Spirito Santo parlaronoquegli uomini da parte di Dio» (II Pietro 1,21). Donde Ambrogio in commento a Luca 9,35: Sono nubi rugiadose, |108ra| che irrorano
v(ersicul)o 10 super Lucam: Sunt nubes roride |108ra| querore gratie spiritualis humectant. Aspice nubem in veteri testamento: «in columna nubis, inquit, loquebatur ad eos»; per Moysen utique loquebatur hic nubes magna; per Yehsum Nave,qui solem statuit ut plenioris acciperet in pulcrum yridem luminis claritatem.
con la rugiada della grazia spirituale. Considera la nube nell'antico testamento: «parlava loro da una colonna di nubi» (Salmo 99,7); qui la grande nube parlava tramite Mosè; e tramite Giosuè figlio di Nun (Ecclesiastico,o Siràcide, 46,1.4), il quale arrestò il sole (Giosuè 10,13) per riversare maggior splendore sul magnifico arcobaleno.
Ergo Moyses et Yehsus Navenubes sunt. Aspice quia sancti nubes sunt, qui sicut nubes volant, alta petere nonformidant. Superne nubes sunt Ysaias, Eçechias; que nubes michi per cherubin et seraphin yridem monstrant quomodo sanctitatem per ter Sanctus divine trinitatis ostendunt. Nubes sunt hii omnes ac nebule glorie, sicutde scriptura legimus: «Quasi archus refulgens inter nebulas glorie».
Mosè e Giosuè figlio di Nun sono dunque delle nubi. Fa' attenzione: i santi sono nubi, perché come nubi volano, e non temono le altitudini. Nubi superne sono Isaia, Ezechia. Nubiche tramite cherubini e serafini svelano l'arcobaleno, così come con il triplice Sanctus mostrano la santità della divina Trinità. Tutti costoro sono nubi e nuvole di gloria, come sappiamo dalla scrittura: «Quasi arcobaleno splendente fra nubi di gloria» (Ecclesiastico, o Siràcide 50,7).
In hiis nubibus venit Christus, quia legimus: «Apparebit Dominus super nubem candidam et cum eo sanctorum milia». Venit in nube in Canticis canticorum, serena nube et sponsi refulgens letitia. Venit in nube levi et candida incarnatus ex Virgine. Iam
In tali nubi verrà il Cristo, e infatti leggiamo: «Il Signore apparirà su nube splendente, e con lui migliaia di santi». Vennenella nube nel Cantico dei cantici (cf. 5,10), nube nitida, che splendeva della gioia dello sposo. Venne in una nube delicatae pura, incarnato nella Vergine. Il color graminaceo, o verde, staper preannuncio della felicità,
per colorem gramineum, idest viridem, intelligi dixi presagium felicitatis; quia scriptura sacra, qua «videmusnunc per speculum et enigmatice», insinuat presagium illius clare et refective visionis «que exuperat omnem sensum» et omnem humanam intelligentiam,antecellit huic visioni faciali, que solo intuitu oculos mentis satiat. «Satiabor, inquit Davit, cum apparuerit gloria tua».
come detto. La sacra scrittura, tramite la quale «ora vediamo come in uno specchio e in manieraconfusa» (I Corinzi 13,12), insinua il presagio d'una visionechiara e rinnovata «che sorpassa ogni facoltà» (Filippesi 4,7) e ogniumana intelligenza; che supera questa fisica visione, capace di saziare soltanto con una visione di occhi della mente. «Mi sazieròdella tua presenza quando apparirà la tua gloria», dice David (Salmo 17,15).
(→Yris ... )
[1] Altrove Simone: «Presens actus nominatur vesperie, quìa vespere fit; sive vesperie quasi vespe ree; sicut enim vespe, que sunt prave et ree, pungunt et cruciant, sic in isto actu consueverunt vesperiandi pungi duris aculeis dum quedam malefacta ad memoriam reducuntur» (M. SORIANI INNOCENTI, La prédication à Pise: le cas du frère dominicain Simone de Cascina (1345-1420 env.), AA. VV., De l'homélie au sermon..., Louvain-la-Neuve 1993, p. 273).Per esempi della "sezione derisoria" delle vesperie, vedi caso di Bartolomeo di Tebaldo da Orvieto (Pisa, autunno 1388).
Vesperie quas feci pro magistro Federico(Pisa 1390-1391 ca.)
BAV, Barb. lat. 710, ff. 107va-108vb
originale latino volgarizzamento (2009) di EPYris autem, idest sapientia
viatorum, est qua ex parte congnoscimus et ex parte
L'arcobaleno, ossia la sapienza dei pellegrini del mondo, è in parte conoscenza, in parte profezia. «Quando verrà ciò
prophetamus. «Cum autem venerit quod perfectum est», tunc «revelata facie gloriam Domini speculantes, transformabimur a claritate in claritatem tamquam a Domini spiritu».
che è perfetto» (I Corinzi 3,10), allora «a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, noi tutti verremo trasformati di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore» (II Corinzi 3,18).
Yris etiam similatur sapientie increate. Audite Ambrosium, libro De fide ad Gratianum, cap. 4: Prophete dicunt: "Splendor est lucis eterne, speculum sine macula Dei maiestatis et ymago bonitatis illius". Vide quanta dicantur: Splendor eo quod claritas paterne lucis in Filio sit; speculum sine macula, quod Pater videatur in Filio; ymago bonitatis, quod non corpus in corpore sed virtus in Filio tota cernatur. Ymagodocet non esse dissimilem; caracter expressum esse significat; splendor significat eternum.
L'arcobaleno inoltre è paragonato alla sapienza increata. Ascoltate Ambrogio, De fide ad Gratianum capitolo 4: Diconoi profeti: "E' uno splendore della luce perenne, specchio senza macchia dela maestà di Dio e immagine della sua bontà" (Sapienza 7,26). Nota l'intensità del messaggio: Splendore, in quanto luminosità della luce paterna nel Figlio; specchio senza macchia, in quanto il Padresi svela nel Figlio; immagine della sua bontà, non quasi corpo in un altro corpo ma l'intera potenza (divina) contemplata nel Figlio: l'immagine denota che nonè dissimile; il carattere denota che si è manifestato; lo splendore denota che è eterno.
Ymago itaque non vultus est corporalis, non p??s composita, non ceris, sed sinplex de Deo expressa de Patre consors nature, egressade fonte. Per hanc ymaginem Philippo Patrem Dominius demonstravit dicens: «Philippe, qui videt me, videt et Patrem. Quomodo tu dicis "Ostendi nobis Patrem"?
Immagine reale dunque, non volto fisico, non modellato da ??, non da cere, ma rigorosamente riflesso da Dio, partecipe della natura del Padre,sgorgata dalla sorgente. Con taleimmagine il Signore mostrò il Padre a Filippo: «Filippo, chi havisto me ha visto il Padre. Come puoi dire "Mostraci il Padre"? Non credi che io sono nel Padre eil Padre è in me?» (Giovanni 14,9-
Non credis quia ego in Patre et Pater in me est?». Videt ymaginem Patris, videt in Patre ymaginem, qui Patrem videt in Filio. Vides quam ymaginem dicat: ymago ista veritas est, ymago ista de??tus est, ymago ista sapientiaest, ymago ista vera vita est.
10). Vedrà il volto del Padre, vedrà nel Padre il volto, colui che vede il Padre nel Figlio. Nota di quale immagine sta parlando: questa immagine è la verità, questa immagine è ??, questa immagine è la sapienza, questa immagine è la vita.
Ecce quadricolor yris lucisinaccessibilis, unicus tamen sinplex individuus, consubstantialis, coevus, immensus. Ergo ymago ista nonmuta quia Verbum est, non insensibilis, quia sapientia est, non inanis quia virtus est, non vacua quia omnipotens vita est, non mortua quia resurrectio est. Resurrectio omnium electorum a?? a miseriis, a morbis, a tenebris, idest «quasi archusrefulgens inter nebulas glorie».
Ecco l'arcobaleno quadricolore: irrangiungibile, unico, incomplesso, individuale, consustanziale, contemporaneo, immenso. Tale immagine dunque nonè muta, perché è Parola, perché èsapienza; non è vana perché è potenza, non sterile perché è vita onnipotente, non defunta perché è resurrezione. Resurrezione di tutti gli eletti ?? dalle miserie, dalle infermità, dalle tenebre: «come arcobaleno splendente fra nubi digloria» (Ecclesiastico, o Siràcide, 50,7),
Dicit ergo noster vesperiatus: Hoc signum federis.Yris scilicet sacratissima theologia erit signum federis; mediante quo yride, videlicet divina pagina, confederabor et coniungar collegio magistrorum.
Et hoc de primo principali.
Dice dunque il nostro vesperiato (Federico): Questo è il segno della federazione. L'arcobaleno, ovvero la sacratissima teologia, sarà il segno della federazione; e tramite questo arcobaleno io saròconfederato ovvero associato al collegio dei maestri.
Fine della prima distinzione principale.
Secundo dixi quod ponitur condonationis vera
Seconda distinzione: autenticagratitudine per la donazione, laddove dice che io pongo o do. Il
gratitudo, quia dicit quod do. Equidem noster vesperiatus veram volens ostendere gratitudinem quia sacram scripturam accepit in ingens donum, tamquam gratus dicit quod do: Propter enim donum quod a magistris et a Deo principaliter cepi, do; do siquidem me, quem quisque admodo in vita et mortum inspiciet transmutatum.
nostro vesperiato intende mostrare sincera gratitudine per aver ricevuto il gran dono della sacra scrittura, e pertanto asserisce che io do. A motivo del dono ricevuto dai maestri e in prima istanza da Dio, io faccio dono; ossia dono me stesso, che ora tutti mi vedono vivo, e mortomi vedranno trasformato.
Nam reperio in scriptura:- novum scriptum preceptorum- verum sensum archanorum- sacrum signum electorum- pulcrum pignus mitorum;quia teste beato Agustino, libro 2° De civitate Dei, cap. xx(?), nichil in scripturis sanctis turpe, nichil vetusteconversacionis et prave, nichil flagitiosum et falsum |108rb| spectandum ymitandumque proponitur. Ubi veri Dei aut precepta insinuantur, aut miracula narrantur, aut archana reserantur, aut dona laudantur, aut beneficia postulantur.
Trovo infatti nella scrittura:- nuovo testo dei precetti- vero significato degli misteri- sacro simbolo degli eletti- piacevole pegno dei miti;perché, a detta di sant'Agostino,Della città di Dio II,28(?), nelle sacre scritture non vi è nulla diturpe, nulla dei vecchi e sconci costumi; e nulla di scandaloso o menzognero |108rb| viene propostoallo sguardo o all'imitazione. Visi propongono invece i precetti del vero Dio, vi si narrano i miracoli, vi si dischiudono i misteri, vi si esaltano i doni, vi si implorano le grazie.
Reperio namque quod ipsa pagina sacra:
- tollit priscam conversationem, donat novitatem
- pellit falsam intellectionem, monstrat
Trovo che la pagina sacra:- rimuove il vecchio
comportamento e ne dona uno nuovo- respinge l'errata
interpretazione e mostra la verità
- supera l'infruttuosa superstizione e condanna la
veritatem- vincit vanam
superstitionem, dampnat falsitatem
- premit stultam tumefactionem, format caritatem,
falsità- comprime la sciocca
gonfiaggine ed educa all'amore.
dicens «Scientia inflat, caritas edificat». Et ad Ephesios 4 dicit: in Christo edocti «deponite vos secundumpristinam conversationem veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovaminiautem spiritu mentis vestre et induite novum hominem, quisecundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis. In spiritu enim consignati estis in die redemptionis».
Dice infatti: «La scienza gonfia,l'amore edifica» (I Corinzi 8,1). E agli Efesini 4,22-24.30: cresciuti come siete in Cristo, «deponete l'uomo vecchio con la condotta di prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici; rinnovatevi nello spirito della vostra mente, e rivestite l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. Nello Spiritofoste segnati per il giorno dellaredenzione».
Dicebat noster vesperiatus:Admodo novus homo efficiar. Nam in die redemptionis novumscriptum in lege, novum sensum in mente, novum signumin fronte, novum nomen in cruce, novum pignus in fide, consequti sumus. Hec omnia nemo scit nisi qui accipit scilicet scripturam sacram, dicente Agustino in fine Confessionum: Nulla cunctarum nationum gimnasia, nulle lictere, nulle doctrine, hiissacris insignis consignantur.
Diceva il nostro vesperiato: Diventerò un uomo nuovo! Nel giorno della redenzione abbiamo conseguito una legge nuova, un intelletto nuovo, un segno nuovo nella fronte, un nome nuovo nellacroce, un pegno nuovo nella fede.Tutte questo cose, nessuno le conosce se non chi si nutre dellascrittura sacra. Agostino, Le Confessioni VII,21: Nessun ginnasiodi qualsivoglia nazione, nessuna cultura letteraria, nessuna filosofia si riversa in queste nostre sacre scritture.
Et subdit: «Aliud est de E soggiunge: «Ben altro è
silvestri cachumine videre patriam pacis et iter ad eam non invenire et frustra conari per invia circum obsidentibus et insidiantibusfugitivis desertoribus cum principe suo leone et dracone, et aliud tenere viamilluc ducentem, cura celestisimperatoris munitam».
guardare la patria della pace da un'altura selvatica e non trovareil cammino che porta ad essa, fare inutili tentativi su e giù per dirupi, mentre tutto intorno tendono attacchi e insidie i fuggiaschi e i disertori con il loro capo, leone e drago; e altroè percorrere la via che là conduce, via ben difesa dalla sollecitudine del celeste imperatore» (Le Confessioni VII,21,brano finale).
Item idem Agustinus in libro Expositionis subdit: Denique et in bellis civilibus observari refertur ut scilicet certo nomine et occulto signo militia inter se sit munita et ab exteris secernatur, quoniam et armorum habitus par est et sonus vocis idem et mos unus et carapter [sic] imperatoris secretus et institutio una bellandi. Et ne aliqua doli subrectio fiat, simbola discreta, nomina secreta, et inditia certa unusquisque duxsuis militibus tradit, que simbola[1] latine signa dicuntur; ut si forte occurrerit aliquis de quo dubitetur, interrogatus simbolum prodat si sit hostisan sotius. Hec autem nemo scit nisi qui decipit, nemo accipit nisi fidus miles et victoriosus bellator.
Il medesimo Agostino nel librodell'Esposizione: Si racconta che nelle guerre civili l'esercito premunisce se stesso tramite accertamento della identità vera e tramite un contrassegno segreto, e ciò per salvaguardarsidai nemici, dato che medesimi sono uso delle armi, segnali vocali, unico è l'intento, segreto il temperamento del comandante, unica la tattica di combattimento. Per non dar spazioal raggiro, ogni condottiero consegna ai propri soldati dei simboli, ovvero contrassegni tagliati in due: nomi segreti e indizi certi. Simboli, detti "segni" in latino. Cosicché, se si presenta un tizio sospetto, gli si chiede di esibire il simbolo o contrassegno identificativo per accertare se ènemico o alleato. Tali contrassegni nessuno li conosce se non chi volesse tradire; nessuno li prende in consegna se non il soldato fedele e combattente vittorioso.
Nonne sic imperator noster Non promette forse nella
promictit in Apocalipsi Iohannis? «Vincenti, inquit, dabo manna» quo videlicet saginetur in preliis, «calculum candidum» quo illustretur in dubiis, «et incalculo nomen novum scriptum»quo secernatur ab adversariis, «quod nemo scit nisi qui accipit» ne fallaturab inimicis ocultis.
medesima maniera il nostro imperatore in Apocalisse 2,17 di san Giovanni? «Al vincitore darò la manna» perché sia nutrito nelle battaglie, «una pietruzza bianca» perché sia ragguagliato nel dubbio, «e sulla pietruzza sta scritto un nome nuovo» perchésia ben distinguibile dai nemici,«nome che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve» perché non sia ingannato da nemici dissimulati.
Ergo rex noster nec inhermes nos dirigit. Accipite, inquit eius preco, armaturam fidei, gladium Spiritus, verbum Dei; nec vacuos spiritualibus alimentis, nec indoctos et incautos adversorum insidiis,ne nos nocturna specula hostis elidant.
Il nostro re, dunque, non ci guida affatto disarmati. Prendete- ci dice il suo araldo - le armidella fede, la spada dello Spirito, la parola di Dio. Né ci guida sprovvisti di cibo spirituale, né disinformati o sprovveduti circa le insidie degli avversari, affinché le spienotturne del nemico non ci abbattano.
Hec noster vesperiatus diligenter attendit, prudenter intellexit, sollicite requisivit, fidenter conservavit, ac priscam conversationem in novitatem mutavit. Ait enim nunc: Sum miles christiane fidei; accepi nomen secretum scilicet sacratissimam paginam, munitus sum armis fortissimis; bellabo viriliter contra hos qui hoc nomen nescierint; quod nomen do si fuero interrogatus.
Tutte queste cose, il nostro vesperiato le ha meditate con diligenza, le ha comprese con sapienza, le ha cercate con sollecitudine, le ha serbate con fedeltà; e ha mutato in nuovo il suo vecchio stile di vita. E ora proclama: Sono soldato della fedecristiana; ho adottato un nome segreto ossia la sacratissima pagina, sono munito di armi possenti; combatterò coraggiosamente contro chi ignoraquesto nome; svelerò il nome se sarò sottoposto al riconoscimento.
Recte ergo dicebat secunda Correttamente dunque diceva laseconda |108va| parte del
|108va| pars thematis quod do.Et hoc de secundo
principali.
versetto tematico che io do o pongo.
Fine della seconda distinzioneprincipale.
(→Dixi tertio...)
[1] Simbolo = contrassegno di riconoscimento, nel suo significato primo. «Mezzo di riconoscimento o di controllo che si otteneva spezzando irregolarmente in due parti un oggetto, in modo che il possessore di una delle due parti potesse farsi conoscere facendole combaciare», così nei dizionari moderni. Per la tradizione esegetica medievale: Summa Britonis sive Guillelmi Britonis Expositiones vocabulorum biblie [1250-70], ed. L.W. Daly and B.A.Daly, Padova 1975, II, 721-22 "Simbolum".
Vesperie quas feci pro magistro Federico(Pisa 1390-1391 ca.)
BAV, Barb. lat. 710, ff. 107va-108vb
originale latino volgarizzamento (2009) di EPDixi tertio quod ponitur
colligationis firma sanctitudo, quia dicitur inter me et vos.
Plane noster vesperiatus magistris et theologie doctoribus, quibus sperat coniungi et agregari, dicit: Inter me et vos erit firma sanctitudo colligationis. Namcolligabimur sapientia increata, quam omnes simul nostris viribus conabimur intelligere.
Terzo, solida santità di ricongiungimento, laddove dice trame e voi.
Il nostro vesperiato dice apertamente ai maestri e dottori di teologia, ai quali spera d'esser aggregato: Tra me e voi visarà salda santità di ricongiungimento. Saremo infatti congiunti dalla increata sapienza, che tutti noi ci sforzeremo insieme d'indagare.
Colligabimur sapientia ins<pira>ta, quam studio et
Saremo associati per opera della sapienza ispirata, che
oratione acquirere meruemur. Per sacram enim scripturam intelligimus sapientiam increatam habere:
meriteremo di conseguire con lo studio e la preghiera. Dalla sacra scrittura apprendiamo che la sapienza increata possiede:
- claram evidentiam quorumcumque dubiorum queribilium
- certam prescientiam quorumcumque futurorum possibilium
- notam luculentiam quorumcumque occultorum credibilium
- summam sapientiam quorumcumque obiectorum noscibilium.
- chiara soluzione di tutti i dubbi inquisitivi
- certa preconoscenza di tutte le possibilità future
- evidente splendore di tutti imisteri della fede
- somma sapienza circa ogni materia conoscibile.
Scribitur enim, 2° capituloApoc., de Christo existente sapientia, «qui habet oculos tamquam flammam ignis». Christo enim convenit:
- oculus inhabitans lucem increatam
- oculus predestinans plebem preamatam
- oculus considerans labem occultatam
- oculus reverberans mentemcelibata<m>.
È scritto in Apocalisse 2,18, a proposito del Cristo sapienza vivente: «il quale ha occhi fiammeggianti come fuoco». Congruo al Cristo è:
- occhio che penetra luce increata
- occhio che presceglie popoloamato
- occhio che vede macchia nascosta
- occhio che riflette mente celestiale.
Propter oculum inhabitantemlucem increatam, ille idem Apostolus qui di?? «lucem habitans inaccessibilem», dicit: «Omnia nuda et aperta sunt oculis eius». Ea propterbeatus Agustinus, libro De agnitione vere vite, cap. 22, dicit: Hec profecto est lux
Occhio che penetra luce increata. Il medesimo Apostolo che aveva detto «Egli abita luce inaccessibile» (I Timoteo 6,16), dice: «Tutto è nudo e scoperto aisuoi occhi» (Ebrei 4,13). E pertanto Agostino, De agnitione vere vite, cap. 22, dice: Questa è la luce inaccessibile che Dio inabita, questo l'occhio limpido
inaccessibilis quam inhabitatDeus, hic oculus limpidus cuiomnia patent, essentia Dei solis mundis cordibus visibilis. Hic nullus cogitetluce Deum quasi tabernaculo hominem circumdatum, quasi aliud sit Deus qui lucem habitat et aliud lux quam inhabitat; sed potius ipsam lucem essentiam(?) Dei sciat,in qua universa bona simul locata intelligat.
cui tutto è manifesto, l'essenza di Dio visibile ai soli puri di cuore. Nessuno pensi che Dio sia circordatato dalla luce al modo che l'uomo è circordatato dalla tenda, quasi che una cosa sia Dioinabitante la luce e altra cosa sia la luce inabitata; piuttosto la luce è la stessa essenza di Dio, nella quale tutte le cose buone risiedono insieme.
Hec est lux que angelos et animas in celis sua visione satiat, eosdem beatificans quos predestinavit, et in celestibus consedere fecit propter oculum predestinantemplebem preamatam. Dicit Psalmus 101 «Oculi mei ad fideles terre sedeant mecum»,propter oculum considerantem labem ocultatam. Dicitur Ecc.23[,19] «Oculi Domini multo plus lucidiores sunt super solem, circumspicientes omnesvias hominum, et profundum abissi et hominum corda intuentes».
Questa è la luce che in cielo sazia della propria visione gli angeli e le anime; che rende felici i predestinati; che tramite lo sguado provvidenziale fa risiedere in cielo il popolo amato. Dice Salmo 101,6, «I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino a me vicino», a motivo dello sguado rivolto alla macchia nascosta. Ecclesiastico (o Siràcide) 23,28: «Gliocchi del Signore sono di gran lunga più luminosi del sole; essivedono tutte le azioni degli uomini e penetrano fin nei luoghipiù segreti».
Et recte dicitur «super solem». Solis enim radius solum presentia non futura, solum extrinseca non interna,solum corporea non abstracta,solum opposita non superna, illustrare et introspicere dicitur. Sed Dei oculus
E rettamente si dice «di gran lunga più luminosi del sole» (Siràcide 23,28). Il raggio del sole illumina e scandaglia soltanto le realtà presenti non le future, soltanto il loro esterno non l'interno, soltanto le realtà fisiche non le nozioni astratte, soltanto il lato
presentia et futura, extrinseca et interna, patentia et occulta, corporeaet abstracta, mundialia et celestia, intuerur; et non ulla creatura invisibilis in conspectu eius.
prospiciente non il retrostante. L'occhio del Signore, al contrario, vede le realtà presenti e quelle future, l'esterno e l'interno, le cose visibili e quelle recondite, le realtà fisiche e quelle astratte,le terrestri e le celesti; e nessuna realtà creata è invisibile al suo sguardo.
Merito ergo oculi Domini lucidiores sunt super solem propter oculum reverberantem mentem nostram celibatam. Dicebat beatus Agustinus, libro Meditationum, cap. 2: Non suffert oculus anime diu capere lucem illam que nonnisi purgata mente videtur; tota ubique est, tota visio est, tota oculus est. Non sufficit mens invalida in illum intendere oculum: reverberatur fulgore,vincitur amplitudine, obruitur immensitate, confunditur capacitate. Ideo dicimus cum psalmista: «Inperfectum meum viderunt oculi» donec veniat quod perfectum est, et videamus eum sicuti est.
Giustamente gli occhi del Signore sono più risplendenti delsole a motivo dello sguardo che rispecchia la nostra mente celestiale. Diceva sant'Agostino,Le meditazioni, capitolo 2: Lo sguardo dell'anima non sostiene alungo quella luce, che è visibilesoltanto a una mente pura; è tutta dappertutto, è tutta visione, è tutta sguardo. Una mente fragile è inabile a rimirarla: colpita dallo splendore, battuta dalla dimensione, sopraffatta dalla immensità, sconvolta dalla perizia. Diciamo infatti con le parole del salmista (Salmo 139,16): «Informe mi hanno visto i tuoi occhi» finché non verrà laperfezione, e possiamo vederlo così com'è.
Noster autem vesperiatus tota operatione po(ssibi)li sibi conatus est sanare oculum cordis, unde videri potest Deus. Consideravit enim quod ad hoc sacrosancta misteria celebrantur, ad hoc
Il nostro vesperiato ha tentatocon tutte le sue forze di curare l'occhio del cuore, cosicché Dio possa esser contemplato. Apprese che a tale scopo i sacri misteri vengono celebrati e la parola di Dio viene predicata, affinché i cuori dei fedeli siano infiammati
sermo Dei predicatur, ad hoc eius eloquiis inflammantur corda fidelium. Nam igitur eloquium Dei vehementer et «preceptum Domini lucidum illuminans oculos».
dai suoi discorsi. Forte è la parola di Dio, «i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi» (Salmo 19,9).
Unde conclusit quod in Christi visione apparet oculus igneus, oculus pervius, oculus lucidus, oculus flameus:
- oculus flammigerans oculus vaporis
- oculus elucidans oculus spendoris
- oculus purificans oculus nitoris
- oculus sanctificans oculus amoris.
Quid enim est aliud flamma ignis nisi vapor accensus? Igitur in Christi visione datur vapor accensus, fervor intensus, splendor immensus, amor extensus ad Deum et ad Christum.
È pervenuto dunque, il nostro vesperiato, alla conclusione che nella visione del Cristo compare l'occhio di fuoco, l'occhio aperto, l'occhio brillante, l'occhio ardente:
- occhio infiammato è occhio di vapore
- occhio brillante è occhio dello spendore
- occhio puro è occhio della lucentezza
- occhio santificante è occhiodell'amore.
E che cos'altro è la fiamma delfuoco se non il vapore acceso? Nella visione del Cristo si dà vapore acceso, calore intenso, spendore immenso, amore esteso a Dio e al Cristo.
Etiam noster vesperiatus vidit quod oculi Christi accipi possunt pro sensibus sacre scripture. Dicit enim Ambrosius, litera xi: Duos oculos habet scriptura, moralem et misticum. Et hii veluti ignis, amore |108vb| flammigerant et accendunt. Misticus oculus acutior est, moralis vero dulcior. Sed in
Il nostro vesperiato, inoltre,ha constatato che gli occhi del Cristo possono essere intesi comesignificati della sacra scrittura. Dice Ambrogio, epistola XI: Due occhi ha la sacra scrittura, quello morale e quello mistico. E come se fosserofuoco, essi per amore |108vb| ardono e infiammano. L'occhio mistico è più acuto, quello morale più dolce. Ma in entrambi la mente umana approva l'amore della verità da scoprire, il
utroque et amorem veritatis congnoscende et fervorem deitatis excolende et dulcorem caritatis accendendeet nitorem claritatis consequende, asciscitur mens humana.
fervore della divinità da adorare, la dolcezza della caritàda accendere, lo spendore della luminosità da conseguire.
Propterea noster vesperiatus, in sacra scriptura studuit diligenter ascultando, eam legit aliis luculenter explanando, servavit et tenuit operanter exequendo et exequenter operando. Nam in scriptura habuit intelligentiam claritatis, efficaciam voluntatis, profectum memorietenacis. Et sic illuminato intellectu adeo aliis elucidabat, devoto affectu inse recipiebat et adherebat, opere et effectu quod legeratadimplebat.
Di conseguenza il nostro vesperiato ha studiato la sacra scrittura in diligente ascolto, l'ha commentata a scuola in ridondante esposizione, l'ha osservata nella pratica di vita enel coerente comportamento. Nellascrittura ha conseguito l'intelletto della chiarezza, l'efficacia della volontà, il frutto d'una memoria tenace. E ilsuo intelletto illuminava quello altrui, accoglieva in se stesso eaderiva (alla sacra scrittura), nei fatti e nelle conseguenze metteva in pratica quel che leggeva.
Sic igitur in sacra scriptura triplex meritum acquirebat: primo pro exercitio studii et instructionis, secundo pro actu credendi et adherendi, tertio pro actu interiori efficaciter operandi vel volendi ad correctionem vite.
Nella sacra scrittura conseguiva tre meriti: primo, dedizione allo studio e all'apprendimento; secondo, atto di fede e di partecipazione; terzo, interiore volontà di agirecon efficacia e predisposizione araddrizzare la rotta.
Ex hiis et aliis, noster vesperiatus cognovit quod studium sacre scripture erat meritorium, dicente Ambrosio,litera 7 super Beati: Hec est
Da tutto ciò, e da altro, il nostro vesperiato ha preso atto che lo studio della sacra scrittura era encomiabile; Ambrogio, epistola 7, commento a Beati (Salmo 119,1): Questo è il
anime nostri vitalis substantia. Et Augustinus ait: Nulle virtutes, quibus beatitudo acquiritur, sine scripture notitia habentur; hic enim datur radix vite meritorie. Sed velle quidquidDeus vult te velle, et nolle quidquid Deus iubet te nolle,hic ostenditur qualiter et quare Deus diligendus, qualiter vitia odienda, parvaappetenda, supplicia fugienda.
nocciolo della nostra vera vita! E Agostino: Nessuna virtù, pegno della beatitudine, è conseguibilesenza conoscenza della sacra scrittura; in essa risiede la radice di una vita degna. Volere quel che Dio vuole che tu voglia,rifiutare quel che Dio vuole che tu rifiuti: qui si mostra come e perché dobbbiamo amare Dio, detestare i vizi, desiderare le cose umili, rifuggire dalle torture.
Ideo noster vesperiatus, obmissis aliis scientiis frivolis, totus inherebat studio sanctissime lectionis;orabatque ut Doctor animarum et illustrator ingenii in eius mentem infunderet veritatem, quam in utilitatemproximi posset effundere luculenter.
Il nostro vesperiato, pertanto,lasciate cadere le frivolezze, siconcentrò pienamente nello studiodella sacra pagina; e pregava affinché il Maestro della anime eluce dell'intelletto riversasse nella sua mente la verità, che a sua volta potesse abbondantementediffondere a bene del prossimo.
Nam sciebat scriptum: «Non enim vos estis qui loquimini sed spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis». Agustinus, super Ps. 88: Si ame loquor, mendax sum; si in me loqueris, Domine, verum dico. Ergo a te, Domine, dicam, et ego dicam duo: quedam sunt unum tuum et unummeum, veritas tua, os meum.
Conosceva le parole: «Non sieteinfatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi» (Matteo 10,20). Agostino, a proposito di Salmo 88: Se fossi io a parlare, sarei menzognero; se sei tu a parlare in me, o Signore, allora dico il vero. Parlerò dunque a tuo nome, Signore, e due cose dirò: una è totalmente tua, e una mia: tua è la verità, mie le labbra!
Ergo nisi loquatur nobis intus filius Dei, sine causa nos foris perstrepimus. Unde
Se dunque il figlio di Dio non ci parla nel cuore, noi sapremo soltanto sbraitare. Ne è prova
hoc apparet: quia cum multi audiunt, non omnibus persuadetur quod dicitur sed illis solis quibus intus loquitur Deus. Dicebat igiturnoster vesperiatus: «Audiam quid loquatur in me dominus Deus, quoniam loquetur pacem»anime sempiternam. Quam nobisconcedat, etcetera.
che laddove sono molti ad ascoltare, non tutti se restano persuasi ma soltanto coloro nel cui cuore è Dio a parlare. Dicevail nostro vesperiato: «Ascolterò che cosa dice Dio il Signore, perché egli annunzia la pace» (Salmo 85,9) sempiterna del cuore. Pace che egli ci conceda, eccetera.
[ Pisa 1390-1391 ca. ] [ Firenze 2009 !]
Emilio Panella OPFirenze, Santa Maria Novella, 2009
Finis!
http://www.e-theca.net/emiliopanella/nomen1/simofc.htmhttp://archivio.smn.it/emiliopanella/nomen1/simofc.htm