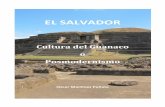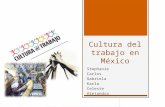S. Gentili, Cultura della razza: alcune strutture concettuali, in Cultura della razza e cultura...
Transcript of S. Gentili, Cultura della razza: alcune strutture concettuali, in Cultura della razza e cultura...
BIBLIOTECA DI TESTI E STUDI / 571
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 3
I lettori che desideranoinformazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editricepossono rivolgersi direttamente a:
Carocci editore
via Sardegna 50,00187 Roma,
telefono 06 /42 81 84 17,fax 06 /42 74 79 31
Visitateci sul nostro sito Internet:http://www.carocci.it
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 4
Cultura della razza e cultura letterarianell’Italia del Novecento
A cura di Sonia Gentili e Simona Foà
Carocci editore
C
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 5
1a edizione, aprile 2010© copyright 2010 by
Carocci editore S.p.A., Roma
Realizzazione editoriale: Fregi e Majuscole, Torino
Finito di stampare nell’aprile 2010dalla Litografia Varo (Pisa)
ISBN 978-88-430-5137-3
Riproduzione vietata ai sensi di legge(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Senza regolare autorizzazione,è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.
Volume progettato nel 2008 e pubblicato con il contributo dell’Assessorato alla Culturadella Regione Lazio, della Facoltà di Scienze Umanistiche, Sapienza Università di Roma,
e della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
FACOLTÀ DI SCIENZEUMANISTICHE
In copertina: Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Demografia e Razza, Divisione Razza, Affari Generali,
Busta 1: tavole genealogiche per la definizione della razza.
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 6
Premessadi Sonia Gentili e Simona Foà
Cultura della razza: alcune strutture concettualidi Sonia Gentili
Parte primaCultura della razza e spazio pubblico: posizioni egemoniche e voci isolate
Contro l’antisemitismo tedesco, per la lotta del l’ebraismo. Il concetto cattolico-fascista di razzadi Patrick Ostermann
Dallo spirito latino allo spirito della razza: il caso Gemellidi Alessandro Ottaviani
I matematici italiani tra “spirito latino” e “spirito di razza”di Pietro Nastasi
Tra sionismo e antifascismo. Memorie di casa Serenidi Oreste Trabucco
Gramsci e il razzismo italianodi Raul Mordenti
7
11
13
43
69
93
115
137
Indice
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 7
159
175
191
213
219
229
247
Parte secondaLinguaggi e silenzio. Lingue e razze superiori
Lingua, fascismo, razza. Considerazioni su un disegno tota-litariodi Marie-Anne Matard-Bonucci
Cultura della razza e ideologia linguistica nella Germanianazionalsocialistadi Sabine E. Koesters Gensini
Politiche culturali e didattica dell’italiano nelle colonie afri-cane (1882-1942)di Laura Ricci
Parte terzaQuesto è un uomo. Individuo e razza
nella costruzione del personaggio letterario
Primo Levi, il 1938, il fascismo e la storia d’Italiadi Alberto Cavaglion
Il caso Sabadi Francesca Bernardini Napoletano
Discriminazioni e/o contraddizioni: la narrativa colonialedel Ventenniodi Graziella Pagliano
Personaggio letterario e carattere «sopraindividuale»:T. Mann, G. A. Borgese, V. Brancati di Sonia Gentili
8
I N D I C E
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 8
273
281
287
291
Parte quartaLo sguardo degli scrittori
Testimonianza. Teatro Comunale di Bologna, 13 marzo 1961di Primo Levi (con nota al testo di Alberto Cavaglion)
Maelstromdi Aldo Zargani
Sulla luna nera un gridodi Lia Levi
Indice dei nomi
9
I N D I C E
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 9
Premessadi Sonia Gentili e Simona Foà
Per il settantesimo anniversario delle leggi razziali (1938-2008) si è svoltoil 13-14 novembre 2008, in due atenei romani (Facoltà di Scienze Uma -nistiche, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia,Università di Roma “Tor Vergata”), il convegno «Cultura della razza ecultura letteraria nell’Italia del Novecento», da noi stesse organizzato. Ilcolloquio era dedicato a indagare su un piano multidisciplinare, di storiadelle idee, la “cultura della razza” formatasi in Italia, la sua imprescindi-bile relazione con la Germania e il modo in cui questa cultura fu assor-bita e trasmessa dalla letteratura.
Le leggi razziali italiane del 1938, rivolte contro i “non ariani” chevivevano nel territorio nazionale (soprattutto, ma non solo, la minoran-za ebraica) e gli abitanti delle colonie africane, furono esito di teorie bio-logiche e antropologiche radicate nella cultura scientifica della primametà del Novecento, veicolate dalla manualistica scolastica e universita-ria: la concezione dell’individuo come esponente di una “razza”, cioè diun’“essenza” sovraindividuale, è corrente nella cultura europea della pri -ma metà del XX secolo. Scopo del convegno era indagare l’impatto ditale “idea dell’uomo” – in cui si mescolano determinismo positivista econcezione sovraindividuale del soggetto di estrazione idealistica – sul-l’immaginario letterario, il ruolo che la letteratura ebbe nel diffonderla,la resistenza e più spesso la debolezza che la cultura letteraria e quellafilosofica mostrarono rispetto alla suggestione da essa esercitata.
Il convegno si è rivelato così partecipato e fruttuoso da giustificarela nascita di un volume che accogliesse anche contributi proposti da altristudiosi e organizzasse i singoli interventi entro una struttura interpreta-tiva unitaria. Le sezioni che compongono il libro rivelano una partizionedisciplinare (storia del pensiero filosofico, politico e scientifico nellaParte prima, Cultura della razza e spazio pubblico: posizioni egemonichee voci isolate; questioni linguistiche nella Parte seconda, Linguaggi e si -lenzio. Lingue e razze superiori; produzione letteraria nella Parte terza,
11
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 11
12
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A E C U L T U R A L E T T E R A R I A N E L L’ I T A L I A D E L N O V E C E N T O
Questo è un uomo. Individuo e razza nella costruzione del personaggio let-terario) a sua volta attraversata orizzontalmente da un gioco costante:quello dell’egemonia culturale, politica e sociale, poiché – è questo unpunto cruciale della questione che qui si affronta – la nozione di “razza”coincide, sempre, con un pensiero forte, al cui centro è po sta una sog-gettività egemone che prevede la relazione con l’“altro” come eserciziodi potere. La Parte quarta, infine, è dedicata alla trasfigurazione in chia-ve letteraria d’una cultura della razza vissuta e subita individualmente:tre testi di scrittori, dunque, perché la ragione di ogni indagine storica,così come la sua necessaria ma difficile meta conoscitiva stanno nellasofferenza e nella ferita di singoli individui che la storia han no vissuto.
Questo volume, come le due giornate di studi da cui esso ha origine,vuole contribuire al rifiuto definitivo e radicale del concetto di “razza”e far emergere il nesso che sempre lega attività culturale e responsabilitàpolitica.
Si ringraziano gli enti finanziatori (Assessorato alla Cultura della Re -gione Lazio; Facoltà di Scienze Umanistiche della Sapienza Università diRoma; Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di “Tor Vergata”) egli innumerevoli e non elencabili amici che in vario modo hanno contri-buito a far vivere questo libro.
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 12
13
Cultura della razza:alcune strutture concettuali
di Sonia Gentili
La trascendenza è fittizia e la pace instabile.
Emmanuel Lévinas@
Cos’è l’uomo? «Essenza» umana, «storia», «destino»
Nel decimo quaderno vergato nel carcere di Turi tra il 1932 e il 1935, Gram-sci rifletté sui punti di un’Introduzione allo studio della filosofia, di cui eccoil principale (Gramsci, 1975, Quaderno 10, § 54, pp. 1343-4):
Che cosa è l’uomo? È questa la domanda prima e principale della filosofia. Comesi può rispondere. […] La domanda è nata, riceve il suo contenuto da speciali,cioè determinati modi di considerare la vita e l’uomo […].
In un passo del settimo quaderno gramsciano (ivi, Quaderno 7, § 35,p. 884), analizzato nel presente volume (pp. 154-5) da Raul Mordenti, laquestione era stata già risolta come segue:
Il problema di cosa è l’uomo è dunque sempre il così detto problema della“natura umana”, o anche quello del così detto “uomo in generale”, cioè la ricer-ca di creare una scienza dell’uomo (una filosofia) che parte da un concettoinizialmente “unitario”, da un’astrazione in cui possa contenere tutto l’“umano”.Ma l’“umano” è un punto di partenza o un punto di arrivo, come concetto efatto unitario? o non è piuttosto, questa ricerca, un residuo “teologico” e “meta-fisico” in quanto posto come punto di partenza?
All’epoca in cui Gramsci scriveva, una parte rilevante della cultura euro-pea aveva risposto alla domanda «Che cos’è l’uomo?» con la nozione di“razza”. Risposta non nuova, certo: quella della “razza” è una delle piùlunghe e peggiori avventure della storia del pensiero. Ci si chiede spessoperché questa concezione dell’uomo vigoreggi, oggi, nonostante il ricor-do vivo dei massacri novecenteschi. È un problema di memoria maleamministrata o di mancata neutralizzazione delle premesse concettualiche resero possibili i fatti che siamo condannati a ricordare? Si è molto
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 13
riflettuto sulla memoria – la gestione del ricordo, i limiti della testimo-nianza, la questione della colpa tedesca e dell’autoassoluzione italiana – emeno, forse, sull’estensione della logica che unisce i razzismi novecente-schi: la concezione razzizzata1 dell’individuo non è stata negata nelle suecoordinate concettuali di fondo; molta cultura dissidente dell’epoca, chel’ha rifiutata moralmente, è spesso rimasta dentro la sua stessa logica. Ilpresente lavoro si propone di sintetizzare a posteriori elementi che, disse-minati nei saggi che seguono, contribuiscono a formare questa ipotesi.
Per individuare il patrimonio concettuale direttamente all’origine delpensiero razzista espressosi nel Novecento italiano è bene analizzare l’ope-razione critica condotta sul campo da un intellettuale che visse e respinsela cultura della razza novecentesca nel suo farsi, e che avrebbe un posto diprimo piano nella condenda e auspicata «storia dell’antirazzismo»2.
Arturo Farinelli, eruditissimo comparatista dedito al sogno goethiano diuna «letteratura mondiale»3, nel 1904 aveva dovuto lasciare la cattedra diFilologia romanza all’Università di Innsbruck, ottenuta nel 1896, perchécacciato dai nazionalisti tirolesi; è incredibile che egli abbia potuto pubbli-care di ciò una bellissima Memoria, grondante antibellicismo e antinaziona-lismo4, nel fascistissimo anno 1939. Risulta da essa che Farinelli andò «vaga-bondando per anni» prima di approdare all’Università di Torino: tre difficilianni, forse occupati da riflessioni sul torto subito e sulle idee dei «panger-
14
S O N I A G E N T I L I
1.@Si impiega qui, e nel corso del presente volume, un verbo diffusosi negli studi suquesti temi per descrivere «quella peculiare modalità di nazionalizzazione della cittadi-nanza consistente nella sua etnicizzazione (razzizzazione)» (Burgio, 2000, pp. 9-10).
2.@È l’auspicio di Cavaglion (2000, pp. 379-81).3.@Sulla biografia farinelliana si veda Strappini (1995); sulla valutazione critica dell’o-
pera e sul profilo intellettuale di Farinelli si vedano Gobetti (1969a, 1969b); Monteverdi(1948).
4.@«Sino al 1904 durò il mio tirocinio professionale a Innsbruck, pacifico sino a quan-do i pangermanisti oltrecotanti e folli decisero il bando degli italiani e ordinarono unapersecuzione che pareva preludesse a un massacro. Io mi salvai a stento. Più dei colleghi egiuristi ero preso io stesso di mira, fermo nel continuare le lezioni italiane che si abolivano[…]. Scorreva il sangue; uno di nostri ed uno dei loro avevano lasciato la vita. Allo sboccodella mia casa, attigua a quella di un feroce caporione pangermanista, lo vidi in agguato conla moglie, muniti entrambi di un grossissimo randello. Mi avvicino e scoppia un grido: “Ètempo di finirla con questi professori!”. E solleva quel suo randello per spaccarmi il cranio.Prontissimo, estraggo di tasca una lunghissima matita […] luccicante come un’arma dafuoco, per il suo involucro metallico, e la punto sul viso dello sciagurato. Convinto ch’iofossi armato di rivoltella […] con quell’innocua arma tesa obbligai il provocatore a rientra-re a precipizio con la compagna nella sua dimora. Una vendetta doveva meditarsi per l’in-domani, un assalto alla mia casa da parte di centinaia di studenti e sbandati che il nemico
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 14
manisti oltrecotanti e folli» che lo avevano cacciato, poiché il 13 dicembre1907 lo studioso inaugurò l’insegnamento torinese di germanistica con laprolusione L’umanità di Herder e il concetto di razza nella storia dello spirito,evidentemente concepita come vaccino contro il virus razzista di cui la cultu-ra coeva – anzitutto quella tedesca – era portatrice. Farinelli apre questo inte-ressantissimo testo, ristampato sino al 1925, con la fatale domanda sull’es-senza umana formulata poi da Gramsci5, e rilevando che parte della culturacontemporanea vi risponde con il «talismano» della razza: interessante defi-nizione, che pare collocare le teorie razziste nel dominio non razionale masimbolico del mito, come fecero poi Gramsci e Cassirer. Dopo il paragrafod’esordio l’autore abbandona bruscamente il registro accademico per assu-mere quello dell’ispirazione visionaria: contro i teorici delle “razze” umaneegli «vede» sorgere lo spirito dolente di Herder!6 Perché Herder e perchél’enfasi profetica della visione? Il fatto è – Farinelli lo rivela qualche paginadopo – che il dilagante mito della razza si richiama alla concezione herderia-na della Volkseele, comune principio informatore di individui appartenentia una comunità geograficamente e storicamente individuata.
In effetti, la terna concettuale che lega genio nazionale, lingua e tradi-zione storica locale, già propria della riflessione settecentesca sulla storia
raggruppava. Non riuscì […] ché la mia fermezza e la popolarità goduta presso quei giova-ni, male gettati nell’avventura e al vandalismo, mi tennero incolume. Due giorni dopo,travestito da contadino tirolese, perché non mi sorprendessero ai treni vigilatissimi, trasci-nando la mia bimba che quei dementi avevano un giorno schiaffeggiata sulla via perchécanterellava in italiano, passavo a Wörgl, di là a Salisburgo e a Gmunden. Come andassi poivagabondando per anni, prima di raccogliermi nell’insegnamento di germanistica a Tori-no, dirò in altre memorie. Nell’estate del 1914 […] la guerra era scoppiata. Si voleva dareuna lezione ai Serbi e si preparava la strage di mezzo mondo» (Farinelli, 1942, pp. 32-3).
5.@«Donde ha origine, da quale prima virtù trae suo colore e sua vita l’opera artisti-ca? […] Svolgesi la storia spirituale de’ popoli secondo fattori etnici fissi, immutabili […]che l’uomo discerne […]? È in molti, fuori d’Italia particolarmente, una credenza ciecanella virtù delle scienze naturali […]. Ed è un parlare di razze, sgomentevole […], in virtùdella stirpe, un trinciar giudizi […] su tutte le arti, di tutti i popoli, di tutti i tempi, eanche, massimamente da chi si rivela digiunissimo d’ogni attitudine e cognizione artistica,e le vicende storiche tutte […] il fiorire e disfiorire delle civiltà […] tutto spiega col tali-smano della razza» (Farinelli, 1919c, pp. 139-41).
6.@«Non so dir come, ma, più forte odo tuonare il verbo delle disuguaglianze dellerazze umane, più inquieta e viva vedo agitarsi tra le ombre de’ grandi estinti, quella diGottfried Herder e sembrami […] voglia muovere lamento agli accecati della patria sua.Or, mentre […] inneggiavo alla fratellanza e concordia de’ popoli, voi inculcate disunio-ne e discordia; gridate le disparità più favolose tra l’una e l’altra stirpe immaginata; muta-te in verbo disumano il vangelo mio dell’umanità» (ivi, pp. 141-2).
15
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 15
delle civiltà e poi centrale nell’elaborazione herderiana e romantica (cfr.Gambarota, 2006), aveva innervato il mito risorgimentale di un’italianitàformatasi geostoricamente e divenuta anima, identità comunitaria onto-logicamente sussistente (Banti, 2000, p. 108 e passim; Burgio, 2000, p. 7).Questo nesso è stato poi centrale nella produzione ufficiale fascista, specieper ciò che concerne la relazione tra genius nationis e la sua espressioneletteraria7.
Perché dunque dinnanzi a simili eredi lo Herder farinelliano si rivoltanella tomba? Perché questa lettura del pensiero di Herder nasce, secondoFarinelli, dalle sue interne contraddizioni: da un lato convinto assertoredell’esistenza di una Volksseele e di una Sprachseele8, dall’altro avverso allanozione di razza, incline a un’ottica comparatistica e non gerarchica di lette-rature e civiltà umane9 e, soprattutto, sostenitore di una concezione nonessenzialista della storia (Farinelli, 1919c, p. 149). Secondo Farinelli (ivi,p. 147), il punto più ambiguo del pensiero herderiano è la concezionedell’essenza umana, forma immutabile o continuo divenire storico:
Nell’ideale stesso dell’umanità, quante oscillazioni! Ove poggi non sai. In checonsista, il filosofo ed evangelista dell’uguaglianza de’ popoli non dice […]. Ordesigna l’umanità un bene eccelso, stabile nello sviluppo umano; or è moto,progresso, divenire continuo, avviamento alla perfezione estrema […]. È la voce
7.@Vedi ad esempio il saggio intitolato alla relazione tra Fascismo e letteratura firma-to da Luigi Chiarini: «Il fascismo stesso, e per esso il suo capo, usa parlare schietto e guar-dare in faccia la realtà […]. Si vorrebbe poter riconoscere soltanto nelle opere d’arte ilvolto spirituale e fisico dell’Italia nuova; si vorrebbero gli artisti animati da quegli stessiideali che han fatto il popolo italiano un blocco solo teso verso un’unica meta. E vera-mente mai come oggi la vita è stata piena di poesia: la lirica si sprigiona dalle cose stesse enon c’è azione del Regime fascista che non ne sia tutta piena nella sua schematica nudità»(Chiarini, 1936, p. 18).
8.@«Al fulgido vero s’intrecciano [scil. in Herder] le contraddizioni più stridenti […].Il cosmopolita de’ primi frammenti ha l’occhio fisso alla patria, che vorrebbe […] posta alcentro del mondo e reggitrice del mondo, per consiglio divino. S’augura una letteraturavivificata da un sentimento nazionale […]; fantastica – ahimè, fantasticherà ancora piùtardi – di un cattivo influsso dello spirito latino sul germanico […]. Sorprendono […] ne’primi saggi di storia e d’arte del seguace e di Winckelmann, le velleità di una scienza fisio-nomica che s’ispira al Lavater» (Farinelli, 1919c, pp. 142-3).
9.@«Pienamente arbitrarie appaiono [scil. ad Herder] le suddivisioni in stirpi, secon-do il paese d’origine e il colore della pelle. Razza è concetto fallace. Né trovi sulla terraquattro o cinque razze, così dette, e nemmeno varietà etniche esclusive […]. Il geniodell’umanità è in ogni popolo; e non bada a favorire più l’uno che l’altro» (ivi, p. 144). Leconsiderazioni sulle letterature si leggono infra, pp. 158-9.
16
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 16
ultima e più solenne della storia; o è corpo, tendenza della storia stessa. Dei vacil-lamenti suoi il grand’uomo ha coscienza; gli sfugge detto un giorno dover lascia-re all’arbitrio d’ognuno facoltà di precisare, allargare e stringere il concettodell’umanità […]. Or questa umanità sua è tutt’una cosa colla ragione; or s’iden-tifica colla tradizione; or è voce di Dio; or è forza educatrice della storia.
Farinelli sa che quando il passato si irrigidisce in genius nationis, cioè in“essenza”, in “anima” collettiva, come in Taine e Gobineau, e come inmolto nazionalismo di ispirazione herderiana, la «psicologia tentata dell’a-nima collettiva non è che un simulacro di storia» (ivi, p. 159). La razza è un«talismano» e il genius nationis un «simulacro» della storia: rischio, a direil vero, affacciatosi sin dalla speculazione vichiana sulle antiquitates nazio-nali e sul loro statuto epistemologico. Quando Vico rifiutò l’ottimismodella ragione cartesiano per riconsegnare parte del linguaggio al mito,concepì quest’ultimo come necessario e illusorio al contempo, come inevi-tabile forma del pensiero umano, ma pericoloso in quanto asservibile alla«boria delle nazioni». Il ripensamento novecentesco – non solo italiano –di questi temi dopo l’orrore nazifascista si fondò appunto sull’intuizionevichiana, cui ci si richiamò esplicitamente per denunciare il genio nazio-nale come forma negativa e “incontrollabile” del pensiero mitico (Cassi-rer, 1987b)10, ovvero come mito asservito alla boria delle nazioni (Colajan-ni, Gramsci)11.
Nel 1945, alla vigilia della propria morte, il vecchio Ernst Cassirerimpegnò le ultime forze nell’analisi del nazionalismo di cui l’umanitàaveva appena vissuto la concretizzazione più tragica. Ne nacque un librocapitale, Il mito dello stato, che individuava il centro nevralgico del mito
10.@«Il tratto forse di maggior rilievo, ed insieme più allarmante, nell’evoluzionedella nostra moderna vita politica è […] la preminenza del pensiero mitico sul pensie-ro razionale e logico nelle teorie politiche del ventesimo secolo. […] Se il mito è unfenomeno tipico della mente primitiva, ossia prelogica e mistica, come possiamo spie-gare la sua ricomparsa improvvisa nelle condizioni della nostra cultura altamente sofi-sticata? Gli uomini che divennero i padri dei nostri miti politici moderni […] nonavevano nulla di “primitivo”. […] Nei momenti critici della vita politica e socialedell’uomo il mito riacquista la sua antica forza. In effetti, era sempre stato in agguatodietro le quinte, attendendo l’ora e l’occasione giuste. E quest’ora arriva quando le altreforze connettive della nostra vita associata perdono, per qualsivoglia ragione, la loroinfluenza, quando non riescono più a controbilanciare la potenza demoniaca del mito»(Cassirer, 1987, pp. 1-5).
11.@La dichiarazione di Colajanni e quella di Gramsci sono entrambe riportate nelpresente volume, rispettivamente in Ottaviani, p. 79 e in Mordenti, p. 142.
17
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 17
romantico di nazione nel valore conferito al passato: non quello di proces-so storico, bensì quello metastorico e identitario di origo, mito fondantedella soggettività. Dal medesimo alveo dello storicismo nasce, insegnòCassirer, una forma di essenzialismo antistorico che è il mito della storiacome anima collettiva: dalle altezze vichiane – l’uomo come processostorico –, attraverso la curva romantica – l’origine come essenza colletti-va –, si giunse alla depressione nazifascista: l’essenza di una certa colletti-vità come realizzazione più piena dell’umano, il suo inverarsi nella storiacome distruzione di altre collettività in nome del Lebensraum, lo spaziovitale concretamente necessario allo sviluppo dello spirito nazionale.
Le opposte potenzialità implicate dal concetto di genio nazionale– quella della storia e quella del mito – sono insomma difficili da separa-re: per certi aspetti più raffinato e complesso del modello antropologicodegli illuministi, universalistico e astratto (quello dell’uomo animale razio-nale) portato a splendore massimo da Kant, il soggetto-nazione è colto inuna – apparentemente – concreta forma storica (tradizione, identità,nazione, secondo la terna herderiana), ma resta dotato di quella che Cassi-rer definiva «potenza demoniaca del mito»: è più leggenda di fondazioneche storia concreta, è più boria delle nazioni che concreta forma di vita(«tradizione, identità, nazione» si legge sui manifesti neofascisti inneg-gianti al genio italico che spesseggiano oggi nelle città italiane).
Il concetto otto-novecentesco di genio nazionale implica che tra indi-viduo e nazione si instauri una relazione logica simile a quella che unisce ilcavallo alla platonica cavallinità, e comporta una concezione essenzialistadell’individuo (si veda Mordenti, infra, p. 154) analoga, di principio, aquella espressa dalle più diffuse e tradizionali antropologie essenzialisteoccidentali (quella aristotelica, che ritiene l’uomo individuato dalla suaforma propria, cioè l’anima razionale; quella cristiana che vuole l’uomoanimato da una forma fatta a immagine del suo fattore, cioè Dio) e tuttaviapeggiore di queste, in quanto escludente il materiale umano che con essanon coincide: mentre l’anima-forma aristotelica e quella cristiana sonouniversali, e fanno dell’uomo un esponente del genere umano, l’anima-nazione riduce l’essenza del singolo a quella del suo gruppo12. Ogni pensie-
12.@Altra importante differenza rispetto all’essenzialismo di estrazione teologica, èche in certa cultura nazifascista il ruolo di dator formarum è trasferito da Dio all’Originegeostorica da un lato, e allo stato dall’altro: come è noto, lo stato hitleriano è descritto dalsuo teorico Carl Schmitt come Dio secolarizzato, come potere che non ha fondamento neldiritto ma solo nella propria potenza creatrice-autoritaria, in quanto ente in grado di esse-
18
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 18
ro essenzialista – a partire da quello più tradizionale e di lunga durata,aristotelico-cristiano, che predica l’essere umano determinato da un’animacreata da Dio – fu naturalmente esposto ad aggiornare la propria logicaincludendovi lo spirito di razza: così fece quella parte di cultura cattolicaaderente al fascismo descritta in questo volume da Patrick Ostermann eda Alessandro Ottaviani.
Coloro che rifiutarono razzismo e bellicismo, e sostennero tuttaviauna concezione essenzialista dell’essere umano e della nazione, manten-nero le premesse concettuali della cultura egemone e ciò indusse, in variogrado, il mantenimento del linguaggio dominante: all’indomani dellaGrande Guerra, Farinelli riconosceva che il culto della razza era vichianaboria delle nazioni13, e tuttavia per esprimere valori di fratellanza univer-sale e cristiana impiegava l’immagine della comunità come corpo dotatodi un’anima sovraindividuale, nella quale i singoli avebbero dovuto discio-gliersi14: una rappresentazione della collettività tipica della propaganda
re norma al disordine. Questa facoltà demiurgica “totale”, applicata alla collettività comeall’individuo, è centrale nel Reich tedesco ma anche, in forme radicalmente differenti,nello stato sovietico (cfr. Kline, 1968; Aschheim, 1992, pp. 219 ss., dove si osserva che nelsocialismo nietzschiano di Maksim Gor’kij e Anatolij Vasil’evic Lunacarskij «God was tobe replaced by a self-conscious and creative humanity, the individual Übermensch tran-smuted into a Marxist Übermenschtum»).
13.@«Corriamo tutti sbandati, senza che ci sorregga e ci guidi il concetto di una soli-darietà umana e fratellanza universale; e se ci abbandoniamo a distinguere gradi di valo-re tra i popoli, scale da ascendere, perché un popolo giunga alla perfezione prima e piùcompiutamente di un altro, non ci libereremo dagli eterni inganni […]. Non livellava giàDante, nel sacro poema, le disuguaglianze umane, e non flagellava l’arroganza e la presun-zione delle schiatte? “La circular natura, ch’è sugello / alla cera mortal, fa ben sua arte, /ma non distingue l’un dall’altro ostello” (Par. VIII 127). E così si spande e si sviluppal’uman seme, indistinto, libero per ogni terra, sotto un sol cielo. Ci è data la luce, la vita,non per disgiungerci, e fomentare le ire e le rivalità […] ma per […] amarci […], perchéla patria nostra rifulga entro il complesso di tutte le patrie […]. Ho sovente combattutol’assurdo concetto delle razze nel dominio dello spirito, le distinzioni folli di stirpi elettee di stirpi reiette […]. Credo che i maggiori mali si producano dall’albagia e presuntuosaarroganza delle nazioni, che ancora persiste e ordina le sue stragi. Sentimmo dai nemiciche combattemmo, le vanterie fatali: e inorridimmo. Ogni attività originale deve attri-buirsi a noi, elevati sulle genti pel volere divino – noi possediamo la privativa del genio –la verità è in noi – la civiltà, l’umanità siamo noi – spetta a noi la missione sacra nella storia– il nostro spirito unicamente riflette lo spirito dell’universo –. Guai se questa mania inva-desse la nostra nazione, e la enfiasse d’orgoglio, la rendesse pazza e delirante. Già inquie-tano i primi sintomi di questa boria nazionale» (Farinelli, 1919b, pp. 130-1).
14.@«Che valore ha l’uomo, isolato e trincerato nel suo mondo, non posto come anel-lo nella catena dell’umanità, trasfusa l’anima sua entro la grand’anima universale? E se
19
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 19
in favore della Grande Guerra, ben rappresentata dal testo di MarianneWeber citato in questo volume (infra, p. 251)15. Analogamente, alla vigiliadella presa di potere hitleriana, Thomas Mann avrebbe incitato le forzeborghesi a una lotta antinazista descritta come autoaffermazione vitale:cioè nei termini del Lebensraum hitleriano16.
Farinelli, cristiano per fede e formazione culturale, sa che dove c’èessenza c’è finalismo. Questo lo porta a cogliere l’altro fondamentalepunto ambiguo dell’antropologia herderiana: il rapporto tra uomo estoria. L’essere umano è forma già data, destinata a dispiegare sé stessanella storia («la voce ultima e più solenne della storia») o è pura proces-sualità («o è corpo, tendenza della storia stessa»)? Punto dolentissimo ediscriminante, questo: Oswald Spengler, la propaganda tedesca in favoredella Grande Guerra, Heidegger e molto nazionalismo di ambito ed epocanazista hanno risolutamente abbracciato la prima ipotesi, sostenendo cheil genio nazionale è essenza che si dispiega nella storia come destino(Losurdo, 1991, pp. 21-3). Antonio Gramsci, che ha notoriamente abbrac-ciato la seconda idea e sostenuto che l’uomo non è «natura» ma «creazio-ne storica», e dunque nessuna «legge fatale delle cose», nessun finalismo
nulla gli avviene di stringere, tesa la mano ai beni vagheggiati, se gli fallisce il benessereproprio, che importa? Potrà dirsi conquista, accrescimento di vita spirituale, quantosoddisfa il nostro cupido desiderio, il nostro egoismo? […] Se è dovere svilupparci comeindividualità spiccate, persuasi che nessuna personalità può essere franta, perché ha il suosuggello divino, è stoltizia convergere nell’io proprio l’amore di un cosmo intero, acca-rezzarci, bearci di prosperare noi, come se il destino nostro non fosse destino dei fratellie dell’umanità intera» (ivi, p. 106). L’ambiguo gioco tra collettività e individuo nell’ideo-logia del genio nazionale era stato sottolineato da Leopardi: «Ma questa è una bella curio-sità, che mentre le nazioni per l’esteriore vanno a divenire tutta una persona, e oramai nonsi distingue più uomo da uomo, ciascun uomo poi nell’interiore è diventato una nazione,vale a dire che non hanno più interesse comune con chicchessia, non formano più corpo,non hanno più patria, e l’egoismo gli ristringe dentro il solo circolo de’ propri interessi[…]. E per questo capo si può dire che ora ci sono tante nazioni quanti individui, bensìtutti uguali anche in questo che non hanno altro amore né idolo che sé stessi» (Zibaldone,148-9). L’impronta leopardiana del ragionamento farinelliano è evidente nel passo chesegue: «Senza fantasticare sulle sorti progressive dell’umanità, illusorie o reali, bene sipotrà affermare che la volontà sempre è diretta a fine di bene, e che, volendo, cioè fuggen-do l’egoismo, l’inerzia e il vuoto, conoscendo sempre più, affinando l’intelligenza, acqui-stando sempre più chiarezza e sapere, portandoci in un mondo sempre più vasto […] noitenderemo a essere migliori» (Farinelli, 1919b, p. 127).
15.@Per un’analisi dei testi e del linguaggio della Kriegsideologie si vedano i capitoliiniziali di Losurdo (1991).
16.@Cfr. su ciò infra, pp. 256-60 del mio saggio nel presente volume.
20
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 20
e nessun destino sono immanenti alla vita umana17, è portatore di unpensiero «antirazzista in radice» (Mordenti, infra, p. 155), capace, aggiun-gerei, di liberarsi persino da un tratto profondo e “tolemaico” implicitoin ogni pensiero razzista: l’antropocentrismo18. Solo i pensatori che nega-rono, nell’uomo, l’attualizzarsi di una forma formans tendente a un suoproprio fine “naturale” furono strutturalmente incompatibili con l’essen-zialismo razzista e nazionalista: il Gramsci protagonista del saggio di RaulMordenti, oppure il Robert Musil antagonista ideale del razzista Gemellinel saggio di Alessandro Ottaviani; il grande scrittore austriaco «tra il 1920e il 1922 […] con la nota formulazione della teoria della Gestaltlosigkeit,approdava alle lande, allora scarsamente lambite, di un’antropologia deci-samente antisostanzialista»19.
Per il resto, nessuna epistemologia sprovvista di questo sistema disicurezza fu al riparo dalla vischiosità dei concetti e del linguaggio razzisti,ed è impressionante osservare come su questo piano il dato irrazionale,cioè psicologico e personale, preceda quello logico e lo determini: maovviamente, entro queste condizioni generali, non tutti i casi si equivalgo-no. Il grande matematico Federigo Enriques, certo suggestionato daimpressioni ed esperienze affatto diverse da quelle dei suoi carnefici,consentì forse inerzialmente al luogo comune che la propensione ebraicaalla logica matematica derivasse dall’ermeneutica del Talmud, ma mutòlinguaggio quando ne comprese le implicazioni contingenti, cioè «dopo le
17.@La realizzazione del socialismo «non può avvenire per evoluzione spontanea […]come avviene nella natura vegetale e animale in cui ogni singolo si seleziona e specifica ipropri organi inconsciamente, per la legge fatale delle cose. L’uomo è soprattutto spirito,cioè creazione storica, e non natura. Non si spiegherebbe altrimenti il perché, essendosempre esistiti sfruttati e sfruttatori, creatori di ricchezza e consumatori egoistici di essa,non si sia ancora realizzato il socialismo» (Gramsci, 1980, pp. 100 -1).
18.@Al figlioletto Delio che osserva l’inferiorità dello sviluppo dell’elefante rispetto aquello dell’uomo, Gramsci risponde: «Non so se l’elefante può (o poteva) evolversi fino adiventare sulla terra un essere capace, come l’uomo, di dominare le forze della natura e diservirsene per i suoi propri fini – in astratto. Concretamente l’elefante non ha avuto lo stes-so sviluppo dell’uomo e non certo l’avrà più perché l’uomo si serve dell’elefante, mentrel’elefante non può servirsi dell’uomo, neanche per mangiarselo […]. Nelle tue ipotesi c’ètroppo antropocentrismo. Perché l’elefante doveva evolversi come l’uomo? Chissà sequalche saggio vecchio elefante o qualche giovinetto ghiribizzoso elefantino, dal suopunto di vista, non fa delle ipotesi sul perché l’uomo non è diventato un proboscidato!Aspetto una tua lunga lettera su questo argomento» (Gramsci, 1965, pp. 890-1, lettera 414).
19.@Cito dal saggio di Alessandro Ottaviani, infra, p. 84, cui rimando anche per i testimusiliani citati.
21
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 21
orribili teorizzazioni dei matematici e psicologi nazisti»20. Diverso è il casodei fratelli Heinrich e Thomas Mann: dissidenti ed esuli, certo, eppureimbevuti di cultura della razza, tanto da elaborare una lettura della storiafamiliare totalmente dominata da un’idea di mescolamento dello spiritolatino (rappresentato dalla madre Júlia da Silva Bruhns, metà creola e metàtedesca) con quello germanico incarnato dal padre, e da porre tale osses-sione genealogica di decadenza familiar-razziale al centro di vari roman-zi21. La dissidenza di Thomas è dunque satura di temi e linguaggi nazisti(l’esistenza come conquista di spazio vitale; la conservazione della purez-za spirituale e genealogica in opposizione al mescolamento; lo spiritogermanico e il suo naturale destino) impiegati come ambigui segni dievoluzione-decadenza della Germania goethiana, cioè borghese, blanda-mente cosmopolita e “universale” (ma sull’ambiguo valore di questauniversalità torneremo più avanti)22. Linguaggio e temi manniani inner-vano la cultura italiana sul piano letterario (ne è esempio la linea Mann-Borgese-Brancati, cui è dedicato il mio altro saggio contenuto in questovolume) e filosofico (vedi gli studi goethiani di Croce, nell’ultimo para-grafo del presente saggio).
Nel concetto di genio nazionale come essenza-destino, incredibil-mente persistente nel nostro oggi (Gentili, 2009), confluì la degenerazio-ne in senso nazionalista di certo pensiero liberale che affermò l’espansio-
20.@Questo elemento è analizzato nel saggio di Pietro Nastasi, infra, p. 96, da cui trag-go la citazione.
21.@Per i temi e i testi relativi a ciò, si veda il mio saggio infra, pp. 255-6 e 262-3, cuiaggiungo qui un documento che testimonia la principale conseguenza di una “razzizza-zione” così profondamente interiorizzata: il complesso di inferiorità generato da unapercezione del proprio essere “imperfetto” in quanto non del tutto tedesco. Nel discorsoLa Germania e i tedeschi, pronunciato il 6 giugno 1945 – un mese dopo la resa dellaGermania – alla Library of Congress di Washington, Thomas Mann ormai settantenne,esule, cittadino americano, forte di una riflessione antinazista durata più di vent’anni,continua a considerarsi – come quarant’anni prima nel Tonio Kröger – figlio bastardo edegenerato della pura razza germanica mercantile: «Mai ho pensato che sarei giuntoall’età patriarcale, quantunque teoricamente già presto lo abbia ritenuto desiderabile.Pensavo e dicevo che, una volta venuti in questo mondo, sarebbe ottima e onorevole cosaresisterci a lungo, condurvi un’esistenza completa e canonica e quale artista serbarsi carat-teristicamente produttivo in ogni fase della vita. Avevo però scarsa fede nella mia voca-zione e capacità biologica, e la perseveranza tuttavia mantenuta mi pare non tanto unaprova della mia pazienza vitale quanto della pazienza che verso di me ha dimostrato ilgenio della vita, cioè un elemento sovrappostosi, una Grazia» (Mann, 1995, p. 27).
22.@A questo proposito, si vedano, infra, l’ultimo paragrafo del mio saggio e lepp. 258-60 del mio altro contributo in questo volume.
22
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 22
ne imperialistica come necessaria all’unificazione della nazione e liquidòinternazionalismo ed egualitarismo di tradizione democratico-illumini-stica osservando che «è difficile essere più liberali della stessa storia»23:poiché la storia dimostra in re che ci sono popoli liberi e popoli non libe-ri. È naturale che Heidegger abbia detto di essersi richiamato a questatradizione nell’intervista a “Der Spiegel” (Heidegger, 1998, p. 267) rila-sciata nel 1966 – e pubblicata il 31 maggio 1976 –: la storia come attuazio-ne di essenza-destino nazionale di espansione e la connessa moralizza-zione della forza capace di espandersi (il vitale è buono in quanto tale)coincidono con il concetto di storicità heideggeriana. Lo svolgersi dell’es-senza-destino nazionale come conquista biomilitare di spazio sempremaggiore da parte di una collettività-razza risulta a Heidegger «metafisi-camente necessaria», anche nei suoi esiti più mostruosi: con queste inac-cettabili parole egli giudica nel 1941 la selezione razziale (Heidegger, 1994,p. 788, su cui cfr. Farias, 1988, passim e Faye, 2005, p. 440). D’altrondeJaspers, che si colloca all’opposto morale di Heidegger nel definire«colpa metafisica» l’essere tedeschi sopravvissuti all’orrore nazista(Jaspers, 1986, p. 73), nell’ottobre 1946 scrive a Hannah Arendt che i nazi-sti, al di qua di ogni pensiero, hanno solo realizzato ciò che sono, come ibatteri e altri esseri dannosi24, cioè mantiene il concetto nazista di storiacome destino segnato dalla propria energheia che meccanicamente siesprime, e invoca «l’essenza tedesca» in un discorso di rinnovamentodell’università (Jaspers, 1945) troppo simmetrico a quello heideggerianodel rettorato. Al contrario, nel 1934, un anno dopo il discorso del rettora-to di Heidegger, Emmanuel Lévinas elaborò, a caldo, completamentecalato nel proprio oggetto di indagine, Quelques réflexions sur la philo-sophie de l’hitlérisme, e di fronte all’urto distruttivo che questa concezio-ne della storia preparava scrisse: «L’histoire est la limitation la plusprofonde […]. La vrai liberté, le vrai commencement exigerait un vraipresent qui, toujours à l’apogée d’une destinée, la recommence éternel-lement» (Lévinas, 1997a, p. 9).
Ma il bisogno di rappresentare la storia come destino dev’essere in noi
23.@Sono parole di Friedrich Naumann (Losurdo, 1991, p. 175). Secondo la definizio-ne di Domenico Losurdo, Naumann fu un «politico nazional-liberale con forti tendenzevölkisch» intenzionato a creare un socialismo nazionale in cui l’individualismo, «piena-mente sviluppato», è trasceso in un gemeinschaftliche Daseinsweise.
24.@«I batteri provocano epidemie capaci di annientare intere popolazioni, eppurerestano batteri e nulla di più. […] Nel fenomeno nazista non c’è alcuna idea né alcunasostanza» (Arendt, Jaspers, 1989, p. 71).
23
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 23
sordo a ogni richiamo della ragione, se un padre dello storicismo, Fried -rich Meinecke, nel 1946 poteva aprire l’opera da lui intitolata alla DeutscheKatastrophe parlando di un’«epoca in cui il nostro destino si compì»,contestualizzata spenglerianamente come segue: «la questione della cata-strofe della Germania si sviluppa […] nel più vasto problema del destinodell’Occidente» (Meinecke, 1948).
L’«essenza» umana: biologismo e idealismo
È usuale distinguere, nel razzismo novecentesco, un filone materialisticoe uno spiritualistico. In base a questa distinzione – e alla connessa, più omeno esplicita, attribuzione di maggior gravità al razzismo biologico – èstata giudicata la compromissione e, per così dire, la “compatibilità” conle dottrine della razza di molti protagonisti della cultura tra le due guerre,per mezzo d’uno schema di ragionamento costante.
L’osso di questo ragionamento, che continua a essere impiegato adesempio in difesa di Gentile e di Heidegger, è che le filosofie idealistichesono strutturalmente a riparo dal razzismo, come da qualunque determi-nismo di matrice naturalistica25: e dunque Gentile come Heidegger nonpotrebbero affermare alcuna forma di razzismo senza negare il proprioidealismo. È un vecchio argomento, usato da Heidegger stesso nel 1945 perdimostrare la propria estraneità al razzismo nazista26, ed è, più in genera-
25.@L’idea che la filosofia di Gentile, in quanto antinaturalistica, sia per ipotesiincompatibile con prese di posizione razziste del suo creatore è sostenuta da GennaroSasso (2009) attraverso un ragionamento analogo a quello con cui François Fédier e GinoZaccaria hanno difeso Heidegger da sé stesso («Se, guidati da Heidegger, pensiamo indirezione del Dasein, siamo il più lontano possibile da ogni forma di pragamatismo e dibiologismo, e quindi da ogni considerazione dell’uomo storico in base all’efficacia dellesue manipolazioni, oppure in base alla razza o alla nazione (là dove s’intenda quest’ultimain senso nazionalistico o biologico). Del resto […] il Dasein […] non è (più) l’homoanimalis!» (Zaccaria, Introduzione a Heidegger, 1998, p. 12). Su Gentile e la politica razzia-le fascista, si veda l’ottimo Rota (2008).
26.@Ecco i punti chiave della posizione heideggeriana espressi dal filosofo nella Lette-ra al Rettorato accademico dell’università Albert-Ludwig di Friburgo in Bresgovia, datata 4novembre 1945: «L’esposizione delle mie posizioni filosofiche fondamentali fu sufficientea segnare l’opposizione netta nei confronti dell’indurimento dogmatico e del biologismoprimario professato da Rosenberg. […] Il solo fatto di esercitare a mio modo il mestieredi filosofo era già fare della resistenza. […] Nel primo semestre dopo le dimissioni tenniun corso e trattai, sotto il tema della Dottrina del logos, l’essenza del linguaggio. Il miointento era quello di mostrare che il linguaggio non è un mezzo di espressione dell’essereumano concepito dal punto di vista biologico e razziale, ma che, al contrario, l’essenza
24
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 24
le, una vecchia pretesa idealistica: il regno dei concetti sarebbe incondi-zionato dalla materia, dalla natura e dai meccanicismi della vita biologica.Eppure, se fosse vero che il Dasein è «lontano da ogni biologismo» e da«ogni considerazione dell’uomo storico […] in base alla razza o alla nazio-ne» Heidegger non avrebbe potuto dire che la nazione è Geschick, cioèdestino comune in cui «i singoli destini sono anticipatamente segnati»(Heidegger, 1976, p. 461, cit. in Losurdo, 1991, di cui riporto la traduzione).
Questo vecchio argomento antinaturalistico è inconsistente, anzituttopoiché in ambito idealistico il mondo delle idee è raffigurato e concepitoin chiave puntualmente organicistica, e poco importa che si tratti di unametafora: al momento di esprimere l’idea calata nella storia, cioè nel dive-nire, l’idealismo non trova altro mezzo di rappresentazione che la genea-logia. Le varie ontologie dialettiche che caratterizzano l’idealismo otto-centesco – da un certo punto di vista riproposizioni in chiavegenealogico-triadica del vecchio passaggio dalla potenza all’atto – coin-volsero anche l’“Idea” di essenza nazionale, in Fichte27 e Hegel28. In
dell’essere umano si fonda nel linguaggio in quanto realtà fondamentale dello spirito. Apartire dal 1936, con la serie dei miei corsi e conferenze su Nietzsche, si accentuarono, conevidenza ancora maggiore, l’opposizione e il contrasto spirituale. Non è assolutamentepossibile porre Nietzsche sullo stesso piano del nazionalsocialismo; a prescindere da ciòche è fondamentale, lo impediscono già sia la posizione di Nietzsche contro l’antisemiti-smo sia il suo rapporto positivo con la Russia. Ma, a un livello più elevato, il dibattito diri-mente con la metafisica di Nietzsche costituisce il dibattito dirimente con il nichilismo,del quale il fascismo si rivelava essere, sempre più chiaramente, la forma di apparizionepolitica» (Heidegger, 1998, pp. 225-6).
27.@È appena il caso di ricordare che Fichte aveva codificato, accanto alla relazionetra io puro e io empirico (cioè tra essenza e fenomenizzazione storica di essa), il tema delprimato del popolo tedesco come prodotto del suo vitalismo assoluto (nessun legame conciviltà e lingue morte) e della sua assoluta purezza di sangue (il sangue del popolo tede-sco non è mescolato a quello di altre stirpi), temi ripetuti da Mann (vedi il mio altrosaggio, infra, pp. 258-9). Questo primato fa sì che il tedesco sia piena realizzazione dell’u-mano; il pensiero tedesco è la filosofia. Quest’ultimo tema è ampiamente ripreso daHeidegger, che si richiama infatti esplicitamente all’idea fichtiana di comunità tedesca; siveda, su ciò, Losurdo (1991, p. 36), dove si osserva che il concetto di comunità nazionalecosì costruito da Heidegger «si configura come “vero cameratismo e autentico sociali-smo”, ma sembra trovare il suo fondamento nelle “forze della terra e del sangue”, anchese è da aggiungere che il biologismo razzista propriamente detto rimane sempre del tuttoestraneo al filosofo». Il ragionamento su biologismo e idealismo razziale che qui propon-go riduce questa “estraneità” a un atteggiamento di superficie.
28.@In ambito nazista l’antihegelismo – cioè il rifiuto dello stato hegeliano massifi-cante in senso egualitario –, sottolineato da Losurdo (1997, p. 657) attraverso la famosafrase di Carl Schmitt (1933, p. 32): «Oggi [scil. 30 gennaio 1933] Hegel, per così dire, è
25
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 25
secondo luogo, nei primi anni del Novecento si registra nel pensiero biolo-gico tedesco e italiano una reazione all’evoluzionismo darwinista (maanche al monismo haeckeliano e all’embriologia sperimentale meccanici-stica) consistente nel recupero della “causa interna” descritta esplicita-mente come entelechia aristotelica e di una sua fenomenizzazione botani-ca, la specie fissa linneana (Ottaviani, 2002, p. 47). Le più autorevoli figuredella biologia italiana29 – così come in Germania Hans Driesch, fondato-re del movimento neovitalista – affermano un principio vitale che sfuggeall’ambito chimico-fisico. Su questo punto si registra reciproco sostegnotra i biologi e i filosofi idealisti italiani30.
Quando gli antidarwiniani come Driesch rivendicano un principiovitale che è forma immutabile e per giunta misteriosa, non del tutto descri-vibile, concettualizzabile e conoscibile, compiono un’operazione analogaa quella con cui Ernst Moritz Arndt (1769-1860), romantico nazionalista,delineò il concetto di lingua tedesca, realtà dotata di un’anima misteriosache la linguistica non può cogliere (Merker, 2001, p. 62). Sullo sfondo ideo-logicamente compatto d’una biologia e d’una filosofia sostenitrici diun’essenza vitale non riducibile alla materia, la linguistica nazista potépredicare una lingua che, in quanto diretta espressione dell’essenza nazio-nale, fosse statica e immutabile (Koesters Gensini, 2008, pp. 192-205);soprattutto, non è un caso che il medesimo Heidegger intento a scagio-narsi dal biologismo volgare della razza, affermi che il suo intento fu «dimostrare che il linguaggio non è un mezzo di espressione dell’essereumano concepito dal punto di vista biologico e razziale, ma che, al contra-rio, l’essenza dell’essere umano si fonda nel linguaggio in quanto realtàfondamentale dello spirito», e poi, nella terribile intervista rilasciata a
morto», convive con le rivendicazioni della radice hegeliana dello stato come potenza: èforse proprio commentando la frase schmittiana, e volendola integrare nel senso di Heller(su cui si veda il mio altro saggio, infra, p. 260), che Heidegger nota: «È stato detto chenel 1933 Hegel era morto; al contrario, è solo allora che ha iniziato a vivere». Traggo ilbreve brano, da me tradotto in italiano, dal testo del seminario inedito dedicato daHeidegger alla teoria hegeliana dello stato (Hegel über den Staat, Winterseminar 1934-35,Deutsches Literatur Archiv, Marbach am Neckar, inizio della lezione ottava, 23 gennaio1935, reportatio di Wilhelm Hallwachs, f. 75v.), citato da Faye (2005, p. 364).
29.@Ad esempio Giovan Battista Grassi, maggior biologo italiano del primo trenten-nio del Novecento, Davide Carazzi, biologo e docente all’Università di Firenze, AndreaGiardina, biologo e docente a Pavia, le cui tesi, per ciò che ci interessa, sono affidate aGrassi (1906), Giardina (1906, 1920), Raffaele (1912) e analizzate da Ottaviani (2002).
30.@Il saggio di Federico Raffaele (1912) è ospitato proprio nel volume 1 del -l’“Annuario della Biblioteca Filosofica”, organo dell’idealismo di Giovanni Gentile.
26
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 26
“Der Spiegel”, affermi che la lingua della filosofia è il tedesco, talché i fran-cesi per riuscire a pensare devono cambiare lingua (Heidegger, 1998, pp.292-3)31. Dove finisce lo spirito della lingua e dove inizia la sua concretez-za vocale e fisiologica? Qui non siamo più nel dominio della filosofia madella cattiva sofistica. Il sofisma antimaterialistico crolla, d’altronde, sottoil bastevole peso del Dasein heideggeriano e dello Schicksal spengleriano:dove si collocano l’“esserci” e il “destino” se non sul piano dell’esistenza,cioè del sinolo di materia e forma?
Questo «approccio vitalistico-metafisico al concetto di nazione»(Merker, 2001, p. 64), già proprio del vitalismo romantico continuato dallacultura idealistica-neovitalistica tedesca, e la connessa sovrapposizione traidealismo e metafora organicistica rendono del tutto naturale la riduzio-ne della dottrina di un Lagarde – che dice biologicamente impossibile lapurezza razziale ma afferma la germanicità come categoria spirituale (ivi,pp. 127-8) – ad autorità invocabile dal razzismo biologico32. D’altronde
31.@A una lingua che è misura del mondo corrisponde sempre, storicamente, la radica-le negazione della facoltà di linguaggio all’umanità che non ne partecipa: lo “staffile” come“traduttore” impiegato dagli italiani con le popolazioni locali nelle colonie africane (si vedail saggio di Laura Ricci, infra, p. 197) corrisponde perfettamente al “bastone”, mezzo dicomunicazione dei nazisti con gli internati nel Lager in Se questo è un uomo di Primo Levi.
32.@Il bel volume di Nicolao Merker ha il solo difetto di mantenere la superficialecontrapposizione tra razzismo biologico e razzismo spiritualistico, e di cadere con ciò inqualche contraddizione. In merito all’uso di Lagarde in ambito nazista, lo studiosodenuncia la strumentale riduzione di uno spiritualista all’orizzonte biologico-materialisti-co: «L’etnocentrismo funzionava dunque anche senza ricorrere al razzismo biologico.Bastava una premessa qualsiasi che sottolineasse le differenze tra i popoli e venisse peròspacciata per universale (in Treitschke era il postulato della diseguaglianza originariadegli uomini, in Lagarde quello delle nazioni che dilapidano l’originario patrimonio crea-zionistico divino, ed ecco pronta per l’uso una dottrina della contrapposizione assiologi-ca tra le nazioni. Certo, un etnocentrismo […] “spirituale” […], lasciava aperta ai gruppiinferiori la strada di redimersi con l’assimilazione culturale al gruppo superiore […]. Maalmeno l’etnocentrismo ideologico non implicava necessariamente l’eliminazione fisicadegli etnicamente diversi: la quale era invece un corollario d’obbligo per l’etnicismobiologistico, non essendo le caratteristiche biorazziali cambiabili a piacere. Quando inazisti fecero di Lagarde un araldo della purezza del sangue e della razza, fu perciò un’o-perazione soltanto strumentale» (Merker, 2001, pp. 128-9). Ma cosa siano le caratteristi-che “biorazziali” ce lo dimostra lo stesso Merker quando afferma che il diritto alla nonassimilazione delle minoranze nell’Europa attuale in quanto «difesa di questo o quelparticolare contenuto etnico-culturale» rischia di essere una «riedizione moderna delcuius regio, eius religio» e dunque «un altro modo, appena più aggiornato, di “biologiz-zare” l’identità nazionale». Insomma, è il linguaggio stesso di Merker a rivelare che labiologicità della nazione consiste nella sua “anima” immutabile di contenuti culturali:
27
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 27
Evola, capofila del razzismo cosiddetto spirituale, sostiene una relazionetra corpo e spirito al contempo reale e «simbolica»33 affermata anche dal«biologizzante» Giulio Cogni34.
Costituzionale degli idealismi non è tanto, dunque, essere incompati-bili con il determinismo naturalistico, ma pretendere di esserlo rappre-sentando i concetti in forma organicistica; la meccanica della vita, impie-gata come strumento descrittivo ma disconosciuta nella sua forzalegislatrice, compie allora la sua nemesi, e accade che un sistema idealisti-co sostituisca alla categoria dell’economico quella del vitale. Mi riferiscoovviamente all’ultimo Croce, partito da una relazione tra uomo e storia incui l’«“accadimento”, che si contrappone all’individualità dell’azione, è[…] “opera di Dio”, cioè sovrapersonale, […] nel senso che è il “risulta-mento” che consegue dal reciproco incontrarsi delle azioni umane» (Mori,2003, p. 709). Questa dimensione, definita nei testi crociani «sovraperso-nale»35, come nei testi tedeschi che illustrano l’ideale mistico-collettivodella Gemeinschaft in cui il singolo trascende sé stesso36, si rivela all’ultimoCroce come il regno in cui «la vita organica non aspetta il nostro permes-so per farsi valere»37.
emerge dalle parole di Merker la tradizionale metafora organicistica cui è affidato il Geistnazionale (ivi, pp. 198-9).
33.@Evola (1979), p. 23, passo discusso in Germinario (2001, pp. 21-2), con acutissimeosservazioni.
34.@Gli ariani sono «simbolo e incarnazione precisa del regno dello Spirito» perché«Il corpo è la prima parola dell’anima […] ed essenziale è propriamente tutto quell’orga-nismo sintetico di linee (piegabili poi naturalmente in infiniti modi) che esprime quellospirito di cui abbiamo parlato. Perché essenziale è lo spirito». L’autore afferma poco piùgiù che la razza è «epifania dello spirito» (Cogni, 1937, p. 184). Sulla parabola di Cognivedi Cassata (2008, p. 24).
35.@Ad esempio: «L’opera del Kant e di ogni filosofo, come di ogni poeta, di ogniuomo nella sua particolare attività, è sempre sovra personale, perché […] nasce dallo spiri-to del tempo e della società a cui egli appartiene, collaborati con lui» (Croce, 1963, p. 191).Vedi inoltre le occorrenze crociane nel Grande dizionario della lingua italiana diretto daS . Battaglia, vol. XIX, alle voci sovrapersonale, sopraindividuale e superindividualistico.
36.@Sul tema della Gemeinschaft, definita «connessione vitale sovrapersonale» in uncomune destino, si vedano Losurdo (1991, pp. 16-23) e il mio altro saggio infra, p. 251.
37.@«Almanaccare che l’elemento morale operi in noi da solo è pensiero sciocco,perché, se così fosse, non avrebbe niente da operare; rinunziare alle leggi della vita pernon passare attraverso i colpi e i rovesci che ci infliggono i bisogni e le necessità delle coseche si dicono naturali e di quelli che si dicono attinenti al corpo dell’uomo, che è un corpotra i corpi, sarebbe pensiero vile, se non fosse assurdo, perché la vita organica non aspet-ta il nostro permesso per farsi valere» (Croce, 2005, p. 807).
28
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 28
La banale, spietata questione di fondo è che nessuna filosofia è exhypothesi all’asciutto dalla bufera delle circostanze storiche; a chi affermache Heidegger prese le distanze dalla propria adesione al nazismo defi-nendola «un errore» basti obiettare che gli errori si pagano; questo nonsu un piano moralistico – cioè nella logica dell’assoluzione – bensì reali-stico: nella logica delle conseguenze. Ancora una volta il precocissimoLévinas del 1934 centra il punto: «una contraddizione logica non può valu-tare e decidere di un avvenimento concreto»; «il significato di unacontraddizione logica che oppone due correnti di idee risulta chiaro solose si risale alla loro fonte originaria, all’intuizione, alla scelta che le rendepossibili»38.
Che cos’è la filosofia?
Bisogna a questo punto retrocedere la domanda gramsciana – che cosa èl’uomo – alla sua premessa di metodo. Dire, come fece Gramsci, che l’uo-mo in generale è un residuo metafisico deve servire a contestare la rimo-zione dal dominio della filosofia dell’individuo singolo, in carne e ossa,con la sua povera realtà di debolezza, di bisogno e di dolore. Risposte aquesto bisogno sono venute da quei sistemi di pensiero che postulavanouna mediazione necessaria tra il singolo e la storia: ad esempio dall’antro-pologia di Ernesto de Martino, sulla cui “filosoficità” condivido piena-mente la posizione di Fabio Ciaramelli; in De Martino il mito religioso sidà come «mediazione originaria tra esistenza e storia, o tra psiche esocietà» (Ciaramelli, 2003, p. 157)39 e compensa lo iato emotivo tra indivi-duo e mondo così come fa ogni «metastoria mitico-rituale» (De Martino,1980, p. 125): compresa quella della razza. Questo iato, questa sofferenzaoriginaria determina una spinta a conoscere, a elaborare strumenti dirappresentazione; ma alla spinta emotiva deve sostituirsi la scelta morale
38.@«Le conflit ne se joue pas seulement entre le libéralisme et l’hitlérisme. Le chri-stianisme lui-même est menacé malgré les ménagements ou Concordats dont profitèrentles Églises à l’événement du régime. Mais il ne suffit pas de distinguer, comme certainsjournalistes, l’universalisme chrétien du particularisme raciste: une contradiction logiquene saurait juger un événement concret. La signification d’une contradiction logique quioppose deux courants d’idées n’apparaît pleinement que si l’on remonte à leur source, àl’intuition, à la décision qui les rend possible. C’est dans cet esprit que nous allons expo-ser quelques réflexions» (Lévinas, 1997a, pp. 25-6; traduzione nostra).
39.@Per una diversa valutazione del rapporto tra De Martino e la filosofia si veda Sasso(2001), d’altronde discusso in Ciaramelli (2003, pp. 155-8), con argomenti su cui concordo.
29
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 29
nella misura in cui questi strumenti di rappresentazione debbono serviread alleviare la sofferenza umana – così il religioso demartiniano – e non aprodurla, come i razzismi d’ogni tempo e latitudine.
La scommessa reale è, sempre, se una certa filosofia sia, sia stata e possaessere “buona” per la vita, e, se ci siamo già risposti che una certa filosofiaè buona per la vita, siamo ancora costretti a chiederci per la vita di chi essaè buona. Il Dasein heideggeriano è buono solo per la vita di sé stessi; l’esse-re per l’altro che Emmanuel Lévinas ha opposto al Dasein di Heidegger èbuono per la vita di tutti40. Lévinas promuove l’essere per l’altro contro lametafisica del sé assoluto: straordinaria intuizione confermataci dal fattoche l’essere per l’altro fu inteso da Evola, campione del razzismo metafisi-co, come caratteristica di una categoria di esseri imperfetti41.
Anche sulla scia della riflessione di Cassirer menzionata alla fine delprimo paragrafo, i filosofi che in epoca novecentesca hanno consideratoloro dovere intellettuale combattere e neutralizzare l’eredità dell’antro-pologia nazionalista (come Isaiah Berlin in Il legno storto dell’umanità del1959 e nel successivo Vico e Herder del 1976) e hanno contrapposto all’es-senzialismo nazionale e razziale la storia come divenire e l’uomo comeparte non predeterminabile di essa, hanno anche cercato di rifiutare lastoria come categoria metafisica. La storia come vicenda di individui,come concreto fenomeno umano (professata da Herder e dal protoro-manticimo secondo Berlin, 1978, dall’illuminismo borghese di Lessing eVoltaire secondo Améry, 2001) resta un orizzonte ancora da raggiungere.
40.@«La source de la barbarie sanglante du national socialisme […] tient à une possi-bilité essentielle du Mal élémental où bonne logique peut mener et contre laquelle laphilosophie occidentale ne s’était pas assez assurée. Possibilité qui s’inscrit dans l’ontolo-gie de l’être “dem in seinem Sein um dieses Sein selbst geht”, selon l’expression heideg-gerienne. Possibilité qui menace encore le corrélatif de l’“être à rassembler” et à “domi-ner”, ce fameux sujet de l’idéalisme transcendental qui, avant tout, se veut et se croit libre.On doit se demander si le libéralisme suffit à la dignité authentique du sujet humain. Lesujet atteint-il la condition humaine avant d’assumer la responsabilité pour l’autre hommedans l’élection qui l’élève à ce degré? Élection venant d’un dieu – ou de Dieu – qui leregarde dans le visage de l’autre homme» (Lévinas, 1997b, pp. 25-6).
41.@«La sostanza della donna è […] eteroriferimento […]: non un essere, ma […] unrimettersi e darsi ad altro; tutto un bisogno di non essere per essere» (Evola, 2007, p. 116).Cavaglion (2000, p. 385) osserva che il raptus teorico evoliano sull’essenza femminile comenon essere, ma chiedere/negare, nasce da «sommità meno metafisiche di quelle esibite inpubblico», cioè dall’amore per Sibilla Aleramo: il culto dell’essere come autoaffermazio-ne e il disprezzo dell’essere per l’altro trovano radice psicologica anche nella banale e vilepaura di affidarsi all’altro ed esserne rifiutati.
30
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 30
Genio nazionale e letteratura “universale” attraverso i classici: Dante e Goethe tra Germania e Italia
In Italia il mito del genius nationis espresso dai classici della letteraturanazionale ha goduto e gode ancora oggi di grande fortuna bibliografica,eppure, per chi voglia sapere di che cosa si sia discusso sotto la comodacopertura dei classici negli anni tra le due guerre, le notizie non abbonda-no. Ecco un episodio significativo sospeso tra Italia e Germania, tra lette-ratura mondiale e universalizzazione di una letteratura nazionale.
Nella Germania degli anni Trenta la partita tra fautori dell’hitleri-smo e suoi oppositori si giocò anche attraverso l’interpretazione dellatradizione letteraria nazionale; nel 1932, attraverso la figura di Goethe,Thomas Mann, chiamato a celebrarne il centenario della morte nellasede dell’Accademia di Prussia, esaltò un germanesimo borghese-illu-ministico che oppose a quello faustiano propugnato dall’imminenteregime hitleriano. Il Goethe manniano è misura universale, eppure tede-sca e borghese42.
La contrapposizione tedesca tra un Goethe, il cui spirito germanico eborghese si dilata a “misura universale”, e lo spirito faustiano dellaGermania nazista venne agita anche in Italia: a un Guido Manacorda,traduttore della letteratura tedesca sub specie hitleriana si contrapposeCroce, lettore di essa sub specie manniana. Questa stagione di studigoethiani è efficacemente evocata da Borgese nell’introduzione al suosaggio su Faust (Borgese, 1933, p. IX):
Intere generazioni di studiosi hanno meditato sul Faust, ed anche l’Italia, sebbe-ne lentamente, si industria a correggere i paradossi di Vittorio Imbriani. In unmedesimo anno gli studenti dell’Università di Torino hanno ascoltato le fervidelezioni di Arturo Farinelli sul capolavoro goethiano e gli editori Laterza hannointrapreso a pubblicare in lingua nostra quel grandioso lavoro di Karl Vosslersulla Divina Commedia, ove si legge, tra l’altro, un veemente e sottile paralleli-smo tra la visione dantesca e il poema drammatico del traviato e redento dotto-re. […] Paragonare la Divina Commedia al Faust, considerare l’una e l’altrocome i due vertici della poesia moderna, era già da gran tempo divenuto uncomune riconoscimento della grandezza di Goethe.
Dal passo borgesiano emergono due elementi importanti: la centralità
42.@L’analisi di questo testo manniano su Goethe è nel mio saggio, infra, pp. 257-60.
31
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 31
del tradizionale parallelismo tra i due poeti dell’oltremondo, Dante eGoethe, a opera del dantista tedesco e sodale di Croce, Karl Vossler, e ilfatto che dall’insegnamento del già menzionato comparatista “eccentrico”Arturo Farinelli, nacque buona parte della critica goethiana prodotta inItalia dagli anni Venti ai Quaranta43. La letteratura tedesca di Farinelli nonera sospesa nell’empireo sottratto alla storia del Goethe crociano: o forsesvelava nel Goethe super partes di Croce e Borgese un universalismo dimatrice un po’ più terrena. Farinelli, erudito irriducibile a ogni legge(Croce lo lodò in quanto autorevole e generosa fonte di informazioni ispa-nistiche, ma ne punì poi il rifiuto a conformarsi alla sua estetica), figliod’un mercante di Verbania cresciuto tra Italia, Svizzera e Germania,realizzò ventenne il sogno d’un viaggio di formazione in Spagna: cosmo-polita per storia e inclinazione, a questa percezione del mondo ne avevalegata una della cultura come fatto non nazionale ma “mondiale”,«persuaso che le correnti spirituali corrono per ogni terra, libere, indeno-minabili, limpide o torbide, pronte a rifiutare quegli argini posti così solle-citamente […] dai solerti regolatori e amministratori dei fatti dello spiri-to» (Farinelli, 1923, p. 32). Dal 1904, anno della sua drammatica cacciatada Innsbruck a opera dei nazionalisti tirolesi, Farinelli aveva imparato asue spese che la «letteratura mondiale» è un «sogno»44 perché nella realtàuna lingua e una letteratura divengono universali per imposizione politi-ca sulle altre, e nella prolusione antirazzista del 1907 aveva aspramentecriticato l’identificazione tra Goethe e lo spirito tedesco45. La linea rettadell’antinazionalismo farinelliano non condiziona la curva assai piùmorbida dei suoi lettori: quella del germanesimo che coincide con il«buon senso» e con l’«equilibrio», universale virtù «borghese» delGoethe manniano e crociano (Croce, 1959, pp. 2-3)46:
Artista nella vita, egli è maestro […] prima di tutto della vita dell’uomo inquanto puro uomo, col mostrare nel fatto come se ne risolvano i problemi gene-
43.@Borgese dedica a Farinelli il suo saggio sul Faust, e lo stesso fa Croce con il primoblocco di saggi goethiani del 1919, sebbene lo critichi poi nel secondo blocco, pubblicatonel 1934.
44.@Il sogno d’una letteratura mondiale è il titolo di una sua opera del 1923.45.@«Né smettono i critici di considerare un tipo letterario determinato, come simbo-
leggiante una nazione o una razza. Ritengono taluni il don Chisciotte, simbolo dellaSpagna intera, il don Giovanni, simbolo della razza latina, il Faust della germanica» (Fari-nelli, 1919c).
46.@La consonanza del giudizio crociano con quello manniano è menzionata daD’Angelo (2003, p. 242).
32
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 32
rali, di totalità e specificazione, di costanza e cangiamento, di passione evolontà, di pratica e teoria. La sua biografia, congiunta all’opera sua, offre uncorso classico e completo […] di alta umanità. Vero è che una certa letteraturadi moda […] ha preso a raccomandare l’imitatio Goethii, descrivendo ilproprio modello come un essere sovrumano o disumano, collocato di là delbene e del male, si è compiaciuta di questa immagine, che rispecchia le proprieinsanie. Ma la figura di Volfango Goethe è composta di virtù tranquilla, di seriabontà e giustizia, di saggezza, di equilibrio, di buon senso, di sanità, e, insom-ma, di tutto ciò che si suole irridere come «borghese». L’arte di sottrarsi aimesti doveri, e di assottigliarsi e trasumanarsi, o di sensualizzarsi e imbestiarsi,si potrà apprendere da altri maestri ma non da lui. Fu profondo ma non «abis-sale», come ora si bramerebbe considerarlo […]. La sua parola era semplice,chiara e bonaria […]. Per esempio, volendo raccomandare di non perdersinell’astratta universalità, diceva «Willst du dich am Ganzen erquicken, Somusst du das Ganze im Kleinsten erblicken» («se tu vuoi ricrearti nell’intero,devi vedere l’Intero nel piccolissimo»).
Croce riconosce nell’opera goethiana uno spazio sottratto alla bufera dellepassioni e della storia (D’Angelo, 2003, pp. 236-8), ma, come già ricorda-to, le premesse di questo giudizio crollano nel Croce del dopoguerra, alfie-re di un vitalismo dotato di opposte potenzialità morali e percepito comeineluttabile correzione alle “illusioni” dei filosofi sull’intangibilità delpensiero47.
Un altro genere di Goethe “universale”, moralmente opposto a quel-lo crociano e manniano, eppure ancora una volta troppo contiguo a esso,fu al centro della lettura nazista del Faust importata in Italia: nella colla-na “Biblioteca di Scienze Moderne” stampata a Torino dall’editoreBocca, una vera e propria concretizzazione italiana della cultura dellarazza, trova posto nel 1932 un Commento alla vita di Faust. Contributo aduna concezione goethiana della vita, dovuto a un Leonardo Grassi, liberodocente presso l’Università di Catania. La chiave esistenzialista dell’in-
47.@«Aborro dalla moda odierna dei “testamenti spirituali” […] ma confesso chetalvolta debbo scacciare la tentazione di raccomandare, quasi come per testamento spiri-tuale, questa parte del lavoro mentale della mia vita alla meditazione e alle ulteriori inda-gini, perché mi pare che riguardi un punto capitale, non considerato o spregiato di solitodai filosofi, ma di grande conseguenza per la interpretazione filosofica della realtà, di unaverità necessaria alle verità dell’estetica e della logica e soprattutto della vita morale, chenella forma vitale, positivamente intesa, nella speciale spiritualità di questa, ha la suapremessa, e nell’elevarsi sopra di essa, dominandola e piegandola a sé, la sua legge»(Croce, 1993, p. 332).
33
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 33
terpretazione, e insomma lo Schicksal faustiano che costituisce secondol’autore la maggior lezione goethiana, è mutuata dai commentatori dellaGermania coeva, mentre la destinazione universale dell’universale inquanto tedesco Goethe è animata dal parallelismo con Dante, già vossle-riano e crociano48.
In questa situazione il cattofascista Guido Manacorda può accusareCroce di esaltare in Goethe l’antipatriota filonapoleonico (D’Angelo,2003, p. 249), e – con assai maggior fondamento – di massacrarne l’ope-ra immortale con traduzioni così fantasiose che fra le parole dell’origi-nale e quelle del traduttore «corre la stessa misteriosa parentela che tra“Nabucodonosor” e “violino”»49 (Manacorda, 1932, p. 12), ma proponedi Goethe una lettura “universale” non dissimile, in radice, da quellacrociana.
Non sorprende, dunque, che l’ermeneutica del Faust divenga terreno
48.@«Non ai soli tedeschi, ma a tutto il mondo ha detto Goethe le parole essenzialidella salute, il “redimersi dell’eroe attraverso l’azione, la vittoria sulla morte e il demonioper mezzo dell’impulso di autoconservazione e svolgimento della monade, l’esplicarsi e ilpotenziarsi dell’entelechia” [citazione tratta dall’introduzione di E. Traumann aJ. W. Goethe, Faust, Beck, München 1920, come quella seguente, in tedesco]. Il grandepoema deve necessariamente ad essi [i tedeschi] apparire, come è stato ben detto, lacanzone del cielo e dell’inferno dell’eroe e dello spirito tedesco – der Lieder vom Himmelund von der Hölle des deutschen Geisteshelden» (Grassi, 1932, p. XV).
49.@«Ad apertura di libro: An Luna (vv. 14-16): “Säh’ der weitverschlagne Ritter /Durch das gläserne Gegitter / Seines Mädchens Nächten zu.” Traduzione letterale:“Potesse il cavaliere sbattuto (errante) lontano contemplare (zusehen) attraverso la vitreagrata di ferro / le notti della sua fanciulla!”; Croce (p. 148): “oh ch’io (?) veda, fra i vetri e icancelli (!), / la stanzetta (?) ove trepida (!) quella / che il mio cuore tutt’empie di sé! (!!)”.Generosa ricompensa a chi troverà nei sopra riferiti versi goethiani: 1) un cancello (bastamicroscopico), 2) una stanzetta, 3) una “quella” che trepida, 4) la medesima “quella” cheriempie di sé il cuore di qualcuno. Analoga ricompensa a chi alla sua volta, riuscirà arintracciare nella versione crociana: 1) un “cavaliere errante lontano” dal suo paese,2) una “notte” da lui contemplata, 3) un rapporto qualsiasi (anche melanconico, anche incagnesco) tra l’ottonario trocaico goethiano (ital.: “Mànda a Cuòsa in vàl di Sérchio”) eil decasillabo o quasi crociano (ital.: “S’ode a dèstra uno squíllo di trómba”)». Brautnacht(vv. 17-18): “Wie bebt vor deiner Küsse Menge / Ihr Busen und ihr voll Gesicht!”. Tradu-zione letterale: “Come trema sotto la quantità dei tuoi baci il suo petto e il suo visopieno!”; Croce (p. 149): “Come freme de’ tuoi baci al furore / il seno a lei, che sa senzasapere! (!!)”. Il lettore ha certo subito inteso che tra “viso pieno” e “sa senza sapere”corre la medesima misteriosa parentela che tra “Nabucodonosor” e “violino”» (Mana-corda, 1932, pp. 11-2).
34
S O N I A G E N T I L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 34
di un regolamento di conti con il passato in epoca postbellica. Così, alFaust nazificato, risponde Theodor W. Adorno (1961, pp. 15-7):
Che cosa non si è combinato con la questione se il diavolo abbia o no vinto lascommessa! Con quanto spirito sofistico ci si è aggrappati al potenziale «potreidire all’attimo fuggente» per dedurne che Faust non pronuncia effettivamentel’«arrestati, sei bello» della scena Studio II! Come si è ben distinta, con la piùmeschina tolleranza, la lettera dal significato del passo! Come se la fedeltà filo-logica non fosse il dominio di col ui che insiste per ottenere la firma tracciata colsangue, perché questo è un succo specialissimo […]! La scommessa è perduta.Nel mondo in cui tutto funziona per bene, in cui si barattano quantità uguali – ela scommessa stessa è un’immagine biblica del baratto – Faust ha perso […]. Seavesse vinto, sarebbe stata un’assurdità, un’ingiuria all’economia artistica,mettergli in bocca nell’attimo della morte proprio quei versi che a norma delpatto lo consegnano al diavolo. Invece è il diritto stesso che viene sospeso. Un’i-stanza più alta pone freno all’eterna parità di credito e di debito. Essa è la Grazia[…] quella che viene prima del diritto e davanti alla quale si interrompe il ciclodi causa ed effetto […]. La metafisica del Faust non è quel faticato anelito a cuiall’infinito arride la ricompensa neokantiana, ma è la scomparsa dell’ordinenaturale in un altro.
È incredibile che Cesare Cases, riportando questo brano nella sua Intro-duzione all’edizione einaudiana del Faust, si sia limitato a osservare chequesta pagina è «più suggestiva che persuasiva»50, senza chiedersi chiAdorno volesse persuadere e che cosa volesse egli suggerire. Secondo ilfilosofo, Faust compie l’errore che lo consegnerebbe al diavolo eppure sisalva, poiché «il diritto è sospeso», così come era avvenuto nella Germa-nia del Dodicennio nero. Ma mentre in quella circostanza storica CarlSchmitt aveva teorizzato lo stato d’eccezione come giustificazione delpotere assoluto dello stato, Adorno cambia di segno alla sospensione deldiritto, riconoscendovi la cessazione dell’ordine umano del contrappassopunitivo e l’istaurarsi dell’ordine della Grazia: quello del perdono divinoe della remissione dei debiti.
La necessità di liberare la tradizione letteraria dall’impronta dei carne-fici produrrà un complesso e “obliquo” modo di reimpiegare i classici neitesti scritti delle vittime: ma questa è un’altra, terribile storia (Gentili,2008, pp. 551-5).
50.@Così Cases (1965, pp. LXVIII-LXIX), da cui traggo anche la traduzione del brano corri-spondente ad Adorno (1961, pp. 15-7).
35
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 35
36
S O N I A G E N T I L I
Bibliografia
ADORNO T. W. (1961), Zur Schlussszene des Faust, in Id., Noten zur Literatur, vol. II,Suhrkamp, Frankfurt am Main.
AMÉRY J. (2001), Illuminismo come filosofia perenne, in “Micromega”, 5, pp. 257-69.ARENDT H., JASPERS K. (1989), Carteggio 1926-1969: filosofia e politica, a cura di
A. Dal Lago, Feltrinelli, Milano.ASCHHEIM S. (1992), The Nietzsche Legacy in Germany: 1890-1990, University of
California Press, Berkeley (CA).BANTI A. M. (2000), La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle
origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino.BERLIN I. (1978), Vico e Herder: due studi sulle idee, introduzione di A. Verri,
Armando, Roma (ed. or. 1976).BORGESE G. A. (1933), Saggio sul Faust, Treves, Milano.BURGIO A. (a cura di) (2000), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia
1870-1945, il Mulino, Bologna.CACCIATORE G., COTRONEO G., VITI CAVALIERE R. (a cura di) (2003), Croce filosofo,
Atti del Convegno Internazionale di studi in occasione del 50o anniversariodella morte (Napoli-Messina, 26-30 novembre 2002), Rubbettino, SoveriaMannelli.
CASES C. (1965), Introduzione a W. Goethe, Faust, Einaudi, Torino, pp. I-XC.CASSATA F. (2008), “La Difesa della razza”. Politica, ideologia e immagine del raz -
zismo fascista, Einaudi, Torino.CASSIRER E. (1987), Il mito dello stato, Longanesi, Milano (ed. or. 1946).CAVAGLION A. (2000), Due modeste proposte, in Burgio (2000), pp. 379-86.CHIARINI L. (1936), Fascismo e letteratura, “Quaderni dell’Istituto nazionale
fascista di cultura”, s. VI, n. VI.CIARAMELLI F. (2003), Croce, De Martino e il problema filosofico dell’origine, in
Cacciatore, Cotroneo, Viti Cavaliere (2003), pp. 153-64.COGNI G. (1937), Il razzismo, Bocca, Milano.CONTE É., ESSNER C. (1995), Quête de la race. Une anthropologie du nazisme,
Hachette, Paris (trad. it. Culti di sangue. Antropologia del nazismo, Carocci,Roma 2000).
CROCE B. (1950), Conversazioni critiche, vol. II, Laterza, Bari, pp. 187 ss.ID. (1959), Goethe, con una scelta delle liriche nuovamente tradotte, parte I, Laterza,
Bari.ID. (1963), Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici, Laterza, Bari.ID. (1993), La mia filosofia, Adelphi, Milano.ID. (2005), Filosofia e storiografia, a cura di S. Maschietti, Bibliopolis, Napoli.D’ANGELO P. (2003), Croce interprete di Goethe, in Cacciatore, Cotroneo, Viti
Cavaliere (2003), pp. 235-50.
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 36
DE MARTINO E. (198o), Furore simbolo valore, introduzione di L. Lombardi Satri-ani, Feltrinelli, Milano.
EVOLA J. (2007), Fenomenologia dell’Individuo Assoluto, Edizioni Mediterranee,Roma.
ID. (1979), Indirizzi per una educazione razziale, Ar, Padova.FARIAS V. (1988), Heidegger e il nazismo, Bollati Borighieri, Torino.FARINELLI A. (1914), Giusta guerra o atroce demenza? (Colloquio tra un Belligero
ed un Umanitario), in Id. (1925), pp. 19-46.ID. (1919a), Franche parole alla mia nazione, con aggiunto il discorso L’uma nità
di Herder e il concetto di “razza” nella storia dello spirito, Bocca, Milano-Roma.
ID. (1919b), Franche parole alla mia nazione, in Id. (1919a), pp. 3-134.ID. (1919c), L’umanità di Herder e il concetto di “razza” nella storia dello spirito, in
Id. (1919a), pp. 135-235.ID. (1923), Il sogno di una letteratura mondiale, Fondazione Leonardo per la
Cultura Italiana, Roma.ID. (1925), Umanità, il Corbaccio, Milano.ID. (1930), Gl’influssi letterari e l’insuperbire delle nazioni, s.n., Paris.ID. (1942), Ricordi Atesini, in Id., Nuovi saggi e Nuove memorie, Paravia, Torino
1942, pp. 29-43 (ed. or. 1939).FAYE E. (2005), Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie: autour des
séminaires inédits de 1933-1935, Albin Michel, Paris.GAMBAROTA P. (2006), Bouhours, Vico, and the Genius of the Nation, in “Romanic
Review”, 3-4, pp. 285-307.GENTILI S. (2008), La legge di san Paolo e la storia del Novecento in Pasolini, in
“Lettere Italiane”, LX, 4, pp. 543-76.ID. (2009), Il “Genio” italiano e la Francia, in “Bollettino di Italianistica”, n.s., VI,
pp. 209-16.GERMINARIO F. (2001), Razza del Sangue, razza dello Spirito. Julius Evola, l’an-
tisemitismo e il nazionalsocialismo (1930-43), Bollati Boringhieri, Torino.GIARDINA A. (1906), Le discipline zoologiche e la scienza generale delle forme orga-
nizzate. Prolusione al corso di anatomia e fisiologia comparate letta il 7 marzo1906 nell’università di Pavia, Tipografia e legatoria cooperativa, Pavia.
ID. (1920), Il concetto di individuo in biologia, in “Rassegna delle ScienzeBiologiche”, II, pp. 65-73.
GOBETTI P. (1969a), Arturo Farinelli, in Id., Scritti storici, critici, letterari e filosofi-ci, a cura di P. Spriano, Einaudi, Torino, pp. 505-9 (ed. or. 1921).
ID. (1969b), Un accademico ribelle, in Id., Scritti storici, critici, letterari e filosofici, acura di P. Spriano, Einaudi, Torino 1969, pp. 573-8 (ed. or. 1923).
GRAMSCI A. (1965), Lettere dal carcere, a cura di S. Caprioglio e E. Fubini, Einaudi,Torino.
37
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 37
ID. (1975), Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura diV. Gerratana, 4 voll., Einaudi, Torino.
ID. (1980), Socialismo e cultura, in Id., Cronache torinesi (1913-1917), Einaudi, Tori-no, pp. 100-1 (ed. or. 1916).
GRASSI G. B. (1906), La vita. Ciò che sembra ad un biologo, in “Rendiconti dellaSolenne Adunanza. Atti della Reale Accademia dei Lincei”, II, pp. 219-39.
GRASSI L. (1932), Commento alla vita di Faust, Bocca, Torino.HEIDEGGER M. (1976), Essere e tempo, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino (ed. or. 1927).ID. (1994), Nietzsche, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano.ID. (1998), Scritti politici, a cura di G. Zaccaria, con prefazione, postfazione e note
di F. Fédier, Piemme, Casale Monferrato (ed. or. 1933-66).JASPERS K. (1986), Erneuerung der Universität, Schneider, Heidelberg (ed. or.
1945).ID. (1996), La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania,
Raffaello Cortina, Milano (ed. or. 1946).KLINE G. L. (1968), Religious and Anti-Religious Thought in Russia, University of
Chicago Press, Chicago-London.KOESTERS GENSINI S. E. (2008), Parole sotto la svastica. L’educazione linguistica e
letteraria nel Terzo Reich, Carocci, Roma.LÉVINAS E. (1997a), Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, suivi d’un
essai de Miguel Abensour, Payot & Rivages, Paris (ed. or. 1934).ID. (1997b), Post-scriptum, in Id. (1997a), pp. 24-6 (ed. or. 1990).LOSURDO D. (1983), Hegel, questione nazionale, restaurazione. Presupposti e svilup-
pi di una battaglia politica, Università degli Studi di Urbino, Urbino.ID. (1991), La comunità, la morte, l’Occidente. Heidegger e l’«ideologia della guer-
ra», Bollati Boringhieri, Torino.ID. (1997), Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e
reazione, Guerini e associati, Milano.MANACORDA G. (1932), Benedetto Croce o dell’improntitudine, Bemporad, Firenze.MANN T. (1995), La Germania e i tedeschi, introduzione di D. Bidussa, Mani-
festolibri, Roma (ed. or. 1945).MEINECKE F. (1948), La catastrofe della Germania, La Nuova Italia, Firenze (ed. or.
1946).MERKER N. (2001), Il sangue e la terra. Due secoli di idee sulla nazione, Editori
Riuniti, Roma.MONTEVERDI A. (1948), Ricordo di Arturo Farinelli, in “Cultura Neolatina”, VIII,
pp. 265 ss.MORI M. (2003), Ancora a proposito dell’individualità in Croce, in Cacciatore,
Cotroneo, Viti Cavaliere (2003), pp. 705-12.OTTAVIANI A. (2002), Introduzione, in Dalla filogenia all’enigma: il problema del
vivente in cinque prolusioni accademiche in Sicilia fra Otto e Novecento,Facoltà di Scienze, Palermo, pp. 5-54.
S O N I A G E N T I L I
38
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 38
RAFFAELE F. (1912), Le nuove tendenze nelle teorie dell’evoluzione, in “Annuariodella Biblioteca Filosofica”, I, pp. 91-112.
ROTA G. (2008), Intellettuali, dittatura, razzismo di stato, FrancoAngeli, Milano.SASSO G. (2001), Ernesto De Martino tra religione e filosofia, Bibliopolis, Napoli.ID. (2009), Gentiliana e Cantimoriana, in “La Cultura”, 2, pp. 187-246.SCHMITT C. (1933), Staat, Bewegung, Volk, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg.STRAPPINI L. (1995), voce Farinelli, Arturo, in Dizionario biografico degli italiani,
vol. 45, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, pp. 21-4.
39
C U L T U R A D E L L A R A Z Z A: A L C U N E S T R U T T U R E C O N C E T T U A L I
Foa-Gentili_def_XP7.qxd:Foa-Gentili_DEF 16-04-2010 12:01 Pagina 39