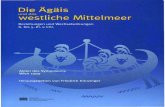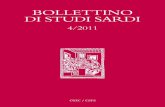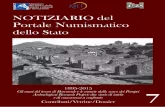QUIRINO 2011, Le case F I e F II del Forcello di Bagnolo San Vito (MN): analisi preliminare di due...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of QUIRINO 2011, Le case F I e F II del Forcello di Bagnolo San Vito (MN): analisi preliminare di due...
3
�IL FILO DEL TEMPO�Studi di preistoria e protostoria
in onore di Raffaele Carlo de Marinis
a cura di
STEFANIA CASINI
Comune di Bergamo
379
Le case F I e F II del Forcello di Bagnolo San Vito (MN): analisi preliminare di due abitazioni etrusche
di fine VI secolo a.C.Tommaso Quirino
Gli ultimi anni di ricerche sul sito occupato dall�abitato etrusco del Forcello di Bagnolo SanVito1 hanno avuto fra gli obiettivi principali quello di riportare alla luce l�intero perimetro dialmeno un�abitazione pertinente alla fase F, databile al 510-500 a.C.2.
A questo periodo risalgono due strutture (F I e F II), il cui scavo ha avuto inizio nel giugno-luglio del 1990 su un�area allora estesa solo 35 mq circa3, che si caratterizzano per una straordinariostato di conservazione: dopo un violento incendio verificatosi alla fine del VI secolo a.C., infatti,i loro resti carbonizzati e il materiale in esse presente, frantumato e talvolta deformato dal calore,sono stati sigillati da un potente livello di bonifica di argilla pressoché sterile. Questa bonifica nonsolo ha permesso una migliore conservazione del sottile strato di ceneri e carboni e dei resti ditravi lignee carbonizzate, ma, grazie al suo notevole spessore, ha anche preservato i piani d�usodall�obliterazione dovuta alle successive attività antropiche. All�interno della complessa articolazionestratigrafica del deposito archeologico del Forcello, dunque, la fase F rappresenta certamente unodei momenti meglio ricostruibili nel dettaglio.
Al termine della campagna di scavi del 20034, l�abitazione principale attribuita alla fase F (casaF I), era stata riportata alla luce per un estensione di circa 105 mq ed erano stati riconosciuti novediversi ambienti5 divisi da canaline di fondazione. I limiti nord-occidentale e nord-orientale, tuttavia,non erano ancora stati raggiunti. Nello stesso anno, per questo motivo, è stato previsto unampliamento dell�area di indagine6, seguito nelle campagne successive da altri tre progressiviallargamenti7. Solo nel 2010 è stato raggiunto l�obiettivo di ricostruire l�intera planimetriadell�abitazione, mentre al termine della campagna di maggio-luglio 2011 è stata riportata alla lucequasi per intero anche la casa F II. Si vuole qui fornire un�analisi preliminare dell�articolazionecomplessiva delle due abitazioni, suscettibile di ulteriori precisazioni in futuro, quando verrannostudiati nel dettaglio anche i materiali provenienti dai relativi piani d�uso.
La casa F I
La casa F I di fase F si presenta ora con la sua planimetria completa (fig. 1), di forma rettangolare,orientata SE-NO e composta da 15 ambienti disposti secondo un modulo regolare � un ambientepiù ampio centrale e due più piccoli ai lati di questo � ripetuto per cinque volte. Gli ambienti
Notizie Archeologiche Bergomensi, 19, 2011, pp. 379-390ISSN: 1127-2155
1) Ringrazio il prof. R.C. de Marinis per avermi accordato lasua fiducia, affidandomi, dal 2005 ad oggi, la conduzione delloscavo nel settore più settentrionale del sito e per avermipermesso di pubblicare questa relazione preliminare sui risultatidelle più recenti ricerche. Il Forcello, con la sua complessaarticolazione stratigrafica, è potuto diventare così una splendidasede di accesi quanto stimolanti confronti.
2) Per la scansione in fasi del deposito archeologico del Forcello,si veda: DE MARINIS 1992; DE MARINIS et Al. 1995;CASINI-DE MARINIS 2007 e bibliografia.
3) DE MARINIS 1992, pp. 241-242.
4) Tale situazione è documentata in DE MARINIS-RAPI 2005,p. 95, figg. 28, 38; la planimetria parziale viene in parteaggiornata dallo scrivente nella riedizione del volume (DEMARINIS-RAPI 2007, p. 87, fig. 37) e in DE MARINIS 2010,p. 104, fig. 5.
5) A questi si aggiungono tre ambienti scavati solo parzialmente.
6) Nei qq. R18 c-i 18-20, R19 c-n 1-7.
7) Rispettivamente nei qq. Q18 s-u 13-19 e R18 a-g 11-20, R19a-k 2-6 ed e-o 7-11, R19 m-s 2-9.
380
centrali hanno una dimensione ricorrente di 6,20/6,10x3,40 m circa, per una superficie occupatadi poco superiore ai 21 mq, mentre gli ambienti piccoli misurano 3,40x1,80/1,70 m circa, per unasuperficie occupata di poco superiore ai 6 mq8. L�intera abitazione, comprese le canaline difondazione delle pareti interne, che presentano una larghezza massima di circa 20 cm, misura17x10 m circa e occupa dunque un�area complessiva di circa 170 mq.
La struttura era circondata su tre lati da altrettanti canali di drenaggio e di scolo: due maggiori,orientati SE-NO e della larghezza massima di 2,5 m9, adiacenti ai lati lunghi dell�abitazione; unominore, orientato SO-NE e della larghezza di circa 1 m, collocato poco oltre il lato corto sud-orientale. I due canali maggiori sembrano esaurirsi verso NO, appena oltre il limite della casa, incorrispondenza di una fascia di circa 2 m caratterizzata da un piano limo-sabbioso pressoché
8) Si confermano dunque le dimensioni degli ambienti giàregistrate nel 1995 (DE MARINIS et Al. 1995, pp. 539-540).
9) Non si conosce la larghezza totale del canale lungo il lato
Fig. 1: Planimetria semplificata delle case F I ed F II (da rilievi di: Casini, Cazzanelli, Degasperi, Longhi, Mangani, Quirino; rilievo digitale: Quirino).
nord-orientale della casa, poiché è stato scavato solo per metàe prosegue oltre i limiti di scavo; tuttavia, la profondità raggiunta ela larghezza della parte indagata lasciano pensare che possa averele medesime dimensioni di quello lungo il lato sud-occidentale.
381
sterile10; verso SE, invece, confluiscono entrambi nel canale minore.Come anticipato, tutta l�area occupata dalla casa F I era ricoperta da un potente strato di
bonifica di argilla sterile di colore grigio (US 461)11, che ha permesso la conservazione del livellod�incendio della struttura (US 476) e del materiale ancora in situ. Al termine della campagna discavo di maggio-giugno 2011 è stato possibile documentare che la bonifica di argilla si esaurisceappena oltre il limite nord-occidentale della casa F I e oltre il limite sud-occidentale della casa F II.
L�andamento rettilineo del limite nord-ovest di US 476, fa supporre che l�incendio si siaconservato esclusivamente al di sotto di US 461. È infatti plausibile che l�area carboniosa abbiainteressato una superficie più estesa e irregolare, ma che la parte non ricoperta dall�argilla sia stataobliterata, o per l�azione degli agenti atmosferici o per l�attività antropica.
Nell�area indagata dal 2006 ad oggi (fig. 2), US 476 risulta coprire in modo abbastanza uniformei piani pavimentali dell�abitazione e gli stessi canali. Si presenta come uno strato centimetrico dicolore nero ricco di carboni, al cui interno si riconoscono ceramiche spesso bruciate o deformatedall�azione del calore, bronzo, ferro e scorie metalliche. In questa distribuzione omogenea dellivello d�incendio si segnala unicamente un aumento del suo spessore verso ovest, nei quadratiR18 e-g 17-19 e in corrispondenza del canale sud-occidentale; qui, tale livello raggiunge unapotenza di circa 10 cm, risulta particolarmente ricco di frammenti ceramici e copre alcuni elementilignei carbonizzati. L�ottimo stato di conservazione dei residui carboniosi all�interno del canale, inparticolare, fa ipotizzare che durante la fase F questo fosse pressoché asciutto e riempito soloparzialmente da uno strato di deposizione naturale (US 703).
Fig. 2: Panoramica in direzione est della metà settentrionale della casa F I, messa in luce dal 2003 al 2010.
10) Non è possibile perciò ipotizzare se, verso NO, ci sia un�altraabitazione o, piuttosto, una via di passaggio o una vera e propriastrada.
11) US 461 contiene solo rari materiali , provenientiprobabilmente dal livello d�incendio e mischiatisi alla sua matricedurante la stesura. In corrispondenza del limite nord-occidentale della casa, invece, così come è stato documentato
anche in passato in corrispondenza dei canali maggiori, è statorinvenuto uno strato di matrice limo-sabbiosa, grigio conchiazze rossastre e con presenza abbastanza rilevante dimateriale (US 2110): una sorta di grossa lente che risultavacontenuta nella bonifica d�argilla e che è stata regolarmentenumerata, al fine di raccogliere il materiale in essa contenutodistintamente da quello assai più scarso di US 461.
382
Per la descrizione e l�interpretazione funzionale dei primi nove ambienti si rimanda a quantogià edito12. Si vogliono qui fornire, invece, alcune indicazioni preliminari sulla funzione, sullapresenza di eventuali arredi e sulla distribuzione dei materiali dei nuovi ambienti riportati alla luce13.
L�ambiente 11, già quasi interamente indagato nel 2007, presenta un focolare di formaquadrangolare, posto al centro, e frammenti ceramici concentrati nella parte sud-occidentale,verso la parete che lo divide dall�ambiente 10: si tratta, in particolare, di ceramica etrusco-padanad�impasto fine, di anfore greche da trasporto e di ceramica attica14. Da una notevole concentrazionedi frammenti ceramici bruciati e deformati dal calore, nei quadrati R19 k-l 2-3 e nei pressi dei restidi due assi carbonizzate ancora fissate insieme da un chiodo di ferro, provengono invece quellipertinenti a un cratere a colonnette a figure nere, quasi integralmente ricostruito15. Poiché incorrispondenza di entrambe le concentrazioni di materiali risultano anche più intense le tracce dellivello d�incendio, è possibile ipotizzare la presenza in questi punti di due arredi lignei16, probabiliscaffalature che ospitavano la ceramica da mensa e per il consumo del vino. Queste poche indicazionisuggeriscono un utilizzo di questo ambiente come sala da pranzo.
L�ultimo ambiente maggiore dell�abitazione, l�ambiente 12, si caratterizza per la presenza di unfocolare sub-quadrangolare addossato alla parete che lo divide dall�ambiente 11 (fig. 3), postonella stessa collocazione di quello del vano 4 e con le medesime caratteristiche. Ci si riferisce in
12) DE MARINIS et Al. 1995; LONGHI-MANGANI 2004;CASINI-LONGHI-RAPI 2007.
13) I materiali degli scavi più recenti sono ancora in corso distudio.
Fig. 3: Panoramica degli ambienti maggiori 11 e 12 e degli ambienti minori 10 e 13 della casa F I; in primo piano ilfocolare dell�ambiente 12 ancora parzialmente coperto da mattoni di argilla.
14) CASINI-LONGHI-RAPI 2007, p. 89.
15) DE MARINIS 2010, pp. 105-106, figg. 7-10; WIEL MARINinfra.
16) CASINI-LONGHI-RAPI 2007, p. 89.
383
particolare al ritrovamento, anche in questo caso, di alcuni mattoni o frammenti di mattoni inargilla cruda, funzionali a isolare dal fuoco del focolare la parete lignea. Attorno al focolare e nellaparte più settentrionale dell�ambiente, in corrispondenza dei quadrati R19 i-k 5-6, si è documentatauna concentrazione di frammenti di macina e macinelli17, frantumatisi per il calore sviluppatodall�incendio. Nei qq. R19 h-k 1-3, in corrispondenza dell�angolo sud-occidentale, invece, si notaancora una volta una maggior concentrazione di carboni e ceramiche, probabile testimonianzadella presenza di un arredo ligneo. Nonostante la minor quantità di materiale in esso presente, lasomiglianza con l�ambiente 4 spinge ad ipotizzare anche per questo ambiente la funzione di cucina.
Gli ambienti minori 10 e 13, come quelli già indagati, dovevano essere utilizzati, in virtù anchedelle loro ridotte dimensioni, come vani di servizio o vani magazzino. L�ambiente 10 si presentavaricco di frammenti ceramici pertinenti soprattutto ad anfore greche da trasporto, concentratinell�angolo orientale. La presenza di alcuni pesi da telaio a ciambella scivolati all�interno del canaleappena oltre la parete esterna, inoltre, fa presupporre la presenza al suo interno anche di un telaio.L�ambiente 13 risulta invece quasi totalmente privo di materiale18, ma con una peculiarità strutturale:appare suddiviso a sua volta, da un�altra canalina di fondazione, in due parti ancor più ridotte (13ae 13b). Nel vano più a nord (13b), inoltre, si trovano due brevi allineamenti perpendicolari dipiccole buche di palo, interpretabili come la traccia di un piccolo arredo o scaffalatura (fig. 4). Aldi sopra di queste buche è stato rinvenuto anche un cumulo di sabbia grigio-biancastra, diconsistenza decisamente sciolta, che trova un precedente in un cumulo molto simile, scavato in
17) Fra questi si trova anche un peso in pietra, costituito da unciottolo con solcature disposte a croce su entrambe le facce ein senso longitudinale.
Fig. 4: Panoramica dell�ambiente 13 della casa F I; in basso a destra, le due file perpendicolari di buche di palopertinenti a un probabile arredo.
18) Si segnala esclusivamente la presenza di alcune pietre dinon chiara funzione.
384
corrispondenza della parete che divideva gli ambienti 3 e 4, e che sembra ugualmente interpretabilecome una gettata finalizzata a placare l�estendersi dell�incendio19.
Più difficoltosa l�interpretazione funzionale degli ultimi due ambienti minori (14 e 15), sullato nord-orientale della casa, dove il livello d�incendio US 476 si presentava molto meno potentedi quanto registrato in corrispondenza degli altri ambienti e decisamente più povero di materiali,quasi completamente assenti. In quest�area si conservano invece numerosi lacerti di travicarbonizzate. I piani pavimentali di questi due ambienti risultano ad una quota leggermente piùalta rispetto agli ambienti grandi posti a sud-ovest e a quelli piccoli posti a sud-est, come se ad uncerto punto del loro utilizzo le superfici pavimentali fossero state ripristinate, stendendo al disopra una nuova preparazione in sabbia20. Qualora ciò venisse confermato dalle indagini future,è possibile che quelle scavate come canaline (EESS 2410 e 2412) siano in realtà la traccia dellaparete lignea alla quale si sono appoggiati i nuovi pavimenti e che, solo al di sotto di questi, sitrovino i tagli delle vere canaline di fondazione dei tramezzi.
Zone più ricche di carbone si ritrovano ancora una volta soprattutto in corrispondenza delfondo del canale che delimita l�abitazione sul lato nord-orientale, esternamente agli ambienti 14 e7. Di notevole interesse sono, in particolare, le travi lignee carbonizzate (ES 2364) rinvenuteproprio all�interno di questo canale, nei qq. R19 r-s 2-3, che potranno fornire un importantecontributo all�interpretazione delle tecniche costruttive utilizzate durante la fase F e allaricostruzione della struttura della stessa casa F I. Si tratta di una struttura lignea complessa,composta da due assi affiancate21 di circa 20/25 cm di larghezza, conservate per quasi 2 m di
Fig. 5: Travi lignee carbonizzate (ES 2364) rinvenute lungo il canale che delimita la casa F I sul lato nord-orientale,esternamente agli ambienti 14 e 7.
19) DE MARINIS et Al. 1995, p. 539.
20) Questa è visibile soprattutto nei qq. R19 p-q 1-2.
21) Alle quali si aggiunge il frammento, anche se molto ridotto,di una terza.
385
lunghezza, orientate sud-est nord-ovest eappoggiate a due travetti a sezione circolare,del diametro di circa 5 cm e ad esseperpendicolari22 (fig. 5). La struttura si èconservata probabilmente anche grazie alleparticolari condizioni prodotte dalla presenzadi uno strato ricchissimo di piccoli concotti inmatrice limo-argillosa (US 2360) che la copriva.ES 2364 si presta a due possibili e differentiinterpretazioni: essa può rappresentare unaporzione di parete lignea dell�abitazione crollatanel canale oppure ciò che resta di una passerellain legno che copriva il canale permettendo ilpassaggio fra l�interno e l�esterno dell�abitazionestessa. Solo un�analisi più approfondita di tutti isuoi elementi potrà tuttavia far propendere perun�ipotesi piuttosto che per l�altra23.
Per quanto riguarda l�interpretazione delletecniche costruttive, si ritiene utile proporre oraalcune considerazione sulla stratigrafia dei pianid�uso e degli elementi strutturali di questa fase.Innanzi tutto le canaline di fondazione dellepareti perimetrali dell�abitazione, al confine coni canali maggiori, non sono sempre benriconoscibili: se ne intuisce la presenza graziealla conservazione di notevoli tratti di travilignee carbonizzate, ma raramente è possibiledistinguere le pareti di un taglio. L�unico puntodove risulta molto ben conservata una canalina si trova in corrispondenza dei qq. S18 a-b 15-17 eR18 t-u 17-20, ovvero lungo il limite esterno degli ambienti 5 e 6, dove la pendenza della paretedel canale appare decisamente meno accentuata. Proseguendo verso nord-ovest, invece, non sene riconosce più il taglio in modo chiaro, ma si conserva solo la sua parete ovest.
Un problema analogo si riscontra per le canaline dei tramezzi che suddividono gli ambientiinterni della casa: sono meglio riconoscibili riempimento e pareti del taglio quando è presentequalche elemento ligneo carbonizzato, ma in alcuni punti il riempimento si confonde con i pianipavimentali in limo-sabbioso. Il passaggio tra un ambiente e l�altro, tuttavia, si riconosce sempregrazie ad una labile traccia più scura, piuttosto che grazie alla netta differenza fra i piani pavimentalidei diversi ambienti, che, benché stesi in un unico momento, hanno subito alterazioni differenti inbase alle attività che vi venivano svolte.
Un importante aiuto per meglio interpretare questi aspetti strutturali è stato fornito dallalettura della stratigrafia visibile nella parete di una grossa buca, attribuibile ad una fase più recentedella F, che però ha obliterato un tratto di piano pavimentale e di canalina di fondazione lungo illato nord-occidentale della casa, nei qq. R19 g-h 5-6 (fig. 6). Qui, infatti, si riconosce in modopiuttosto chiaro come il pavimento dell�abitazione appaia interamente contenuto in un taglio. Inconclusione, dunque, sembra di poter ricostruire le procedure di edificazione della casa nel modoseguente: prima della costruzione è stato effettuato uno splateamento dell�area di interesse, unvero e proprio scasso per posizionare le fondazioni; successivamente sono state collocate le travi
Fig. 6: Panoramica del limite nord-occidentale della casaF I; sono visibili, sulla destra, il piano pavimentale
dell�ambiente 12 e, sulla sinistra, l�esterno dell�abitazione.
22) Alcuni campioni di carbone provenenti da questa struttura,insieme ad altri resti di travi lignee carbonizzate e ai carboniprovenienti dai livelli di altre fasi archeologiche, sono in corsodi studio da parte di Lorenzo Castellano. Il riconoscimento deilegnami utilizzati potrà fornire importanti indicazioni anchesulle tecniche costruttive utilizzate.
23) Anche l�US 2360, tra l�altro, data la presenza massiccia dielementi edilizi, deve essere interpretata in connessione allastruttura ES 2364: una sorta di intonacatura della parete ligneao una parte di parete realizzata con una differente tecnicacostruttiva.
386
di fondazione della casa e stesi al loro interno i riporti di limo e sabbia che avrebbero dovutofungere da pavimento; infine è stato costruito l�alzato. In tal caso, la difficoltà nel riconoscere ilriempimento delle canaline di fondazione � spesso sciolto e carbonioso, non sempre bendistinguibile o addirittura assente � potrebbe essere dato dal fatto che un vero riempimento oinzeppatura delle canaline non esistesse del tutto, ma che i piani pavimentali fossero stati appoggiatidirettamente su travi già in posto. Quello che si riconosce è il disfacimento delle travi di fondazionein legno; dove queste non si sono conservate, il vuoto lasciato fra la preparazione dei piani pavimentalie i livelli esterni all�abitazione si è colmato in seguito ad eventi post-deposizionali.
Ma qual era la tecnica costruttiva degli alzati? Quello che è certo è che le pareti della casafossero edificate interamente in legno e che il tetto fosse rappresentato da spioventi realizzati conpaglia pressata o, meno probabilmente, ancora in legno. Fino ad ora è stato ipotizzato l�utilizzodella tecnica del Blockbau24: le pareti venivano edificate con travi di legno orizzontali sovrapposte,con incavi singoli o doppi nei pressi delle estremità, funzionali a incrociare e giuntare le travistesse con quelle delle pareti contigue. Non si esclude tuttavia la possibilità che, sempre sfruttandotravi di fondazione, venisse costruita un�intelaiatura lignea alla quale venivano incastrate o inchiodateassi verticali o orizzontali. A favore di questa seconda ipotesi vi sarebbero la presenza di unabuona quantità di chiodi in ferro nel livello d�incendio e la presenza di coppie di pali verticali nelleintersezioni delle canaline, attestata già dopo i primi scavi25.
L�articolazione planimetrica di questa abitazione non trova attualmente confronti con altreabitazioni etrusche, né in Etruria propria né nella stessa area padana26. La pianta della casa F Itrova invece un confronto più puntuale, per non dire quasi coincidente, con una tipologia di casarinvenuta presso l�insediamento fortificato tardo-hallstattiano della Heuneburg (Germania)27,appartenente alla fase IVc dell�abitato (Ha D 1-a) e quindi più antica della fondazione del Forcello.Il confronto non stupisce, poiché sono ormai ben noti i contatti commerciali fra l�emporio etruscoe il mondo celtico nord-alpino, testimoniati da rinvenimenti di fibule tardo-hallstattiane28 nelprimo e di materiale etrusco e greco nel secondo.
La casa F II
La seconda abitazione pertinente alla fase F presenta una planimetria completamente diversadalla prima29. Innanzi tutto la disposizione degli ambienti non è modulare e appare meno articolata:si riconoscono solo tre ambienti allineati e di dimensioni diverse fra loro30 (fig. 1). I piani d�uso,inoltre, sono decisamente peggio conservati rispetto a quelli della casa F I: da una parte, la fasciasud-occidentale dei primi due ambienti (1 e 2) non risultava coperta dalla bonifica di argilla (US461), che così bene ha preservato la restante superficie e che invece in quest�area va progressivamenteassottigliandosi; dall�altra, i piani pavimentali di questi stessi ambienti si trovano ad una quotaquasi 25 cm più alta rispetto a quelli della casa F I, venendo così obliterati in più punti da strutturenegative delle fasi più recenti31 (fig. 7). Anche la casa F II sembra circondata da due canali maggiori32,
24) CASINI-DE MARINIS 2007, p. 41.
25) DE MARINIS 1992, p. 242; DE MARINIS et Al. 1995, p. 540.
26) Si veda, ad esempio, MALNATI 1999 e bibliografia;CALASTRI et Al. 2011 e bibliografia.
27) KURZ 2007, p. 17, Abb. 2.
28) DE MARINIS 1987; DE MARINIS 2007.
29) Le campagne di scavi 1990-1993 avevano permesso dimettere in luce solo parzialmente i due ambienti meridionali(DE MARINIS et Al. 1995, p. 542, fig. 19), ma con i successiviampliamenti del 2005 e del 2008 e soprattutto con la campagnadi maggio-giugno 2011 è stato possibile ricostruire quella chesembra essere l�estensione completa dell�abitazione.
30) Lo schema, pur con una differenza nella tecnica ediliziautilizzata, potrebbe rientrare in quello delle abitazioni a sviluppolaterale, meglio note in Etruria propria, caratterizzate da trevani affiancati in larghezza, (COLONNA 1986 e bibl.; DEMARINIS et Al. 1995, p. 541, nota 13; PRAYON 2011 e bibl.).
31) Ci si riferisce, in particolare, ad alcuni forni a fossa per lalavorazione del bronzo, attribuibili alla fase E; a un canale discarico, attribuibile alle fasi C-D, e ad uno scasso attribuibileaddirittura alle fasi più recenti dell�abitato (A-B). I livelli dellacasa F II non furono quindi intaccati da lavori agricoli, comesuggerito in passato (DE MARINIS et Al. 1995, p. 542).
32) Non si conosce l�ampiezza precisa del canale lungo il latosud-occidentale poiché prosegue oltre la sezione di scavo.
387
orientati SE-NO, cha la delimitano sui lati lunghi, e da uno minore (la prosecuzione di quello chedelimita la casa F I sul lato sud-orientale), lungo il lato corto meridionale. L�intera abitazione33
misura 17x5,70/5,60 m, per una superficie complessiva occupata di circa 97 mq.I primi due ambienti, già parzialmente noti ed editi, conservano il materiale in situ nella fascia
nord-orientale, mentre, dove mancava la bonifica di argilla, il materiale con ogni probabilitàpertinente a questi stessi piani è stato rimosso e spinto, per livellare l�area, nel canale a SO dell�abitazione.
L�ambiente 2, il più meridionale e il più piccolo, misura circa 5,70/5,60x2,10 m, per una superficiedi circa 12 mq. Al suo interno sono stati recuperati numerosissimi frammenti di ceramica etrusco-padana, sia di impasto fine sia di impasto grossolano, una grande quantità di ceramica attica eduna tazza paleoveneta con ansa sopraelevata34. Lo stesso tipo di reperti è stato recuperato durantela campagna 2011, in corrispondenza della parte più sud-occidentale dell�ambiente e nel canaleposto appena al di fuori di esso, nella stessa direzione. Anche in virtù delle sue ridotte dimensioni,è possibile che questo ambiente rappresentasse un magazzino o una dispensa.
L�ambiente 1, di forma quadrangolare, misura circa 6,40/6,30x5,70/5,60 m, per una superficiedi circa 36,5 mq, e presenta il medesimo stato di conservazione del precedente. Al centro è presenteun focolare di forma quadrangolare, nel quale si notano ancora quattro tracce nere rettilinee,probabile residuo di piccoli travetti di contenimento delle ceneri. L�angolo occidentale del focolarerisulta obliterato da una buca di palo attribuibile alla fase C. All�interno di questo ambiente si sonorinvenuti i frammenti di una macina, i frammenti pertinenti a due dolii e a numerosi vasi diceramica attica, e un esemplare di amphoriskos di Fikellura: una piccola anfora a collo distinto,dipinta con un motivo di fiori e boccioli di loto alternati e con una fascia di sottili mezzelune35.Fra l�abbondante materiale rinvenuto durante l�ultima campagna di scavo nel riempimento delcanale sud-occidentale, interpretato come pulizia del livello d�incendio, si segnalano inoltre: un
Fig. 7: Panoramica della casa F II.
33) Non è ancora stato individuato il lato corto nord-occidentale,ma, allo stato attuale delle ricerche, si suppone con buoneprobabilità che termini allineato con il lato corto della casa F I. Lemisure si riferiscono dunque a questo allineamento.
34) DE MARINIS et Al. 1995, p. 542; RAPI 2007, p. 45, fig. 42:3.
35) DE MARINIS 1992, pp. 254-255, fig. 9; WIEL MARIN2007, p. 131, fig. 77.
388
mortaio integro di ceramica fine etrusco padana sovradipinta, un fornello ricostruibile quasiintegralmente e una fibula Certosa tipo Este-Costa Martini36. Le dimensioni dell�ambiente, lapresenza del focolare e il materiale in esso rinvenuto fanno ipotizzare che potesse essere utilizzatocome vano per la preparazione del cibo e sala da pranzo e, forse, persino come thalamos.
L�ambiente 3, infine, messo in luce fra il 2008 e il 2011, risulta il più ampio, con dimensioni di8,40x5,70/5,60, per una superficie complessiva occupata di quasi 48 mq. Esso si caratterizza perla presenza nella parte nord-orientale di una grossa buca di forma ovaleggiante e molto profonda(45 cm), ancora di difficile interpretazione (ES 2120)37. I piani pavimentali, poi, appaiono piuttostocome piani di lavoro: in corrispondenza dei qq. R18 a-c 19-20 il piano d�uso si presenta moltoannerito, ricco di carboni e cenere, e a tratti scottato e arrossato, probabilmente per il contatto conil fuoco; in corrispondenza dei qq. R18 e-g 14-16 è composto invece da limo giallo molto compatto epresenta i resti di un cordolo della stessa matrice e consistenza, alto circa 5 cm, a sezione piano convessae di forma semicircolare. Nei qq. R18 d-f 15-16, inoltre, non lontano quindi dal piano di limo giallo, siregistra una concentrazione eccezionale di frammenti di corallo, raccolti anche setacciando l�interosedimento (fig. 8). Se si eccettua il corallo e un numero notevole di pesi da telaio tronco-piramidali didimensioni medio-piccole, spesso frantumati dal calore dell�incendio, collocati nell�area corrispondenteai qq. R18 a-d 15-17, l�ambiente risulta quasi privo di materiali. L�unico interessante ritrovamento èquello di una coppa paleoveneta su alto piede, decorata a fasce rosse e nere38 (fig. 9).
Fig. 8: Rametti di corallo provenienti dal pavimento dell�ambiente 3 della casa F II.
36) PERONI et Al. 1975, pp. 44 e 49, fig. 7, 10; p. 145, fig. 49,2; tav. XIV, 12; CHIECO BIANCHI-CALZAVARA-DE MIN-TOMBOLANI 1976, p. 30, tav. 20, fig. 23; la datazione alperiodo Este III D1-Este III Medio conferma ulteriormentela datazione già proposta per la fase F.
37) Come già anticipato risultava riempita da US 461 e da US476, doveva quindi essere una struttura aperta o in uso almomento dell�incendio.
38) Questo tipo di coppa è caratteristico dei periodi Este IIIantico ed Este III medio: nel primo la coppa ha parete lisciadecorata a stralucido a fasce verticali (t. Ricovero 232; Este I,tavv. 173-180), mentre in Este III medio la coppa è cordonatae a fasce rosse e nere alternate, come nell�esemplare del Forcello(tt. Pelà 14 e Ricovero 205; Este I, tavv. 122-125). In Este IIItardo il piede non è più così sviluppato in altezza.
389
39) Sia ceramiche che oggetti d�abbigliamento.
Ma il ritrovamento più importante connesso all�ambiente 3 è certamente un livello piuttostoesteso di crollo di concotti lungo quasi tutto il lato lungo sud-occidentale. Se dunque la casa F Iera costruita interamente in legno, questa seconda abitazione presentava una tecnica mista, ovveroalmeno una parete realizzata con la tecnica dell�incannucciato. Al momento, non sono statericonosciute nei piani pavimentali buche di palo come quelle, destinate a pali portanti, chedelimitavano il perimetro della casa di fase C, ma si suppone che l�armatura per questa paretedella casa F II potesse essere la stessa che, per le altre pareti, serviva per inchiodare le assi orizzontali.Si può solo ipotizzare, senza comprenderne la precisa funzione, che la scelta dell�incannucciatofosse legata alle attività artigianali che si svolgevano nell�ambiente 3, che per le strutture e imateriali in esso presenti, sembra avesse funzione di officina domestica.
Il ritrovamento di un numero significativo di reperti paleoveneti39, infine, porterebbe a formularel�ipotesi, tanto suggestiva quanto difficilmente dimostrabile, che questa fosse l�abitazione di unartigiano veneto. Un�ipotesi in ogni caso non troppo azzardata, se si considera quale straordinarioincontro di antiche culture potesse realizzarsi in un centro come il Forcello, di primaria importanzaper gli scambi commerciali tra le popolazioni del Mediterraneo, dell�Italia e dell�Europa centrale.
Tommaso QuirinoUniversità degli Studi
Via Festa del Perdono 7I-20122 Milano
Fig. 9: Coppa paleoveneta su alto piede, rinvenuta nell�ambiente 3 della casa F II.
390
Summary
The FI and FII houses at Forcello (Bagnolo S. Vito, MN). Preliminary report about two Etruscan housesof the end of the 6th century BC. The excavations carried out in the Etruscan settlement of Forcello (Bagnolo S.Vito, Mantova) during the last few years brought to light the full extent of two houses built at the end of the 6th
century BC. A preliminary analysis of these houses and of the stratigraphic context gives an overall account of thelayout and use of domestic space � in addition to what is already known. Data here collected open new and interestingperspectives for the study of construction techniques and etruscan architecture in the Po plain.
Riferimenti bibliografici
CALASTRI C.-CORNELIO C.-CURINA R.-DESANTISP.-LOCATELLI D.-MALNATI L.-MIARI M.2011 L�architettura domestica in Cispadana tra VII e II secolo
a.C. Una rassegna alla luce delle nuove scoperte, in M.BENTZ-C. REUSSER (Hrsg.), Etruskisch-italischeund Römisch-republikanische Häuser, Studien ZurAntiken Stadt, 9, 2011, pp. 43-63.
CASINI S.-DE MARINIS R.C.2007 La città etrusca del Forcello, in DE MARINIS-RAPI
2007, pp. 35-49.
CASINI S.-LONGHI C.-RAPI M.2007 Le case del periodo arcaico: le fasi G e F, in DE
MARINIS-RAPI 2007, pp. 83-92.
CHIECO BIANCHI A.M.-CALZAVARA L.-DE MINM.-TOMBOLANI M.1976 Proposta per una tipologia delle fibule di Este, Biblioteca
di Studi Etruschi, Firenze.
COLONNA G.1986 Urbanistica e architettura, in Rasenna, Milano, pp.
369-530.
DE MARINIS R.C.1992 La stratigrafia dell�abitato del Forcello di Bagnolo S.Vito
e i rapporti cronologici con le culture dell�ar eacircumalpina, in Archeologia Classica, XLIII, 1991,Miscellanea etrusca e italica in onore di M.Pallottino, pp. 237-259.
1987 Fibule tardo-hallstattiane occidentali dall�abitato etruscodel Forcello (Bagnolo S.Vito), in Celti ed Etruschinell�Italia centro-settentrionale dal V secolo a.C. allaRomanizzazione, Bologna, pp. 89-99.
2007 Le relazioni degli Etruschi del Forcello con Veneti, Reti eCelti, in DE MARINIS-RAPI 2007, pp. 203-212.
2010 Die etruskische Siedlung des Forcello im Lichte derBeziehungen zu den Gebieten nördlich der Alpen, inAktuelle Forschungen zu den Kelten in Europa,Festkolloquium für Jörg Biel, 1 August 2008 inAltheim, Esslingen, pp. 101-114, 127-132.
DE MARINIS R.C.-CASINI S.-CATTANEO A.C.-DEGASPERI N.-FRONTINI P.1995 Forcello (Comune di Bagnolo S.Vito, Mantova), in
Studi Etruschi, LX, 1994, pp. 534-549, tavv.LXXIX-c, LXXX, LXXXI.
DE MARINIS R.C.-RAPI M.2005 (a c. di), Il Forcello di Bagnolo S. Vito (MN). Le fasi
di età arcaica, Mantova.2007 (a c. di), Il Forcello di Bagnolo S. Vito (MN). Le fasi
di età arcaica, Firenze, II edizione con aggiunte ecorrezioni.
Este I1985 L. CAPUIS- A.M. CHIECO BIANCHI, Este I.
La necropoli di Casa di Ricovero, Casa MulettiProsdocimi e Casa Alfonsi, Monumenti Antichidell�Accademia dei Lincei, 51, Serie Monografica,2, Roma.
KURZ S.2007 Untersuchungen zur Entstehung der Heuneburg in der
späten Hallstatzeit, Forschungen und Berichte zurVor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band 105, Stuttgart.
LONGHI C.-MANGANI C.2004 GIS spatial analysis in the Etruscan trading centre of
Bagnolo S . Vito (Mantova, Italy) , in K.F.AUSSERER-W. BÖRNER-M. GORIANY-L.KARLHUBER-VÖCKL (eds.), Enter the Past. TheE-way into the four Dimensions of Cultural Heritage,CAA 2003, Computer Applications andQuantitative Methods in Archaeology,Proceedings of the 31st Conference, Vienna(April 2003), BAR International Series 1227,Archaeopress, Oxford, 2004 pp. 263-266.
MALNATI L.1999 Note sull�edilizia residenziale preromana a Oderzo e
nell�Italia nord-orientale , in G. CRESCIMARRONE-M. TIRELLI (a c. di), Vigilia diromanizzazione: Altino e il Veneto orientale tra II e Isec. a.C., Atti del Convegno, Venezia, S. Sebastiano(2-3 dicembre 1997), Altinum, 1, pp. 171-191.
PERONI R.-CARANCINI G.L.-CORETTI IRDI P.-PONZI BONOMI L.-RALLO A.-SARONIOMASOLO P.-SERRA RIDGWAY F.R.1975 Studi sulla cronologia delle civiltà di Este e Golasecca,
Origines, Firenze.
PRAYON F.2011 Frühetruskische Hausarchitektur. Bemerkungen zum
Forschungsstand, in M. BENTZ-C. REUSSER (ac. di), Etruskisch-italische und Römisch-republikanischeHäuser, Studien Zur Antiken Stadt, 9, 2011, pp.9-28.
RAPI M.2007 Schede di materiali delle fasi arcaiche , in DE
MARINIS-RAPI 2007, pp. 93-111.
WIEL MARIN F.2007 La ceramica greca figurata. Schede, in DE MARINIS-
RAPI 2007, pp. 131-156.